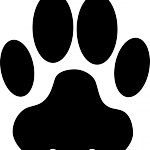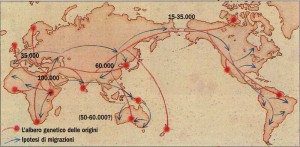(Giulio Cavalli, dopo anni di teatro, inchieste e impegno civile che lo obbligano ancora oggi a vivere sotto scorta, pubblica, scritto con la stessa rabbia e lucidità, il suo primo romanzo: Mio padre in una scatola da scarpe. Il libro è da qualche giorno in libreria e l’autore ci regala qui un estratto dal secondo capitolo. Noi per questo lo ringraziamo. G.B.)
La mattina presto. Per Michele può esserci il caldo più unto, il freddo più buio o la pioggia più fitta, ma il mattino va rispettato: l’alba è l’inizio. Cose semplici. Sono due anni che la scuola è finita e tutto il giorno ha già la forma del callo sulle mani, che ti sfregano ruvide la faccia quando ti lavi.
Lavorare rende liberi.
Michele era stato studente diligente e poco curioso, ma questa cosa del lavoro e della libertà non gli era mai andata giù. I vecchi dicono: “Tocca per farsi una famiglia ed essere una persona per bene”, ma la libertà proprio non c’entra. Ci sono città del mondo in cui il lavoro è un canale che bisogna navigare per stare a galla e sopravvivere, mentre qui a Mondragone si lavora per non dovere niente a nessuno e perché nessuno ti debba niente, per questo Michele ama la fatica: la fatica infatti ha una faccia sola, è meccanica senza viti, acido lattico senza sentimento. La fatica non ha bisogno di merletti. Sono le sei e Michele si alza come si alza il mattino: sale in fretta per scaldarsi.
«Si fatica principalmente per non sentire tutto il resto» dice sempre quello scemo di Massimiliano.
Caffè amaro. Le scarpe che si scollano. Una camicia spessa come pelo di topo, a quadrettoni, con i gomiti quasi trasparenti. Guardandosi allo specchio si osserva. Non è un bel vedere, no, ma tutta questa stoffa è l’armatura per la fatica al magazzino. La porticina del cortile di casa cigola come il portone di un castello abbandonato. Fuori, Mondragone è odore di caglio e case che si sbriciolano.
«Buongiorno e ben alzato, Michè!» La signora di fronte sta già bollendo la salsa. È cieca e sorda come la salsa ma saluta da orologio svizzero tutte le mattine alla stessa ora.
Lui risponde, anzi ci prova. Meglio, alza la mano e scatta con la testa, gli viene male: cade come da un lato, inciampa, sorride, rialza la mano, ride, no forse non se ne è nemmeno accorta e allora stinge il sorriso e niente, come se non fosse successo niente. «’Ngiorno.» Che fatica.
Mentre la strada scende vuota verso lo stop Michele prova a ripensare alla serata appena passata e a quelle voci che lo rivolevano in piedi: non è facile portare addosso le botte a mezza faccia facendo finta di essere elegante, tu che elegante poi non lo sei stato nemmeno al battesimo o alla comunione.
Erano in tre e Michele li aveva notati già da giorni per quelle smorfie da guappi che qui vengono ammaestrati in serie, seduti arrampicati sul muretto in piazza. Ieri sera erano nella solita posa, di quelli che vorrebbero essere falchi ma sono solo una nidiata di avvoltoi. Ieri aveva anche deciso di bersi una bottiglia in compagnia e festeggiare l’assunzione che era diventata ufficiale per tutti, al magazzino. Adulti a tempo indeterminato con il libretto di lavoro in tasca. Ci avevano promesso anche un po’ di malattia e ferie, non proprio tutte quelle che c’erano scritte nel contratto – che per sicurezza avevano fatto leggere a Giulio, che si era trasferito su a Milano e aveva imparato l’italiano meglio di come si impara un po’ sgarruppato nella scuola di Mondragone, e anche Giulio aveva esultato per un contratto che in fondo anche a parole era simile a quello che c’era scritto. Per questo avevano deciso di prendersi il vino, mica quello più buono, ma la qualità subito sotto, ben distante dal vino schifoso e lunghissimo che si bevevano di solito a pranzo. La locanda li conosceva per nome e cognome e si era fidata anche a dargli quattro bicchieri di vetro da portare fino in mezzo alla piazza con la bottiglia impolverata, perché c’è da fidarsi di Michele e quegli altri colleghi suoi, che non creano mai problemi.
Stavano appena stappando il tappo a vite come quello della spuma e ridevano pensando che poi magari un giorno qualcuno sarebbe diventato capoturno, poi magari un giorno, ridevano, avrebbe comprato un vino con il tappo quello vero.
Era stato un attimo e gli altri tre guappi erano già in mezzo. Dammi. No. Forza, dài qua. Ma che vuoi. Festeggiamo anche noi. Facciamo da soli grazie. Lo decidiamo noi chi festeggia qui in piazza. Non ci penso nemmeno…
Ed è stata subito una paranza di botte che facevano più rumore dei bicchieri che rotolavano sui sassi. Tonfi secchi sulle parti molli e il fruscio dei rami secchi quando si pestano con le scarpe, solo che questi erano in faccia, sulla mandibola e sotto gli occhi. Roba forte. Gli scappa anche da ridere, gli scapperebbe se non fosse per quell’angolo della bocca che brucia. Bicchieri come bombe a mano e pugni dappertutto: una sagra. Michele aveva cominciato a picchiare con tutta la voglia che aveva accumulato negli anni, come si immaginava si potesse picchiare solo prima di morire. E non menava solo quei tre cuccioli d’avvoltoio, no, picchiava i ricchi sempre gonfi alla domenica mattina; picchiava quelli che gridavano scemo a Massimiliano che piangeva come i magri anche se è grasso come un tacchino, e picchiava anche per lo scemo di troppo che gli dava quando anche lui esagerava con lo scherzo; picchiava per i vecchi così vecchi che fuori dalla chiesa sembra che ci manchi solo che se li porti via il vento o li sciolga questo sole unto. Picchiava l’odore dell’incenso che cuoceva la bara di sua madre; picchiava suo padre e il vino che gli aveva trasformato il cervello in una crosta incapace d’intendere cosa fosse quel fumo e cosa fosse quella bara; picchiava Giulio che tornava sempre così felice e tuttoaposto che sembrava avere anche perso l’odore di quelli che erano nati lì e aveva il colore delle persone sempreaposto che vivono a Milano; picchiava nonna che non era mai scivolata nemmeno per sbaglio in un abbraccio o un “ti voglio bene” e intanto picchiava anche quel “ti voglio bene” di nonno che è un cappio ogni domenica a fare la zuppa loro due come due vedovi. Picchiava gli indecisi come lui che vivono la vita come si mangiano le unghie; picchiava i prepotenti che tutti li condannano ma alla fine vincono sempre; picchiava la sua scuola così lercia che non gli aveva insegnato il vocabolario per le volte che avrebbe voluto dare un nome alle cose; picchiava la tranquillità che sono vent’anni che la insegue e che dio non chiedo mica tanto e che gli sembra irraggiungibile, nemmeno avesse voluto fare il pilota cacciabombardiere. Picchiava quel prete che ora se n’è andato dalla parrocchia e che si portava le donne nel retro dopo l’ultima messa; picchiava il nonno dei Torre che si faceva restituire i prestiti tra le cosce delle mogli degli altri – e si picchiava anche, per tutte le volte che non aveva avuto abbastanza coraggio; poi picchiava gli infami, i soloni, i tristi a comando, gli urlatori, i maleducati perché prepotenti, i prepotenti maleducati e gli educati a essere bravi prepotenti; picchiava quella sera che sua madre aveva detto di non dirlo a papà e quel mattino che papà gli aveva detto torno e non era tornato.
Solo dopo aveva picchiato Tore, Pino e Ciro. Solo dopo. Soprattutto Tore: l’avevano portato via all’ospedale di Caserta che piangeva e urlava ormai come un pulcino.
«Ritardo! Sei e quarantacinque, cos’hai? Pisciato nel letto?»
È già arrivato al magazzino, ha superato la discesa e il capannone è in fondo alla prima strada a destra. Il capoturno è già acceso sulla modalità scassaminchia.
«Non sono stato bene.» Sembra di essere ancora a scuola. Giustificarsi.
«Lo so.»
Mentre il capoturno parla sbucano alle sue spalle Ciccio e Berto. Hanno gli occhi bassi e tremano. Berto ha un ematoma sulla faccia, sembra un’ombra controsole. Volano le notizie, qui al magazzino, e con queste facce lavate male dal sangue raffermo di ieri sera non è facile fingere.
Ciccio balbetta un avvertimento verso Michele, ma l’aria è così spessa che sbatte prima di arrivare.
«Capo, alla fine siamo tutti qui.» Dio, che difesa debole, vedi che serve studiare.
«Noi non ne vogliamo teste matte, noi vogliamo gente che sistema la merce!»
Forse Berto ora sta cercando di dire che siamo pronti, che mancano i guanti e si entra subito di corsa nel capannone in mezzo alla sabbia ma viene zittito: è bastato un occhio di sguincio. Il capoturno ha la barbetta incolta che vibra come quella di una capra. «Andate a casa.»
Finalmente Ciccio emette suoni e abbozza una difesa: stiamo bene, non c’è problema, sono solo tre pugni, li abbiamo presi e li abbiamo dati tutti da ragazzi, domani si saranno già dimenticati. È sempre il più diplomatico, Ciccio, giù al capannone.
«Andate a casa. Lavatevi. Noi non abbiamo bisogno di ragazzi!»
Il portone si chiude con un glong. Ogni portone suonerebbe la fine esattamente così.
Licenziato poche ore dopo essere diventato indeterminato, Michele non l’avrebbe nemmeno mai potuto immaginare, con quella fantasia piatta che si fermava alla discesa fuori casa.
«Dite che siamo licenziati?»
«Avevo sentito alla radio, mi pare, alla radio hanno detto che ci vuole il preavviso. Che ti avvisano prima.»
«Mica abbiamo rubato. Mica abbiamo ammazzato.»
«Altrimenti che posto fisso è, fisso di che cosa…?»
«Ci ha avvisato? Sì. Ci ha detto di andare a casa? E noi andiamo a casa. O c’è qualcuno che stamattina vuole fare l’eroe? Con la faccia mezza spaccata, pure.»
Nessuno risponde. Prega, Michele. Prega che davvero sia tutto un falso questa storia dell’ultima occasione, perché non è mica normale avere l’ultima occasione che non hai nemmeno diciotto anni e che si è tuffata dentro una bottiglia di vino rosso di mezza qualità. Non aveva pregato mai, nemmeno ai funerali aveva pregato, e questa tanto non è nemmeno una preghiera ma sperare di convincersi a sperare di avere frainteso. Berto ha il sole che batte sull’ematoma e sembra che si faccia ombra da solo.
Ciccio continua a chiedere se davvero sono licenziati ma intanto, senza pensarci, ha cominciato a contare gli spicci nei pantaloni consumati sulle ginocchia.
Non si dicono nemmeno un “ciao” e si dividono innaturali, come se non fossero i tre che si sono difesi dalle stesse botte la sera prima.
La carriera più veloce della storia, pensa Michele. E gli verrebbe da ridere, se non fosse per il solito angolo della bocca. Davanti al portone coglie la differenza tra galleggiare e camminare. Ma dura un attimo: la signora salsa sta già chiedendo come mai è tornato a casa così presto.




 La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta.
La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta.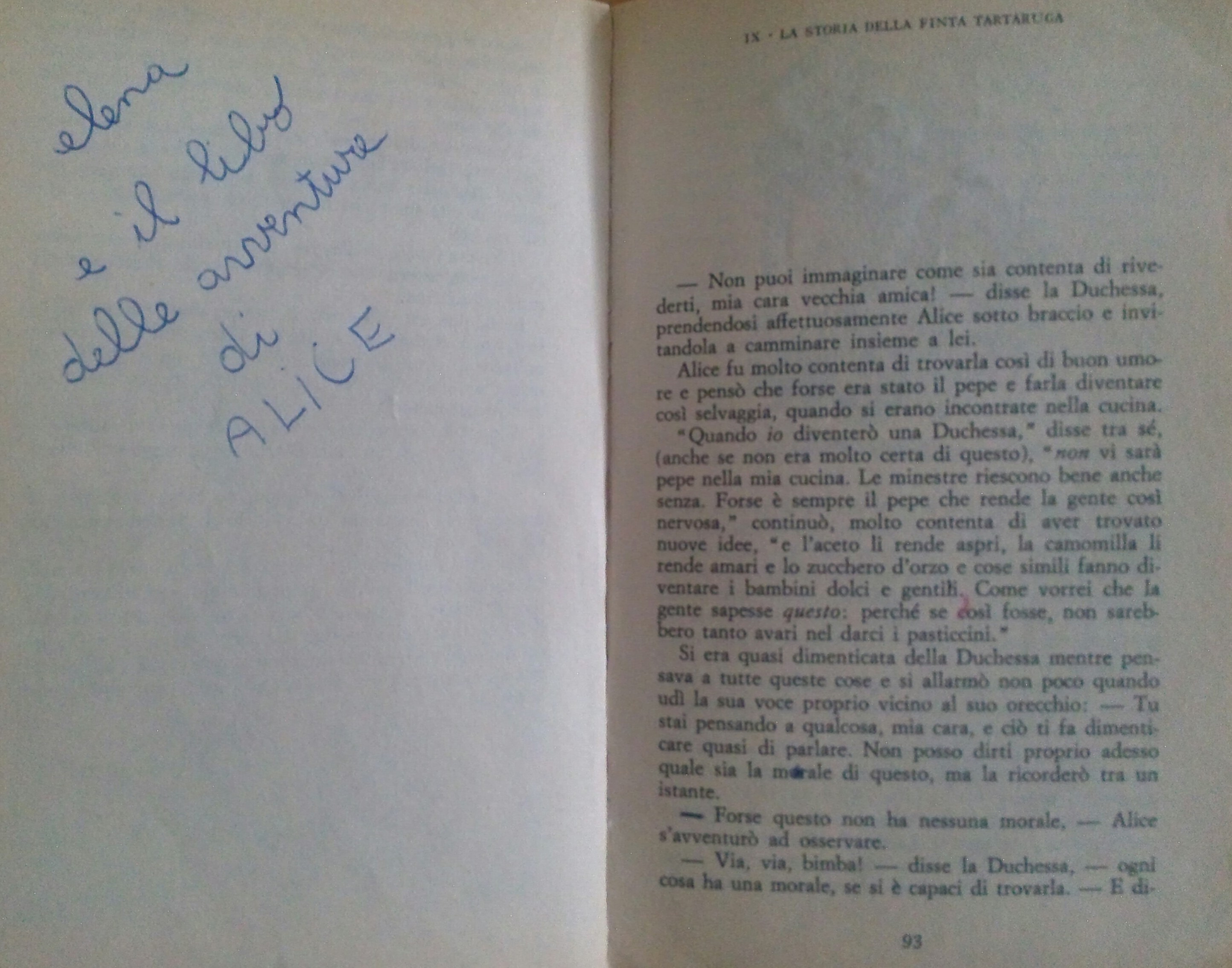 Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più.
Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più.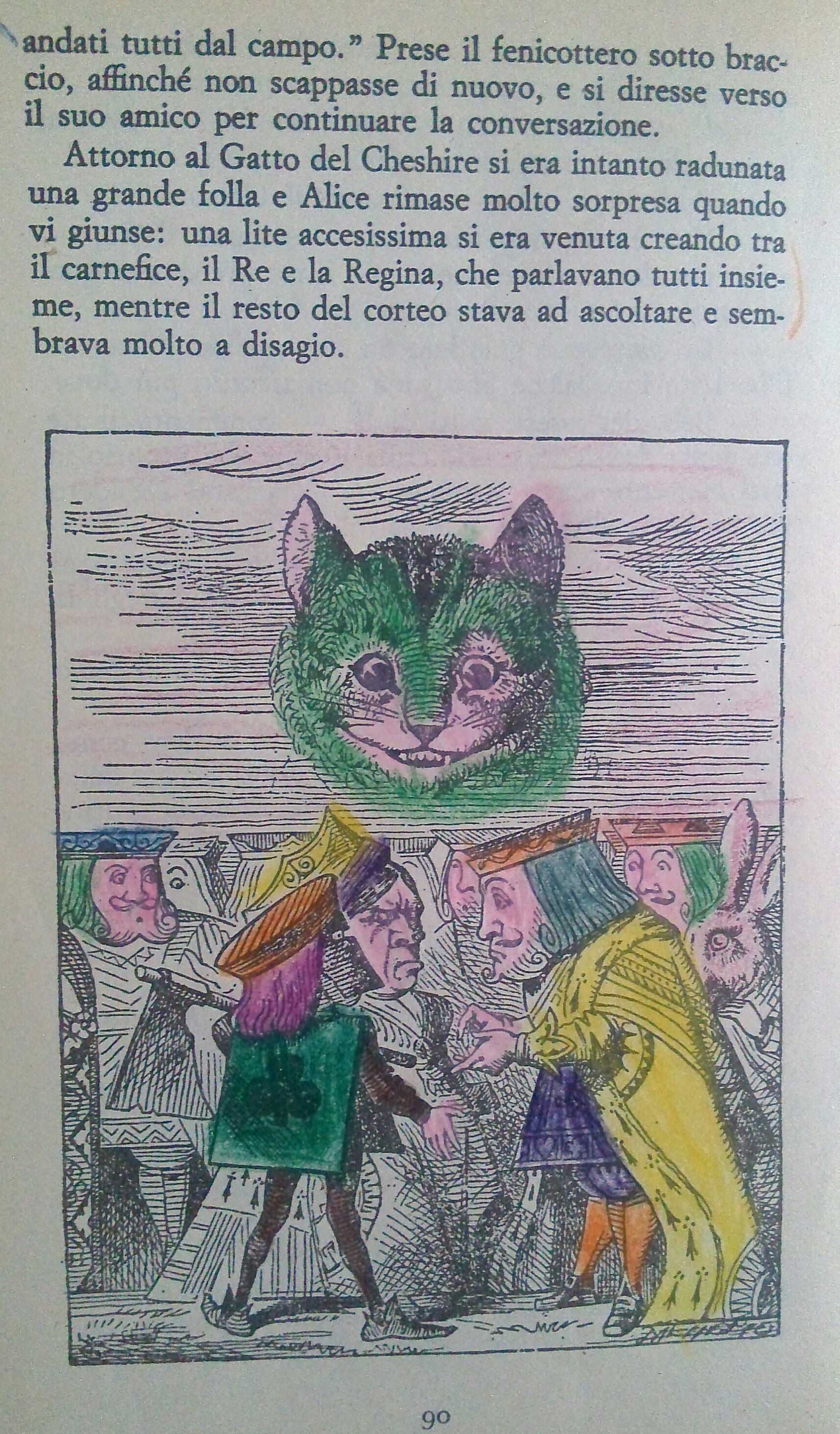 sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).
sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).
 N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso
N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso  N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?
N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?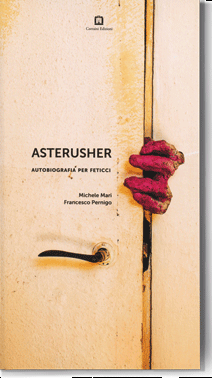

 Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».
Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».



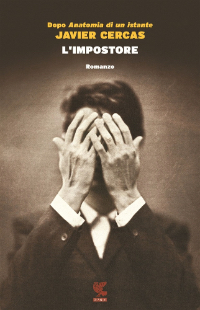
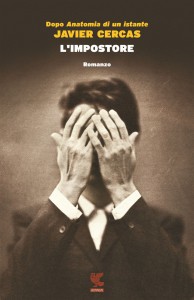 Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.
Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.

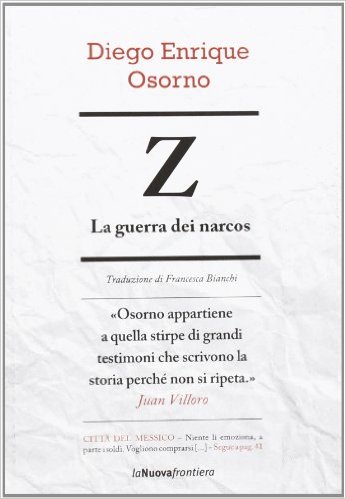




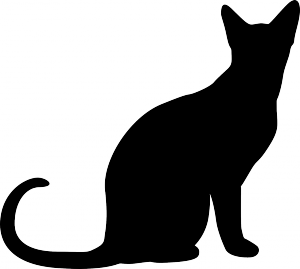 – Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.
– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.