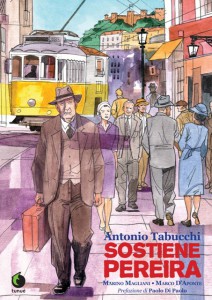Francesco Permunian, La Casa del Sollievo Mentale, Nutrimenti, 2011; La maison du soulagement mental, traduit de l’italien par Lise Chapuis, Éditions de l’Arbre Vengeur, 2015.
“Peut-être est-ce le vent descendu impétueusement des Alpes – il brouille les herbes des prairies et les humeurs féminines – qui remue le sang et l’esprit de certaines femmes du lac de Garde. Lorsque tante Arpalice, par exemple, fut frappée de cette maudite apoplexie qui la cloua sur un fauteuil roulant, elle sembla tout à coup avoir été heurtée de plein fouet par le vent tourbillonnant et sournois de la folie. Privée désormais de retenue et de pudeur, elle commença par alterner des moments de prière avec d’interminables parlottes truffées de phrases à double sens. Après quoi, la situation s’aggravant, elle se mit à jurer comme un charretier du matin au soir, à la maison et au dehors, et finit par perturber les enfants du quartier avec ses expressions obscènes et ordurières”.
(Forse è il vento di primavera che scende impetuoso dalle Alpi – e scompiglia le erbe e dei prati e gli umori femminili – a rimescolare il sangue e la mente di certe donne del lago di Garda. Quando alla zia Arpalice, per esempio, capitò quel maledetto colpo apoplettico che la ridusse su una sedia a rotelle, tutto ad un tratto sembrò essere stata investita dal vento turbinoso e maligno della follia. Senza più freni né pudore, all’inizio cominciò ad alternare momenti di preghiera a interminabili sproloqui infarciti di frasi a doppio senso. Dopo di che, peggiorata la situazione, prese a sacramentare come un turco dalla mattina alla sera, in casa e fuori casa, finendo col turbare i bambini del quartiere con espressioni oscene e scurrili)
Così le prime parole di La maison du soulagement mental, uscito a gennaio in Francia nella traduzione di Lise Chapuis, storica traduttrice di autori italiani del calibro di Antonio Tabucchi. Grazie al cielo continuiamo ad esportare cultura a livelli di piccola editoria. Il che significa esportare non solo best seller di largo consumo ma anche Letteratura con la elle maiuscola. E per di più, in questo caso, verso una nazione che è restia a concedere spazio a tutto ciò che non sia prodotto nazionale. Non per nulla Permunian, come ho scritto nel luglio scorso, qui, è autore così singolare da fare della sua scrittura un genere letterario.
Ho letto dunque La Casa del Sollievo Mentale (2011) dopo aver letto Il gabinetto del dottor Kafka (2013). L’ho letto quasi d’un fiato, come se l’esercizio effettuato su quest’ultimo avesse rodato il mio motore di lettore di Permunian. E allora mi sono chiesto: qual è il segreto della sua scrittura? Voglio dire, come è costruita questa macchina complessa di personaggi grotteschi, di continue discese tra gli inferi, di alternanza di voci narranti, e di follie, certo, follie che in un modo o nell’altro contaminano tutti, protagonista compreso? (Discese tra gli inferi, ho detto bene, perché La Casa del Sollievo Mentale è una vera e propria cantica dantesca con tanto di rinvenimento della personificazione del male – alias Lucifero – nel gran finale con coda)
È stato così che ho deciso di smontarla, questa macchina letteraria. A cominciare dalla dichiarazione di responsabilità all’inizio del testo: “Tutti i personaggi del libro sono stati inventati dall’autore e vivono unicamente nei suoi sogni. Nei suoi incubi”. L’ho comparata con quella anteposta a Il gabinetto del dottor Kafka, dove le stesse parole giocano su sfumature diverse: “Tutti i personaggi del libro esistono o sono esistiti realmente. Anche quelli inventati dall’autore”. Dunque La Casa del Sollievo Mentale è popolata di fantasmi dei sogni di Permunian, Il gabinetto del dottor Kafka di personaggi esistiti realmente o di fantasmi divenuti reali. Ho preso allora i fantasmi della Casa e li ho messi da parte. In quanto fantasmi letterari, il solo elencarli ne fa già una narrazione nella narrazione, come a dire che ognuno di loro porta nel romanzo la sua propria storia che va ad incastrarsi in una macrostoria più generale. Eccoli qui, più o meno in ordine di apparizione:
Ludovico Toppi, bibliotecario folle (alter ego di Permunian); zia Arpalice, trasformata in ninfomane da una sorta di improvvisa demenza senile; Camillo Gruber, spietato nazista in incognito; il barone Alfonso Maria Manotazo, per gli amici don Alfonso o addirittura Alfonsino; il padre di lui, Ottone Manotazo, con la sua splendida ed esilarante rassegna di ritratti che adattano l’espressione a seconda dei reparti del manicomio in cui sono collocati; Madame Pompadour, ex “bomba sessuale” che con l’avanzare della vecchiaia si è convertita a esempio (esteriore) di devozione religiosa; Guido Ceronetti, proprio lui, il poeta “dall’impareggiabile volto clownesco”; lo psichiatra psicopatico Diomede Korea, che scrive un libro sulla seduzione dal titolo “Immobili come gechi” ovvero “Brevi raccomandazioni pratiche per corteggiare una dama nelle sale cinematografiche durante il periodo invernale”; don Tibaldo, cappellano del manicomio; il fidanzato dell’impazzita zia Arpalice, incendiario irriducibile; donna Maria Reginalda Manotazo, presidentessa delle Dame di San Vincenzo pronta a prostituirsi per la causa; Amalia Barroso, cognata di don Alfonso, ex ballerina ormai ridotta a rottame umano per abuso di alcol; le signorine Eburnea e Leocadia, Real Doll ovvero bambole a grandezza naturale che si muovono come automi intelligenti negli ambienti del romanzo; il signor Armando o Armandino, necroforo necrofilo e sfruttatore delle due bambole; il vicino di casa Osvaldo, prostatico impotente e assassino per corna, rinchiuso anche lui nella Casa del Sollievo Mentale; il vecchio e monomaniaco falegname Girolamo Toppi e moglie, genitori del protagonista, dediti all’agioterapia; Ninetta e Cristoforo, ambigui custodi dell’Albergo del Mutilato.
Nella mia opera di demolizione della macchina permuniana ho stilato altri elenchi. Quello delle voci narranti: Ludovico Toppi, in prima persona sino al cap. XXI; Camillo Gruber, in prima persona dal cap. XXII alla fine, con eccezione delle chiusure dei capitoli XXIV, XXV e l’intero capitolo XXVI, tutti in terza persona. Poi l’elenco delle ambientazioni: l’Imperial-Regia Casa del Sollievo Mentale, con annessa l’inquietante Villa dei Bambini (“Mi piacerebbe farne un museo dell’infanzia. Dell’infanzia perduta del Novecento” – dice il Korea in una drammatica anticipazione del finale); la casa del bibliotecario, con annessa scena del crimine dove il signor Osvaldo scatena la sua pazzia pluriomicida; l’Albergo del Mutilato, che si rivela un doppio della Casa del Sollievo Mentale.
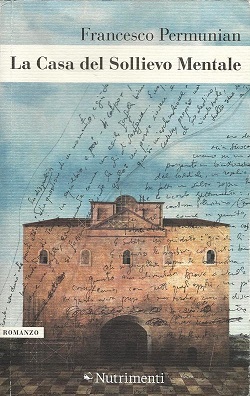 Poi c’è l’elenco delle epigrafi in testa ai capitoli: dalla dedica a Benedetta Centovalli “che crede ancora nella letteratura”, ai brani tratti dall’introduzione di un libro di Bruno Schulz o da un saggio su Fogazzaro, a citazioni di Terenzio, Cioran, Prezzolini, Giovanni Macchia, György Konrad, sino alla lettera di Kokoschka alla signorina Moos con cui si apre il libro e della quale si scopre il senso solo a pagina 110: “Ultimamente mi sto appassionando alle lettere di Oscar Kokoschka indirizzate a Hermine Moos, un’artigiana di Stoccarda da lui incaricata di costruirgli una bambola di stoffa che fosse la copia esatta di Ala Mahler, da cui il pittore era stato piantato in asso. E al cui abbandono non si rassegnava”.
Poi c’è l’elenco delle epigrafi in testa ai capitoli: dalla dedica a Benedetta Centovalli “che crede ancora nella letteratura”, ai brani tratti dall’introduzione di un libro di Bruno Schulz o da un saggio su Fogazzaro, a citazioni di Terenzio, Cioran, Prezzolini, Giovanni Macchia, György Konrad, sino alla lettera di Kokoschka alla signorina Moos con cui si apre il libro e della quale si scopre il senso solo a pagina 110: “Ultimamente mi sto appassionando alle lettere di Oscar Kokoschka indirizzate a Hermine Moos, un’artigiana di Stoccarda da lui incaricata di costruirgli una bambola di stoffa che fosse la copia esatta di Ala Mahler, da cui il pittore era stato piantato in asso. E al cui abbandono non si rassegnava”.
Altro elenco, quello degli oggetti: qui ne cito solo due, la sega elettrica a cui paròn Toppi dedica l’ossessiva manutenzione serale, e lo straordinario bastone di Antonin Artaud – vero o falso che sia – che il barone Alfonso Maria Manotazo trasforma in una “Colonna Traiana da passeggio” incidendovi un fregio a spirale di caratteri alfabetici con “la sintesi del pensiero ateo di tutto l’Occidente”.
Tolti tutti questi ingranaggi – personaggi, ambienti, oggetti, – cosa rimane della Casa del Sollievo Mentale? La potenza della scrittura di Permunian. Una lingua pulita e tagliente, ruvida e colta, quasi dantesca: intendo di quel Dante che passa con disinvoltura dalle più bieche parole attinte dal volgare ai termini colti delle citazioni latine ed ebraiche. Allo stesso modo Permunian non si scandalizza a spaziare dal doppio senso sarcastico del “gioco dell’usignolo” all’umorismo puro e raffinato di don Alfonso: “È un mio sacrosanto diritto di ateo, perdio!”, sino alla spassosa scenetta del festival di Mantova con cui Guido Ceronetti vuole farsi sostituire da una controfigura letteraria: “Ma ci vada lei al posto mio, caro don Alfonso, ci vada lei a incontrare il pubblico che mi aspetta! Tanto nessuno se ne accorgerà, glielo garantisco. Ci parli lei, per favore, a quella massa di imbecilli ammucchiati là sotto, uomini e donne che leggono con occhi di ciechi e hanno l’impudenza di ritenersi miei lettori! Analfabeti che corrono su e giù per l’Italia da un festival all’altro, tirando per la giacca ogni scrittore che incontrano… Idioti con la testa rintronata per i libri mai letti e convinti che il festival di Mantova sia un reality televisivo. Per queste ragioni, gentile amico, io le conferisco seduta stante la carica di mio sosia letterario con funzioni di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e le rinnovo l’invito ad affrontare quei coglioni che poco fa l’hanno scambiata per il sottoscritto”. E via così sino all’opposto di questa verve, ossia gli stati di depressa ma poetica malinconia: “Umiliato dagli anni e dalla solitudine, sto invecchiando come un imbecille che non sa rassegnarsi al fallimento della sua vita e solo adesso, nell’ora del crepuscolo, mi accorgo di essere ricoperto della polvere dei sogni”. Oppure la scrittura rabbiosa di quando sputa veleno sugli psichiatri, “medici idioti che s’illudono di guarire la follia a suon di farmaci”.
Scrittura potente, dicevo, che sfoggia tutta la sua forza espressiva quando i temi si fanno crudeli, quando i fantasmi non sono più – o meglio, non sono solamente – fantasmi del suo mondo interiore ma rispecchiano il mondo al di fuori, la parte violenta e drammatica della vita. E allora Permunian passa dalla descrizione spietata dell’alienazione mentale a quella evocativa e più terribile del male, di quell’umanità che fa del male con la consapevolezza di farlo e con l’assurda ignoranza di non comprenderne la gravità. Male che si concretizza nell’infierire sui deboli, soprattutto bambini, nel negare loro la facoltà di vivere una vita, come appunto è successo nei campi di concentramento. Il male è lui, Camillo Gruber. Ex nazista che come tanti gerarchi responsabili dei genocidi si è riciclato nel nuovo mondo. Plastica facciale, una cattedra a livello universitario e la possibilità di continuare, anche se non con la stessa libertà, gli esperimenti più atroci. Sì, perché Gruber ha appunto a che fare con l’inquietante Villa dei Bambini, con le stragi di Treblinka, di Terezín, di Auschwitz. In un continuo evocare i bimbi uccisi, vero e proprio esercito ai suoi comandi, il vecchio Gruber è in realtà un evocatore di fantasmi. Sembra quasi non si renda conto dell’orrore compiuto (anche se usa espressioni come: “Ancora oggi mi dolgono i polsi, tanti ne ho strozzati”), e in questo sta la sua malvagità più raccapricciante. Esalta il massacro e la pedofilia, le camere a gas e quelle ad acido cianidrico, la sua “macchina prediletta”, il tutto in una visione deformata della realtà che confonde esseri esistiti con fantasmi inventati.
Follia criminale da un lato, follia creativa dall’altro. In fondo anche la letteratura è follia, una follia benefica. “La scrittura è illusione”, dice Permunian, “una ridicola farsa”. Ma è grazie ad essa, alla possibilità di creare mondi paralleli a quello reale, che lo scrittore si salva. Scrive Permunian: “Senza la mia dolce e lucida follia, sarei già morto da un pezzo”.

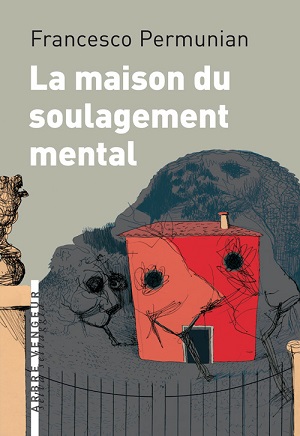



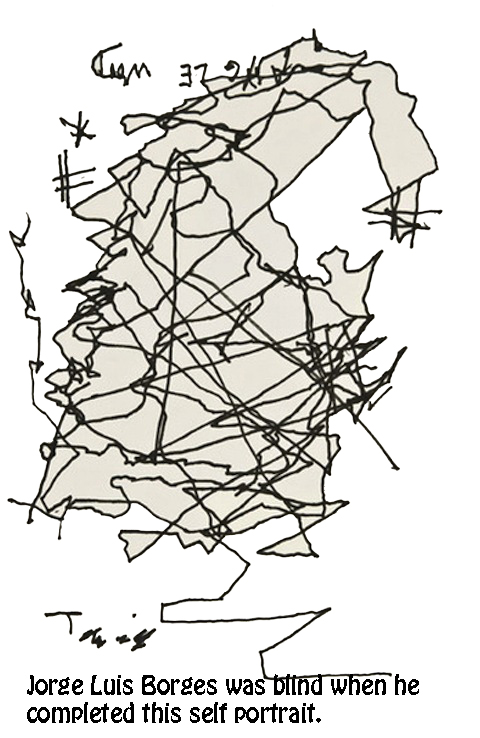

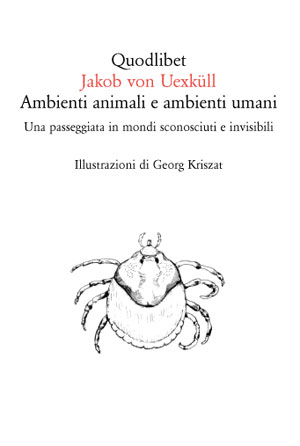


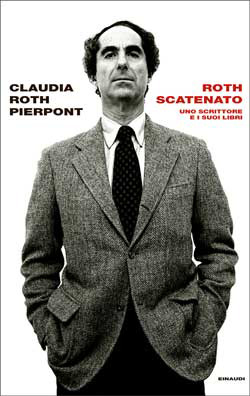
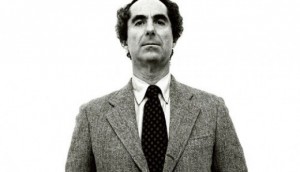 di Giovanni Dozzini
di Giovanni Dozzini