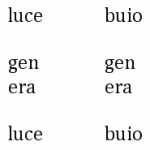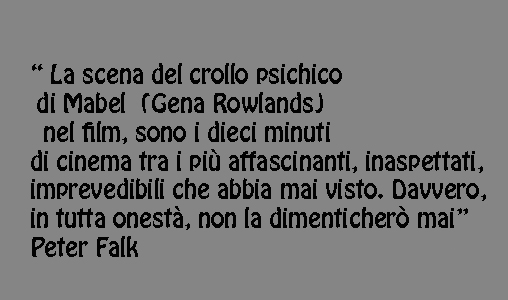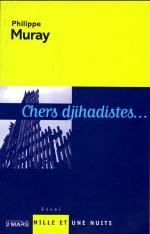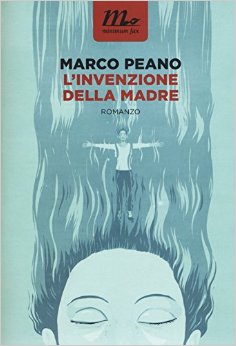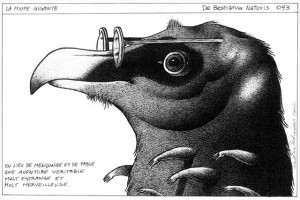[Riproponiamo oggi uno speciale apparso su alfabeta2 a un mese dagli eccidi di Parigi. Abbiamo raccolto alcune voci e privilegiato alcuni aspetti, convinti non solo che non sia facile dare una lettura univoca di quegli eventi, ma che non sia neppure necessario. In Francia, intanto, analisi e discussioni continuano, e non solo su legislazioni antiterrorismo e sul potenziale nemico interno, ma anche sulla segregazione sociale e razziale che mina la “République” ben più in profondità degli occasionali massacri realizzati da un piccola minoranza di adepti dell’idiozia e del fascismo di marca religiosa. Articoli di Badiou, Inglese, Donaggio, Buffoni, Rakha, Gallo Lassere. a. i.]
Luce, di Robert Lax
tradotto da Andrea Raos
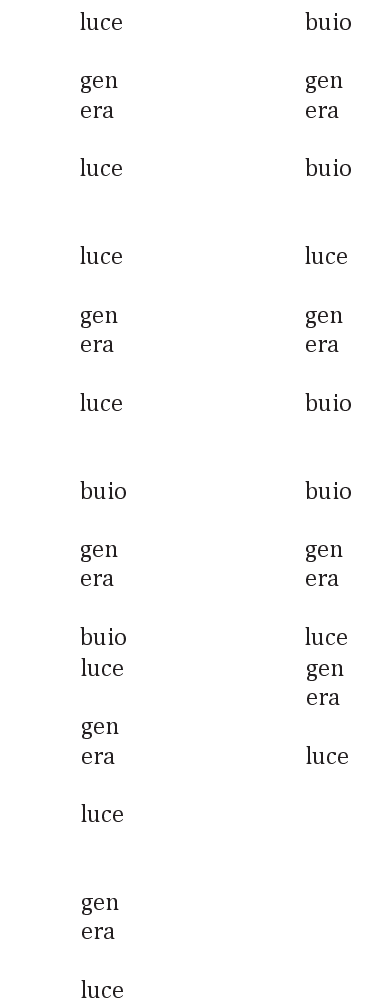
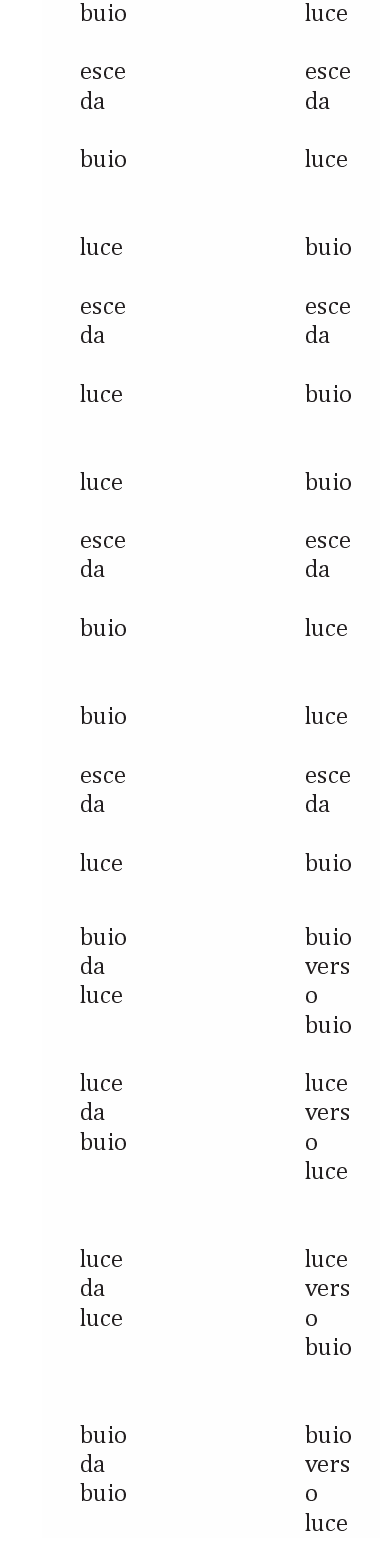
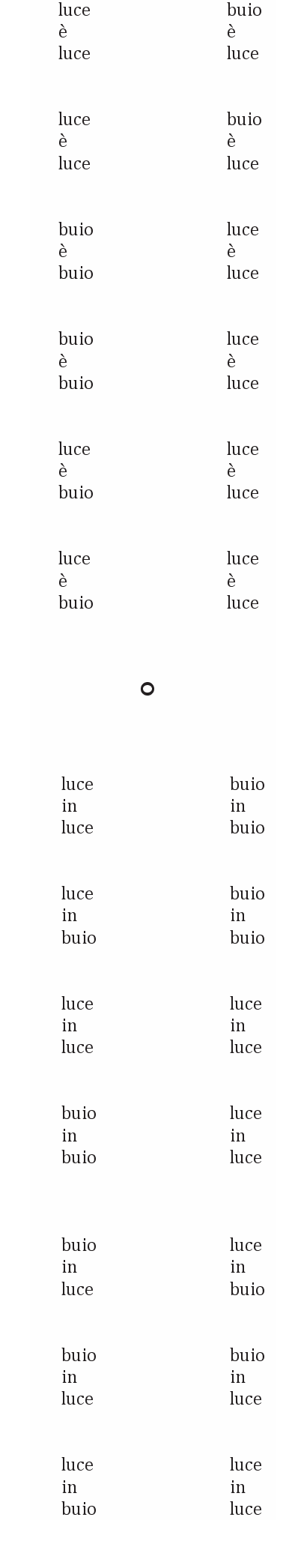




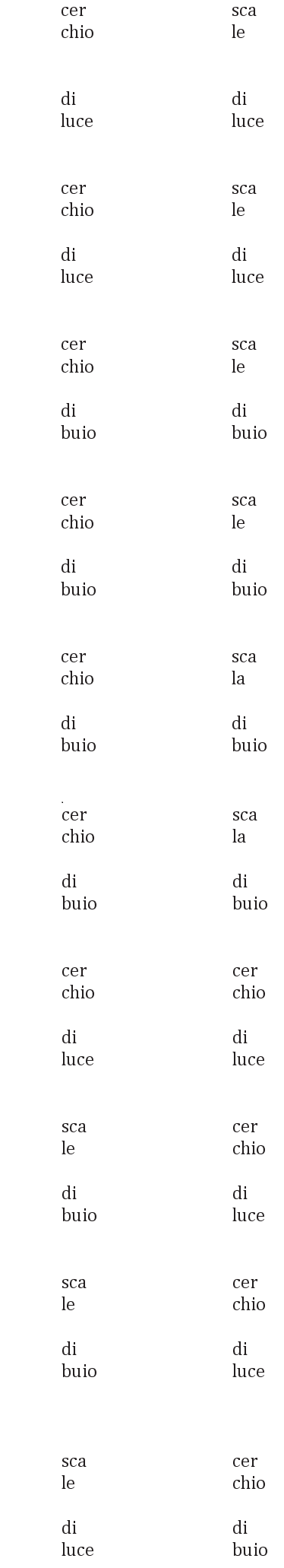
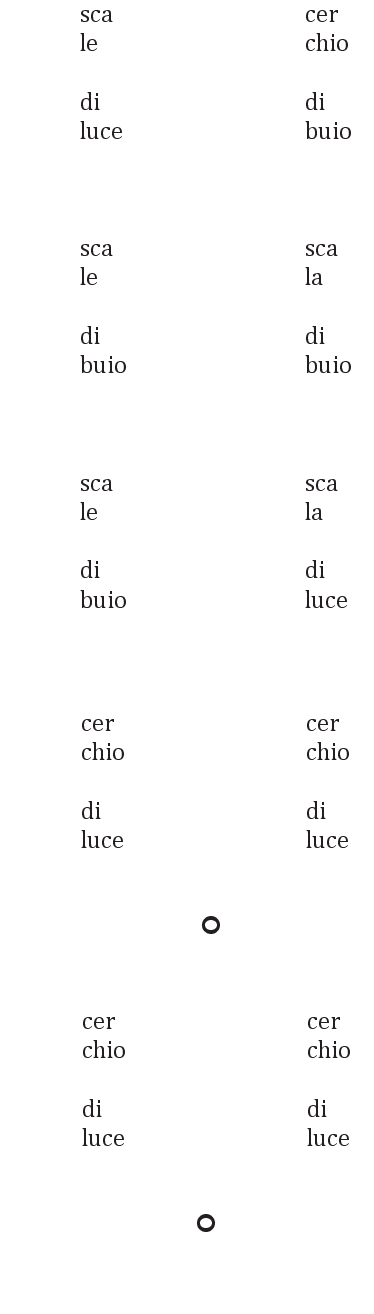
Tratto da Robert Lax, Poems (1962 – 1997), a cura di John Beer, Wave Books, 2013, p. 102 – 122. Grazie a Renata Morresi per un paio di migliorie e a Orsola Puecher per l’impaginazione.
cinéDIMANCHE #14 JOHN CASSAVETES “Una moglie” [1974]
 Intervista di Yves Bourde (Le Monde) a John Cassavetes pubblicata in Hommage à Cassavetes a cura di Orly Films
Intervista di Yves Bourde (Le Monde) a John Cassavetes pubblicata in Hommage à Cassavetes a cura di Orly Films
traduzione di Francesco Forlani
#
A Woman Under the Influence. Una donna “sotto influenza”… di che influenza si tratta?
Di una forza … L’influenza del suo entourage, della società, del marito, della sua famiglia, della maternità. Una donna lacerata tra diversi poteri, tra diversi ruoli.
Dopo Husbands, Mariti, Minnie e Moskowitz, l’amante, ecco la donna. Quale donna?
Ho scritto questa sceneggiatura per mia moglie, Gena Rowlands, splendida attrice però non si tratta di un’autobiografia. Questo lavoro nasce forse dalla disperazione, dall’interrogarsi sul senso della nostra vita? Ho messo da parte l’allegria, l’umorismo, il ridicolo, e mi sono immerso in qualcosa di serio, in questo desiderio di dire, dire qualcosa per Gena, per la mia stessa famiglia. Gli uomini non sono abbastanza sensibili, riconoscono le difficoltà delle donne, non le conoscono. La scrittura del soggetto è nata in solitudine, anche qualcosa di più della solitudine: in uno stato d’innamoramento. Man mano che procedevo nell’elaborazione e poi durante le riprese, ho preso coscienza di problemi che mi erano sconosciuti, per non dire estranei. Infine, quando ho visto il film terminato, sono rimasto scioccato dalla realtà.
Film-psicodramma, Psicoterapia ?
No. È la vita che è uno psicodramma. Il film tratta di ciò che ci è peculiare, le ossessioni generali tra uomini e donne. C’è un problema legato all’amore. Una donna come Mabel, il personaggio protagonista, si è forse detta prima del suo matrimonio: “Io non voglio sposare quest’uomo,” eppure lo ha fatto. Questa coppia è diversa dalle altre in quanto è così coinvolta da non potere divorziare. La domanda allora è: “L’amore è possibile, in particolari circostanze, può resistere quando la famiglia si divide? »
Si dividerà?
Non lo credo. Il legame è la conoscenza di tale legame. È fuori di discussione. L’uomo deve prima escludere la sua famiglia per cominciare a spezzare questa influenza e lasciare alla moglie il tempo di esprimersi, di essere degna, di essere sé stessa. Alla domanda “Mi ami? ” lui non può rispondere, si rifiuta di mettere un’etichetta a un sentimento che va ben oltre l’interrogativo. Tutto rimane aperto. Il nodo non è nella passione della sessualità, l’uomo e la donna se ne accomodano. È che lui ama ciò che la rende diversa, l’anima originale, ma crede di essere l’unico a capirla. Ecco allora che non riesce a superare il proprio disagio nelle situazioni in cui si ritrovano di fronte a molte persone. Peter Falk pensava del marito, del suo personaggio, che l’amore fosse un ostacolo alla sua comprensione di lei.
Come ha diretto i suoi interpreti?
In primo luogo, per me non si tratta di attori, ma di persone, esseri viventi. I registi sono piccoli dittatori e la stampa dà loro troppa importanza, a me compreso. È l’intensità delle emozioni che conta. I ruoli sono interpretati da persone che amo, mia moglie, sua madre, mia madre, altri Cassavetes, amici, ed è impossibile controllare le emozioni di coloro che amate, però più li conoscete, più si può far passare quello che sentono.
Io non li dirigo in ogni dettaglio e non si correggono mentre recitano. Non cercano di dare al pubblico un‘immagine simpatica di sé stessi. La cosa rara è che si rivelano come persone. Questo fa parte della mia mentalità. Dobbiamo allenare noi stessi a rimanere sensibili, sono le emozioni a farci vivere. Amo questo film perché non vi è alcun punto di vista. Non ce ne possono essere. La storia e i personaggi sono molto reali per me. Se pur la visione di queste fratture è compiacente, questa cosa esiste: alla prima occasione, ci allontaniamo di corsa dall’amore.
 Quanta parte lascia all’improvvisazione durante le riprese?
Quanta parte lascia all’improvvisazione durante le riprese?
Praticamente nessuna. Il film si compone di diversi scritti sparsi e messi insieme e tutti i dialoghi sono stati rispettati alla lettera. In compenso, la libertà che hanno gli interpreti di esprimersi fisicamente ripugna a tanti. Pensano che il loro comportamento vada troppo lontano. Mi ricordo di un nuovo assistente operatore sul set di ripresa, talmente sorpreso dalla violenza di una scena che gli è caduta di mano la telecamera. In effetti, quando si lavora su un terreno così fragile e pericoloso, l’intensità, l’atmosfera così tesa possono impressionare. In realtà la cosa importante è la paura che hanno le persone di esprimersi e voglio che nessuno si senta in colpa per avere qualcosa da comunicare. È la libertà di esprimere la propria profondità ad essere rivoluzionaria.
Dalle memorie di un insonne/5
di Giorgio Mascitelli
Un amico, un sedicente amico, mi ha propinato delle strane bustine color fucsia che mi dovrebbero far dormire come un angioletto, visto che i metodi naturali hanno fallito al pari di quelli sociali. Ma per me qui c’è puzza di bruciato, non mi convince la sua affabilità, la sua gentilezza un po’ melensa. Qui c’è puzza di Big Pharma. Essi si insinuano nei meandri dei loro oppositori e dei loro detrattori proponendo tramite falsi amici dei prodotti che creano dipendenza. Essi vanno davanti alle scuole a distribuire certe deliziose caramelline ai bimbi contenenti un principio attivo che crea dipendenza. Essi prendono certe medicine prodotte per certe malattie e, senza averne le prove, dicono che servono anche per curare altre malattie per creare dipendenza. Lui mi ha garantito che le bustine erano dei generici. Ma io non mi fido e certo non diventerò uno zombi di Big Pharma.
Le bustine a ogni modo giacciono sul ripiano dell’armadietto in bagno, anche se non le prenderò mai.
Poi bisogna stare attenti ai falsi amici, dal momento che qui siamo tutti amici e fratelli che si danno del tu, che non è nient’altro che l’abbreviazione di tutum, il rumore della zanzata che ti arriva nei denti, non appena voltato l’angolo. Basta un attimo e i cosiddetti amici ti fanno fare la fine di Compare Salsiccia. Mi risulta che ci siano dei ministri degli esteri di vari paesi che chiamavano per nome i primi ministri di altri paesi, che pochi mesi dopo sarebbero stati bombardati per ordine di quegli stessi ministri degli esteri. Almeno una volta, quando c’erano ancora i conoscenti, uno stava sul chivalà. Adesso con tutte queste interfacce amichevoli, con questo continuo darsi un cinque, con questi bacini e bacetti, con gli emoticon d’amicizia e affetto, con pacche e scappellotti siamo in pericolo. Occorreva che il galateo degli hippy e dei fricchettoni vincesse affinché continuasse a comandare il soldo. E Big Pharma.
Qualcuno potrebbe anche dire che sono un sognatore o meglio un illuso ( perché per sognare dovrei dormire), ma preferisco un mondo in cui perfino i fidanzati si danno del lei, almeno fino alla prima volta in cui copulano assieme, e ci sia la sanità gratuita per tutti, che un mondo in cui tutti fanno gli amiconi e Big Pharma riempie i giornali di annunci che tra pochi anni saremo immortali o comunque giovani fino a cento anni. Qualcuno potrà dire che sono un illuso, ma così dandosi del lei nel mondo ci sarebbe molta più armonia.
Forse sono davvero un illuso e dovrei semplicemente andare in bagno, aprire l’armadietto e prendere una di quelle bustine. Questo sarebbe una forma di sano pragmatismo: basta con i pensieri, le ansie, le angosce, finalmente dormire. Se, però, un pragmatismo riesce a esprimere tutta la sua sanità solo attraverso l’assunzione di medicinali che probabilmente hanno qualche effetto collaterale a seguito di un uso abituale e danno dipendenza c’è nelle cose oggettivamente come un’amara ironia, che ai tempi di mia nonna non si coglieva e che non dipende da nessuno stato d’animo soggettivo. Alla fine, la percezione di questa ironia è l’unico baluardo che mi trattiene dal mandar giù una bustina.
Contravvenendo a una prassi consolidata, questa notte ho posto una sveglia, anche se non carica, sul comodino e dunque vedo che sono già le due. Immagino allora la mia calotta cranica che balugina nell’oscurità ( m’immagino sempre più cose del necessario). Magari aveva ragione la nonna di un tempo, non la mia, non una in particolare, ma la nonna per antonomasia, che la causa dell’insonnia nasce dal fatto di non sapere che fare durante il giorno. Gli onesti lavoratori dormono profondamente, essa pensava, un sonno senza interruzioni perché se lo sono guadagnato con il sudore della fronte. Ora a me non sembra di battere la fiacca, anche perché ho paura che non mi rinnovino il contratto, eppure non prendo sonno. Non sono un lazzarone, non sono un perdigiorno che va a zonzo, non sono uno zuzzerellone, non sono un turista della vita, però anch’io in un certo senso non so che fare durante il giorno perché quest’idea che si lavori duramente per ottenere il diritto al sonno grazie al quale ci si rifocilla per poter sostenere un’altra giornata di lavoro non mi sembra una strada percorribile. O meglio ci vedo l’ironia della cosa. A me l’ironia m’ha rovinato: invece di rigirarmi nel letto, e sono già le tre, a quest’ora se non c’era l’ironia, ero a Londra e avevo già musicato tutto l’orario musicale, come quel tale.
Adesso magari viene fuori che, se ho l’insonnia, è colpa mia e che se fossi veramente zelante e desideroso di venirne fuori prenderei le bustine senza perdermi in tanti ragionamenti contorti. Infine mi si chiede soltanto di barattare un po’ d’ironia per la felicità o almeno la serenità; cioè in realtà nessuno mi chiede o mi ha mai chiesto nulla, ma le cose si mettono sempre in modo tale che nella realtà avverti una sorta di pressione come se tutti le chiedessero ( e le idee dominanti continuano a essere quelle delle classi dominanti). Ciononostante nella notte della mia insonnia, e vedo le cinque sul quadrante e sento qualche uccellino cantare ( è strano che succeda a Milano eppure succede), nella notte della mia insonnia in cui mi conosco nuovamente come insonne mi sembra di essere più vicino a qualcosa che grosso modo all’incirca più o meno si potrebbe chiamare la verità.
Forse anche il vitello e il maiale di un allevamento bio sono più agitati, ma più veri di quelli degli allevamenti industriali. Non lo so. So soltanto, in questa notte della mia insonnia, che finché il fisico regge è giusto che vada avanti così. All’alba non vincerò o crollerò, andrò avanti così senza bustine. Come fanno gli uomini, come hanno sempre fatto, compiendo milioni di cose e raccontandosene ancor di più finché il fisico regge.
(5,fine)
Francesca Borri, La guerra dentro
di Mario Sechi

Foto: Goran Tomasevic
Diciamo giornalisti free lance, o giornalisti embedded, e ci interroghiamo magari sulla nuovissima specie dei citizen journalists, e proviamo a farci un’idea di come si sia evoluta nel caos delle guerre asimmetriche la figura del reporter. Mi riferisco soprattutto al fronte arabo, in quella enorme mezza luna tra terra e mare che parte dal Mali e arriva all’Afghanistan, con le note propaggini caucasiche. Guerre su guerre, da molti decenni ormai, guerre civili interne a ciascun paese, oppure più spesso guerre esogene, scatenate dalle grandi potenze occidentali contro nemici dichiarati unilateralmente tali, contro minacce o pericoli talora inventati di distruzione totale, contro fantasmi sfuggenti di nuovi soggetti, che sono di certo reali ma paiono entità. Guerre di qualcuno contro qualcun altro, e alleanze di volenterosi, coperte all’ultimo dall’ombrello dell’ONU o della NATO, in accordo o con la tacita connivenza della comunità internazionale.
Ciò che è cambiato rispetto all’epoca eroica di Remarque e di Hemingway, per fare solo due nomi, non sta tanto nella sovrapposizione e nella confusione del conflitto fra eserciti e fra combattenti irregolari, che finisce per polverizzare l’idea stessa di una linea del fronte, dove il giornalista dovrebbe stare per presidiarla e misurarla, quanto nella perdita di credibilità dei tradizionali schemi di interpretazione e di gestione dei conflitti, fondati sui più collaudati modelli di strategia militare e di geo-politica. Il caso della Siria oggi è il caso in cui più clamorosamente si evidenzia una vera e propria impotenza delle organizzazioni e degli osservatori internazionali, sia sul piano dell’analisi delle situazioni sul campo, sia e tanto più nella costruzione di percorsi di pacificazione e di equilibri possibili per il futuro.
Come in un avvitamento continuo di fattori imprevisti, nei tre anni trascorsi dalle prime rivolte di piazza contro il regime dittatoriale di Assad si sono innescate reazioni a catena di movimenti e di eventi, che hanno fatto emergere sempre nuovi attori, confusi nel perseguimento di obiettivi spesso non chiari, e tra di loro in aperto conflitto: dalla Coalizione Nazionale, che è il rassemblement dei gruppi politici siriani operanti all’estero, all’Esercito Libero dei ribelli della “primavera”, occupanti alcune regioni centrali del paese e impegnati nella interminabile battaglia di Aleppo, agli islamisti di al-Qaeda radicati nelle moschee e contigui ai ribelli nelle stesse strade e quartieri, ma con ben altri piani politico-militari, alle potenze regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita) e ai paesi limitrofi (Iraq, Libano, Israele, Palestina), gli uni e le altre intrecciati fra loro in un’inestricabile ragnatela di interessi e di alleanze: e si pensi a Hezbollah o ad Hamas, soggetti politico-militari di importanza non primaria, e tuttavia decisivi nell’interdire e nel bloccare vie d’uscita dallo stallo di una situazione incancrenita, destinata forse a un’irreversibile implosione.
Ma a un livello persino più profondo la non fungibilità dei vecchi schemi è dichiarata dalla diffusa strumentalizzazione delle appartenenze religiose, nel contesto di un Islam che appare ormai deflagrato, scosso da vecchie e nuove eresie e fanatismi di origine oscura, per non dire sospetta. Assad appartiene al campo sciita ma nella sua variante alawita, è legato alla tradizione del Bahatismo laico (la stessa che fu di Nasser e di Mubarak in Egitto), e non molto ha a che fare sul piano culturale e ideologico con gli sciiti iraniani, che pure sono suoi alleati. I suoi primi oppositori interni sono sunniti laicizzati di nuova generazione, ma ad essi si sono aggiunti e sovrapposti gli jihadisti, che non alla Sunna si rifanno ma al Wahhabismo fondamentalista, foraggiato dai petrodollari della penisola arabica, dove sono insediati i governi più filo-americani del pianeta. La Turchia dal canto suo – membro della NATO e aspirante UE – è uno stato laico a maggioranza sunnita, che nel corso del conflitto siriano svolge un doppio gioco politico, ufficialmente sostenendo la Coalizione nazionale e i ribelli dell’Esercito libero, ma di fatto non contrastando i transiti di mezzi e truppe irregolari che alimentano il cosiddetto Califfato e che dal territorio del Califfato sciamano intorno, fino alle destinazioni europee. E non si può trascurare, attorno a queste realtà più compatte, il reticolo delle religioni pre-islamiche che sono praticate ad esempio dagli Yazidi e dagli Zoroastriani, schiacciati insieme ad ebrei e cristiani e sottoposti ad azioni di sterminio, in una deriva di emarginazioni che non ha tregua, e che punta in primo luogo al contenimento dell’indipendentismo curdo.
Al di là delle semplificazioni brutali della realpolitik, che passano sopra la realtà delle vite umane senza alcuna vergogna, come muoversi e come orientarsi in questo ginepraio di sangue e di distruzione? Francesca Borri è testimone diretta e coinvolta di questa lunga storia sbagliata, avendo vissuto e lavorato per quasi un anno nei luoghi e tra i pericoli di quella realtà. La sua attività di reporter non è nata però da uno slancio idealistico, e neppure dal gusto della scommessa con se stessa, in un progetto auto-centrato di addestramento e di crescita professionale. La sua esperienza sul campo cominciò infatti nel teatro balcanico, nel 2007, durante la guerra del Kossovo, sotto l’egida delle organizzazioni internazionali preposte alle operazioni di peace keeping: e fu allora un’esperienza nutrita e motivata da una fresca e solida formazione accademica, in ambito di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani. E poi proseguì in Medio Oriente, dall’osservatorio di Ramallah guardando alla frontiera delle innumerevoli tregue fallite nella guerra israelo-palestinese, con la tenacia di voler riconoscere e censire, di qua e di là, i soggetti possibili e dispersi di una trama civile culturale umana, capace di risarcire ferite e di interpretare lo spirito di una intermediazione reale. Il mestiere di giornalista e di testimone Francesca lo ha imparato cioè a partire dalla fiduciosa adesione a una linea teorica e persino dottrinaria, e nella convinzione di poter contribuire a un grande piano di conoscenza e di regolazione dei rapporti di convivenza, di relazioni, di integrazione tra popoli diversi e storicamente nemici, attraverso l’analisi e la gestione delle situazioni e il riconoscimento attento e scrupoloso dei soggetti in campo.

Foto: Manu Brabo
Il suo La guerra dentro, uscito per Bompiani non molti mesi fa, e ora in corso di traduzione per le edizioni americana e norvegese, dichiara e denuncia il dolore di una delusione, che lei stessa vive come crollo di ogni riferimento ideale, giuridico, politico, logico, di fronte allo spettacolo avvolgente, non distanziabile, di quanto accade dove nulla più accade ormai, o così sembra. Aleppo, che è il suo luogo di osservazione, è un paesaggio di rovine e di sopravvivenze umiliate, di fame e di malattia, dove si aggirano gruppi di combattenti con kalashnikov e con bombe rudimentali, spesso bambini, bande di cecchini di ogni specie, mentre dalla distanza piovono missili, raffiche, piogge di fuoco, a cui si sopravvive, se si sopravvive, per caso. E’ lo spettacolo del nulla, una distruzione di cose, edifici case strade, vissuti familiari e personali, senza possibili conforti né risarcimenti, poiché lì non c’è ONU non c’é Europa non c’è Croce Rossa e neppure ci sono ONG, se non quelle finte, emanazioni del potere governativo. Ci sono morti e profughi a centinaia di migliaia forse milioni, di cui si è sospesa anche la contabilità, e c’è lo scardinamento di ogni parvenza di civiltà. Chi abbia visto di recente le foto di Kobane strappata dai combattenti curdi alle forze dell’ISIS può più facilmente farsi un’idea di questo vuoto di realtà umana che sussegue agli spari, e richiamare magari alla memoria collettiva la irreale desolazione dei paesaggi carsici, dove la grande guerra europea raccontata da Emilio Lussu inaugurò la pratica dei massacri lucidamente programmati per contendere pochi metri di territorio al nemico, in un’ottusa coazione di morte.
Ma proprio qui, di fronte a questo spazio di civiltà suicidata, l’autrice del libro, un libro che è reportage ed è diario, ma è anche e soprattutto scrittura, oltrepassa il piano giuridico-politico e persino quello degli interrogativi etici, che pure pulsa al fondo di ogni pagina. E centra con crudezza il problema della verità: la costruzione delle notizie e la elaborazione delle verità, che sono il dovere del testimone e che tuttavia sfuggono, si sbriciolano in frammenti, si avviliscono in dubbi senza fine, in situazioni dove mancano i riferimenti certi del diritto internazionale o di una politica intesa come visione e narrazione plausibile di fatti e di scenari. Perché ad Aleppo non ci sono più neppure le grandi Agenzie di stampa, che pure continuano a produrre lanci e commenti da lontano, e non ci sono giornalisti all’altezza, non molti almeno, e dal terminale di Aleppo il sistema mediatico planetario esige una varietà appetibile di scoop, che sono poi stereotipi, fissati in fotografie e video, e stringhe di titoli in caratteri cubitali: dal “medico bambino” al “bambino soldato”, alla donna italiana jiahdista (col “fidanzato talebano”?), e così via.
Nessuno più si stupisce di questo funzionamento della cosiddetta informazione, da quando almeno Baudrillard analizzò e denunciò le tecniche di de-realizzazione della realtà sperimentate durante la prima guerra del Golfo, col supporto di tecnologie di ripresa sofisticate, messe a servizio di una rappresentazione contraffatta a fini spettacolari. Francesca Borri documenta anche con nomi e cognomi, con episodi e con date, lo scialo delle notizie fabbricate secondo questo metodo di produzione e riproduzione della realtà. E attesta ogni volta il proprio sconcerto, la propria delusione, ma allo stesso tempo si interroga sul proprio mestiere, sul senso del proprio stare lì. E si trova a un certo punto a raccontare la guerra non come “guerra degli altri”, ma come una guerra che lei stessa vive dentro di sé, nello specchio infranto dei propri pensieri e delle proprie emozioni, mescolando e tenendo in equilibrio istinto di sopravvivenza, lucide analisi dei fatti e interrogativi senza risposta, che diventano appelli al lettore, ai suoi corrispondenti dispersi nei più diversi angoli di mondo, lontani e ravvicinati in una sorta di doloroso abbraccio.
In quanto libro pensato e costruito, La guerra dentro è un tentativo di narrazione, è documento, è diario, ma è allo stesso tempo letteratura. Perché Borri sa bene come la ricerca di verità, per non soggiacere del tutto ai modi di riproduzione delle verità di comodo, debba rischiare una qualche forma di racconto, montando voci e spezzoni di scritti altrui, descrivendo immagini e fotografie, e riprese video fatte con la fotocamera, e non sottraendosi a una certa esposizione della propria figura, del proprio attraversare la scena in corsa, in fuga, ma anche in ascolto, in attesa, e poi partire, andare via per un po’, fino ad Amsterdam, fino a casa in Italia. Prendere fiato, recuperare distanza, per tornare, ed è quel che lei fa. Questo sforzo di narrazione, sia pure frantumata, sia pure a flash, vuol essere da parte sua una protesta contro i tanti che – riprendendo e banalizzando nel chiacchiericcio quotidiano delle redazioni quello che fu il leit motiv del grande romanzo europeo d’avanguardia e di post-avanguardia – sostengono l’inutilità del racconto, anzi l’evaporazione, l’inesistenza di temi narrabili: “Ma che ci fai ancora lì? non c’è niente da raccontare”. Ma il dolore, come la fame, come lo sterminio, come la distruzione, esigono di non essere invano, pretendono voce e parola. Da lì, da quella linea sottile che separa e congiunge la radicalità dell’esperienza umana e il castello infinito delle parole e degli schemi mentali, cognitivi, ideologici, torna a suonare la campana, per quei tanti o anche pochi che – come lei scrive – abbiano la forza di non aver paura.
“Le cose terrene”

Giulio Einaudi editore, Torino 2014
di: Francesca Fiorletta
[articolo apparso su: “Nuova Corvina” (N.26), Rivista di Italianistica dell’Istituto Italiano di Cultura per l’Ungheria – Budapest, diretta da Gina Giannotti]
È Wolfgang Goethe, nell’ormai classico dei classici, “Le affinità elettive”, (“Die Wahlverwandtschaften”, splendido romanzo del 1809) ad usare con precisione estrema l’espressione “le cose terrene”, per identificare i piccoli passi quotidiani compiuti dagli uomini e dalle donne di tutti i tempi, nel dare seguito, attimo per attimo, alle loro passioni sentimentali.
Passioni che, per quanto possano poi rivelarsi al loro epilogo come effimeri fuochi fatui, oppure invece al contrario come progettualità di coppia specificatamente ragionate, cito ancora l’autore, “c’inducono a immaginazioni tali che non hanno nessuna rispondenza nella realtà”.
Da Via Ripetta 155 al futuro. Il nuovo romanzo di Clara Sereni

di Giacomo Verri
Stile che ammassa e punge, e che aggancia all’uno l’altro argomento come un treno in corsa, o come i fogli del ciclostile. Frasi che da un particolare quasi lì gettato, con studiata noncuranza, compongono una scena, generano un microcosmo. Quello sconnesso dell’appartamento romano di Via Ripetta 155, “in quel tratto di strada che perfino molti autisti provetti ritenevano appartenesse già a via della Scrofa”, tra pavimenti a losanghe nere e rosse (ove dormiva chiunque arrivasse, purché in possesso di un sacco a pelo) e uno scaldabagno sghembo, in cui Clara Sereni ha vissuto per dieci anni, tra il 1968 e il 1977. Non un decennio qualunque, ma il doppio lustro dell’“orda d’oro” che cambiò il volto delle generazioni, segnando lo iato più caldo che la Storia abbia conosciuto dopo i conflitti mondiali.
Inno ps. Omerico a Demetra
trad. isometra di Daniele Ventre
Bella di chiome, Demetra, dea grande, incomincio a cantare,
lei e la figlia di snelle caviglie, che Aidòneo aveva
presa con sé (gliela offrì Cupo-tuono, l’ampio-veggente
Zeus, derubando Demetra aurea-spada, ricca di frutti)
mentre con figlie sinuose d’Oceano stava giocando:
gemme coglieva per sé, rose e croco e belle viole,
su un prato morbido, e insieme le iridi con i giacinti,
e quel narciso, che Terra, piacendo a Chi-molti-riceve,
fece a un comando di Zeus, per tutti un prodigio a mirarsi,
per gli immortali, gli dèi, nonché per le genti mortali,
dolo ammirando e prezioso alla giovane occhi-gentili;
dalla radice del fiore crescevano cento corolle;
dolci fragranze esalò: tutto, in alto, il cielo spazioso,
tutta la terra gioì, e il salato flutto del mare.
E la fanciulla stupì, si tese con ambe le mani
per afferrare il bel gioco; si schiuse la terra, ampia via,
nella pianura di Nisa, ne uscì sui cavalli immortali
Chi-molti-accoglie, il glorioso di nomi, il re figlio di Crono.
Contro la sua volontà la rapì sul carro tutt’oro,
via la portò che piangeva; levò un acutissimo grido,
ella, chiamando suo padre, il Crònide, l’ottimo e sommo.
Fra gli immortali nessuno e nessuno poi fra i mortali,
il suo gridare sentì, non gli olivi ricchi di frutti,
solo la figlia di Perse, colei che ha pudichi pensieri,
Ècate chiara di veli, aveva sentito dall’antro,
e d’Iperíone il figlio stupendo, il sovrano dio Sole,
lei, la fanciulla, chiamare il Crònide padre; era assiso,
questi, in disparte dai numi, nel tempio ov’è spesso invocato,
e riceveva graziose offerte da genti mortali.
Lei, suo malgrado, per cenno di Zeus, sui cavalli immortali,
se l’era presa il glorioso di nomi, il fratello del padre,
Chi-molti-accoglie, Chi-molti-assoggetta, il figlio di Crono.
E fino a quando la terra e il cielo trapunto di stelle
scorse, la dea, e poi il mare dai gorghi violenti, pescoso,
e le faville del sole, e fu certa di rivedere
la degna madre e le schiere dei numi di stirpe immortale,
la confortò nel gran cuore speranza, ancorché nell’angoscia;
quando discese sotterra, levò un acutissimo grido,
e riecheggiarono i picchi dei monti e gli abissi del mare
della sua voce immortale e la udì la nobile madre.
Aspro dolore le invase il cuore ed intorno alle chiome
gli incorruttibili veli strappò con le stesse sue mani,
e si coperse ambedue le spalle d’un funebre manto,
peregrinò sulla zolla e sull’onda, simile a uccello,
alla ricerca; e però a farle verace racconto
no, non si spinse nessuno fra i numi e le genti mortali,
e fra gli uccelli nessun messaggio verace a lei venne.
Per nove giorni, reggendo accese le fiaccole in pugno,
da quel momento, Deò sovrana percorse la terra,
non una volta d’ambrosia e nettare dolce da bere,
si satollò, nell’affanno, né immerse in lavacri le membra.
Come fu giunta per lei la decima nitida Aurora,
Ècate incontro le venne, reggendo una torcia nel pugno,
a ragguagliarla le disse parola e spiegò la sua voce:
“Dono d’estate, Demetra, ah, sovrana ricca di doni,
chi dei celesti, dei numi, o chi fra le genti mortali,
t’ha trafugata Persèfone, ed ha contristato il tuo cuore?
Io l’ho sentita gridare, né ho visto però coi miei occhi,
chi fosse mai; te ne reco in fretta l’annuncio verace”.
Ècate disse così, né a lei con parole rispose,
quella figliola di Rea la bella di chiome, e al suo fianco
mosse con fretta, reggendo le fiaccole accese nel pugno.
Giunsero infine dal Sole, vedetta di uomini e numi,
s’ersero innanzi ai cavalli; poi chiese, la splendida dea:
“Sole, tu serba rispetto a me dea, se mai nel passato
o con parola o con atto nell’animo e in cuore ti piacqui.
La figlia mia, dolce gemma che io partorii, chiaro viso,
sì, il suo gridare angosciato nell’etere limpido ho udito,
quasi subisse violenza, né ho visto, però, coi miei occhi.
Dunque tu stesso –sì, tu dall’etere splendido, infatti,
posi lo sguardo dei raggi sul mare e su tutta la terra–
parla sincero, se mai vedesti la mia creatura,
chi, defraudandomi, a forza e contro sua voglia l’ha presa
e se ne fugge, chi fu, tra gli dèi, tra genti mortali”.
Disse così; l’Iperiònide a lei con parole rispose:
“Figlia sovrana di Rea la bella di chiome, Demetra,
tutto saprai; serbo a te gran rispetto e sono pietoso:
per la figliola di snelle caviglie hai tu angoscia e non altri,
fra gli immortali ne ha colpa, che Zeus, Chi-le-nubi-raduna,
egli che all’Ade la offrì, la chiamasse florida sposa,
a quel fratello di sangue; fra tenebra cupa di nebbie,
la trascinò coi cavalli, la prese che forte gridava.
Dea, quest’acerbo tuo pianto tu frenalo; non t’abbisogna,
struggerti invano d’immenso rancore; oh, non è di te indegno
genero, fra gli immortali, Aidòneo, Chi-molti-assoggetta,
quel tuo fratello di sangue e congiunto: sorte d’onore
ebbe, allorché da principio fu il tutto diviso in tre parti;
vive fra quelli su cui per sorte egli regna sovrano”.
Come ebbe detto, incitò i cavalli: svelti, al richiamo,
trassero, simili a uccelli ali-tese, l’agile carro.
Ma ben più atroce, più cane, il cruccio a lei scese nel cuore.
Dunque da allora, adirata col Crònide nero di nembi,
s’allontanò dai concili di dèi, dall’Olimpo elevato,
fra le città, fra le pingui campagne degli uomini errava,
la sua beltà lungo tempo occultando; nell’incontrarla
uomo non la ravvisò, no, né donna snella di cinto,
prima che fosse venuta in casa di Cèleo animoso,
ch’era in quel tempo il sovrano d’Eleusi odorata d’incensi.
Presso quel pozzo Partenio, dove acqua attingevano all’ombra
i cittadini (cresceva al di sopra un ramo d’olivo),
lungo la via s’era assisa e si macerava nel cuore,
simile a vecchia già avanti degli anni, e che ormai sia lontana
dal generare e dai doni d’Amica-di-serti, Afrodite:
balie così, per i figli, i principi fonti di legge,
hanno, nonché dispensiere, in dimore fervide d’echi.
Ecco, la videro, allora, le figlie di Cèleo eleusino,
mentre per l’acqua sgorgante venivano, sì da portarne
dentro le brocche di bronzo alle care case del padre,
quattro fanciulle nel fiore degli anni e parevano dee,
tanto Callídice quanto Cleisídice e Demo l’amata,
e poi Callíroe, colei che fu la maggiore fra tutte;
né la conobbero: è arduo ai mortali scorgere i numi.
Avvicinatesi a lei, parlarono alate parole:
“Vecchia, chi sèi, e di dove, fra gli uomini, fra i primigenii?
Dalla città perché mai fuggisti lontana e alle case
più non t’accosti? Là donne per sale ammantate dall’ombra
vivono, della tua stessa età, e più giovani donne,
che con parole e con gesti a te si farebbero amiche”.
Questo ella disse e la dea sovrana, in parole, rispose:
“Figlie, chiunque voi siate, in mezzo alle tenere donne,
io vi saluto; sì, a voi lo dirò: né è poi sconveniente,
visto che m’interrogate così, quel ch’è vero, narrarlo.
Deo è il mio nome: ché questo mi impose la nobile madre;
Ora da Creta fin qui sui dorsi spaziosi del mare
giungo –né io lo volevo: per forza, nolente, costretta,
uomini m’hanno condotta, predoni; ecco, infine, che essi
spinsero l’agile nave a Tòrico, dove le donne
in terraferma accalcate discesero e insieme anche loro
si prepararono il desco alla nave, ai cavi di poppa.
L’animo mio non curava, però, quel banchetto di miele,
no, di nascosto balzai sulla terraferma nerigna,
e dai superbi padroni fuggii, non avessero mai
altro guadagno da me, vendendomi senza comprarmi!
Quindi arrivai fino a qui, vagando; e però non so nulla,
né quale sia, questa terra, né poi quale gente ci viva.
Ora per voi gli dèi tutti che hanno dimore in Olimpo
abbiano in serbo mariti legittimi, diano a voi i figli
che i genitori hanno grati; ma siate pietose, fanciulle,
ditemi tutto con piena chiarezza, a che io sappia bene
–siatemi amiche, voi, figlie –a casa di chi potrò andare,
d’uomo o di donna, così che per loro possa adempire
io di buon grado i lavori adatti a una donna, a un’anziana;
ben cullerei fra le braccia un bambino nato da poco,
ben saprei fargli da balia e poi custodire le case,
e preparare, nel chiuso di talami ben costruiti,
letto ai padroni, nonché vegliare i lavori di donne”.
Disse la dea e all’istante rispose Callidice, intatta
vergine, lei, fra le figlie di Cèleo prima in bellezza.
“Nonna, da umani dobbiamo, sia pur con angoscia, costretti,
cedere ai doni dei numi, ché sono di molto i più forti.
Ma ti dirò con chiarezza e ti farò i nomi di tutti
gli uomini che fra di noi hanno gran potere ed onore,
quelli che sono eminenti fra il popolo e salvano i veli
della città, con i loro consigli e le rette sentenze.
Savio d’ingegno com’è, Trittòlemo, e Díoclo con lui,
quindi Polísseno e insieme a lui l’impeccabile Eumolpo,
Dòlico infine, nonché il nobile nostro parente:
tutte le loro consorti sorvegliano casa, in faccende;
certo, nessuna di loro, appena t’avesse veduto,
disprezzerebbe il tuo aspetto o ti scaccerebbe di casa,
anzi ti riceveranno: a una dea somigli, davvero.
Dunque, se vuoi, resta qui, fin tanto che a casa del padre
non giungeremo, e diremo alla madre snella di cinto,
a Metaníra, ogni cosa, con cura, così che ti inviti
a presentarti da noi, senz’andare a casa d’un altro.
Suo prediletto, ella cresce, nel ben costruito palazzo,
l’ultimo nato, un bambino, a lungo sperato ed atteso.
Se lo saprai allevare e verrà nel fiore degli anni,
chi ti vedrà, facilmente, in mezzo alle tenere donne,
t’invidierà: tale prezzo darà, ella, in premio alle cure”
Disse, e la dea le accennò col capo: esse, allora, felici,
d’acqua riempirono e indietro portarono i lucidi secchi.
Già alla gran casa del padre eran giunte e in fretta alla madre
dissero quello che videro e udirono. In fretta, a sua volta,
ella ordinò che a chiamarla corressero, a prezzo infinito.
Come cerbiatte o vitelle saltellano, nella stagione
di primavera, se appena han sazi del pascolo i cuori,
proprio così, sollevando i lembi alle amabili vesti,
sull’incavata carraia correvano, e intorno le chiome
simili al fiore del croco balzavano sopra le spalle.
Scorsero presso la via la gloriosa dea, dove prima
l’abbandonarono; allora alle care case del padre
l’accompagnarono; e dietro, sia pur macerandosi in cuore,
ella incedeva, col capo velato, ed intorno il suo peplo
nero ondeggiava, seguendo quegli agili passi di dea.
Giunsero presto alle case di Cèleo alunno di Zeus,
attraversarono il portico –assisa, la nobile madre
lì le attendeva, a un pilastro di quel ben costrutto palazzo,
col nuovo fiore al suo seno, il bambino; presso di lei
corsero; venne alla soglia, la dea, e col capo il soffitto
quasi toccò e le porte riempì di splendore divino.
N’ebbe la donna rispetto e stupore e smorto terrore;
ecco che dunque dal trono s’alzò, l’invitò, che sedesse.
La donatrice di messi, Demetra, la ricca di doni,
non accettò, tuttavia, di sedersi al lucido trono,
se ne rimase in silenzio, e tenne abbassati i begli occhi,
fino a che, saggia di probi pensieri, a lei Iambe non porse
solido seggio, e poi su vi distese un candido vello.
Vi si sedé, quella dea, ma il velo serrò con la mano,
e su quel seggio gran tempo restò, macerandosi, muta,
né di parole né d’atti porgeva ad alcuno il saluto:
senza sorridere, priva di cibo nonché di bevanda,
stette –soffrì nostalgia per la figlia snella di cinto–,
fino a che, saggia di probi pensieri, a lei Iambe non volse
molti motteggi, scherzando, e forzò la chiara sovrana
ad un sorriso, ed al riso, ad avere l’animo lieto
(Iambe per sempre, da allora, le fu graditissima in cuore).
Poi Metaníra una coppa di vino soave di miele
piena le offrì; rifiutò, la dea: le era illecito, disse,
bere del vino rossigno e chiese piuttosto che offrisse
acqua e farina mesciute, da bere con morbida malva.
Ella mescé il ciceone, lo diede alla dea, come imposto;
ne affermò il rito, accettando, Deò, la sovrana di molti.
Prima fra loro parlò Metaníra bella di cinto:
“Donna, salute: non credo, non già, che da vili parenti
sia nata tu, ma da nobili; irradi dagli occhi il rispetto
e quella grazia che sono dei principi mastri di leggi.
Pure, da umani dobbiamo, sia pur con angoscia, costretti,
cedere ai doni dei numi: è il giogo che abbiamo sul collo.
Ora che sèi fra di noi, avrai tutto quello che ho anch’io.
Tu alleverai il mio bambino, che tardi, contr’ogni speranza
diedero a me gli immortali, ed a cui va tutto il mio amore.
Se lo saprai allevare e verrà nel fiore degli anni,
chi ti vedrà, facilmente, in mezzo alle tenere donne,
t’invidierà: tale prezzo offrirei, compenso alle cure”.
Disse di contro perciò Demetra la bella di serti:
“Donna, salute anche a te, ti rechino bene gli dèi.
Accoglierò di buon grado il bambino, come m’imponi.
Lo alleverò, né già credo che per la follia d’una balia
un maleficio potrà fargli danno o un’erba maligna:
so d’un antidoto assai più valido d’ogni veleno,
al maleficio luttuoso so opporre una buona difesa”.
Quindi, ciò detto, l’accolse nel seno odoroso d’essenze,
fra le sue braccia immortali, e fu lieta in cuore la madre.
Dunque il rampollo di Cèleo longanime, Demofoonte
splendido, che partorì Metaníra bella di cinto,
ella educò nel palazzo; egli crebbe simile a un dio
senza mangiare mai pane o suggere latte: sì, Deo,*
quasi egli fosse progenie di un dio, con ambrosia l’ungeva,
dolce spirando su lui, e se lo stringeva al suo seno,
come tizzone lo offriva a notte alla forza del fuoco,
ai genitori celandosi; a quelli sembrò gran prodigio,
come crescesse precoce, eguagliasse i numi in aspetto.
Certo l’avrebbe poi reso immune a vecchiaia, immortale,
se, nella propria follia, Metaníra bella di cinto,
che la spiò nella notte, nel talamo dolce d’essenze,
non li vedeva: gemé, si batté su entrambe le cosce,
tanto tremò per suo figlio, e fin troppo in cuore fu folle,
quindi, con voce di pianto, parlò con alate parole:
“Ah, figlio mio, Demofonte, in un grande fuoco ti cela,
questa straniera ed infligge a me lutto e lugubri pene!”
Sì, così disse, piangendo, e l’udì la splendida dea.
Dunque con lei s’adirò, Demetra la bella di serti,
e quel bambino che in casa già nacque contro ogni speranza,
con le sue braccia immortali da sé lo respinse ed al suolo,
fuori del fuoco, lo pose, assai incollerita nel cuore;
subito rimproverò Metaníra bella di cinto:
“Uomini privi di senno, inabili nel prevedere
ogni destino di bene o di male che vi raggiunga:
ecco che tu per la tua pazzia, troppo folle sèi stata!
Sappia però, giuramento di dèi, l’acqua amara di Stige,
che il figlio tuo l’avrei reso immune a vecchiaia, immortale
tutti i suoi giorni, e così gli avrei dato onore infinito,
ora non più gli è concesso sfuggire alla morte, alle Chere.
Pure avrà sempre infinito onore, perché m’è salito
sulle ginocchia, perché ha dormito fra le mie braccia.
E di stagione in stagione, per lui, al passare degli anni,
giovani fra gli Eleusini, in guerra, in terribile lotta
sempre, nei giorni futuri si combatteranno fra loro.
Sono Demetra la chiara d’onori, colei che procura
per immortali e mortali supremo conforto e dolcezza.
Ma tutto il popolo presso la rocca e l’impervia muraglia
m’erigerà un gran sacrario e poi, all’interno, anche un’ara,
sulla collina elevata che sopra Callícoro sorge;
v’insegnerò io in persona i miei riti, sì che in futuro
li celebriate piamente e così plachiate il mio cuore”.
Come ebbe detto, la dea, mutò di statura e figura,
e si svestì di vecchiaia, bellezza a lei intorno si effuse;
una gentile fragranza dai pepli odorosi d’essenze
si diffondeva; un chiarore di dea dal suo corpo immortale
prese a brillare, le chiome sugli òmeri scesero, bionde,
come d’un guizzo di lampo s’empì quella solida casa.
Poi se ne uscì dalle sale; la donna sentì le ginocchia
sciogliersi, muta rimase gran tempo, e nemmeno pensava
a sollevare da terra il bambino, il suo prediletto.
Ma le sorelle ne udirono allora la voce pietosa,
fuori dai letti ben fatti balzarono; ed ecco che una
strinse il bambino al suo seno, prendendolo fra le sue braccia,
l’altra avvivò poi la fiamma, la terza coi morbidi piedi
corse e scortò via la madre dal talamo dolce d’essenze.
Poi, affollandosi intorno, lavarono il bimbo scalciante,
con ogni cura; e però non più s’addolciva di cuore,
già, ché badavano a lui ben peggiori balie e nutrici.
Tutta la notte la dea gloriosa eran tese a placare,
e dal terrore tremavano; appena fu sorta l’aurora,
diedero nunzio verace a Cèleo vasta potenza,
su quel che impose la dea Demetra, la bella di serti.
Egli chiamò in adunanza la gente dai vasti confini,
e un opulento santuario ordinò d’erigere e un’ara
sulla collina elevata, a Demetra bella di chiome.
Essi obbedirono in fretta, ascoltarono la sua voce,
come egli impose, l’eressero; e sorse, in virtù della dea.
Come compirono tutto, conclusero quella fatica,
se ne tornarono ognuno a casa; e la bionda Demetra
dentro sedendovi, allora, lontana da tutti i beati
stette –sentì nostalgia per la figlia snella di cinto.
E spaventoso, il più cane, su terra nutrice di molti,
ella per gli uomini rese quell’anno e la terra altro seme
non rilasciò: li nascose Demetra la bella di serti.
Molti pieghevoli aratri invano i buoi trassero ai campi,
molto orzo bianco poi cadde a terra, e restò senza frutto.
Tutta periva la stirpe degli uomini nati a morire,
per la dolente penuria, e il glorioso onore di doni
e sacrifici svaniva, per quanti han dimore in Olimpo:
Zeus tuttavia vi pensò, meditò rimedio in cuor suo.
Iride, l’ala dorata, da prima egli inviò, che chiamasse
bella-di-chiome, graziosa d’amabile aspetto, Demetra.
Questo le impose; ella a Zeus, al Crònide nero di nembi,
ben si piegò, con i piedi in fretta percorse il cammino.
Dunque raggiunse la rocca d’Eleusi odorata d’incensi,
vide così, nel sacrario, Demetra la nera di pepli,
e dispiegò la sua voce e le disse alate parole:
“Il padre Zeus, che ha infinita sapienza ti chiama, Demetra,
a presentarti alle schiere dei numi di stirpe immortale.
Vieni, che questa parola di Zeus non rimanga incompiuta!”
Disse così, nel pregarla, né a lei tuttavia piegò il cuore.
Ecco che il padre i beati, i numi che vivono sempre,
tutti da lei li mandò; giungendo in alterna vicenda,
la supplicavano, offrivano immensi e bellissimi doni,
fra gli immortali scegliesse gli onori per lei più graditi.
Ma non riusciva nessuno a piegarle il cuore e la mente,
tanto in cuor suo s’adirava; spregiava aspramente i consigli.
E ripeteva che mai sull’Olimpo dolce d’incensi,
ritornerebbe, né più ridarebbe frutto alla terra,
prima d’avere rivista con gli occhi la bella sua figlia.
Ma non appena l’udì, Cupo-tuono, l’Ampio-veggente,
Zeus, verso l’Erebo inviò l’uccisore d’Argo, Aurea-verga,
che con sue blande parole potesse convincere l’Ade
a ricondurre fra i numi, da tenebra cupa di nebbie,
verso la luce, la chiara Persèfone, sì che la madre,
vistala con i suoi occhi, infine cessasse dall’ira.
No, non fu Ermes restio, ma subito in grembo alla terra
in un baleno calò, lasciando la sede d’Olimpo.
E ritrovò quel sovrano all’interno delle sue case:
era disteso sul letto insieme alla sposa pudica,
che s’angosciava e voleva sua madre –e la madre, lontana,
contro i beati, gli dèi, concepiva fiero consiglio.
Avvicinatosi, disse il potente uccisore d’Argo:
“Ade, nerigno di chiome, che regni sovrano sui morti,
ordina Zeus genitore che d’Erebo tu riconduca
presso i celesti la chiara Persèfone, sì che la madre
con i suoi occhi la veda ed agli immortali condoni
l’inesorata sua collera e l’ira: ah, gran fatto ella pensa,
spegnere esangui le stirpi degli uomini nati da terra
dentro la terra celando i semi, estinguendo gli onori
degli immortali: ira truce la domina, né fra gli dèi
più ricompare, in disparte, nel tempio odorato d’incensi
anzi dimora, abitando l’impervia fortezza d’Eleusi”.
Sì, così disse, e sorrise Aidòneo, quel re degli estinti,
pur con il ciglio, e restio non fu al cenno di Zeus sovrano.
All’animosa Persèfone allora sollecito impose:
“Torna, Persèfone, là da tua madre nera di pepli
e nel tuo petto conserva sereni il tuo cuore e la mente
e non covare sconforto nell’animo, troppo più d’altri.
Fra gli immortali sarò per te non ignobile sposo,
come fratello di Zeus tuo padre; ah, se qui rimanessi,
tutte le cose che vivono e strisciano domineresti,
fra gli immortali i più grandi onori ne riceveresti,
chi t’offendesse ne avrebbe la pena per tutti i suoi giorni,
chi non volesse d’offerte saziare la collera tua,
non celebrasse i tuoi riti, offrendoti doni dovuti”.
Sì, così disse e gioì Persèfone ricca di senno,
rapida sorse, per sua letizia: egli allora di furto
fece mangiare a lei il chicco dolcissimo di melagrana
e si guardò ben accorto, affinché per tutti i suoi giorni
non seguitasse Demetra onorata, nera di pepli.
Ecco che allora sul carro tutt’oro i cavalli immortali
si preparò ad aggiogare, Aidòneo che molti assoggetta.
Ella sul carro salì e il possente uccisore d’Argo
strinse, al suo fianco, le briglie, le redini, con le sue mani,
e fra le sale li mosse; volarono docili i due.
Svelti gli immensi cammini compirono, no, non il mare
non la corrente dei fiumi, non valli ammantate dall’erba,
non le giogaie impedirono il corso ai cavalli immortali,
essi al di sopra dei monti tagliavano il cielo profondo.
Dove la bella di serti Demetra attendeva, li spinse,
presso il sacrario odorato d’incensi: e Demetra, al vederli,
come impazzita balzò per il monte ombrato di selve.
Ma a lei di fronte Persèfone, appena ebbe visti i begli occhi
della dea madre, ecco, allora, lasciando quel carro, i cavalli,
corse, balzò, ed a lei s’aggrappò gettandosi al collo.
Questa, benché fra le braccia stringesse la cara sua figlia,
subito in cuore temé l’insidia, ebbe forte tremore
e dall’abbraccio si sciolse e chiese, con queste parole:
“Figlia, mentre eri laggiù non avrai di certo toccato
cibo? Non chiuderlo in petto, ma parla, a che entrambe sappiamo.
Se così è, ritornata quassù, via dall’Ade aborrito,
presso di me, con tuo padre, il Crònide nero di nembi
fra gli immortali, fra tutti, avrai onorata dimora;
o tornerai, altrimenti, di volo giù in grembo alla terra,
là d’anno in anno vivrai per un terzo delle stagioni,
per i due terzi con me ed insieme agli altri immortali.
Quando la terra di fiori odorati, primaverili,
d’ogni semente fiorisca, da tenebra cupa di nebbie,
tu tornerai, gran prodigio ai numi, alle genti mortali.
Con che malia t’ingannò, fiero, il dio che molti riceve?”
Ecco che a lei la stupenda Persèfone disse di contro:
“Sì, certamente, a te, madre, ora io svelerò tutto il vero.
Quando arrivò da me nunzio il veloce uccisore d’Argo,
spinto dal Crònide padre e dagli altri Figli del Cielo,
sì che io uscissi dall’Erebo, e tu mi vedessi con gli occhi,
e perdonassi agli eterni la collera e l’ira tremenda,
ecco che io mi levai in letizia; ma Ade di furto
del melograno mi diede il chicco che è dolce a mangiarsi,
contro la mia volontà mi costrinse a forza a mangiarne.
Come per trama sottile del Crònide, sì, di mio padre,
m’abbia rapita e involata e sia sceso in grembo alla terra,
ti narrerò, tutto quanto dirò quel che tu mi domandi.
Ecco che noi tutte insieme in mezzo ad un prato stupendo
–con me Leucippe, nonché Fenò, ed Elettra ed Ïante,
Mèlite ed Íache e poi Rodea e Callíroe, e ancora
c’era Melòbosi e Sorte e Ocíroe occhi-gentili,
quindi Criseide, nonché Ianira ed Acaste ed Admete,
Ròdope ed anche Plutò, e desiderata, Calipso,
Stige ed Urania, e con lei l’adorabile Galassaure,
Pallade pronta in battaglia e Artèmide saettatrice–,
noi giocavamo, tendendo le mani agli amabili fiori
croco soave mischiando e iridi e insieme giacinti
e le corolle di rose e i gigli, un prodigio a vedersi,
e quel narciso che offrì pari al croco Terra spaziosa.
Ecco che lieta lo colsi, allora, e la terra al di sotto
si spalancò, ne balzò, fiero, il re che molti riceve.
Sotto la terra così mi rapì, sul carro tutt’oro,
contro la mia volontà –un acuto grido levai.
La verità tutta quanta, sia pur con angoscia, t’ho detta”.
Dunque per tutto quel giorno, a lungo, con cuore concorde,
dandosi l’una con l’altra nell’animo e in cuore conforto,
si circondavan di cure –il cuore guarì dalle angosce.
L’una dall’altra ebbe gioia e gioia donò l’una all’altra.
Ecate chiara di veli, in quella, ad entrambe fu presso,
con ogni cura onorò Core, nata a Demetra augusta:
sin da quel tempo la dea sovrana le è amica e compagna.
Nunzia fra loro da Zeus cupo-tuono, l’ampio-veggente,
venne Rea bella-di-chiome –Demetra la nera di pepli
ella guidasse alle stirpi dei numi: accettò Zeus d’offrirle
tutti gli onori che avesse voluto fra i numi immortali
e stabilì che però sua figlia, al passare d’ogni anno,
la terza parte vivesse fra tenebra cupa di nebbie,
ma le altre due con la madre e con gli altri i numi immortali.
Disse –né già fu restia, la dea, ai comandi di Zeus.
Ecco che Rea con un balzo calò dalle cime d’Olimpo
quindi su Rario planò, su zolle di terra feconda
prima, ma allora non era feconda, ah, fin troppo tranquilla,
senza germogli, era inerte: celava la bianca farina
per volontà di Demetra di bella caviglia: ben presto
tutta doveva però fiorire di spighe distese,
a primavera avanzata, e nel piano i solchi opulenti
germoglierebbero in spighe da stringere insieme in covoni.
Ed a quel luogo per primo dall’etere limpido venne
e si rividero allora con gioia, eran liete nel cuore.
Subito disse così Rea chiara di pepli a Demetra:
“Qui, figlia mia, chiama te Cupo-tuono, l’Ampio-veggente,
Zeus, perché torni alle stirpi dei numi: ha accettato d’offrirti
tutti gli onori che tu sceglierai fra i numi immortali;
e stabilì che però tua figlia, al passare d’ogni anno,
la terza parte vivesse fra tenebra cupa di nebbie,
ma le altre due insieme a te ed agli altri i numi immortali.
Questo annunciò che avverrà: così t’accennò col suo capo.
Torna, però, figlia mia, obbedisci, no, non serbare
ira fin troppo inflessibile al Crònide nero di nembi.
Fa’ rampollare per gli uomini in fretta un fecondo raccolto”.
Disse –né già fu restia Demetra la bella di serti
Subito fece spuntare dall’aie feconde il raccolto.
Tutta di foglie e di fiori allora la terra spaziosa
si caricò: la dea venne fra i re che amministrano il giusto,
prese a indicare a Trittòlemo e a Dìocle sferza-cavalli
ed alla forza d’Eumolpo e a Cèleo sovrano d’armate
il compimento dei riti, e svelò i misteri per tutti,
sì, per Trittolemo e per Polìsseno e Diocle stesso,
sacri, che no, non è dato intendere, né profanare
né rivelare: timore di dèi frena grave la voce.
È fortunato chi assiste ai riti, fra gli uomini in terra:
chi di quei riti è all’oscuro, il profano, no, non ha pari
fato, nemmeno da morto, fra tenebra sordida, mai.
Ma non appena ebbe tutto mostrato, la splendida dea,
se ne tornò sull’Olimpo, al consesso degli altri numi.
Stanno lassù le due dee, con Zeus, il signore del lampo,
ambe temute e onorate. Felice è davvero, colui
che le due dee hanno caro, benigne, fra gli uomini in terra:
nella sua grande dimora inviano, al suo focolare,
Pluto, colui che dispensa ricchezza alle genti mortali.
Dee che abitate la terra d’Eleusi odorata d’incensi,
Paro lontana fra i gorghi e Antrone l’impervia di rupi,
Deo sovrana, signora di messi, tu, ricca di doni,
e tu non meno al suo fianco, Persefone, figlia stupenda,
per il mio canto benigne donatemi dolce ricchezza
Te io ricordo, o Demetra, ed insieme un’altra canzone.
Les infréquentables: Philippe Muray – cari jihadisti
traduzione di Francesco Forlani
Cari jihadisti,
Voi sopravvalutate alla grande la posta in gioco della battaglia in cui vi siete buttati a capofitto. Apparite come le prime vittime della nostra propaganda. Credete di mettere sotto attacco una civiltà e le sue tendenze profonde, secolarizzanti, seducenti, desacralizzanti, oscenizzanti e mercatizzanti. Vi sbagliate di mulino a vento. Non c’è nessuna civiltà. Accordate fin troppa fiducia, seppure con l’intento di odiarlo, al discorso comune dei nostri portavoce, innumerevoli, politologi, editorialisti, commentatori e osservatori, che dicono e non dicono che siamo sprofondati in una “guerra dei mondi”. Non ci sono più mondi. Il termine “mondializzazione” si è fatto carico lui stesso di eludere la sua scomparsa. Inoltre ci raccontano i nostri incantatori di serpenti, e su questo ci ritorneremo, che la Storia continua, ma non c’è più Storia; o per lo meno, proprio la Storia ha smesso di produrre Storia: produce innocenza, la nostra innocenza, e non produce ormai altro che questa.
A troppo credere al nostro potere, avete finito con il convincervi che esistiamo. Prendete le nostre lucciole per lanterne. Vi precipitate contro specchi per allodole e manifesti che noi stessi abbiamo costruito a nostro uso interno, e vi riponete quella energia inconsapevole da cui siete posseduti quando vi abbattete sulle nostre torri al comando di aerei imbottiti di kerosene. Ma lo sappiamo, noi, che questa civiltà presente che ci ostiniamo a chiamare Occidente e che non ne ha ormai più nessun lineamento, è incompatibile con la dignità umana la più elementare: è anche il motivo principale per cui saremo implacabili nella sua difesa. Le vostre risposte non faranno altro che nutrire la nostra determinazione. La vostra violenza per quanto sempre più folle e omicida, non smetterà di rafforzarci legandovi dialetticamente, e ogni volta più strettamente, a noi.
 La messa in rete dell’ umanità, di cui tanto si parla, e questa dinamica d’interdipendenza di cui ci si delizia, lavorano soltanto in nostro favore. Le vostre ragioni religiose, che non possiamo prendere in considerazione, tranne che per fornirvi delle ragioni, il che equivarrebbe ad attribuirvi anche dell’ umanità, si perderanno nella fiabesca baraonda del parco dei divertimenti di cui siamo i creatori e che poco alla volta, soppianta il resto.
La messa in rete dell’ umanità, di cui tanto si parla, e questa dinamica d’interdipendenza di cui ci si delizia, lavorano soltanto in nostro favore. Le vostre ragioni religiose, che non possiamo prendere in considerazione, tranne che per fornirvi delle ragioni, il che equivarrebbe ad attribuirvi anche dell’ umanità, si perderanno nella fiabesca baraonda del parco dei divertimenti di cui siamo i creatori e che poco alla volta, soppianta il resto.
Male che vada, cari jihadisti, potrete rappresentarvi nel nostro nuovo sistema, come una sorta di opposizione provvisoria a Nostra Maestà lasciando credere ancora in un bipolarismo del pianeta, e in un’« alternanza » plausibile (per quanto temibile) dal momento che ad estendersi è il nostro sistema planetario, senza controparte.
Nel nostro altro mondo senza l’Altro, potrete essere per qualche tempo quest’ altro posticcio che, in ogni caso, e con diverse vesti , ci sarà sempre necessario. Vi siete voluti scontrare con noi. Avete voluto entrare in gioco, nel nostro gioco. E ora bisognerà giocarlo questo gioco, e giocare a questo soltanto, e giocarlo fino in fondo, anche se vi ostinate a colorarlo con riferimenti pittoreschi al califfato, alla ummah, agli antichi splendori di Granada, all’età dell’oro di Cordova e tante altre turqueries che vi danno ancora nella vostra lotta l’illusione d’una sostanza, di un contenuto, di un’ autonomia, di un’origine e di uno scopo.
Eppure il vero segreto è che ciò contro cui ve la prendete è senza contenuto. E se ci tenete a rimanere all’altezza della situazione senza precedenti che avete creato, vi toccherà imitarci. Da questo momento, quindi, il vostro orizzonte assegnato è l’assenza di significato.
estratto dal libro di Philippe Muray, Chers djihadistes, Mille et une nuits, 2002
il testo originale qui
Quello che brucia
di Lorenzo Trombetta
Più per l’orrore che toglie il sonno per le atroci immagini del pilota giordano, Muaz Kassasbe, che si dimena abbrustolito nella gabbia, lo stomaco si contorce per l’indifferenza di molti europei di fronte all’uccisione da parte della polizia egiziana di Shaimaa Sabbagh, una giovane madre colpita a morte a piazza Tahrir al Cairo lo scorso 25 gennaio mentre tentava di deporre dei fiori nella piazza simbolo delle proteste di quattro anni fa.
Ferisce nel profondo la stessa indifferenza con cui in Europa è stata accolta la notizia che Mazen Darwish, giornalista siriano e instancabile difensore del diritto di espressione, è stato trasferito nei giorni scorsi dal carcere di Damasco a quello di Hama, città sigillata e militarizzata dalle forze governative, sancendo l’ennesimo rinvio di un processo per “terrorismo” che forse non comincerà mai.
Seguendo la carrellata di fotogrammi che ritraggono i tentativi disperati degli amici di Shaimaa di salvarle la vita in mezzo agli scontri di Tahrir, tornano alla mente altre immagini: quelle dei governanti europei accorsi alla corte del presidente egiziano Abdel Fattah Sisi a esprimere l’appoggio al suo potere.
In Egitto è in corso la restaurazione. E a molti, in Europa, va bene così. La visione è talmente manichea – o i militari o l’oscurantismo degli estremisti – che non c’è spazio nemmeno per indignarsi della vigliacca uccisione di Shaymaa Sabbagh.
Il suo gesto – tentare di portare dei fiori in un luogo simbolo della primavera egiziana – è dissonante, fuori fuoco rispetto alla convinzione, sempre più dominante in molti ambienti politici e intellettuali europei, che lo Stato islamico e le sue barbarie siano il risultato delle sollevazioni popolari del 2011.
Anche la vicenda kafkiana e terribile di Mazen Darwish – un essere umano trattato come un topo di fogna da un governo con cui in molti vogliono tornare a trattare – stride con il mantra per cui il potere siriano degli Asad sia l’unica alternativa ai roghi umani dello Stato islamico.
Dal febbraio 2012 il potere di Damasco ha di fatto tolto a Mazen Darwish l’occasione di vivere umanamente. E di lavorare per lo sviluppo del suo Paese. E’ un fatto che non merita di essere sottolineato, raccontato a dovere, amplificato. Come invece si fa per ogni notizia truculenta riguardante le barbarie commesse dai jihadisti.
Da anni, Mazen lavorava a Damasco per una Siria migliore. Per una Siria dei diritti. Per una Siria di cittadini e non di membri di comunità confessionali, sudditi appartenenti a “minoranze da proteggere” dalla minaccia takfira.
Moltissimi dei giovani egiziani che, per 18 giorni erano scesi in piazza tra il gennaio e il febbraio del 2011, erano uniti a Mazen e a moltissimi altri siriani, tunisini, libici, yemeniti, iracheni, marocchini, algerini, del Bahrein, giordani.
Per lunghi mesi, nel 2011 manifestanti pacifici e rappresentati dell’emergente società civile irachena si erano accampati a Mosul, ora capitale dello Stato islamico, così come a Ramadi, capoluogo della regione di al Anbar, culla dell’Isis. A più riprese, donne libere di Raqqa, ormai capitale siriana dei jihadista, fino a un anno e mezzo fa col loro volto e la loro voce contestavano apertamente i jihadisti.
Chi si ricorda le manifestazioni a Piazza Perla a Manama, in Bahrain, represse nel sangue dalla polizia e dai militari del Consiglio di cooperazione del Golfo, emanazione del potere saudita? Chi si ricorda dei caccia dell’aviazione egiziana che, per terrorizzare la folla pochi giorni prima dell’uscita di scena del presidente Hosni Mubarak, sorvolarono piazza Tahrir gremita di egiziani?
Chi si ricorda delle manifestazioni a Tunisi, Sanaa, Tripoli, Algeri, Rabat, Amman? Chi si ricorda della piazza dell’Orologio a Homs, prima del massacro compiuto dalle forze siriane il 18 aprile 2011? E chi si ricorda dell’oceano di siriani riunitisi sotto la torre della piazza centrale di Hama?
Mazen Darwish il “terrorista” è ora in una cella nella prigione centrale di Hama, tristemente nota per le pessime condizioni in cui sono costretti a sopravvivere i detenuti. Il suo nome e la sua storia rimarranno nell’oblio. Shaimaa Sabbagh, “uccisa dal complotto”, è sotto terra. E il suo nome sarà presto ricordato solo dai suoi amici e da qualche irriducibile attivista. Chi voleva deporre fiori a piazza Tahrir, ormai non compierà più un passo. E tacerà chi voleva lavorare per la libertà di espressione a Damasco.
La restaurazione in nome della “sicurezza-e-stabilità” ha bisogno di silenzio. Della benedizione dei nostri sorridenti governanti. E dell’appoggio di tutte le forze reazionarie della regione. E’ una restaurazione che continuerà a produrre migliaia di altri invasati terroristi pronti a tagliare gole a giornalisti e cooperanti. Pronti a bruciare vivi prigionieri di guerra. Soprattutto pronti a uccidere vignettisti nel cuore dell’Europa.
Più delle bombe sganciate dai colleghi arabi del povero Kassasbe sulle teste dei jihadisti – ma anche dei civili – in Siria e in Iraq, erano Mazen e Shaimaa il vero antidoto al cancro jihadista. Erano loro i membri di una più genuina ed efficace Coalizione contro l’oscurantismo, sia esso con la barba o in giacca e cravatta.
Questo articolo è apparso su SiriaLibano.
La creazione del lutto
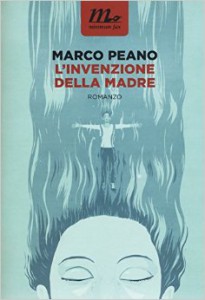
di: Alessandro Garigliano
Non so se durante la lettura de L’invenzione della madre di Marco Peano (minimum fax 2015) mi abbia commosso più la storia o lo stile. Non starò qui a rimuginare se ciò che si racconta sia biografia o invenzione, e in che percentuali. Si narra in terza persona con una voce vicina, quasi complice, al protagonista ventiseienne che ha nome Mattia (l’unico in tutta la storia a essere nominato, mentre gli altri sembra godano di una sorta di sacralità grazie alla quale i loro nomi resteranno impronunciati). Dirò subito che ciò che più mi ha coinvolto e stravolto non è né l’esattezza delle parole né l’essenzialità dei periodi necessari a narrare il decorso terminale di una donna malata di diverse forme di cancro; ciò che mi ha coinvolto e stravolto è la capacità di sottrarre pathos senza sottrarsi, senza disinnescare il dolore spaventoso scaricando la tensione con l’ironia o usando artifici inadeguati.
Il marmo di César Aira
 di Francesca Matteoni
di Francesca Matteoni
Pietra splendente è il marmo, lavorato a lastre che trattengono l’esistenza trascorsa dentro una lapide cimiteriale. Certezza, chiarore, fissità: sono tutte caratteristiche facilmente attribuibili alla sostanza. Eppure ne Il marmo, romanzo dell’argentino César Aira, queste si sgretolano in globuli di poco valore, dati ai clienti nei supermercati cinesi per arrotondare il resto in mancanza di spiccioli. Si sgretolano, ancora prima, nell’incidente che dà inizio al racconto: attraverso un’immagine la solidità del marmo si cambia nella fluidità di un’epifania, che risveglia il protagonista in un presente dove ignorava di trovarsi, e a cui è giunto schivando (o utilizzando) le schegge di molte possibili storie.
“Cerco di spremere altri dati dall’unica visione o dall’unico momento che mi è rimasto impresso. (Da un po’ la mia penna ha ricominciato a posarsi sul foglio. Ho rinunciato all’attesa passiva.) Cerco il filo che mi porti al ricordo. Un solo dato, minimo, basterebbe … Ma l’unico dato che riesco a tirar fuori dal cilindro non potrebbe essere più intrigante: nel momento in cui mi abbassavo i calzoni ero seduto su un blocco di marmo”.
Come riporta Giuseppe Genna nella sua introduzione, Aira è uno scrittore di romanzi brevi, capace di finirne e pubblicarne diversi l’anno, seguendo un metodo: scrive ogni giorno almeno una pagina, seduto in un caffè, affidandosi all’improvvisazione e soprattutto andando sempre avanti, in una fuga che non permetta al racconto di voltarsi indietro. Proprio come nella vita, anche gli errori, i conti che non tornano, il superfluo, il nostro smemorarsi o attaccarsi perfino in modo ossessivo a dettagli irrilevanti, costituiscono materia narrabile, compongono l’immaginazione. Questa fuga è un incessante e progressivo ribaltamento di prospettiva che permette di immaginare l’ordinario quale sostanza nuova e bizzarra, lo turba, smascherandone il fulcro ignoto.
A dar l’avvio alla vicenda sono una serie di oggetti insignificanti come una molletta dorata, una macchina fotografica grande un centimetro, un cucchiaino-lente, una tavoletta delle proteine, che al protagonista vengono dati, insieme ai globuli di marmo, dal commesso cinese. Ognuno di questi oggetti tuttavia si rivela risolutivo nel succedersi degli eventi. Uscito dal supermercato infatti l’io narrante incontra la sua guida agli inferi o la sua nemesi: un ragazzino cinese dall’aspetto trasandato e lo spagnolo approssimativo, infarcito degli accenti del suo proprio idioma. Il mondo noto viene a questo punto sovvertito e così i generi letterari, che appaiono e si disinnescano nel viaggio rocambolesco dei due: inusuale romanzo d’avventura, tutto svolto all’interno di mura innocue, non memorabili, della città; storia che vira al fantascientifico in un lasso velocissimo di tempo per mostrarci che gli alieni sono uguali ai cinesi – agli altri, che altri non sono, umani e mortali come noi, che ci invadono, controllano un numero crescente di attività commerciali, instancabili e indistinguibili all’occhio da conquistatore in pensione dell’occidente. Infine, macchina del ricordo dove lo sforzo del vagare a ritroso e la propulsione all’accumulo di frammenti narrativi si fondono felicemente, catapultando lettore e attori in un sogno trafelato tra i fatti e le immagini.
“Ma sono stati davvero i fatti? O tutto continuava a succedere sul piano delle mie supposizioni? Il pensiero si basa sempre sui fatti, li rende ‘fatti significativi’. E nel corso della mia avventura, che somigliava tanto a un sogno, ho scoperto che la carica di significato dei fatti si moltiplica in modo portentoso quando si tratta di fatti strani, imprevisti, per esempio quando come in questo caso, vi prendono parte degli extraterrestri”.
Assurdità e pregiudizi formano quindi il tessuto marmoreo di questo reale pronto ad esplodere per rivelare il suo premio o la sua mancanza ultima, ciò per cui davvero, pur senza saperlo, si affannano il protagonista, il ragazzo cinese, gli alieni – una profonda nostalgia per qualcosa che è stato o che può divenire, sebbene i mondi conoscibili non facciano altro che rispecchiarsi identici, sebbene tutto l’esperibile sia solo un ripetersi del sé, la sensazione di esserci già stati. La variabile sta nello scivolamento delle cose dentro una mente o una memoria, nel moto nostalgico verso l’origine o la prima ragione – prima del fatto concreto, dell’universo codificato, quando la scrittura e le sue storie non sono ancora nulla, si manipolano in tasca come amuleti, si affrancano dalle verità e dai fini nella pura, splendente invenzione.
César Aira, Il marmo. Prefazione di Giuseppe Genna, Traduzione di Raul Schenardi (Edizioni Sur, 2014)
Bestiaire
di
le illustrazioni utilizzate per questo articolo sono di Andrea Pedrazzini ( tratte dal libro De bestiarum Naturis e altri disegni)
allez annoncer partout que l’homme n’a pas encore été capturé!
Siamo tutti forzati del successo, bestie da successo.
Looking for Giuseppe Terragni
di Gianni Biondillo
(Sta per essere pubblicato un libro, Negli immediati dintorni, nato dall’iniziativa di Viavai – contrabbando culturale Svizzera/Lombardia – in collaborazione con Edizioni Casagrande e con gli amici di Doppiozero. Nel volume c’è anche un mio testo, che qui vi allego. L’8 febbraio ne parlano Marco Belpoliti, Luigi Grazioli, Matteo Campagnoli e Alberto Saibene a Writers. G.B.)

Le città non sono musei, c’è poco da fare. E meno male, viene da aggiungere. Sono organismi complessi, mutevoli, palinsesti su cui gli abitanti scrivono e cancellano segni di continuo. Anche per questo l’architettura è un’arte ibrida, sporcata con la vita quotidiana. È vero, molti architetti hanno segnato il volto di una città, e una persona, per fare un esempio, se volesse conoscere Palladio dovrebbe, soprattutto, girare per Vicenza. Ma le sue opere non sono di certo disposte una dietro l’altra, seguendo un ordine cronologico, così come appunto in un museo.
Penso a tutto questo mentre faccio la mia ennesima capatina a Como. Da Milano è poca roba col treno. In fondo è un viaggio che molte persone per lavoro fanno tutti i santi giorni della settimana. Ma per me venire a Como è sempre una specie di regalo, di piccola vacanza a portata di mano. Ci venivo da bambino con i miei genitori, quelle domeniche mordi e fuggi viaggiando sui treni delle Ferrovie Nord, ci sono tornato da studente d’architettura, ci vengo ora con le mie figlie. E non c’è volta che non provi a fare il mio personale pellegrinaggio razionalista, che non provi a capire come sia possibile che, dopo tutti questi anni, Giuseppe Terragni riesca ancora a stupirmi. Como è la sua città, lo sappiamo. Certo, ha lasciato in giro, fra Seveso ed Erba, fra Lissone e Milano, qualche manciata di opere, ma è qui che ha segnato il gusto di un intero territorio. E forse di un intero periodo, non solo in Italia.
A voler consigliare al turista volenteroso un itinerario seguendo l’ordine topografico, dovrei dirgli di iniziare dall’Asilo Sant’Elia. A sud, in via Alciato, fuori dalla città storica. Che però è praticamente la fine del percorso umano del progettista. L’edificio assolve ancora oggi alla sua funzione, con decoro. Sembra anzi costruito da poco. A guardarlo appare incredibile che, mentre nel resto del paese la tipologia di queste costruzioni era ancora tetragona e monumentale, qui Terragni, consapevole di ciò che si teorizzava nel resto d’Europa, elaborasse edifici bassi, d’un solo piano, candidi, a misura di bambino, fin nello studio degli arredi. Ma oggi non mi posso fermare, sono di fretta. Devo, risalendo, tornare indietro nel tempo.
Non c’è molto da fare, le città non sono musei, l’ordine d’apparizione delle opere è sempre topografico, mai cronologico. Occorre saper saltare di palo in frasca, riconnettere le discrepanze. Che nel caso di Terragni, sperimentatore indefesso, si fanno così evidenti che pare abbia operato per decenni, quando invece la sua parabola umana è stata tragicamente breve. Salto Casa Pedraglio, una delle sue ultime opere, incompiuta, in via Mentana, e punto senza indugi verso il suo capolavoro.

Aggiro il centro, mi lascio alle spalle l’abside del duomo, supero la ferrovia e resto a contemplare la facciata della Casa del Fascio. C’è ancora qualche guida che la chiama, con un pudore che suona falso, Palazzo della Guardia di Finanza. L’adesione al Partito Nazionale Fascista determinò la sfortuna critica di Terragni, una sorta di onta incancellabile nella generazione storiografica del dopoguerra. Ridicolaggini. Non solo perché quella di Terragni fu una adesione imposta dall’alto, che accettò più per quieto vivere, all’italiana; non solo perché, nei fatti, anche promulgate le leggi razziali, non smise mai di frequentare amici, intellettuali e artisti ebrei; non solo perché, morto nel ’42 al ritorno dal devastante fronte russo, non poté come molti altri “ex-fascisti” riscattarsi vivendo gli anni della Resistenza, ma semplicemente perché, su tutto, la sua fu una architettura, qualunque fosse la sua intima ideologia politica, naturalmente lontana dalla retorica di regime.
Basti pensare che, mentre progettisti suoi coetanei (alcuni poi anche partigiani o deportati nei campi) riuscirono a edificare praticamente tutti in quel laboratorio di architettura fascista che fu l’Eur, l’unico progetto a rimanere sulla carta fu proprio quello del Danteum di Terragni e Lingeri: troppo poco retorico, troppo alto, troppo poetico per la greve propaganda di quegli anni.
Una Casa del Fascio così concepita, a ben vedere, poteva essere costruita solo qui, ai confini dell’impero italico, lontano da Roma, a pochi chilometri dalle brume calviniste. Neppure un balcone, un arengario, neppure un romanissimo arco, nessuna torre. Semmai una macchina formale perfetta. Un manifesto razionalista che sapeva essere autonomo, che guardava al mondo ma che conosceva perfettamente il valore del contesto, in polemica con le dottrine d’oltralpe. Lo dimostra il fatto che Terragni non ha rispettato nessuno dei cinque punti dell’architettura moderna che Le Corbusier imponeva a chi voleva essere à la page, riuscendo a trovare lo stesso, anzi proprio per questo, una sua lingua davvero personale, scabra e poetica.

L’incarico glielo affidano nel ’32, penso, mentre mi muovo verso piazza Cavour. Aveva 28 anni. Poco più che un ragazzo. Il razionalismo, in Italia – che poi significa a Como –, è stato una “cosa di ragazzi”. Lo erano Radice, Rho, Cattaneo, Sartori. La sua prima opera da laureato ventiduenne era stata il rifacimento della facciata dell’Hotel Metropole Suisse, quello che ho di fronte ora. Certo, nulla a che vedere con quello che sei anni dopo farà con la Casa del Fascio. Eppure si vede già la sua voglia di novità, di slancio verso il moderno, che qui ha un’inflessione viennese, secessionista. Ma era ancora un esercizio di stile, da ex studente del Politecnico. Basta proseguire, andare verso il Novocomum, verso lo stadio, quartiere all’epoca di nuova edificazione, per capire quanto la sua fosse stata davvero una battaglia civile ed etica, persino integralista, per la modernità.
Nel ’27 consegna un progetto alla commissione edilizia che poi, in cantiere, sconfessa radicalmente. Due anni appresso, compiuti solo 25 anni, tolte le impalcature rivela ai suoi concittadini questa sorta di transatlantico pronto a navigare nelle acque del lago. Uno shock. I rifacimenti del dopoguerra hanno deturpato la tavolozza cromatica dei serramenti (e qui Terragni guardava all’Olanda neoplastica e al costruttivismo russo), ma la massa tettonica, confrontata col contesto, resta considerevole.
Proprio qui dietro c’è Casa Giuliani-Frigerio, la sua ultima opera, progettata lavorando sulle sezioni e non sulle piante, mentre era al fronte. L’inizio di un nuovo percorso che purtroppo non sapremo mai dove lo avrebbe condotto. Lo so, detto così sembra che io sia preso da sacri e romantici furori. Ma forse per comprenderne il portato rivoluzionario dovremmo pensare che, mentre Terragni lavorava al cantiere del Novocomum, la città celebrava Alessandro Volta, il suo scienziato più insigne, col tempio a lui dedicato che formalmente pare provenire da un’altra epoca, da un passato pacificato e irrealistico.

E proprio a pochi passi da qui, a pensarci bene, il cerchio si chiude. Il Monumento ai Caduti sul lungolago è la sintesi materiale che tiene assieme due generazioni di giovani talenti lariani. La sua storia è presto detta: un primo progetto, il risultato di un concorso, rifiutato; poi l’idea lanciata da Marinetti di lavorare sul disegno della Torre Faro di Antonio Sant’Elia, il giovane architetto futurista morto al fronte; infine l’affido dell’esecuzione proprio a Terragni. Un passaggio di testimone inevitabile. Guardo il monolite di granito e diorite e mi commuovo. Ragazzi. Che hanno cambiato il modo di vedere l’architettura. Qui è il mio approdo, oggi. Il mio punto d’arrivo di questa passeggiata nella memoria urbana. Quanto vorrei fosse, però, un punto di partenza, logico, naturale, per ogni architetto che voglia davvero scrivere sul palinsesto della città con consapevolezza, con etica, con responsabilità.
Portarsi avanti con gli addii
Da L’infanzia vista da qui (Sottomondo, 2005)
Nelle campagne dietro Cormons
Quanta limpidezza d’aria che c’è oggi
se lo sguardo ha spazio siamo tutti viaggiatori
bastano i filari delle viti come rotta
e le scie di aerei a sostenere il cielo
Impercezione
Dormi e il tuo corpo si fa sottile
come un quadrifoglio tra le pagine
e non è carta ma stoffa di lenzuola
e non è libro ma tu portaci fortuna
in questa escoriazione fino al vivo
che per paura di essere banali
solo di rado chiamiamo amore
(a Stefania, finalmente)
Eri troppo minuta per essere donna e sorella maggiore
come sembrava impossibile che tu fossi madre
come sembrava impossibile morire di parto
nell’anno duemila di Dio
pesavi di meno di questo cognome che oggi
io porto da solo che se si potesse prenderlo
in braccio e sollevarlo come facevo con te
sarei un uomo diverso e avrei un sorriso
più facile da regalare ai miei figli
Da A ogni cosa il suo nome (Le voci della Luna, 2008)
Il terremoto del ‘76
Quando venne il terremoto del ‘76
era sera ed io avevo otto anni
uscimmo tutti di corsa nei cortili
così come eravamo, noi bambini già in pigiama
ricordo la casa che tremava nel buio
e non ho mai pensato che potesse cadere
ma avevo paura, paura per il rumore
e perché si muoveva la terra
e restava ferma l’aria
una cosa sconosciuta
il contrario del vento
A mia madre
Guardo la casa dove vivi sola
la stessa dove anch’io sono nato
e ho vissuto
dici che più niente ti lega a questa terra
che verrai ad abitare più vicina a me
non si sa mai, un’influenza
o soltanto un mobile da spostare
intanto hai rinnovato le stanze
cambiato la cucina lucidato i pavimenti
dipinto la ringhiera dello stesso colore bruciato
che ha sempre avuto
è come se prima di andare
tu mettessi in ordine i ricordi
e ho paura di pensare che hai più di settant’anni
e senza dirmi niente per non farmi preoccupare
ti stai preparando a qualcosa di più grande
di un trasloco
Tre diviso due
Ricordo che un giorno scherzavamo
se ci lasciassimo cosa sarebbe dei nostri tre figli
uno e mezzo a testa?
li taglieremmo a metà?
era un gioco stupido, ancora più stupido
adesso che sembra avverarsi
c’è una realtà dove tutti si perde
e tre diviso due fa zero
Da Portarsi avanti con gli addii (Raffaelli, 2014)
Mezzo vuoto mezzo pieno
Io ti osservo e penso sempre a tante cose
che vorrei avere più tempo
e più attenzione da te
che invece per i figli sei presente e ti consumi
come io non sarei mai capace
ma anche quando resto ai margini di te
comunque c’è bellezza nel vederti
in fondo
neanche i fiori fioriscono per noi
A conti fatti
Lo puoi vedere ancora nei miei occhi:
sono stato un bambino con poca gioia
invece il tuo sorriso esplode spesso senza alcun motivo
allora ho pensato che ne potesse avanzare per me
e anche per altri
per questo è nel tuo ventre
che ho cercato i miei figli
Izet
Devo cercare da qualche parte
una nuova sorella.
Perché io non posso
non essere fratello.
Izet Sarajlić
Non è così semplice
non essere più fratello
per anni continui a voltarti
aspettandoti la stessa faccia conosciuta
per anni ti viene da telefonare
a un numero che conosci ancora a memoria
anche se suona vuoto
pensi che a Natale devi fare gli auguri
a tutti i parenti e non
a tutti meno uno
non è così semplice
non esserti più fratello
e quando ti abitui
e quando poi ti abitui
capisci che i figli unici
soffrono sempre di solitudine
Una forma di gelosia
Ti sei addormentata ancora nuda
adesso il tuo torace si muove lentamente
lo sento appoggiandoti le mani sulla pelle
penso al fiato veloce di prima
che era tuo e nostro insieme
mentalmente faccio la differenza
per capire quanta parte del tuo respiro
sia dedicata a me
[Una mia nota di lettura sul recente libro Portarsi avanti con gli addii si può trovare qui.
Di seguito una scheda bibliografica dell’autore presentato.B.C.]
Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia, dove insegna Biologia e Chimica nelle scuole superiori. Dalla metà degli anni novanta ha partecipato a letture ed incontri nazionali ed internazionali, così come a trasmissioni radiofoniche e televisive in Italia e all’estero. I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes e siti web in Italia, Slovenia, Canada, Francia, Slovacchia, Lituania, Austria, Messico, Spagna, Svizzera, Belgio, Bulgaria, Croazia. La sua prima raccolta, “L’infanzia vista da qui” (Sottomondo), è stata edita nel dicembre 2005 e ristampata nel marzo 2006. Nel 2007 ha vinto Premio Nazionale “Beppe Manfredi” per la migliore opera prima. La seconda raccolta, “A ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna), è stata pubblicata nel dicembre 2008 ed ha ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi a carattere nazionale. Ma i premi che non ha vinto sono molti di più. Recentemente ha curato un’antologia sulla produzione letteraria della Provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi. Nel 2014 è stata pubblicata la sua terza raccolta, “Portarsi avanti con gli addii”, per Raffaelli Editore.
Abitare il romanzo
di Roberta Salardi
A me pare che più che costruire un romanzo sia bello abitare un romanzo, una scrittura. Scrivere come abitare il tempo, racconto come un luogo da esplorare nelle sue diverse possibilità. Il verbo costruire presuppone un progetto ben definito, un procedere razionale, un tendere a qualcosa, perfino un elevarsi e un compiersi, che non sempre nella dimensione reale si verificano.
Tende a qualcosa il tempo? Fondamentalmente tende alla morte, quindi il racconto-tipo potrebbe consistere in questo avvicinarsi o palesarsi della morte, in questo rapportarsi con l’apparir del vero leopardiano. Magari stare in un racconto come in un diario non personale, non per forza autobiografico, preferibilmente di finzione. Oppure no. La questione è da esplorare: non soltanto trame puntiformi ma anche complesse.
Anziché costruire: abitare, esplorare, espandere. Orizzontalità anziché verticalità del narrare. Perché continuo a usare, nonostante tutto, la parola narrare? Se nulla si muove il racconto non nasce neppure, forse resta, ne migliore dei casi, un testo filosofico o saggistico. L’orizzontalità sarà mossa, almeno un po’ increspata, dal momento che inquietudini, tensioni e dinamismi interni non possono mancare.
Non vorrei qui elencare i primi titoli famosi che vengono in mente a proposito degli spazi mentali esplorati nei romanzi (La nausea di Sartre, La montagna incantata di Thomas Mann, La palude definitiva di Manganelli, Dissipatio H. G. di Morselli, Il deserto dei Tartari di Buzzati, L’uomo avanzato di Mariano Baino) piuttosto che brani della Recherche o dell’Ulisse. Mi piace supporre che lo spazio per il dispiegamento di varie forme di pensiero, da quello argomentativo/analitico a quello associativo/intuitivo, trovi il suo luogo ideale proprio nella forma romanzo genericamente intesa: luogo dello stare, appunto, del resistere o risiedere o insistere dentro un confine dato; e dunque sia una possibilità offerta a chiunque si accinga a scrivere un romanzo.
Non m’immagino un abitare particolarmente ricco di comfort. Come discreto comfort, raro sollievo, immagino frequentazioni e dialoghi con amici o letture di scrittori e filosofi.
Infatti, che cosa rende una casa, anche povera, una splendida abitazione?, si domandava Heidegger nello scritto intitolato Abitare, costruire, pensare, che prende spunto dalla penuria di alloggi in Germania nell’immediato dopoguerra. L’abitare, modo specifico in cui i mortali stanno sulla terra secondo Heidegger, si contrappone al puro e semplice costruire, tipico anche degli animali per quanto riguarda le loro tane. Il costruire è finalizzato all’abitare e lo coltiva già nel suo farsi. La questione è che cosa vogliamo mettere dentro alle case una volta edificate. Che cosa distingue e caratterizza l’abitare umano? Le relazioni, i legami con gli altri. L’abitare è un prendersi cura all’interno delle pareti domestiche, ma anche per ciò che sta fuori: Heidegger aggiungeva infatti i legami con la terra e con il cielo (il tempo). Con questi legami s’intrattiene l’abitazione umana, che per Heidegger significa soprattutto avere cura, prendersi cura. Esistono quindi un abitare autentico e un abitare inautentico, a seconda che siano vive le relazioni o meno. Per abitare il tempo s’intende vivere la pazienza, non avere fretta, essere lontani da ritmi produttivi frenetici. E per rispetto della terra che cosa s’intende? Rispetto e valorizzazione degli spazi circostanti, una variante della relazione con gli altri, cura di ciò che sta intorno.
L’abitare, stare al di qua di una soglia, ha anche a che fare con il limite, con il senso della finitezza della condizione umana. Sapersi accogliere, riuscire a stare nei propri limiti.
Una delle ossessioni della narratologia editoriale mi pare che sia la costruzione: che un romanzo sia ben costruito, che un racconto stia in piedi e così via. Questo confezionamento, forse finalizzato a un attraversamento veloce, senza intoppi. La casa dev’essere attraversata celermente dal lettore, senza perdere troppo tempo, dev’essere visitata sotto la supervisione di un’agenzia immobiliare che dice: questo funziona, questo muro sta in piedi, qui il discorso fila e così via.
E l’aspetto abitativo, che, dicevamo è l’aspetto fondamentale, è il fine?
Arriviamo a un elemento fondamentale dell’aspetto abitativo: il personaggio. Considerato che l’io è un altro, secondo le indagini psicanalitiche, o comunque in larga parte sconosciuto a se stesso oltre che agli altri (nel migliore dei casi, senza scomodare per forza Freud e Lacan, in un semplice approccio relativistico ormai in uso nella nostra epoca: composito, sfuggente, contraddittorio), a maggior ragione, il personaggio, creazione prettamente mentale, ben di rado potrà apparire ben definito e monolitico o tutto d’un pezzo o a tutto tondo, come si suol dire. I petali che costruirono la nostra anima, per dirla poeticamente usando un’espressione di Pablo Neruda, sono gli altri, le persone che hanno preso parte alla nostra crescita e formazione, le persone incontrate in una relazione costante che continuamente può condizionarci e modificarci.
Con quest’altro termine, condizionamento, si apre un’ampia parentesi relativa agli stereotipi, dacché sappiamo che i condizionamenti possono derivare pure dai mezzi di comunicazione, dal discorso mediatico che ci avvolge. Questi stereotipi, decisivi o molto significativi per esempio per Debord (“Lo spettacolo non è un insieme d’immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini”, La società dello spettacolo) e Baudrillard (La società dei consumi, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?), in un racconto o romanzo a mio avviso sono comunque soggetti al vaglio della personalità, per quanto fragile e frastagliata sia, dei personaggi in questione. Il condizionamento non per forza deve essere fagocitante, completamente appiattente. In questo caso ritornerebbe, seppur riveduto e corretto, lo spettro del personaggio-monolite, della figura tagliata un po’ con l’accetta. Operazione che si può fare, certo, ma che rischia di apparire a lungo andare un po’ didascalica.
In una dimensione orizzontale si procede esplorando in molte direzioni. Anche testi dalla trama puntiforme come Dissipatio H.G. di Morselli oppure La palude definitiva di Manganelli indagano il più possibile la situazione in senso psicologico, metaforico, simbolico. Questa sensazione del non sapere esattamente dove ci si trova o che cosa sta succedendo, verso dove si sta andando è avvertita fortemente nella lettura; come non poteva succedere in opere più costruite, magari sulla base di trame prestabilite, con inizio, acme, scioglimento già nella testa dell’autore ancor prima d’iniziare il romanzo, magari infarcite di archetipi come l’agnizione, il ricongiungimento familiare, il matrimonio finale, la morte dell’eroe eccetera.
Di per sé il vocabolo impianto risente di un’eccessiva fiducia nella razionalità e di un riferimento implicito ai concetti di solidità, robustezza, progettualità messi in crisi già nell’Ottocento e nel Novecento.
Se proprio si deve pensare a un qualche tipo d’impianto, mi viene in mente un impianto idraulico, per il passaggio di fluidi… o un impianto elettrico, per quanto riguarda le libere associazioni, intuizioni e correspondances.
Dalle memorie di un insonne/4
di Giorgio Mascitelli
Non sempre giova una vita densa di contatti umani, apparentemente cordiali, ma in fondo superficiali; non sempre giova abusare del proprio successo in società, come se un mondo che soffre non esistesse; non sempre posso addormentarmi alle cinque del mattino, dopo essermi coricato alle due e mezza, per essere svegliato alle sette dalla sveglia.
Allora mi convenne tornare a un regime serale più domestico e sono ricorso di nuovo a quelle procedure di addormentamento dalle quali ho spesso ottenuto benefici indiscutibili. Per rinfrancarmi e prendere l’esempio, soglio pensare a esempi di sonni illustri e profondi in condizione difficili come quello di Frodo in compagnia del fido Sam e dell’infido Gollum lungo la strada segreta, erta e scoscesa che tramite il valico di Cirith Ungol porta a Mordor oppure come quello di Macbeth quando ospita nel suo castello il vecchio re. Talvolta, bisogna ammetterlo, questi esempi non hanno su di me l’effetto auspicato, ma io non mi abbatto e anche quando l’obiettivo finale non è raggiunto, valorizzo sempre i risultati intermedi. A un certo punto mi ricordai o mi fu ricordato che un rimedio antico ma salutare e sempre valido contro l’insonnia è quello di una passeggiata di un’oretta prima di andare a letto.
Scegliere questo rimedio significava fatalmente entrare in contatto con il mondo dei padroni di cani del quartiere, che conducono le loro creature all’espletazione dei bisogni prima del riposo. Non che io avessi dei cattivi rapporti con loro, anzi si può dire che i miei rapporti con il mondo della cinofilia fino ad allora erano improntati a una forse non del tutto commendevole, ma complessivamente corretta indifferenza reciproca, tuttavia essi per me rimanevano gente strana disposta a sacrificare un’ora delle propria sera per consentire ai loro protetti di scaricarsi con ogni agio in qualsiasi condizione atmosferica. D’altronde, chi va con gli zoppi impara a zoppicare. Se fossi stato stitico per esempio, avrei senz’altro incontrato altre persone e vissuto situazioni differenti.
Non che io abbia mai sofferto di questo tipo di disturbo perché al contrario proprio in bagno ho trascorso momenti felici e, per così dire, ho sempre assolto alle condizioni prescritte per poter intonare l’inno del corpo sciolto, ma ho sempre sentito in nome della comun madre una sorta di affinità elettiva con il mondo della stipsi. Se un ventre da svuotare e una notte da colmare non sono in alcun modo assimilabili e, piuttosto, conducono a esperienze, provvedimenti e conoscenze del tutto diversi, e un bacile di prugne resta per me un bacile di prugne, esattamente come per il fratello stitico e soprattutto la sorella stitica una pastiglia di valeriana resta soltanto una pastiglia di valeriana, e non posso davvero dire cosa sia per loro davvero un bacile di prugne, reputo, nonostante tutto, che le loro tribolazioni non mi siano estranee perché siamo uomini. Non so quali ostacoli incontrino sulla loro via, ma vedo al fondo la medesima angoscia che per mezzo di una notte di veglia o di una pancia gonfia ci è comunicata dalla precarietà del nostro stare al mondo.
Sì, laddove le persone serie che sanno già qual è la loro strada non vedono che insonni o stitici, io vedo l’uomo. Spesso, nell’accingermi a raccogliere queste mie memorie, mi andavo ripetendo che con esse avrei voluto erigere un monumento forse modesto ma di marmo imperituro alla veglia forzata, ora che scorgo nella penombra di una lampadina accesa tutta la notte sopra un comodino o dietro le scatole ammonticchiate di beveroni ricchi di fibre e purghe naturali e chimiche le fattezze dell’uomo, mi accontento di lasciare trascritto su ghiaia fugace, come si conviene al nostro tempo, qualche palpito non insincero.
Dunque, fatalmente cominciai a prendere confidenza per via delle mie passeggiate serali con i passeggiatori di cani: la diffidenza era reciproca e i saluti brontolati e gli sguardi sbiechi. Dal canto mio, come già detto, non potevo che nutrire sospetto per chi trae piacere dal sacrificare le ore riservate al riposo o al diporto per consentire a un animale, una creatura, per quanto gli manchi solo la parola, di fare i propri sozzi comodi sul marciapiede in un silenzio imbarazzato e imbarazzante come è del resto prevedibile in compagnia di una creatura priva della facoltà del linguaggio, impestando successivamente le suole di tanti onesti passanti. Da parte loro, ammettiamolo, non poteva che suscitare diffidenza uno che per addormentarsi faceva una lunga passeggiata, una cosa che fa molto boy scout o proprietario terriero del secolo decimonono o poeta ermetico. Certo non è che potessi diventare uno schiavo di Big Pharma in attesa, come un tossico, del nuovo sonnifero messo sul mercato per tranquillizzare i loro timori da borghesucci. Forse non avrò rapporti del tutto sereni con il vicinato, ma sono un uomo libero!
Infine l’abitudine, la Grande Ottimizzatrice, creò tra noi una situazione di fatto di mutua sopportazione, una sorta di modus vivendi o meglio videndi, visto che i nostri rapporti consistevano essenzialmente nel guardarci di sottecchi e subito dopo nello scambiarci saluti gutturali. Così pian piano, facendo ricorso al mio proverbiale spirito di tolleranza ( da bambino durante le colonie estive a Camogli presso i Padri Sefarditi mi chiamavano il piccolo Voltaire), mi convinsi che un uomo non deve essere giudicato per come trascorre il proprio tempo libero, anche se lo passa a curare che i suoi migliori amici espletino i loro bisogni; a loro volta essi si persuasero che non ero nient’altro che un innocuo stravagante col quale si poteva perfino scambiare qualche parola.
Addirittura un professore in pensione che portava il suo cagnolino al pascolo inverso prese a salutarmi chiedendo a che punto era la notte. Se dapprincipio accondiscesi con simpatia al suo saluto come quello di uno che cercasse di vedere l’uomo e non l’insonne ( così io del resto mi sforzavo di vedere in lui l’uomo non l’accompagnatore del cane), poi esso principiò a irritarmi perché mi parve una mancanza di rispetto, come se io fossi una volgare sentinella e lui un uomo preso da sofferenze interiori. Nulla di più falso, invece, perché ero io, con i miei tormenti che mi impedivano di prendere sonno, che con tutta chiarezza denunciavo una travagliata vita interiore, mentre lui era soltanto uno che portava fuori il cane affinché non gli cagasse in casa, a orari regolari, perdipiù, proprio come le sentinelle. Le sue provocazioni divennero insostenibili, la situazione degenerò, lo sfidai a duello e lo schiaffeggiai.
Scegliemmo di incontrarci alle sei del mattino del sabato successivo in un prato presso la cascina Monlué, sarebbe stato più adatto qualche luogo nel parco della Villa Reale di Monza, ma lo scartammo sia per il timore di incappare in qualche pattuglia della polizia di stato sia di perderci. A lui in quanto sfidato toccava la scelta delle armi. L’unico problema furono i padrini, visto che lui aveva indicato altri due pensionati proprietari di cani; io purtroppo non conoscevo insonni affidabili per un incarico così delicato e poi francamente di restare ferito ( si era optato per un duello al primo sangue) davanti a uno che si metteva magari a sbadigliare mi rugava un po’. Si decise allora che avremmo trovato i miei padrini tra coloro che andavano al vicino ortomercato per farsi ingaggiare come scaricatori di camion.
Confesso che quella sera tornai a casa vuoto e presi sonno con facilità, rinfrancato dal pensiero che la notte prima del duello avrei avuto tutte le giustificazioni per restare sveglio, come accade sovente a coloro che al mattino presto successivo avranno un duello.
Mi recai sul posto prescelto mezz’ora prima dell’ora stabilita, come è giusto per uno sfidante, aspettandomi di trovare lì per lo meno i suoi padrini. Restai per circa un’ora in compagnia delle sole zanzare che in quel luogo, un’ex risaia, non si peritano di sapere a quale punto siano la notte e il giorno. Dopo circa un’ora il mio cellulare fu animato dal trillo che annunciava il ricevimento di un messaggio. Lo aprii e sul display apparve la scritta “Pirla!”.
(4,continua)
cinéDIMANCHE #13 “La regina delle nevi” di Lev Atamanov [1957]
di Cristina Babino
- Hai ancora freddo?
- Si, ho freddo, e sento male qui dentro.
- E allora non ti bacerò più.
Il Natale a casa mia non è mai stato un evento granché celebrato. Mio padre, ferroviere, nei giorni di festa era molto più spesso via per lavoro che con noi a riposare e a godersi, appunto, la festa. E Natale non faceva eccezione. Per cui quasi sempre si restava in casa, mia madre, mia sorella ed io. Mia madre un po’ contrariata, ma tutto sommato sollevata dal non dover indulgere in stressanti preparativi, io e mia sorella rassegnate, e nemmeno tristi. Andava così. In fondo i nostri regali li avevamo avuti. In fondo noi due si stava bene insieme, in quelle giornate, chiuse nella nostra cameretta con la carta da parati a strani motivi blu e arancio, molto anni ’70, e pochi giochi, rigorosamente da condividere: un paio di barbie, uno spiderman di gomma, un goldrake in gommapiuma grande quanto me, preso coi punti di qualche supermercato. Quello sì, meraviglioso.
Dei pomeriggi natalizi ricordo soprattutto, alla tv, un cartone animato. Uno di quelli che davano puntualmente in quel periodo dell’anno, sotto le feste. Un vecchio film di animazione russo, l’unico del genere che mi abbia lasciato un segno davvero forte nella memoria. Sarà per l’ambientazione glaciale che tanto bene si sposava al freddo che bussava allora alle finestre. Sarà perché era la storia di due bambini, amici e quasi fratelli.
De La regina delle nevi conservo negli occhi soprattutto una scena, che è per me l’immagine stessa del Natale, di quello della mia infanzia. Un bambino biondo, delicatissimo, nei lineamenti e nei movimenti, che gioca intento con dei prismi di ghiaccio. Li tiene pensoso tra le mani, ne valuta la consistenza, la perfezione gelata e lucente. Si accorge però, deluso, che non hanno profumo. Dice: «L’amore non ricordo. Però ricordo una cosa: Gerda».
Il nome del bambino è Kai, e Gerda è la sua amica inseparabile. Insieme vivono una fanciullezza allegra e spensierata, giocando al sole pallido del nord, ascoltando i racconti della nonna davanti al fuoco, e coltivando rose. Gelosa della loro felicità e indispettita dalle loro risa, la Regina delle Nevi, bellissima e spietata, scatena una terribile tempesta di neve. Una scheggia di ghiaccio incantata entra nell’occhio di Kai e il maleficio lo rende improvvisamente crudele, il suo cuore insensibile all’affetto della piccola amica. Non contenta, la Regina rapisce il bambino e lo conduce nel suo palazzo di ghiaccio, dove lo istruisce affinché dimentichi l’amore, la bellezza e tutte le gioie di cui ha vissuto sino a quel momento, per sostituirle con la quiete gelida e immobile dell’indifferenza. Inconsolabile, sola e senza scarpe, la piccola Gerda parte alla ricerca di Kai. Un viaggio difficile e pericoloso, lungo una terra fredda e spesso ostile, che ha tutto il carattere della quest, e costellato di incontri magici e più o meno salvifici: la vecchia signora che con un pettine magico vuol far scendere l’oblio su Gerda, così che non soffra più per la perdita dell’amico, il corvo parlante, la buona pescatrice e la maga finlandese che aiutano Gerda a giungere a destinazione, e il personaggio, di insolita ambiguità, della piccola ladra, che prima deruba e imprigiona Gerda insieme agli animali che sadicamente tiene in gabbia, quindi la libera – e li libera tutti – mossa a compassione dalla sua storia e dalla gentile purezza del suo animo. Raggiunto finalmente il castello, l’affetto profondo e indissolubile che lega i due bambini oltre ogni possibile amnesia o distanza spezza l’incantesimo e costringe l’odio della Regina a sciogliersi come neve al sole.
A questo film hanno rimproverato un disegno poco accattivante, meno fluido rispetto ai capolavori Disney, una lentezza poco vendibile nello sviluppo della trama. A me sembra di riconoscere nella staticità di alcuni fotogrammi, specie nella rappresentazione dell’algida Regina, un riferimento forse inconsapevole, ma ancora più autentico, a quella Uta degli Askani a cui già si ispirò Disney per realizzare la sua Grimilde. Riconosco nelle delicate gestualità di Gerda e Kay dei dettagli accurati e poeticissimi, una grazia quasi di antica miniatura, e nel personaggio di Ole Lukoje, dio dei sogni senza invero molto physique du rôle – piuttosto un incrocio tra un minuto nonnino e un folletto magico – una voce narrante/moralizzante che tanto mi ricorda il Grillo parlante. Solo più simpatico, senescente e antropomorfo.
Oggi che sono sulla soglia dei quaranta, e madre, e rivedo questo film con mia figlia, non so dire la soddisfazione quando mi dice, contro ogni pronostico e aggressione pubblicitaria, che lo preferisce al recente Frozen, rifacimento rutilante e rumoroso, in chiave pseudo-femminista, della medesima fiaba di Andersen. Qualcosa di me, del mio essere stata bambina, mi illudo di averle trasmesso.
 Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Il Valle dopo il Valle (intervista a Valerio Aprea)
a cura di Carlo Baghetti
Ritornai a vivere in Italia, dopo una parentesi durata alcuni anni in Francia, a causa di due ragioni: l’occupazione del Teatro Valle e la crisi politica di Silvio Berlusconi. A dire il vero le ragioni erano tre, ma la terza purtroppo è durata troppo poco: la generazione TQ.
Ci volle poco tempo a rientrare nel giro teatrale che lasciai prima di partire. La curiosità mia e l’eccitazione che vedevo in giro era tanta, tantissima. Certo non mancavano voci critiche, di persone che lavoravano al Valle fino a poco tempo prima e che erano state lasciate per strada o di patentati scettici, ma tutto sommato la capitale, ovviamente quella che frequentavo e che ero venuto apposta per conoscere, era entusiasta.
Dei fantasmi della democrazia
 di Lorenzo Rustighi
di Lorenzo Rustighi
Pochi giorni fa abbiamo visto Marine Le Pen e Massimo D’Alema fronteggiarsi in una battaglia di retorica televisiva, che verteva sull’utilità e il danno delle istituzioni europee, delle strategie monetarie dell’Eurozona, dell’appartenenza alla UE, del ritorno alla sovranità politica ed economica, e affini. Ci hanno presentato punti di vista apparentemente molto diversi. Ciascuno dei due, tanto per cominciare, ha accusato l’altro di essere testimone di una sorta di anacronismo epocale: l’uno arroccato su una posizione difensiva, vigliacca, retrograda, “comunista”, l’altra in preda alla nostalgia reazionaria della nazione autarchica, quella del sangue e della terra. Se D’Alema sosteneva la necessità di continuare a fare fronte comune con l’Europa in un panorama di processi sociali ed economici di entità globale, dove lo Stato-nazione non sarebbe che un residuo della storia costituzionale del XIX secolo, Le Pen insisteva invece sull’urgenza di una ripresa di possesso di tipo territoriale, amministrativo e non da ultimo etnico da parte dei paesi europei. E ancora, Le Pen imputava all’Euro e alla sua agenda finanziaria la responsabilità del declino economico e sociale che ci investe; D’Alema invece ha ripetuto come il fattore determinante non debba essere rintracciato nella negatività intrinseca del sistema economico ma nella cattiva politica che ne ha fatto ostaggio, non nelle istituzioni, quindi, ma nell’azione dei governanti contro l’interesse dei governati – il “liberismo selvaggio”, come lo ha definito l’ex premier, salvo poi dimenticarsi di aver sostenuto, quando dalla parte dei governanti ci stava lui, una delle guerre chiave della grande stagione neo-liberista inaugurata dal terzo millennio.
Su due punti, però, i due interlocutori mi sono sembrati, assai sintomaticamente, d’accordo: il problema della democrazia e il problema della crisi. Orizzonte comune, cioè, sembra essere anzitutto un certo appello emergenziale alla centralità della prassi politica come prassi democratica, giocata cioè questa volta dalla parte dei governati, dalla parte del popolo o dei popoli, che in un caso come nell’altro sarebbero chiamati a riprendersi, strappandola alla cattiva politica, la scena di una politica autentica. Nell’una come nell’altra prospettiva, il problema di fondo sembra risiedere in un difetto, un “troppo poco” di democrazia, nell’assenza strutturale del popolo dal proprio destino. Che si scelga il ritorno all’indipendenza sovrana o che si chieda una politica comunitaria più genuina, diretta e trasparente, allora, non fa troppa differenza: ciò che importa è che il popolo si sottragga alla bugia che l’ha ingannato, al tradimento di chi ne ha pervertito le intenzioni, alle pratiche che ne hanno violato la fiducia, che il popolo in definitiva possa cominciare o ricominciare a governare sé stesso. Ed è proprio qui che si profila la crisi. Crisi economica, certo, crisi del lavoro, dei salari, della mobilità sociale, degli investimenti, quella crisi che negli ultimi anni ha scosso vecchie certezze o riconfermato le incertezze, che ha fatto esplodere proteste, lotte, rivendicazioni, ma anche pessimismi, chiliasmi, teorie del complotto. Ma prima ancora è in gioco la crisi della democrazia e delle istituzioni repubblicane, che erode infallibilmente il vincolo del mandato politico, che precipita le promesse del buon governo nell’abisso della malafede e dell’abuso, che trasforma il sogno edificante della partecipazione nell’incubo misterioso e intollerabile dell’esclusione. E allora tornare alle redini della democrazia sembra la sola parola d’ordine possibile, correggere ciò che è stato sbagliato, raddrizzare ciò che è stato storpiato, riportarsi sulla strada maestra, su questo Le Pen e D’Alema si trovano uniti: la democrazia che vive nell’ortopedia sempiterna del suo sempiterno fallimento. Perché la democrazia dei governati è esercizio di una critica fondamentale. E la critica, ci insegna Koselleck, è inseparabile dalla crisi. Meglio ancora, l’homo democraticus è l’uomo di un potere in crisi, perché il potere in qualche modo è sempre di troppo, è un fardello ingombrante, è il rovescio della libertà, negazione della verità, soppressione dei diritti: occorre continuare a dire la verità al potere perché il potere ci governi con la verità, lo si deve smascherare, obbligare, incatenare, controllare, e in fin dei conti bisogna sempre sbarazzarsene. Il diritto, quello vero, sarebbe in qualche modo uno spazio libero dal potere. Il popolo della democrazia, allora, popolo depositario de iure del discorso vero, è sempre stato un popolo che complotta contro il complotto originario del potere. Perché governare significa sempre necessariamente nascondere qualcosa, tradire qualcuno: non si può governare innocentemente, diceva un grande campione della nostra storia democratica. Ecco perché la storia della democrazia è la storia di una crisi, che ora sembra intrecciarsi, confondersi con la crisi di un destino in perenne recessione: il soggetto in crisi ha da difendersi su due fronti, ora, sul fronte del potere e su quello dello scacco del potere.
Il mito della purezza, del popolo sovrano, della volontà generale, della verità contro la falsità, della libertà contro il governo, è stato un tempo il vettore di una riconquista dei processi sociali da parte della riforma degli strumenti amministrativi; è stato il luogo di articolazione della proprietà, dell’accumulazione e dell’interesse alla superficie liscia e docile del contratto sociale; è stato lo spazio di applicazione del lavoro e delle sue discipline ad una rete di autorità indisponibili agli occhi e alla spada del Leviatano. Dove si trova la nazione? – chiedeva Sieyès? Bisogna andarla a cercare nelle provincie, nelle diocesi, nelle circoscrizioni, nelle nervature reali di un tessuto sociale segnato dal lavoro, dalla produzione, dai servizi, dall’amministrazione. La rivoluzione e la sua forza costituente parte da qui. È la grande finzione del popolo, certo, mappa di soggettività, volontà e diritti che catturano i corpi della nation. Ma la crisi della democrazia ha saputo essere il motore di una critica rivoluzionaria permanente, dissolutrice e creatrice ad un tempo, che la nazione del XIX secolo ha dovuto disciplinare, ricombinare ed integrare se voleva essere in grado di governare una crisi più radicale e spaventosa, quella del conflitto di classe.
Ma dov’è oggi il popolo democratico di Le Pen e di D’Alema? Dove si trova quella nazione che, tradita per un verso o per un altro, dimenticata dagli uni o dagli altri, dovremmo riportare alla ribalta della politica? Che voce ha quella cittadinanza che, ci dicono, deve ricominciare ad essere ascoltata? E quali colori, quali corpi espone agli occhi del potere? Sta proprio qui, forse, il più grande e il più sottile tradimento che dovremmo iniziare a criticare. Perché il discorso democratico si è trasformato totalmente da discorso sulla crisi in discorso della crisi. Non è più, cioè, un discorso capace di analizzare, dissolvere, dislocare il potere, di creare costellazioni, norme, soggetti, istituzioni – che certamente possono, devono essere oggetto di un’altra, diversa e più profonda critica. No, il discorso della democrazia oggi riesce solo ad introiettare completamente la propria disfatta, ad identificarsi con la propria impossibilità, con la propria angoscia, ad armarsi contro di essa; è un discorso in guerra, che mobilita il ressentiment di un popolo senza nome, in grado di tacere, di dimenticare e rifiutare l’infinita ricchezza di una cittadinanza fatta di superfici frastagliate e discontinue, scenario di linguaggi, di costituzioni, di differenze, di confini e di conflitti la cui materialità vivente non sa essere ricondotta all’antico fantasma del popolo della sovranità democratica. La democrazia paladina di una verità massimamente oscena, dell’occultamento più imperdonabile: non solo non è rappresentata da nessuno, ma prima ancora non rappresenta nessuno; sembra spiegare tutto e invece non ci spiega nulla; vorrebbe comprendere tutti ma non sa che cancellarci tutti. Questo fantasma sempre vilipeso, sempre inascoltato, sempre sotto attacco, che adesso non fa che tapparsi le orecchie e serrare gli occhi e affilare i denti dinanzi allo spettacolo meraviglioso e terribile di forme di vita, identità, culture, erranze e composizioni che reclamano categorie di governo nuove, nuove pratiche di cooperazione, nuove definizioni del lavoro, una nuova nozione di libertà. Si tratta allora per noi di operare uno spostamento fondamentale, verso il rifiuto di questa guerra in nome del popolo e contro il popolo stesso, ormai assolutamente introvabile, svanito, evaporato, non solo perché incommensurabile ai corpi esuberanti e multiformi delle nostre città e della nostra esperienza, ma anche perché annientato dalla tirannide della società democratica. Si tratta, in ultima analisi, di sottrarsi a quella serie argomentativa asfittica e reazionaria che continua a rappresentarci l’Europa come il catalizzatore di una falsa alternativa, quella tra la riappropriazione di una volontà sovrana originaria e la sua monolitica proiezione sulle istituzioni europee. Cominciare a pensare l’Europa, piuttosto, come il laboratorio di una relazione etica e politica che la democrazia della crisi non può e non deve più afferrare.
*immagine: Agim Sulaj
ENEIDE – libro I, [a-d], 1-156; libro IV, 296-387; libro IX, 387-444; libro XII, 919-952.
 trad. isometra di Daniele Ventre
trad. isometra di Daniele Ventre
Protasi – La tempesta –Eneide – libro I vv. [a-d], 1-156
[Io, che in passato intonai su gracile canna il mio canto,
poi, fuoriuscito dai boschi, piegai le vicine campagne,
sì che rendessero pago l’avaro colono, fatica
ai contadini gradita, ora invece, orrori di Marte,]
Canto le armi e l’eroe, che primo dal suolo di Troia
mosso dal fato raggiunse l’Italia e le sponde lavinie
profugo; a molto vagare lo spinsero in terra e sull’onde
forze superne, per l’ira tenace dell’aspra Giunone,
molti dolori anche in guerra patì, per fondare nel Lazio
una città, per condurvi gli dèi: di qui il seme latino
e i nostri padri, gli Albani, e dell’alta Roma le mura.
Musa, le cause ricordane a me: che ferì quella dea,
che lamentò, la regina dei numi –e forzò ad affrontare
tante vicende un eroe per pietà glorioso, a subire
tante sciagure? Sì grande è l’ira nei cuori celesti?
Era un’antica città, la tennero tirii coloni,
contro l’Italia e le foci del Tevere sorta, lontano,
ricca di beni, Cartagine, e fiera alle prove di guerra;
più d’ogni terra Giunone quell’unica, è fama, ebbe cara,
e l’antepose perfino a Samo: eran lì le sue armi,
v’era il suo carro; la dea sin da allora brama ed agogna
che reggitrice di genti divenga, ove piaccia ai destini.
Ma una progenie, ella udì, dal sangue troiano nasceva,
tale, che avrebbe in futuro distrutte le torri dei Tirii;
donde una stirpe dai vasti domini e temibile in guerra
strage di Libia farebbe: le Parche filavan l’evento.
Questo temé, la Saturnia, tenace al ricordo d’antica
guerra che a Troia fra i primi ingaggiò per Argo diletta,
(e non ancora le cause dell’ira e i cocenti dolori
l’eran caduti dal cuore; al fondo dell’animo infitti
stanno il giudizio di Paride, ingiuria a beltà dispregiata,
di Ganimede rapito la stirpe aborrita e gli onori);
più da quegli odi infiammata, ovunque sul mare spingeva
quanti Troiani fuggirono i Danai e Achille crudele,
li ricacciava lontano dal Lazio; e così per molti anni
essi vagarono in tutti i mari, in balia dei destini.
Era di tanto gravame fondare la gente di Roma!
Fuori di vista da poco da terra di Siculi, al largo,
gai veleggiavano e ai rostri frangevano spume di sale,
quando Giunone, che in petto covava un’eterna ferita,
disse fra sé: “Che io vinta desista da quel che intrapresi?
Ch’io dall’Italia non possa sviare il sovrano dei Teucri?
Certo, lo vietano i fati. Ma Pallade ben ha potuto
dare alle fiamme una flotta d’Argivi e sommergerne in mare
gli uomini, colpa e follia d’uno solo, Aiace l’Oilide!
Ella avventò dalle nubi il rapido fuoco di Giove,
quindi disperse le navi e sconvolse il mare coi vènti:
abbandonò al turbinio, su uno scoglio aguzzo confisse
lui, ch’esalava dal petto trafitto un respiro di fiamme;
io che regina dei numi incedo, io sorella e ad un tempo
sposa di Giove, frattanto, una sola gente combatto
già da molti anni. Ed ancora alla dea Giunone qualcuno
leva preghiere o sull’ara le rende, da supplice, onore?”
Questo la dea meditava fra sé, nel suo animo acceso,
e in luoghi fertili d’austri furiosi, alla patria dei nembi
venne, in Eolia. Qui Eolo sovrano, in un’ampia caverna,
sotto il suo regno reprime e in ceppi e prigioni contiene
gli irrefrenabili vènti e le fragorose tempeste.
Essi, furenti di rabbia, con forte boato del monte,
fremono dentro quei chiostri; sta Eolo sull’alto del picco,
stringe lo scettro e ne placa i cuori, e ne modera l’ira.
Che non lo faccia, e con sé mari e terre e cielo profondo
d’impeto travolgeranno, li disperderanno nel vuoto.
Questo temeva e li chiuse in oscure latebre, il padre
onnipotente, e su loro una mole d’alte montagne
fece gravare ed impose un re che con ordine fermo,
ad un suo cenno, sapesse serrare e allentare le briglie.
Supplice a lui si rivolse con queste parole Giunone:
“Eolo (a te il padre dei numi, sovrano degli uomini, ha dato
di racquietare i marosi e di sollevarli nel vento),
naviga il mare Tirreno una gente a me non amica,
verso l’Italia trasporta con Ilio i suoi vinti penati:
sfrena la forza dei vènti, sommergi e travolgi le prore,
per ogni dove disperdili e spargine i corpi sull’onda.
Ho presso me sette ninfe e sette, d’altera bellezza,
d’esse, colei che su tutte risplende in beltà, Deiopea,
unirò a te con sicuro connubio e farò che sia tua,
sì che al tuo fianco, per questi tuoi meriti, tutti i suoi anni
ella trascorra e ti renda parente di splendida prole”.
Eolo di contro le disse: “Tua cura, o regina, è vagliare
quello ch’è il tuo desiderio; mia legge è obbedire al comando.
Sia quel che sia, tu il mio regno mi doni e lo scettro di Giove
rendi benigno; tu dài che io sieda a mensa fra i numi
e delle nubi mi fai e delle tempeste sovrano!”
Come ebbe detto, girò lo scettro e batté la parete
all’incavata montagna; i vènti, a un serrarsi di schiere,
corrono, schiusa la via, di turbini squassan la terra.
Precipitarono al mare e tutto dagli ultimi abissi
l’Euro e al contempo anche il Noto lo smossero e greve di nembi
l’Africo e contro le sponde rivolsero vasti marosi.
Ecco innalzarsi clamore di genti e stridore di funi.
Allontanarono i nembi d’un tratto alla vista dei Teucri
giorno e sereno: calò sul pelago nera la notte.
Tuonano i poli, e frequente di folgori l’etere guizza,
ed ogni cosa minaccia agli uomini prossima morte.
In un momento ad Enea si sciolgono in gelo le membra:
rompe in un gemito, alzando alle stelle entrambe le mani
queste parole egli grida: “O tre, quattro volte beati,
voi, a cui in vista dei padri e dell’alte mura di Troia
sorte toccò di perire! O Tidide, il più valoroso
della semenza dei Danai! Perché non potei nella piana
d’Ilio cadere e gettare così per tua mano la vita,
dove si giace, per l’arma d’Eàcide, Ettore fiero,
dove è Sarpèdone il grande, e tanti rapì Simoenta,
volse nell’onde elmi e scudi e validi corpi d’eroi!”
Mentre così si lamenta, un nembo, un urlio d’aquilone,
coglie di fronte la vela, alle stelle innalza i marosi.
Cedono i remi; la prua, ecco, gira, e all’onde il suo fianco
volge: crollò il monte d’acqua precipite con la sua mole.
Pendono alcuni su creste di flutti, e tra i flutti, sorgendo,
l’onda apre ad altri il fondale, ne bolle la furia alle sabbie.
Noto, rapite tre navi, le avventa su rocce nascoste
(rocce nel mezzo dei flutti, che gli Itali chiamano Altari,
dorso gigante sul pelo dell’acqua), e tre l’Euro dal largo
ai bassi fondi, alle Sirti sospinge –ahi, pietoso a vedersi!–
e tra le secche le getta, le cinge d’un muro di sabbia.
A un’altra nave, che i Lici e il fedele Oronte portava,
sotto la vista d’Enea, un’onda mostruosa dall’alto
coglie la poppa; è sbalzato in avanti e cade il nocchiero,
giù, capofitto; tre volte la fece girare il maroso,
la roteò, l’inghiottì l’impetuoso gorgo nel mare.
Uomini sparsi si scorgono a nuoto nel vortice vasto,
armi d’eroi e relitti e gemme troiane fra l’onde.
Già sulle solide navi d’Iliòneo e del valido Acate,
già sulle prore che Abante portavano e Alete longevo
ebbe la meglio quel nembo: dal franto fasciame dei fianchi
tutte ricevono l’acqua nemica e son piene di falle.
Ma percepì, nel frattempo, Nettuno, a quel forte boato,
l’onda sconvolta e sfrenato il nembo e negli ultimi abissi
smossi i più quieti fondali, e assai fu turbato; dal largo
sporse, guardando, a fior d’acqua il volto, a portare la pace.
Vide la flotta d’Enea per l’intero mare dispersa,
vinti dai flutti i Troiani e dalla rovina del cielo.
Né di Giunone sfuggì rabbia e dolo, al dio suo fratello.
L’Euro e lo Zefiro a sé richiama, e così dice loro:
“Tanta superbia allignava in voi della vostra progenie?
Vènti, già avete l’ardire di smuovere il cielo e la terra
senza il mio cenno e destare marosi di simile altezza?
Io vi… ma prima conviene acquietare i flutti agitati;
poi pagherete con pena inaudita i vostri misfatti.
Allontanatevi in fuga, a quel vostro re riferite
ch’egli non ebbe il dominio del mare e l’immane tridente,
io dalla sorte l’ottenni. Su rocce scoscese egli impera,
Euro, sui vostri ripari; di quella sua reggia s’esalti
Eolo, governi da re nel carcere chiuso dei vènti”.
Dice, ed in men che non dica, pacifica i gonfi marosi,
fuga le nubi ammassate e riporta il sole di nuovo.
Via dall’aguzza scogliera con forza Cimòtoe e Tritone
tolsero insieme le navi, il dio le innalzò col tridente,
quindi dischiuse le sirti immani e placò la distesa,
poi con le ruote leggere volò sulle creste dell’onde.
Come sovente in un popolo immenso, al momento in cui scoppia
la ribellione e s’accendono i cuori all’anonima torma,
subito volano torce e pietre e follia porge l’armi;
se d’improvviso, a quel punto, han veduto un uomo onorato
per pietà e meriti, tacciono e aspettano, tese le orecchie:
con la parola egli domina i cuori e pacifica i petti:
cadde così tutto il rombo del mare, allorché il genitore,
sulla distesa guardando, passò nell’aperto sereno,
resse i cavalli e diè in volo di briglie al suo docile carro.
* * *
Enea e Didone – Eneide Libro IV, vv.296-387
Ma presentì quegli inganni (chi sfugge a una donna in amore?)
e le imminenti partenze per prima intuì la regina,
d’ogni certezza temendo. La stessa empia Fama all’insana
già rivelò che s’armava la flotta, era pronta a salpare.
Fuori di senno, impazzisce, e per la città va furiosa,
rabida, come al destarsi dei sacri cortei, l’invasata
tìade, quando di Bacco ode il grido e l’orge triennali
l’eccitano –Citerone a notte la chiama con voci.
Prima parlò, finalmente, ad Enea con queste parole:
“Tanto delitto speravi, tu, perfido, che si potesse
dissimularlo? E partire in segreto dalla mia terra?
Non ti trattengono il nostro amore e la mano che un tempo
tu mi porgesti, e Didone votata a una morte crudele?
Anzi perfino col cielo invernale appresti la flotta,
e fra gli urlii d’aquilone hai fretta di prendere il largo,
tu, scellerato! E se poi non cercassi terre straniere
e sconosciute dimore e l’antica Troia s’ergesse,
dirigeresti su Troia le prue per l’ondosa distesa?
Fuggi da me? Io per queste mie lacrime, per la tua destra,
(già, poiché nulla di più m’è rimasto, me sventurata!)
e per la nostra passione, e per gli iniziati imenei,
se meritai qualche bene da te, se per me qualche gioia
mai ti fu dolce, ti imploro, pietà d’una casa in sfacelo,
se v’è più spazio per una preghiera, ah, deponi l’intento!
M’odiano solo per te le genti di Libia, i tiranni
Nomadi; i Tirii mi sono ostili; e per te, non per altri,
la pudicizia è in me morta, quell’unica gloria per cui
venni alle stelle. A che sorte abbandoni me moritura,
ospite? L’unico nome che resti del nome di sposo…
Che più m’attendo? Che queste mie mura le abbatta il fratello
Pigmalïone, o mi tragga al servaggio Iarba il getùlo?
Ah, se soltanto da te, prima della fuga, mi fosse
nato un bambino! Se solo, a palazzo, almeno, giocasse,
a ricordarmi di te col suo volto, un piccolo Enea,
certo non mi sentirei del tutto delusa e tradita”.
Disse. Negli ammonimenti di Giove egli fissi teneva
gli occhi e forzando se stesso, premeva l’angoscia nel cuore.
Poco, alla fine, parlò: “Per quanti tu valga a elencarne
e a noverarne, regina, io non negherò gli infiniti
meriti tuoi, né mai grave sarà ricordarmi d’Elissa,
fin che di me mi ricordi e regga le membra il respiro.
Poco dirò del mio intento. Non crederlo, no, non sperai,
io, di celarti una fuga furtiva, e del resto nemmeno
torce nuziali innalzai, ed a tali patti non venni.
Se mi lasciassero i fati condurre secondo i miei voti
questa mia vita, e sedare a mio modo queste mie pene,
prima la rocca di Troia, le dolci reliquie dei cari
raccoglierei, l’elevata dimora di Priamo vivrebbe,
Pergamo rasa due volte io ai vinti offrirei di mia mano.
Ora, però, tanto Apollo Grineo che le sorti di Licia
ordinano che l’Italia spaziosa io ricerchi, l’Italia.
Quello il mio amore e la patria. Ché se di Cartagine i tetti
t’hanno chiamata, Fenicia, l’attesa di libiche mura,
che nella terra d’Ausonia risiedano i Teucri, che invidia
è questa mai? Nostro fato è cercare un regno straniero.
Il padre Anchise, ogni volta che notte ricopre la terra
d’ombre stillanti, ogni volta che sorgono gli astri infocati,
me con visioni ammonisce e sgomenta, immagine fosca.
L’onta all’affetto più caro me morde, ad Ascanio fanciullo,
che del dominio d’Esperia derubo e dei campi fatali.
Ora anche il messo dei numi, inviato da Giove in persona
(giuro sul capo d’entrambi), portò con le celeri brezze
tali comandi: ho veduto il dio nel più chiaro fulgore
oltrepassare le mura, ne bevve la voce il mio orecchio.
Smettila d’esasperare me e te con le tue lamentele;
non per mia voglia io ricerco l’Italia”.
Mentre le parla così, a lungo ella torce lo sguardo,
gli occhi distoglie di qua, di là, con i muti suoi lumi
per ogni dove si volge, ed accesa, infine, prorompe:
“Non una dea fu tua madre, né è Dardano padre al tuo seme,
perfido, ti generò fra dirupi impervi l’orrendo
Caucaso, tigri d’Ircania offrirono a te le mammelle!
Ora a che fingere, a quali più grandi sciagure serbarmi?
Ha sospirato una volta al mio pianto? Ha vòlto il suo sguardo?
Lacrime, vinto, ha versato, ha avuto pietà di chi l’ama?
E che dirò che sia peggio? Ormai né Giunone suprema,
né il genitore saturnio qui posano equanimi gli occhi.
Mai ben riposta è fiducia. Gettato a una riva l’ho accolto,
e bisognoso, e l’ho messo a parte d’un regno, insensata:
gli ho ricondotti i compagni da morte e la flotta perduta.
M’ardono, in loro balia, ahi, le furie! Ora auspice è Apollo,
ora le sorti di Licia, inviato da Giove in persona,
porta ora il messo dei numi nell’aria gli atroci voleri.
Già, tanta angoscia affatica gli dèi, ne sconvolge la quiete
tanta apprensione! Non io ti freno, e non ho da smentirti.
Segui col vento l’Italia, va’ via, cerca un regno fra l’onde.
Spero che in mezzo agli scogli, se i numi pietosi han potere,
tu sconterai la tua pena, e più e più volte Didone
invocherai. Seguirò te con nere tede, lontana.
Quando la gelida morte dell’anima privi le membra,
ombra al tuo collo dovunque sarò. Pagherai, scellerato!
Io lo saprò, ne verrà tra i mani in abisso la fama!”
* * *
Enea e Didone nell’Ade – Eneide, Libro VI, vv. 434-474
Sono in un luogo vicino gli afflitti che diedero morte
di propria mano a se stessi, innocenti, e odiando la luce
le loro vite gettarono. O quanto nell’etere aperto
ora vorrebbero avere miseria e travaglio crudele!
Fato lo vieta e coi tristi suoi flutti l’odiosa palude
li àncora, Stige li chiude scorrendo nei nove suoi cerchi.
E non lontano di lì, estesi per ogni contrada,
s’aprono i Campi di Lutto: è il nome con cui son chiamati.
Quelli che amore spietato consunse d’un male crudele,
qui li nascondono occulti sentieri e una selva di mirti
dentro li accoglie; nemmeno in morte li lascia l’affanno.
In questi luoghi sia Fedra, sia Procri, sia, mesta, Erifìle,
che le ferite del figlio feroce palesa, Enea vide,
e poi Evadne e Pasìfae; a queste s’affianca compagna
Laodamia, nonché Cèneo, che un tempo fu uomo, ora è donna,
e nell’antica sua forma di nuovo tornò per destino.
E la fenicia fra loro, recente di piaga, Didone,
vagabondava in quell’ampia foresta. E l’eroe dei Troiani,
come al suo fianco ristette e la riconobbe fra l’ombre,
fosca –così si solleva in mezzo alle nubi la luna,
se la si vede, o si crede vederla, al principio del mese–,
diede alle lacrime sfogo e con dolce amore le disse:
“Ah, sventurata Didone, veridica nuova a me, dunque,
venne, che tu t’eri spenta, e venuta a morte di spada?
Della tua fine, ahi, fui io la causa? Io lo giuro per gli astri
e per gli dèi, e per quanto è di fede in grembo alla terra,
no, non per mia volontà, regina, io partii dal tuo lido.
Le imposizioni dei numi, che adesso a esplorare fra l’ombre
luoghi annebbiati d’oblio mi forzano, e notte profonda,
m’hanno costretto, col loro imperio; e non seppi pensare
che il mio partire t’avrebbe arrecato tanto dolore.
Fa’ che il tuo passo s’arresti e non evitare il mio sguardo.
Chi stai fuggendo? Per fato quest’ultima volta ti parlo!”
A carezzare il suo animo acceso e il suo sguardo crucciato
tali parole tentava, e versava lacrime, Enea.
Fissi alla terra la donna teneva i suoi occhi, nemica,
né da che s’era iniziato quel dire, ella mosse il suo volto,
più che se fosse di selce immota o di pietra Marpesia;
gli si sottrasse, alla fine, e si rifugiò, come avversa,
dentro l’ombrosa foresta, in cui il primo sposo, Sicheo,
l’è di conforto all’affanno e ne corrisponde l’amore.
* * *
Eurialo e Niso –Eneide Libro IX, 386 – 444
Niso va via; senza averne contezza ha passato i nemici
e le contrade che poi si dissero albane, dal nome
d’Alba (quei pascoli fitti ebbe allora il sire Latino),
quand’ecco stette, e cercò invano l’amico smarrito:
“In quale plaga, infelice Eurialo, t’ho abbandonato?
Dove inseguirti, esplorando di nuovo ogni strada contorta
dell’ingannevole selva?” All’indietro intanto le tracce
segue e le scruta e s’aggira in mezzo ai cespugli silenti.
Sente i cavalli, anche sente schiamazzi e segnali di caccia,
né si frappone gran tempo in mezzo e un clamore alle orecchie
giunge ed Eurialo egli vede, che già tutt’intera una squadra
(frode del luogo e del buio), a un chiasso di subita turba,
sta trascinando e circonda -invano egli tenta più fughe.
Come farà? Con che forza o che armi oserà strappar loro
il giovinetto? O deciso a morire, in mezzo alle spade
si getterà, cercherà fra quei colpi nobile morte?
Tende di scatto il suo braccio così fa oscillare la lancia,
quindi sogguarda la Luna in alto, e con voce la prega:
“Tu, dea, tu sii d’aiuto alla mia fatica, propizia,
tu, sfavillio delle stelle, guardiana dei boschi, Latonia.
Se già per me il genitore mio Irtaco sulle tue are
pose le offerte, e se mai con mie prede io stesso le accrebbi,
sotto la volta le appesi o le infissi ai sacri fastigi,
fa’ ch’io disperda la folla e guida il mio dardo nel vento”.
Egli diceva e con tutto il corpo si tese e col ferro
li saettò. L’asta vola e ferisce l’ombra notturna,
e nella schiena colpisce Sulmone rivolto e lì stesso,
lì, si spezzò, lacerò con l’infranto legno i precordi.
Egli si torce e dal petto rivomita un tiepido fiotto,
gelido, fra convulsioni penose contorce i suoi fianchi.
Guardano gli altri di qua di là. Così Niso, più ardente,
ecco che sopra l’orecchio librò una nuova saetta:
trepidano, ma già l’asta va a Tago attraverso le tempie,
stridula, calda del suo cervello trafitto s’infigge.
Truce s’infuria Volcente, e però l’autore del colpo
no, non lo vede, né dove impetuoso avrà da lanciarsi.
“Ma sarai tu nel frattempo, col caldo tuo sangue, a pagarmi
per l’uno e l’altro la pena!” esclamò: poi tratta la spada
venne avanzando su Eurialo. Ecco allora folle, atterrito,
Niso proruppe in un grido e non gli riuscì d’occultarsi
più fra le tenebre né d’accettare tanto dolore:
“A me, a me! Sono io, sono io, vibrate in me il ferro
Rutuli! E’ mio quest’intero inganno; ah, non ne ebbe il coraggio
lui, non poteva: ne attesto il cielo e le complici stelle!
Solo ebbe caro fin troppo il suo sventurato compagno”.
Tali parole gridava. Ma spinta con forza, la spada
ruppe le coste d’Eurialo e squarciò il suo candido petto.
Ecco piegarsi alla morte Eurialo, rivola sangue
lungo le belle sue membra, si china sugli òmeri il capo.
Proprio così dall’aratro un fiore purpureo reciso
nel suo morire languisce o chinano il capo sul collo
stanco i papaveri, quando per caso li grava la pioggia.
Niso però fa irruzione nel mezzo, a quell’uno fra tutti
punta, a Volcente, non ha che Volcente come bersaglio.
Ecco affollarglisi intorno i nemici, e da un lato e dall’altro,
a rintuzzarlo. Ma Niso resiste non meno e la spada
ruota fulmineo, finché nella gola al rutulo urlante
non la ricaccia, e morendo al nemico strappa la vita.
Sopra l’amico anche lui senza vita infine procombe:
là, nella placida morte trovò, crivellato, la quiete.
* * *
Morte di Turno – Eneide, libro XII, 919-952.
Mentre egli dubita, Enea fa oscillare il dardo fatale,
punta con gli occhi la sua fortuna e con tutto vigore
vibra lontano il suo colpo. Non fremono tanto le pietre
che da un ordigno murale si lanciano, né tali tuoni
rombano al fulmine. Simile a turbine cupo trasvola
l’asta portando la morte crudele e dilacera gli orli
della corazza e la cerchia estrema al settemplice scudo;
passa stridendo attraverso il femore. Còlto s’abbatte
Turno, possente qual è, ripiegando in terra il ginocchio.
Con un lamento si levano i Rutuli, tutto d’attorno
mugghia anche il monte e gran tratto riecheggiano il grido alti i boschi.
Egli da supplice, a terra, protesi i suoi occhi e la destra
alla preghiera: “Lo merito io, sì, non recrimino” esclama:
“godila tu la tua sorte. Però se d’un padre infelice
può mai toccarti il pensiero, io ti imploro (Anchise tuo padre
era lo stesso per te), la vecchiaia di Dauno compiangi,
e la mia spoglia, anche priva di vita, ove questo ti piaccia,
rendila ai miei. Tu mi hai vinto e tendere vinto le mani
m’hanno veduto gli Ausoni: Lavinia sarà la tua sposa:
non infierire più oltre nell’odio”. Aspro in armi ristette
gli occhi d’attorno volgendo, Enea, e represse la destra;
sempre di più cominciava ormai a piegarlo nel dubbio
quella preghiera, allorché brillò alto in spalla il ferale
balteo, da borchie ben note rifulsero allora le cinghie
del giovinetto Pallante, che Turno d’un colpo già vinse
e trucidò: sulle spalle ne aveva l’insegna nemica.
Ecco che Enea, come bevve l’emblema del truce dolore
e quelle insegne con gli occhi, acceso di furia e spietato
nella sua ira: “E così tu che indossi spoglie dei miei
troverai scampo da me? Pallante al mio colpo, Pallante
ti immolerà, dal tuo sangue assassino avrà sua vendetta!”
Sì, così dice e gli immerge attraverso il petto le spada,
fervido. Al giovane allora si sciolsero in gelo le membra,
e in un lamento la vita fuggì desolata fra l’ombre.