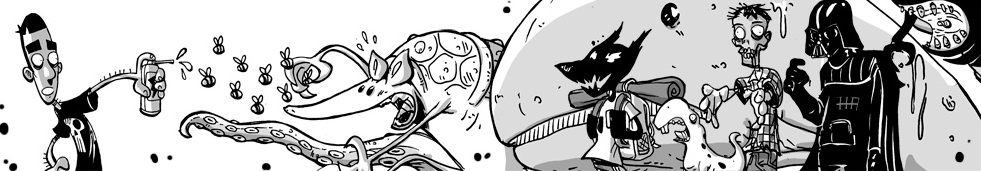di Andrea Inglese
… s’instaura comme une fallite de ma mémoire: je me mis à avoir peur d’oublier, comme si, à moins de tout noter, je n’allais rien pouvoir retenir de la vie qui s’enfuyait.
Georges Perec
Non so Perec, ma io non ci sono riuscito, anche se la sindrome è la stessa, e il metodo è quello, il migliore, schietto e intransigente, la documentazione neutra, burocratica, da segugio dei servizi segreti, quelli che frugano nel pattume per ricostruire il tuo stile di vita, le frequentazioni, i saliscendi emotivi, gli orientamenti politici, e si basano su scontrini, confezioni vuote, indumenti lacerati, residui di cibo, lampadine andate in pezzi, io non ce l’ho fatta, ho finito per scrivere qualsiasi cosa nei miei quaderni, ma da rapsodo, da radiolina fuori frequenza, i documenti sono scarsi, disordinati, e mancano le date, la topografia è vaga, le cifre sono discordanti, la descrizione di un incubo non si distingue dalla cronaca di una riunione di lavoro, interi passi di Pessoa sono presentati come trascrizioni di recensioni cinematografiche, un’analisi intimista può essere confusa con l’esegesi di un’installazione contemporanea, perché io non è che scriva in modo metodico e freddo, scrivo a sprazzi, per scalmane, copiando e riassumendo, interpolando e deformando, come se dovessi far convergere in una data frase, in un piccolo paragrafo scritto sul seggiolino ribaltabile del metrò, nel tratto che mi porta da Nation a Père Lachaise, tutta la mia circoscrizione umana più vasta, il dentro e il fuori, l’osso e l’anima, la paranoia privata e l’allucinazione di massa, la scarpa slacciata e la metafisica dei costumi, l’alone sulla lente degli occhiali e lo scoppio della caldaia nel bilocale di periferia.
Da un quaderno senza data, Clairefontaine, copertina rosso scozzese, “douceur de l’écriture”, Made in France, paragrafo su: “Soggetti di conversazione al ristorante a mezzogiorno”.
“Vicini di casa, vicini rumorosi, vicini con cane, un’anziana come vicina che si sveglia alle quattro di mattina e mette la radio a tutto volume, colleghi di lavoro, colleghi nuovi, colleghi morti, colleghi che si stanno separando, colleghi che mettono bastoni tra le ruote, colleghi che vanno dribblati, ignorati, sconfitti, colleghi più anziani che non sanno fare il loro lavoro, tutto il lavoro che si è costretti a fare e che non spetterebbe a colui che racconta, colleghi che scrivono troppe mail, colleghi che non riescono a telefonare al responsabile vendite quando è necessario, colleghi che parlano male l’inglese, datori di lavoro e capi, descrizione fisica e difetti di pronuncia, stile dell’abbigliamento, tipologia di automobile dei datori di lavoro, e proprietà immobiliari secondarie se conosciute, quanto sono efficaci i capi e quanta fiducia dimostrano in colui che racconta, la carta bianca, il margine d’iniziativa, la grossa responsabilità che gli forniscono, quanto sono imbelli i responsabili, i direttori, i vertici dell’azienda, i capi e i vertici vanno sempre contro il muro, sono incredibilmente ciechi, sono sostanzialmente sprovveduti, mancano di qualsiasi chiaroveggenza, non hanno una idea che sia una, sono davvero delle belle intelligenze, perché hanno capito il lavoro indispensabile fatto da colui che racconta, senza colui che parla i capi e la loro azienda avrebbero i mesi contati, i sottoposti non sanno lavorare, tutti i nuovi assunti non hanno mai capito come si lavora, cosa si deve fare in ufficio, come ci si comporta in azienda, i sottoposti semplicemente non dovrebbero esistere, i nuovi assunti non dovrebbero essere assunti, l’importanza dell’esperienza, la celebrazione dell’esperienza, l’esperienza vale qualsiasi formazione, qualsiasi titolo di studio, qualsiasi statuto professionale, quale telefonino e soprattutto quale abbonamento fare, comparazione e analisi, le potenzialità del nuovo smartphone, siti che presentano esperienze concrete d’uso di smartphone, gli sperimentatori di smartphone, l’intramontabile problema della memoria ram, e di come si possa espanderla, il back up, con i dischi duri esterni, che può essere molto o poco aggiornato, la perdita di dati, ma anche la perdita del telefonino, la morte del disco duro, il recupero dei documenti persi con la morte del disco duro, i videogiochi legati all’ultima serie televisiva americana, l’evoluzione incontrollata dei videogiochi e la loro stimolazione cognitiva assodata, i progetti d’insegnamento attraverso consolle e videogiochi: umanistici e scientifici, il crescente effetto di realtà dei videogiochi di guerra e di strage, la Playstation come passione solitaria o gregaria, i raduni reali a periodicità mensile dei giocatori virtuali, l’adolescente giapponese che non è più uscito dalla camera per tre anni, perché impegnato in un gioco di ruolo obsoleto, vantaggi e svantaggi di agende, tavolette e lettori elettronici, la salvaguardia dei figli dal consumismo elettronico o dagli eccessi della tecnologia, il pericolo di emarginazione sociale di figli sprovvisti di wi fi, limiti d’orario quotidiano nella visione di cartoni animati Disney, propensione all’acquisto di videogiochi per tutta la famiglia del tipo rompicapo o sportivo manageriale, la persona con cui si sta uscendo, caratteristiche psicologiche e profilo sentimentale, i trascorsi affettivi della persona appena conosciuta, e i problemi derivanti dal suo tenore di vita o dalle cerchie amicali o dagli impegni professionali, i luoghi dove è possibile conoscere gente nuova, gli incontri programmati a casa di amici, come gestire la vita a due dopo una sconfitta sentimentale, come ricostruire una sessualità vivace dopo anni di routine, come annunciare il capolinea di un rapporto, se si debba o meno amare la persona con cui si va a letto, cosa rispondere a un certo tipo di sms, numero di sms giornalieri che non è patologico inviare al proprio partner, non farsi troppe illusioni sulla persone più giovani o più vecchie che si potrebbero incontrare, il poco tempo che lui mette a disposizione, le pretese eccessive di lei, l’importanza della riservatezza, la necessità di dire le cose, normalità o meno di chi tiene spesso il telefonino spento, l’attaccamento alla propria ex, dubbi sull’uso perenne del telefonino anche a tavola, anche di domenica…”
A volte, quando vado in giro, qualsiasi parola che sento dire, mi fa impazzire. Non sono le parole, in realtà, sono le frasi. Ci sono certe frasi che non sopporto. A volte quasi tutte le frasi dette nello spazio pubblico, nella grande rete viaria europea, mi sembrano insopportabili, e mi producono come un disturbo mentale. In questi casi, le frasi più disturbanti mi sembrano quelle formulate in italiano, e in particolare modo da italofoni che parlano con qualcun altro al telefono. Se poi questi italofoni sono degli uomini del terziario avanzato, se sono all’incirca dei professionisti di qualcosa, e parlano in italiano dentro un telefono cellulare, con o senza auricolare, seduti in un vagone di un treno Frecciarossa o Frecciabianca, o nel corridoio stretto di una carlinga di aeroplano prima o dopo il decollo, io impazzisco. In quei momenti, anche se è loro diritto, anche se non per forza urlano o si vantano o sono grossolani o dicono frasi fatte o esprimono opinioni marce sul mondo, in quei momenti è come se io dormissi dopo una pesante giornata di lavoro, e dormissi in un letto caldo, in una camera al riparo dalle intemperie, con le persiane chiuse per garantire un’oscurità ottimale, e di colpo quei signori venissero da me, al mio orecchio, a parlare delle loro cose, a dire le loro frasi, non per forza fatte, magari sono completamente senza costrutto, oppure originalissime, ma è come se me le urlassero nelle orecchie, che poi non stanno neppure urlando, parlano semplicemente, ma parlano con un’insana disinvoltura, seduti a pochi centimetri da me, dalla mia testa posata sul guanciale, e quindi mi svegliano nel pieno della notte, e non mi lasciano più riaddormentare, perché la loro conversazione non è telegrafica, fatta di grandi silenzi, e non è nemmeno pragmatica, secca ed efficace come ci si aspetterebbe da professionisti come loro, la tirano in lungo, intorno a una mail non ricevuta, o poco chiara, costruiscono tutta una storia, una saga islandese, una narrazione torrenziale. Ma è chiaro che la colpa è mia, non è loro, e che nella rete viaria europea, nel multiforme spazio pubblico mondiale, non si può imputare a gente sui treni, sugli aerei, alle poste, nei corridoi della metropolitana, di parlare al telefono, e di parlare di questioni urgenti di lavoro, o che a loro paiono urgenti, e non si può stabilire un tassametro, una specie di controllo sulla lunghezza di queste conversazioni e sul numero massimo di parole – proferite ad alta voce – che dovrebbero includere. Spesso, questo è innegabile, di parole, negli spazi pubblici, soprattutto dentro i telefoni cellulari, se ne dicono troppe, e soprattutto su questioni professionali, che se il capitalismo non fila liscio, se c’è questo problema della crescita che non cresce e della ripresa che non riprende, è probabilmente anche per colpa di queste spiegazioni eccessivamente circostanziate, queste insistenze, su concetti base e chiarissimi, come se si trattasse invece di aforismi di Eraclito che si vorrebbero rendere pienamente intelligibili. Gli uomini che fanno gli affari, e quelli che aiutano questi uomini a fare gli affari, anche se dicono che il tempo è denaro, e se proclamano che gli affari sono affari, e sempre si muovono in modo deciso e scattante, con cartelline sotto il braccio, o agende elettroniche, o valigette di pelle, questi uomini e gli uomini di questi uomini, tanto sono tonici e rapidi sul piano motorio, tanto sono prolissi e ridondanti sul piano verbale. Qualcuno dovrebbe esaminare spassionatamente il fenomeno e portarlo all’attenzione dei nostri migliori opinionisti.

Questa cosa, però, che dipende esclusivamente da me, da mie predisposizioni fisiologiche o genetiche, chissà, non mi capita spesso. Più spesso mi capita una cosa diversa, e in qualche modo opposta. Soprattutto se mi trovo a pranzare, nella pausa del lavoro o dello studio, in qualche ristorante parigino, di quelli piccoli ed economici, magari giapponesi o cinesi, dove devi infilarti a sedere dietro uno stretto tavolino, con i gomiti che sfiorano quelli dell’avventore accanto, ebbene lì, pranzando da solo, mi è possibile non solo sintonizzarmi sulle conversazioni in corso, quelle più facilmente percepibili nei tavoli vicini, ma da queste conversazioni la mia mente è completamente risucchiata, il mio stesso carattere, mi verrebbe da dire, ne è parassitato, non solo io ascolto, e ascolto con una straordinaria attenzione, come si ascolta la parola di un morente, l’ultima e solenne, di augurio o malaugurio, rischiando – come spesso accade – che se ne esca biascicata e indecifrabile un attimo prima del decesso. Così io ascolto tutto, e con elettrizzata attenzione, senza alcuna forma di discernimento, di selezione o filtro argomentativo, e dopo l’ascolto, o già nella continuazione di esso, comincio a elaborare in proprio, a fare mie certe preoccupazioni, certi giri di frase, un determinato vocabolario, e per alcune ore questi brandelli di conversazione altrui, amplificati e manierati, occupano il mio spirito, come succedeva, probabilmente, ad Ezechiele, con le parole divine, che non bastava memorizzare alla lettera, ma che si dovevano far scendere profondamente dentro di sé, perché in ogni organo e capillare, in ogni pensiero futuro e ricordo passato, governassero incontrastate.
Quindi io non trovo, nei miei quaderni, documenti come si converrebbe a un archivio dell’esistenza fuggente, non trovo riflessioni personali sulla morte dell’Occidente, sulle guerre del petrolio o su i miei riti masturbatori, né vi leggo descrizione degli arredi del ristorantino dove sono attavolato, con tutti i dettagli del menù, piatti e prezzi, e magari le neutre ma sempre pertinenti notazioni meteorologiche, no, vi abbondano invece conversazioni altrui malamente stenografate, senza nemmeno caratterizzazione psicologica dei loro autori, o ritratto ottocentesco degli abiti, delle capigliature, movimento degli occhi, pieghe del viso, grassezza o nodosità delle dita.
“Lui, il suo problema, è l’ego.”
“I migliori dj in questo momento si trovano a Londra o a Berlino, anzi ad Amsterdam.”
“È una tipa della mia età, che non è obesa, è carina invece, molto carina, è un po’ grossa, ma non obesa…”
“Gliel’ho ripetuto: non spendo prima di avere soldi, quando avrò i soldi va bene, andiamo assieme, guardiamo le tende, i rivestimenti del bagno, guardiamo anche il frigorifero, benissimo, lo prendiamo nuovo, io tiro fuori i soldi e compriamo, andiamo a Darty, non so, ma devi farmeli avere, lui invece vuole che io spenda, che io compri, senza avere i soldi, perché tanto dice arrivano, io gli dico: no, non arrivano, devono esserci, devo averli già, e quando li ho li spendo, e ci occupiamo del frigo, se ti mette in ansia il frigo, e del bagno, se non riesci più a farti la doccia con calma…”
“È un egocentrico, non egoista. È uno che ti invita fuori, davvero, ti offre il pranzo, è così, ma parla lui, parla solo lui, in genere dei suoi successi sul lavoro, di come riesce a mettere in difficoltà il suo capo, e poi ti parla dei lavori che ha fatto in passato, di come erano bene pagati, ma di come questo è pagato ancora meglio, e lui sa che può mettere in difficoltà il capo, a te non ti ascolta, non ti lascia parlare, ma t’interroga sulle ordinazioni, vuole sapere che cosa prendi come antipasto, e perché non bevi vino, ma poi ritorna subito a bomba: i clienti, tutti i clienti che lui è riuscito a procurare alla ditta, per quello il capo sta zitto, per quello si lascia mettere in difficoltà, a volta deve andarsene prima di bere il caffè, mi ordina il caffè anche se non lo bevo, mi saluta calorosamente, va a pagare, e corre fuori.”
“Non fa le diete, su questo è decisa, ha fatto troppe diete, dice, e poi ritorna sempre al punto di prima, ha un po’ ragione io credo, e non è che sia obesa, il volto poi è molto carino, è una persona briosa, magari sì, a volte sbaglia a mettersi le gonne, quando porta gonne troppo corte, non dico che debba portare sempre quei gonnoni che si mettono le donne che hanno le gambe orrende, che per altro lei non le ha orrende, sono grosse, più che grasse sono proprio grosse, basta una gonna al ginocchio, e l’effetto è già diverso, ma tu come la dici una cosa così? Glielo puoi dire?”
“Io sono d’accordo con lui: vuoi comprare? Compriamo! Ma i soldi li dobbiamo avere, li dobbiamo avere prima di comprare, e lui s’impunta, su questo insiste, e dice che non è vero, che questa è una mia fissazione, che i soldi arrivano, e uno non deve essere ossessionato dai soldi, ma lui è ossessionato dallo spenderli i soldi, deve spendere i soldi che arriveranno, ma quando? Gli dico io… Quando arriveranno i soldi che hai già speso!”
“Oggi i migliori locali sono a Berlino e ad Amsterdam. A Parigi non c’è più niente, è tutto finito. E più in generale è finita la musica dal vivo, la gente che sale sul palco, infila il jack nella chitarra e si mette a fare gli accordi agitando la testa. Nessuno ci crede più, nessuno ha più voglia di passare una sera a guardare un tizio, sul palco, che si agita, e che solo perché produce da sé la musica diffusa in sala vorrebbe che tutti lo guardassero, e lo guardassero beati, come se stesse realizzando un miracolo, quando invece suona e basta, è un tizio che sa suonare, come ne è pieno il mondo, oggi la gente va in un locale per essere lei il tizio importante, lei vestita in un certo modo e che balla in un certo modo, è una storia vecchia, certo, ma oggi ha preso il sopravvento, c’è il dj in un angolo della sala, è un tipo simpatico il dj, non produce lui la musica, lui si limita a captarla, c’è un sacco di musica nel mondo, sempre disponibile, su mille supporti, per mille canali, e lui ne prende un po’ è la spara in sala, e in sala quella musica diventa la musica di chi la balla, e la balla con i suoi vestiti e le sue maniere, il tizio che sale sul palco come fosse un piccolo dio e dev’essere venerato perché prende un microfono in mano e ci urla dentro, questo è finito per sempre, siamo tutti miscredenti, tutti atei, ognuno è il suo dio, e basta.”







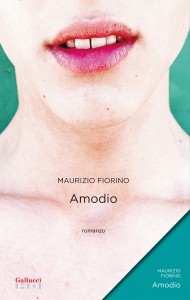 Forse non poteva essere più spigliato l’esordio letterario di Maurizio Fiorino, giovane talento della fotografia italiana ma che per anni ha vissuto a New York. Amodio (Gallucci, pp. 176, 16,50 euro) narra infatti la storia d’amore tra Armando e il figlio di uno dei boss più temuti della ‘ndrangheta, l’immaginario Carlo Costa, il quale scoperta la relazione è costretto ad appellarsi alle leggi mafiose, spietate quanto necessarie, e la cui violazione può sancire una condanna a morte.
Forse non poteva essere più spigliato l’esordio letterario di Maurizio Fiorino, giovane talento della fotografia italiana ma che per anni ha vissuto a New York. Amodio (Gallucci, pp. 176, 16,50 euro) narra infatti la storia d’amore tra Armando e il figlio di uno dei boss più temuti della ‘ndrangheta, l’immaginario Carlo Costa, il quale scoperta la relazione è costretto ad appellarsi alle leggi mafiose, spietate quanto necessarie, e la cui violazione può sancire una condanna a morte.
 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot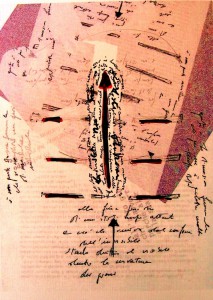

 Il 23 marzo 2013 viene inaugurata ad Ancona la statua Violata, monumento in ricordo “di tutte le donne vittime di violenza”, voluto e finanziato – senza alcun bando di concorso, ma accettando la proposta di una statua già realizzata in gesso dallo scultore Floriano Ippoliti – dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in accordo con alcuni altri enti e associazioni femminili locali. La statua, che rappresenta una donna con borsetta di ideale bellezza dalle vesti succinte e stracciate in modo da scoprirne, mettendoli in tutta evidenza, il seno e il sedere, suscita immediatamente incredulità e sdegno. Una rappresentazione che viene giudicata da troppi semplicistica e inopportuna, se non offensiva della dignità delle donne vittime di violenza. Ne derivano diverse lettere di protesta (consultabili qui:
Il 23 marzo 2013 viene inaugurata ad Ancona la statua Violata, monumento in ricordo “di tutte le donne vittime di violenza”, voluto e finanziato – senza alcun bando di concorso, ma accettando la proposta di una statua già realizzata in gesso dallo scultore Floriano Ippoliti – dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in accordo con alcuni altri enti e associazioni femminili locali. La statua, che rappresenta una donna con borsetta di ideale bellezza dalle vesti succinte e stracciate in modo da scoprirne, mettendoli in tutta evidenza, il seno e il sedere, suscita immediatamente incredulità e sdegno. Una rappresentazione che viene giudicata da troppi semplicistica e inopportuna, se non offensiva della dignità delle donne vittime di violenza. Ne derivano diverse lettere di protesta (consultabili qui: 







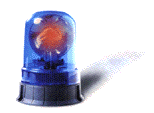


 Immaginate una principessa che proprio non ne vuole sapere di prendere marito, a meno che non sia tanto abile da arrivare a lei senza farsi scoprire.
Immaginate una principessa che proprio non ne vuole sapere di prendere marito, a meno che non sia tanto abile da arrivare a lei senza farsi scoprire.