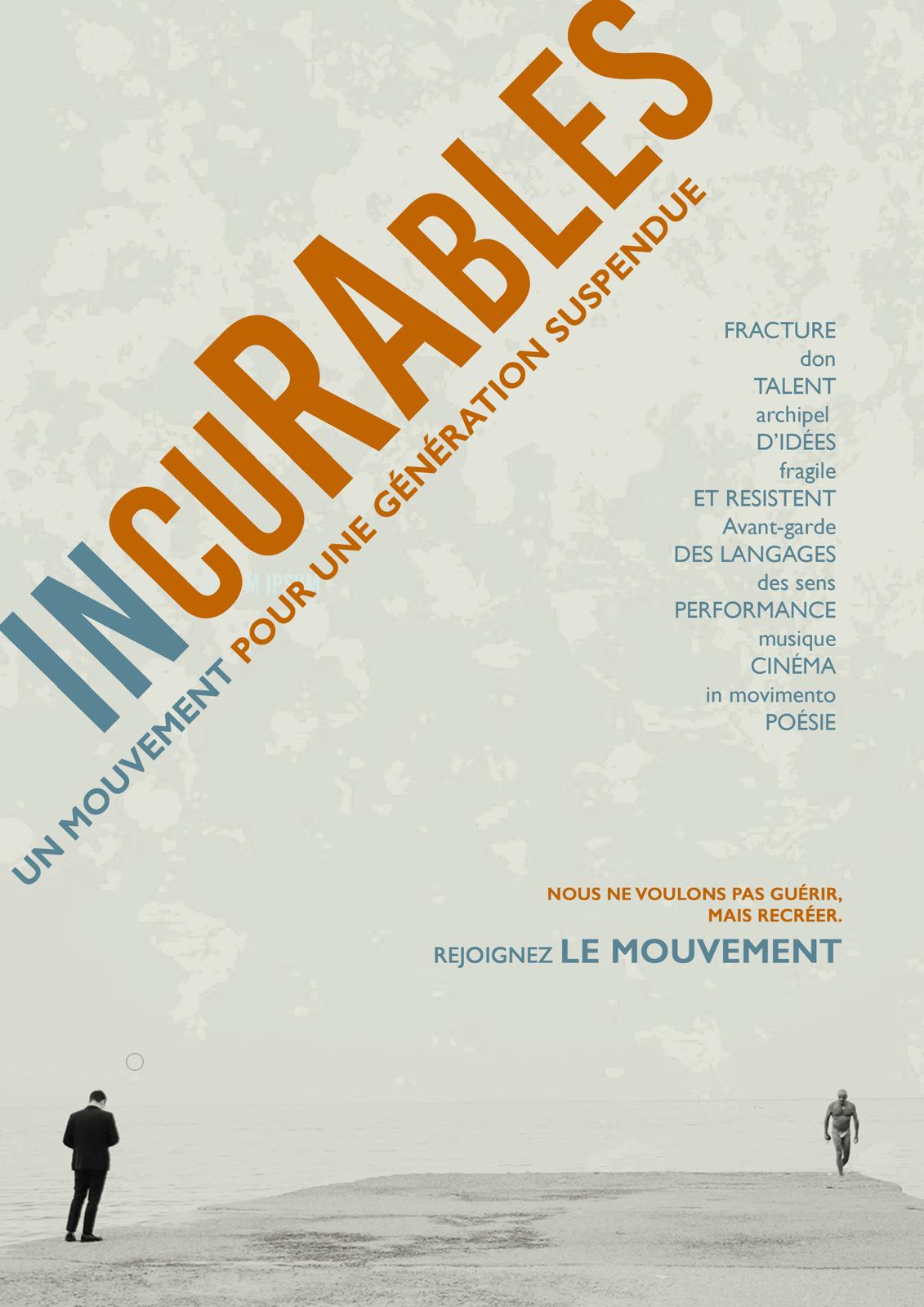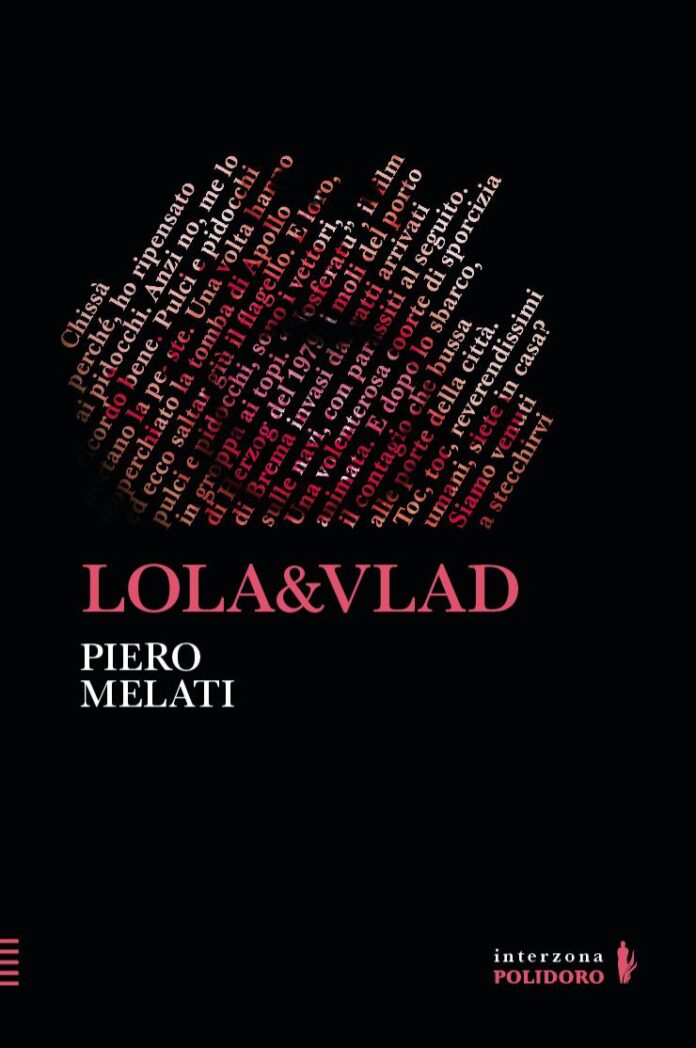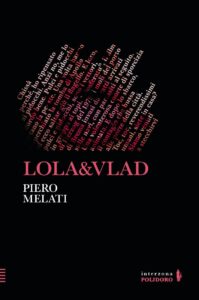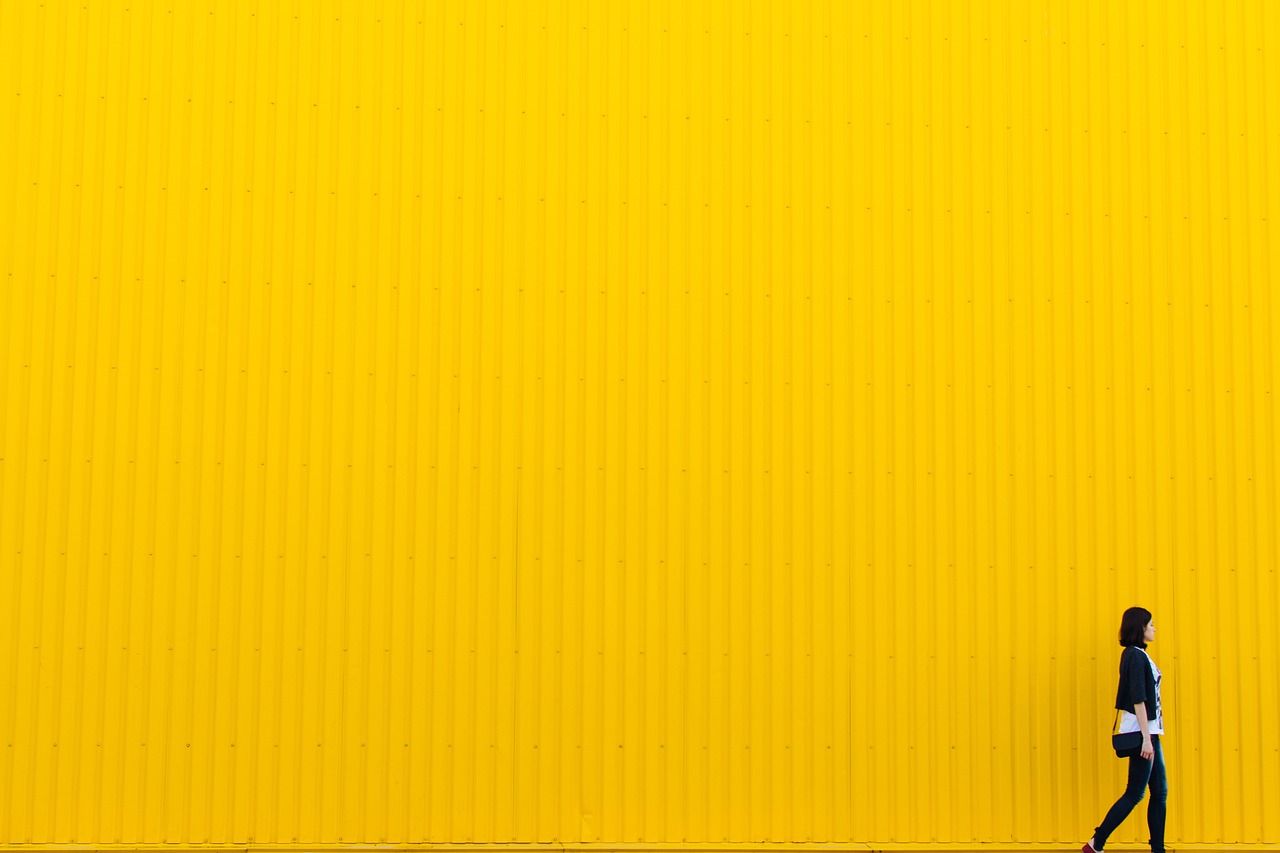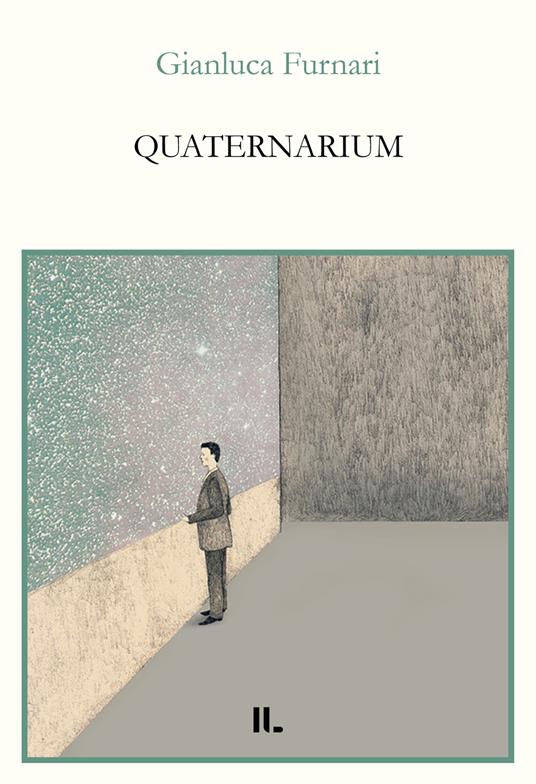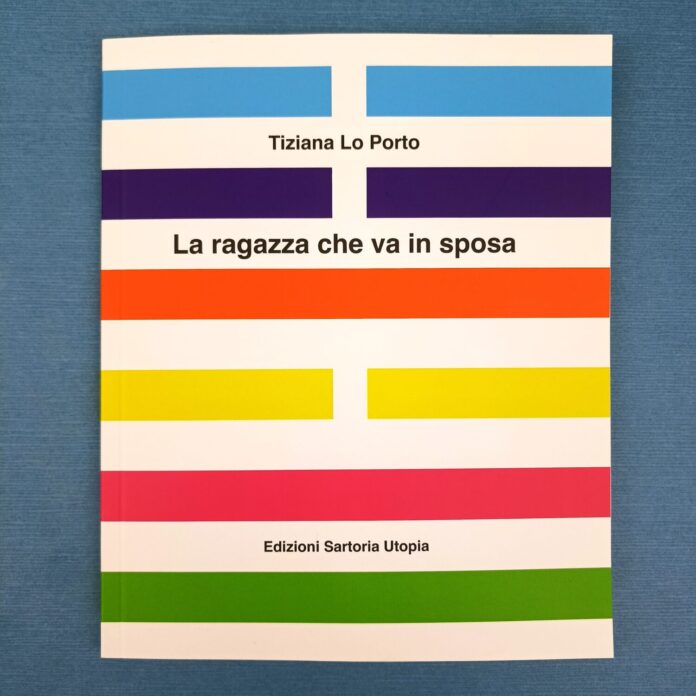Pubblichiamo alcuni estratti dal saggio di Adriano Ercolani Don Giovanni, eroe tragico della rivolta antidivina, pubblicato nel volume Le prigioniere divine. Il teatro d’opera come dramma delle differenze a cura di Andrea Panzavolta (Il Poligrafo).
Il volume raccoglie contributi di: Nicola Berardinelli, Stefania Navacchia, Daniele Capuano, Umberto Curi, Filippo La Porta, Filippo Pantieri, Nicola Morgese, Ilario Belloni, oltre ovviamente ai citati Ercolani e Panzavolta.
Nel saggio di Ercolani si fa riferimento a due interventi reperibili su YouTube:
-l’intervento di Umberto Curi durante il Festivalfilosofia del 2013 intitolato Don Giovanni, dal nome proprio al nome comune
https://www.youtube.com/watch?v=d086eKXd3ms
– l’intervento di Giovanni Bietti sul Don Giovanni durante la rassegna Preludi all’Opera per l’Università di Catania
https://www.youtube.com/watch?v=L_A4WlyUJ7g
PREMESSA
Pavel Florenskij, nel suo cruciale saggio Le porte regali, ci ha donato una celebre sentenza, che nel suo splendore apodittico è forse una prova più convincente dell’esistenza di Dio rispetto all’argomento ontologico nel Proslogion di S,Anselmo:
«Esiste la Trinità di Rublev, perciò Dio è».
Chiaramente, nell’asserzione rivelativa del sommo pensatore russo emergono secoli di Filocalia, di tradizione meditativa dei Padri del Deserto, di Neoplatonismo congiunto ai misteri della fede ortodossa, in una vertiginosa sintesi culturale, tra le più abissali del Novecento.
Ben più modestamente, nel mio entusiasmo adolescenziale ho sempre considerato due opere come dimostrazione definitiva e inoppugnabile dell’esistenza di una Perfezione Divina in esse manifestatasi: La Divina Commedia e il Don Giovanni di Mozart.
Se nel poema dantesco, non solo l’oggetto e il/la fine stessi dell’opera, ma la sua complessa impalcatura teologica da maestosa cattedrale medievale, potevano più immediatamente presupporre l’unione mistica con una dimensione divina, il capolavoro mozartiano appare al contrario (nonostante l’ironica benevolenza moraleggiante dell’happy ending) una celebrazione estetica e filosofica del più fascinoso demone carnale e luciferino della storia del mito e della letteratura.
Dunque, ancor di più risplenderebbe in essa il nitore della bellezza e del genio per comunque testimoniare, pur per contrasto, la Presenza gloriosa e travolgente di un afflato divino.
E come il poema divino, anche se da una prospettiva rovesciata (stavolta non nel senso florenskijano), l’opera mozartiana coniuga Eternità e Tempo, Aion e Chronos (avendo come protagonista un irrefrenabile inseguitore del Kairos), il rapporto col Sacro e la schiavitù dei sensi, la filosofia perenne e la dialettica sociale.
(…)
I MILLE VOLTI DELL’EROE DEMONIACO
L’eroe dai mille volti è un celebre saggio del 1949 di Joseph Campbell, tra i più brillanti e originali allievi di Carl Gustav Jung, che ispirò la codificazione del cosiddetto “Viaggio dell’Eroe”, divenuto a sua volta lo schema principale per la costruzione delle sceneggiature hollywoodiane (…) il viaggio eroico del protagonista in un’impresa avventurosa, chiara allegoria del percorso di iniziazione, della Grande Opera, dell’illuminazione, dell’incontro col proprio Sé o col divino, a seconda delle diverse tradizioni o interpretazioni.
Don Giovanni compie, nella maniera più affascinante e rocambolesca, questo viaggio al contrario: è un eroe demoniaco e daimonico, il cui itinerarium lo conduce agli antipodi del Poeta Divino, ma che proprio per questo ha un fascino irresistibile e ispira un’umanissima empatia, proprio come i più celebri dannati infernali danteschi (pensiamo alla commozione per Paolo e Francesca o al rispetto ispirato dal carisma di Farinata degli Uberti): del resto, Kierkegaard insiste proprio sullo spiegare come lo stadio estetico sia lo stato esistenziale iniziale di tutti gli esseri umani.
Sempre Dante, nel XVI del Purgatorio, fa spiegare a Marco Lombardo con accenti poetici memorabili la condizione umana: “«Esce di mano a Lui che la vagheggia / prima che sia, a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo pargoleggia, // l’anima semplicetta che sa nulla, / salvo che, mossa da lieto fattore, / volentier torna a quel che la trastulla. // Di picciol bene in pria sente sapore; / quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, / se guida o fren non torce suo amore.» . Don Giovanni, supremo ingannatore e per questo ingannato, nel suo apparente dominare la materia, cade nella trappola del velo di Maya, per questo, nel suo alone demoniaco e superumano, appare una maschera profondamente umana. Egli forza i limiti della condizione umana, come un Ulisse perso nei sensi, con la massima fierezza, fino alle estreme conseguenze.
E come Ulisse, vedremo, si presenta come un Nessuno, senza nome.
Probabilmente, proprio per questo possiede, per sua natura di dramatis persona e per la perenne attualità propria dei classici, mille cangianti volti.
(…)
Don Giovanni è stato, ovviamente, per i suoi caratteri di carisma dannato e ribelle, icona praticamente obbligatoria del Romanticismo, eppure anche qui non mancano le sorprese: nel 1812 la fantasia vulcanica e bizzarra di E.T. Hoffmann si ispira al Don Giovanni mozartiano (“opera delle opere”) con un racconto strabiliante, Don Juan. Un evento fantastico che è accaduto ad un entusiasta viaggiatore, in cui una confessione in camerino del personaggio di Don Anna rivela come il suo vero grande amore sia stato proprio Don Giovanni: furono i vincoli tragici a impedire il compimento del loro autentico amore, ed ella morirà prima di adempiere alla promessa a Don Ottavio, in un capovolgimento faustiano della figura del seduttore, non spietato violentatore ma innamorato vittima di un Fato crudele; non possiamo non citare il poema omonimo (iniziato nel 1818 e mai compiuto) di Lord Byron, che vede il protagonista come una sorta di improbabile Candide, goffo e ingenuo e facilmente sedotto dalle donne, ancora in una inversione provocatoria dei ruoli; maggiore attenzione merita una delle Piccole Tragedie (che ispirerà l’opera omonima di Dargomyžskij del 1872), Il convitato di pietra (1830) di Puskin, autore straordinario che nella stessa raccolta dedica un’altra pièce a Mozart e Salieri (inaugurando la leggenda nera dell’avvelenamento per invidia che arriverà fino al film Amadeus di Miloš Forman); ci limitiamo a segnalare, per limiti di spazio, le versioni simboliste e decadenti di Theodore de Banville, di Flaubert, di Huysmans e Remy de Gourmont, per dedicarci a un ritratto memorabile del più grande poeta loro contemporaneo.
Charles Baudelaire, sommo cantore della ricerca vana dell’unità mistica nei sensi (il sonetto Correspondance, lungi da essere lo scolatico “manifesto del Simbolismo”, nelle prime due quartine potrebbe essere scritto da uno yogin o da un sufi), nei suoi Les Fleurs du Mal (1857) immortala con la magnifica potenza del suo dono poetico la fierezza maestosa dell’eroe dannato:
Quando Don Giovanni verso l’onda sotterranea
discese, ed ebbe dato il suo obolo a Caronte,
uno straccione cupo con l’occhio fiero d’Antistene,
s’impossessò dei remi con gesto di vendetta.
Mostrando i seni penduli e le vesti aperte,
donne si torcevano sotto il nero firmamento,
e come un vasto gregge di vittime offerte
dietro di lui muggivano con lungo lamento.
Sganarello, ridendo gli chiedeva la paga,
e intanto Don Luigi, con dito tremante,
mostrava a tutti i morti che sulle sponde vagavano
il figlio audace che schernì il suo capo bianco.
In lutto, tutta brividi, la casta e magra Elvira,
presso lo sposo perfido, che fu suo amante un tempo,
sembrava reclamare un ultimo sorriso
acceso dalla dolcezza del primo giuramento.
Ritto nell’armatura un uomo alto di pietra
Stava al timone e fendeva l’onda nera:
ma il calmo eroe, sulla sua spada raccolto,
fissava la scia e non degnava altro vedere.
Sembra di leggere di Farinata che “s’ergea col petto e con la fronte/ com’avesse l’inferno a gran dispitto.”. Come scrive Giovanni Casoli in Novecento letterario italiano e Europeo, Baudelaire è un cristiano diviso, “dimezzato e révolté”: dall’unità metafisica alla base del simbolismo medievale che (fin dall’etimo del termine symbolon) trovava il proprio senso nel rapporto creaturale e verticale con Dio, il Simbolismo, moderno e decadente, cerca l’unità nell’esperienza dei sensi, in un “misticismo estetico” che trova solo un senso di unità materiale e orizzontale. Una riflessione che indurrebbe a un accostamento, che in questa sede ci limitiamo ad enunciare, con la visione leopardiana (pensiamo solo al possibile confronto tra la comune rivolta antidivina presente ne Le Litanie di Satana di Baudelaire e l’Inno ad Ad Arimane di Leopardi).
Don Giovanni di questa rivolta è appunto il più grande eroe.
Albert Camus, ne Il mito di Sisifo, lo interpreta, appunto, come eroe della rivolta esistenzialista, sembrando credere alla risposta di Don Giovanni quando Leporello gli rinfaccia le continue infedeltà (“È tutto amore! Chi a una sola è fedele, verso l’altre è crudele”), vedendolo come simbolo de “l’intelligenza che conosce le proprie frontiere. Sino ai confini della morte fisica, Don Giovanni ignora la tristezza. Dal momento in cui egli sa, il suo riso prorompe e fa tutto perdonare (…) per lui nulla è più vanità, all’infuori della speranza in un’altra vita. ed egli ne dà la prova, poiché se la gioca contro il cielo stesso”.
Passando al cinema (ricordando en passant che il primo film sonoro della storia è Don Giovanni e Lucrezia Borgia di Alan Crosland del 1926), ne L’occhio del diavolo (1960), Ingmar Bergman ci mostra un Don Giovanni sconfitto e malinconico, in chiave poetica e ironica: si tratta del film probabilmente più “leggero” del serio regista svedese, da egli stesso definito un “rondò capriccioso”, opera speculare, e antidoto complementare, al contemporaneo, agghiacciante e cupissimo, La fontana della vergine. Partendo da un proverbio popolare irlandese («La verginità di una giovane è come un orzaiolo nell’occhio del diavolo»), Bergman immagina Belzebù infastidito, appunto, alla vista a causa della purezza di una fanciulla rimandare sulla terra Don Giovanni per sedurla, offrendo in cambio uno sconto di trecento anni sulla pena infernale. Accompagnato dal il suo fido servo (lo scudiero Pablo, che avrà più successo di lui), Don Giovanni finirà per innamorarsi dell’innocenza della ragazza, sancendo la vittoria delle potenze celesti (pur con un’ironica coda finale a smentirne maliziosamente la morale).
Il Don Giovanni di Carmelo Bene, lungometraggio del 1970, ispirato da un’inquietante novella di Barbey d’Aurevilly, è, invece, crudele, sadiano, un corruttore pienamente consapevole dell’innocenza e della fede. Con uno schema simile, non a caso, a quello del suo spettacolo S.A.D.E (che tanto entusiasmò l’intellighenzia francese degli anni ‘70, anche per la parodia dell’hegeliana dialettica servo/padrone, con Bene intento nei panni di Leporello), l’anziano seduttore trova ormai eccitazione solo nel paradosso: nello spettacolo teatrale questo è rappresentato dall’irruzione della polizia durante l’orgia, nel film solo dalla malsana conquista di una ragazzina bruttina e baciapile, figlia di una delle sue amanti. Con la cifra stilistica tipica di Bene, il film, costruito su un montaggio frenetico e quasi intollerabile, prova generale di Salomè, è un colto intarsio di citazioni; si apre, ad esempio, con il celebre sonetto di Shakespeare “No, non ti vanterai, tempo, ch’io muti”, e fin dall’inizio, una stupenda Lydia Mancinelli incarna, sulle note dell’aria del catalogo, tutti i dodici archetipi femminili elencati da Leporello, come poi durante il film rappresenterà celebri nudi della storia dell’arte, quale ad esempio la Venere di Velasquez. A un certo punto, con una geniale sovrapposizione archetipica, alla vicenda viene sovrapposto un dialogo tra la Fata Turchina e Pinocchio (maschera che era già un cavallo di battaglia di Bene), particolarmente significativo se si conosce l’interpretazione capovolta del mito collodiano da parte del regista.
Nel finale, Don Giovanni, davanti all’ennesimo fallimento, frantuma uno specchio, mentre risuona il monito di Jorge Luis Borges: “gli specchi, e la copula, sono abominevoli, poiché moltiplicano il numero degli uomini”.
Non possiamo non citare la celebre trasposizione filmica di Joseph Losey del 1979: film che si apre con una rinomata citazione gramsciana (“ il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”), prosegue con immagini dal simbolismo ermetico (per uno scherzo del destino realizzate da un illustratore di cognome Salieri!), ritmate dalle onde sempiterne della risacca, prima della suggestione alchemica della vetreria di Murano; un Don Giovanni cupo, crudele, quello interpretato da Ruggero Raimondi, antitetico a quello atletico e vitale di Cesare Siepi nelle versioni dirette da Furtwängler nel ‘54 e (quella che mi è personalmente più cara) da Krips nel ‘59; una versione in cui l’armonia delle diafane architetture palladiane (il film è girato a Vicenza) crea un perturbante contrasto col nero funereo dei costumi, in una riproposizione a scacchiera sia del pavimento della Loggia che della lotta allegorica tra Bene e Male.
In questa chiave iniziatica, obbligatorio è ricordare il saggio di Marius Schneider Il vero Don Giovanni, pubblicato su Conoscenza Religiosa del 1974, che interpreta in chiave solstiziale il mito come solare, nelle sue versioni arcaiche. Così ne evoca il senso, in Le Meraviglie della Natura, Elémire Zolla: “Il carnevale è il mese inaudito: il tredicesimo: suo eroe è un travestito sfrontato, un Lucifero, un Don Giovanni, un figlio del Sole”.
Concludiamo questa rapida rassegna con Cristian Jacq, che nella sua monumentale quadrilogia dedicata alla ricostruzione quasi quotidiana della vita di Mozart, Il romanzo di Mozart (2006), offre, nel volume Il Fratello del Fuoco, un’accurata interpretazione massonica dell’opera (come del resto fa di tutto il percorso artistico del compositore): Don Giovanni è il Compagno, Leporello il Primo Sorvegliante, Donna Anna, Don Ottavio e Donna Elvira rappresentano le tre colonne del tempio (Saggezza, Forza e Bellezza), Masetto e Zerlina la piccola unione, prima tappa della Grande Opera, mentre il Commendatore, chiaramente, è il Maestro d’Opera, ritualmente assassinato all’inizio dell’iniziazione (perdonate il bisticcio).
(…)
DON GIOVANNI DI MOZART, UNICUM INAUDITO
A questo punto arriviamo a uno sguardo più ravvicinato al vero oggetto della nostra trattazione, il capolavoro (non l’unico, ma forse il più universale) della produzione mozartiana.
(…)
L’Ouverture, anch’essa leggendariamente composta la notte prima del debutto, è un riassunto vertiginoso e memorabile di tutta l’opera: inizia con le note tremende e ieratiche dell’avvento finale della Statua del Commendatore, per poi liberarsi nel brio divinamente giocoso tipico della gioia compositiva mozartiana, nel rocambolesco mescolarsi di spunti travolgenti, melodie memorabili, cambi di ritmo, di atmosfera, di umore, per poi sfumare con serena, quasi fiabesca, compostezza.
Nei sei minuti scarsi dell’Ouverture del Don Giovanni non c’è solo già tutta l’opera ma c’è tutta l’esperienza umana, l’itinerarium e la catabasi, la violenza e la pietà, l’innocenza e il peccato, la dannazione e la redenzione, la rivolta luciferina e l’implacabile giustizia divina, un prodigio musicale supremo, degnamente posto all’inizio di una delle più alte creazioni della storia della composizione.
Soprattutto, c’è evidente la cifra stilistica, inedita e irriducibilmente peculiare, dell’opera: la mescolanza inaudita di generi, stili, ritmi che poi diventa specchio artistico perfetto del travolgimento di tutte le convenzioni sociali incarnato dal protagonista, che nella sua furia dionisiaca (ci ritorneremo) decostruisce e svela la vanità illusoria di tutte le sovrastrutture morali.
Iniziamo, proprio, da questo punto: Mozart segna nel suo catalogo personale il giorno della prima il Don Giovanni come “opera buffa”.
Una storia che inizia con un tentato stupro, l’omicidio di un vecchio nobile intervenuto a difendere l’onore della figlia e finisce con il protagonista trascinato all’inferno, da vivo, per sempre…”opera buffa”!
La spiegazione è squisitamente tecnica: l’opera buffa è fondata sull’azione, la velocità, sui concertati, sui brani d’assieme, sui dialoghi. Esattamente le caratteristiche necessarie per raccontare la vicenda di un protagonista continuamente in movimento, sfuggente, inafferrabile, preda di continui innamoramenti, seduzioni, colpi di scena, travestimenti, inversioni di ruolo, apparizioni e repentine sparizioni.
(…)
Come sottolinea Bietti, Mozart e Da Ponte sono esattamente al centro della tradizione, e da quel punto centrale uniscono e mescolano elementi dell’opera buffa e dell’opera seria: in questo, l’opera è unica perché il personaggio è unico.
Se i personaggi virtuosi (Donna Anna, Donna Ottavio e Donna Elvira) utilizzano il registro dell’opera seria (arie in cui il personaggio riflette a voce alta sulla propria condizione), Leporello (la versione dapontiana di Sganarello) è pienamente all’interno dei codici dell’opera buffa, Masetto e Zerlina portano nella loro litigiosa allegria la musica popolare, il Commendatore incarna ieratico il registro sacro, Don Giovanni attraversa e mescola tutti i generi.
Le sue tre arie sono velocissime e travolgenti, due delle quali cantate nei panni di Leporello, qualcosa di inaudito per il protagonista di un’opera.
La rivoluzione musicale di Mozart non è solo il significante estetico perfetto per la natura luciferina del protagonista, ma coglie con inquietante dono profetico lo Zeitgeist (meno di due anni dopo accadrà lo spartiacque storico della Rivoluzione Francese).
Ma, soprattutto, da supremo burlador, come è stato notato da diversi critici, Don Giovanni “si impossessa del materiale musicale” (Bietti) degli altri personaggi, e gli “fa il verso” e così facendo ruba loro l’identità.
In perenne movimento, immerso nell’attimo, non nel presente meditativo ma nel continuo rapimento della Maya, dello stimolo sensuale, si esprime per battute folgoranti, ordini imperiosi, irosi capricci, fregole incontenibili: le sue arie sono velocissime e travolgenti, consuma il tempo, divora gli amori, brucia le esperienze, sconvolge legami e calpesta ciò che è sacro, sacrificando il tutto sull’altare della propria inappagabile sete di piacere.
Al contrario, la sua Nemesi, il Commendatore, si esprime per frasi lunghissime, lentissime, solenni e definitive, come l’eterna pace dei giusti a cui appartiene.
Eppure, nella sua inafferrabile evanescenza Don Giovanni è il centro dell’opera, tutti i personaggi esistono in sua funzione, animati, per seduzione o per contrasto, dalla sua energia ferina e primordiale; per questo, come sottolinea non solo Bietti, il “lieto fine” non è poi tanto lieto, se non per i semplici Masetto e Zerlina: Don Ottavio dovrà ancora aspettare un anno di cordoglio per coronare il suo sogno d’amore con l’affranta Donna Anna, Donna Elvira si ritirerà in convento, Leporello va all’osteria “a trovar padron miglior”.
Senza Don Giovanni tutto torna piatto, banale, malinconico, privo di vita.
Altro paradosso, inevitabile da notare per qualsiasi spettatore accorto: Don Giovanni, il gran seduttore che nell’aria del catalogo può vantare 2.065 conquiste, nelle oltre tre ore dell’azione drammaturgica…va sempre in bianco.
(…)
Probabilmente, la castità forzata a cui il Nostro è costretto non dal demonio che gli par si diverta ad opporsi ai suoi “piacevoli progressi”, ma è la legge divina del karma, del contrappasso che sta incombendo con i passi ultraterreni e spaventosi del Commendatore in spiritu.
Come nota Bietti, tantissimo si potrebbe dire sulla genialità che ha ispirato praticamente ogni frase, ogni battuta, ogni nota (almeno nella sua disposizione) dell’opera: ben noto è come la coloratura cromatica a passi discendenti, tipica del registro drammatico, della morte del Commendatore ispirerà il celeberrimo Chiaro di Luna di Beethoven (sono state trovate delle trascrizioni di pugno del genio tedesco proprio delle battute simili alle terzine discendenti più famose della storia della musica); più volte è stato sottolineato come lo stile sillabico buffo alla Paisiello venga ripreso nel personaggio di Leporello; l’aria “Madamina, il catalogo è questo” è costruita al contrario, prima veloce, poi lenta, a minuetto (il servo si identifica col padrone, usando lo stile nobile, non a caso apre l’opera dicendo “Voglio fare il gentiluomo”); nel duetto con Zerlina (quel “Là ci darem la mano”, spesso preso a canto di “innocente amore”, che in realtà è duetto di un seduttore ingannatore e una fedigrafa sospettosa), Don Giovanni “ruba” il ritmo alla controparte femminile per portare a termine la seduzione (all’inizio cantano la stessa melodia, ma lui sul tempo forte, lei in levare), passando dallo stile nobile a quello popolare (come dirà a Leporello per giustificare lo scambio di costumi, “Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili”), nel manoscritto, addirittura Mozart storce le gambe delle note a simulare l’abbraccio incombente fra i due; chiaramente il tutto ha un evidente significato anche sociale: nella scena della festa (scandalosamente aperta “a tutti quanti”, abbattendo le barriere sociali, pur per perseguire i suoi scopi seduttori) si indugia quasi inutilmente sulla ripetizione di “Viva la libertà”, forse non a caso, visto che in prima fila c’era un Imperatore; una ulteriore raffinatezza compositiva da sempre elogiata è proprio nel proseguio di quella scena, in cui tre orchestre suonano tre danze diverse (un minuetto, una contradanza, una danza popolare tedesca): non si tratta solo di uno stupefacente virtuosismo compositivo, ma della sovrapposizione eversiva delle tre classi sociali (nobile, borghese e plebea) a cui le tre danze corrispondono.
L’unico che che attraversa tutti gli stili (e tutte le classi) è Don Giovanni, unicum irriducibile, suo essere “camaleonte musicale” (Bietti): mentre tutti gli altri personaggi rimangono ancorati al loro stile, lui lo cambia continuamente, per sedurli, parodiarli, attraversarli: lo stile ecclesiastico del Commendatore, lo stile buffo di Leporello, lo stile tragico di Don Anna, quello patetico di Donna Elvira, quello serio di Don Ottavio, quello popolare di Masetto e Zerlina.
Dice Bietti: “continuamente Mozart articola il percorso drammaturgico attraverso queste gradazioni”, a lente ondate, è se la mescolanza dei generi è tipica dell’Opera, questa “capacità di articolare il crescere e diminuire della tensione drammatica” nessuno l’aveva mai sperimentata prima.
La poetica della gradazione si rivela cristallina ai primi confronti filologici: nella versione originale praghese, la furia vendicativa tragica di “Or sai chi l’onore”seguiva immediatamente quel momento (appena un minuto e mezzo scarso!) di pura, perfetta, divina follia dionisiaca che è“Fin ch’han dal vino”, ma, come sappiamo, per la versione viennese Mozart inserirà una nuova scena, donando allo scialbo Don Ottavio una delle arie più belle di tutti i tempi: “Dalla sua pace”, il meraviglioso canto dell’innamorato più puro, un’oasi lirica tra il registro drammatico dell’aria precedente e quello buffo (nel senso del trickster divino) di quella successiva.
A questo punto, una breve carrellata di riflessioni sui personaggi.
Leporello, da par suo, è una maschera comica perenne, che da Plauto e Aristofane, attraverso la Commedia dell’Arte, conduce, nella sempiterna efficacia delle gag classiche, ai volti della comicità contemporanea: si lamenta come Peppino De Filippo, è scaramantico come Totò, fa la supercazzola come Ugo Tognazzi in Amici Miei, mangia di nascosto come Paolo Villaggio nei panni di Fracchia. Nel ruolo di travestimento, inversione e autoparodia con Don Giovanni viene messa in scena, usando un antico dispositivo dell’arte comica, una carnevalesca esposizione della dialettica servo/padrone: Leporello inizia l’opera lamentandosi, dichiarando ad alta voce invidia sociale, ma per tutto il tempo drammatico non fa che esprimere un misto di ammirazione virile e vile condanna morale delle imprese del padrone; un conflitto che esplode e si ricompone all’inizio del secondo atto, in uno degli scambi più vivaci e comici della drammaturgia mozartiana; anche i recitativi fra i due sono speculari, per contenuto e posizione negli atti, procedono per stilemi variati che ritmano il progressivo sfaldarsi della lealtà reciproca davanti all’ineluttabilità del Fato (“Va là che sei il grand’uom” vs “Va là che sei un buffone!”); se Don Giovanni nell’unica occasione in cui rischia il successo amoroso è nei panni del servo (la stupenda serenata “Deh vieni alla finestra”) è significativo che il monito letale del Commendatore (“Di rider finirai pria dell’aurora”) geli con il suo brivido lugubre i due proprio mentre il padrone dice apertamente che avrebbe, senza esitazioni, sedotto con l’inganno la moglie di Leporello: il tradimento dell’amico fedele è l’ultimo paletto etico che una volta abbattuto spalanca le porte della dannazione.
Donna Anna, fiera, nobile, purissima nella sua bellezza e nel suo unico scopo di vendicare il padre assassinato: il meraviglioso “monologo” con cui descrive il tentativo di stupro subito e la sua coraggiosa resistenza è uno dei più picchi di un’opera in cui, sostanzialmente, non c’è un momento di pausa, di calo, di abbassamento di tensione.
Accanto a lei, Don Ottavio, uomo della delega, del dubbio, dell’incertezza, contrapposto al puro istinto, all’astuzia da Odisseo nell’oceano dei sensi di Don Giovanni: esordisce con il goffo “Tutto il mio sangue verserò se bisogna”, prosegue con la gaffe edipica “Lascia, o cara/ la rimembranza amara:/ hai sposo e padre in me” (rivolgendosi a una donna a cui trenta secondi prima hanno ucciso il padre che la stava difendendo da un tentato stupro), per tutta l’opera viene redarguito per le sue romantiche inopportunità da Don Anna che lo richiama al comandamento della vendetta, dubita ingenuamente anche davanti all’evidenza della colpevolezza di Don Giovanni, fino allo smacco finale di dover lasciare un anno ancora allo sfogo del cor di Donna Anna. Eppure, pur nella sua insopportabile inadeguatezza al ruolo, nel suo candore risplende un puro amore: “Tra cento affetti e cento/ vammi ondeggiando il cor” è uno dei momenti più alti e commoventi della storia della musica, una vertigine abissale di due teneri amanti, innocenti e tremanti al cospetto del Male assoluto.
Donna Elvira, figura dalla femminilità complessa e contraddittoria, amante tradita e furiosamente vendicativa, eppure irresistibilmente ancora innamorata, pronta immediatamente a cedere, ancora, a cadere nuovamente nell’illusione, donna ferocemente passionale eppure destinata al convento, fino all’ultimo tenta di redimere il crudele ingannatore che la sbeffeggia: significativo che perfino Leporello, fin dall’inizio complice della burla, dall’esposizione del catalogo fino alla beffa spietata del travestimento, davanti alla derisione finale si commuova e si sdegni (“Quasi da pianger mi fa costei”, unendosi al di lei grido “Cor perfido”).
Zerlina, stadio estetico che la semplicità popolare induce a diventare etico, astuta e maliziosa sposina, pronta a tradire subito il novello sposo col seduttore facoltoso, ma altrettanto abile a riconquistarlo facendolo fesso, giocando magistralmente le carte della sensualità femminile per giostrare il rozzo e amabile Masetto, scarpe grosso, cervello fino, amore bello perché litigarello, e tutti i proverbi della saggezza popolare di cui la coppia è leggiadra e consapevole incarnazione (fin dall’entrata in scena, che riecheggia il Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo De’ Medici).
Il Commendatore, figura nobile e ieratica, Giusto per antonomasia, per cui Mozart (nota Bietti con una boutade) compone una serie dodecafonica ante litteram, una scala cromatica di dodici note nel verso: “Non si pasce di cibo mortale/ chi si pasce di cibo celeste”, monito sublime della Trascendenza che si confronta col Grande Negatore dello Spirito; difficilmente si riscontra nella storia della musica una scena in grado di commuovere profondamente, fino ai brividi, a ogni singolo ascolto come l’incontro finale tra la Statua e il dissoluto punito. Tutto ciò, avendo poco prima mostrato Don Giovanni al vertice del suo splendore materiale , nel trionfo edonistico, nella massima fierezza della sua rivendicazione filosofica (“Viva le femmine, viva il buon vino/ sostegno e gloria d’umanità”): tutti conoscono l’autocitazione, al culmine degli omaggi ai compositori contemporanei, dell’aria “Non più andrai, farfallone amoroso” de Le Nozze di Figaro, nel momento in cui Leporello si fa perdonare vellicando la vanità del padrone (“Sì eccellente è il cuoco mio, che lo volle anch’ei provar!”), in un vortice di calembour fra il “piatto saporito” e Teresa Saporiti (Donna Anna nella prima rappresentazione) e il cognome Cucak (“cuoco”, in boemo) del secondo maestro di cembalo nell’orchestra della prima praghese.
Quello che non tutti, a un primo ascolto, notano è come in quel momento quell’aria evocata non rappresenti un rimprovero giocoso, ma una tragica premonizione di quello che accadrà dopo pochi minuti (del resto, Kierkegaard vedeva proprio l’aria “Non so più cosa son, cosa faccio” di Cherubino, il farfallone dedicatario del monito, come perfetta rappresentazione dello stadio estetico): ulteriore raffinatezza, ricorda Bietti, l’ennesima specularità col finale del primo atto: mentre in quel caso tre orchestre suonano tre brani diversi contemporaneamente, qui una ne suona tre di seguito.
CONCLUSIONI
Il Don Giovanni è un “dramma giocoso”, e, se leggiamo etimologicamente i termini, dal punto di vista sapienziale non c’è più bella definizione della vita stessa.
Nella sapienza vedica del Brahmasūtra esiste il concetto di Līlā, la creazione stessa è un gioco divino: «Egli non ha motivo di essere./ Allo stesso modo il mondo è semplicemente un suo gioco.»
La Bhagavad Gita, supremo testo di conoscenza spirituale, insegna che dobbiamo essere attori e testimoni del gioco dell’esistenza, arrendendo i frutti delle nostre azioni.
Shakespeare farà eco secoli dopo: “Tutto il mondo è un palcoscenico, donne e uomini sono solo attori che entrano ed escono dalla scena.”.
In uno dei più oscuri e illuminanti aforismi della storia della filosofia occidentale, il sapiente Eraclito sancì che “Il Tempo (Aion) è un fanciullo che gioca”.
Friedrich Nietzsche in Così parlò Zarathustra, facendo eco al maestro di Efeso, proclamerà: “Innocenza è il fanciullo e dimenticanza, un ricominciare, un gioco, una ruota che gira su se stessa, un primo moto, un santo dire di sì. Sì al gioco della creazione, fratelli, occorre un santo dire sì”.
Tutto questo ci riporta al grande archetipo, che agisce come un daimon occulto nella maschera eternamente cangiante di Don Giovanni: sotto al cappello a piume svolazzanti, sotto il volto celato del gran seduttore, appare il sorriso beffardo e lo sguardo cavo della maschera tragica di Dioniso.
Non sono certo io il primo ad aver colto questa profonda connessione, segnalo a riguardo i contributi Un viaggio da Mozart a Dionisio. Oltre il Don Giovanni. Essere per divenire e Dioniso immortale. Il Don Giovanni tra iniziazione e mito e di Domenico Alessandro De Rossi.
In particolare, nell’ultimo contributo citato, l’autore, dopo aver affrontato con profonda consapevolezza simbolica la figura del Nostro come riproposizione dell’archetipo dionisiaco, offre un’ardita quanto convincente interpretazione in chiave massonica, che capovolge in maniera sorprendente, e per questo illuminante, la prospettiva più immediatamente decifrabile dell’opera.
Dopo aver proposto una complessa esegesi numerologica dei messaggi occulti disseminati da Mozart e Da Ponte nel libretto, De Rossi, con un brillante guizzo ermeneutico, arriva a fornire una interpretazione di rara profondità esoterica del celebre beffardo gobbledygook di Leporello “Conciossiacosaquandofosseché il quadro non è tondo”, sintesi solo apparentemente giocosa dell’emblema cardine della Massoneria, ovvero l’unione di squadra e compasso.
De Rossi, da questa premessa, lascia scaturire un’interpretazione vertiginosa: l’opera è una meravigliosa allegoria di un’iniziazione dionisaca, in cui l’adepto è Leporello, testimone del superamento, in un complesso rito di morte e resurrezione durato quasi tre ore, della contrapposizione tra il dover-essere del Commendatore (pietrificato nel suo rifiuto di Dioniso, immagine del “sonno di Kundalini) e la libera volontà di Don Giovanni (sprofondato nelle fiamme della sua ricerca del piacere): “In finale, l’apparente contraddizione tra dimensione terrena di Don Giovanni e dimensione superumana del Commendatore, perde qui ogni valenza di sostenibilità. Ambedue le figure simboliche nel dramma giocoso, nella commedia e nella tragedia rappresentano insieme e nello stesso tempo l’unità della vita con le sue opposte alternanze. Tra dovere e libertà, tra conservazione e rivoluzione, tra ordine e disordine, tra regola ed eccezione, tra intuizione e razionalità, tra permanenza ed effimero, tra apparenza ed essenza, tra intelligenza ed ebbrezza, tra morte e vita, tra thanatos ed eros: tra Apollo e Dioniso.”.
In questo senso, il Don Giovanni rappresenterebbe il vero capolavoro iniziatico di Mozart, rispetto al più celebrato, in quel senso, Die Zauberflöte, il quale è in realtà la più esplicità esposizione essoterica della simbologia massonica in ambito artistico.
(…)
Parlando di Dioniso, è altamente significativo che lo stesso Nietzsche, il filosofo che ha riportato la deità greca al centro della riflessione occidentale, dedichi, in Aurora, al Nostro questa riflessione: “Il don Giovanni della conoscenza: non è stato ancora scoperto da nessun filosofo e da nessun poeta. Gli manca l’amore per le cose che conosce, ma nella caccia e negli intrighi della conoscenza- su su fino alle stelle più alte e lontane della conoscenza- è ingegnoso, formicolante di desiderio e ne gode, finchè non gli resta più nulla cui dar la caccia se non quel che nella conoscenza è assolutamente nocivo, come fa il bevitore, che finisce per darsi all’assenzio e all’acquavite. Così, alla fine, s’incapriccia dell’inferno- è l’ultima conoscenza, quella che lo seduce.”.
Altrettanto illuminante è pensare che per celebrare Dioniso in musica, sotto il travestimento continuo di Don Giovanni, si sia dovuto incarnare il dio opposto e complementare, Apollo, nella perfezione armoniosa del genio di Mozart.
Se non cogliete immediatamente l’accostamento al dio dell’ebbrezza, leggete queste parole di Davide Susanetti (tratte dal saggio L’altrove della tragedia greca) e pensatele riferite a Don Giovanni:
“Appare Dioniso. All’improvviso, come colui che sempre giunge da altrove, che irrompe da molto lontano. Inatteso e ignoto come se fosse sempre la prima volta. Estraneo e alieno, eppure così intrinsecamente intimo e proprio, come sempre è intima e propria la vita, anche quando non lo si sa o non lo si vede (…) Dioniso è qualcosa che forse non si vorrebbe, che si desidererebbe ignorare. Ma non è possibile, come non è possibile negare la radice che sta al fondo dell’esistenza e della natura. E la lezione per chi rilutta non può che darsi nella forma di uno choc violento (…) E insieme all’identità si frangono anche tutte le credenze, le opinioni e le scelte che da tale identità scaturiscono come necessario e inevitabile corollario. Nel compiersi della sventura assoluta o del più grande pericolo, vi è una crepa che non cessa di aprirsi e di approfondirsi fino a ingoiare ogni cosa (…) Vita assoluta in cui tutti gli opposti si congiungono e si sciolgono”.
Ecco perché amiamo il Don Giovanni, colui che diventa Oltreuomo in quanto “umano, troppo umano”, colui che inseguendo l’immediato non è mai nel presente, colui che per eccesso di amore spezza il cuore di chiunque, colui che fieramente va all’inferno perché a testa alta dichiara “A torto di viltate tacciato mai sarò”, colui che davanti all’incarnazione dell’Etica che gelida gli impone il ravvedimento oppone il suo “Ho fermo il cuore in petto”, colui che calpesta ogni rispetto ma ha alto il senso dell’onore, colui che inganna e violenta ma è colmo di coraggio, colui che è nella sua incessante ricerca del piacere è un bambino che ha smarrito l’innocenza e, quindi, come Pinocchio, strepita per affermare la propria unica, irredimibile, ardente individualità, egli è la manifestazione, trionfale e per questo fallimentare, seducente e per questo punita, per sempre fascinosa e per sempre dannata, di ciò che affratella tutta l’umanità come il vero Peccato Originale: l’ego.
Per questo, per affrancarci dalla sua trappola seducente, dobbiamo sublimarlo nella trasfigurazione apollinea dell’istinto dionisiaco, un miracolo che solo Wolfgang Amadeus Mozart, prediletto degli Dèi, poteva compiere.
BIBLIOGRAFIA
Le porte regali. Saggio sull’icona, Pavel Florenskij, a cura di Elémire Zolla, Milano, Adelphi, 1977
Vita avventura e morte di Don Giovanni, Giovanni Macchia, Bari, Laterza, 1966, poi Torino, Einaudi, 1978, poi Milano, Adelphi, 1991 e 1995
Lettura del “Don Giovanni” di Mozart di Massimo Mila, Collana Piccola Biblioteca n. 494, Einaudi, Torino, 1988-2000
Don Giovanni. La musica di Mozart e l’eros, trad. Kristen Montanari Guldbrandsen e Remo Cantoni, Milano: Denti, 1944: Milano: Mondadori, 1976
L’eroe dai mille volti, Joseph Campbell, Milano: Feltrinelli, 1958; 1984
La Divina Commedia, Dante Alighieri, ora in: Umberto Bosco e Giovanni Reggio (a cura di), Purgatorio, in Divina Commedia, vol. 2 Firenze, Le Monnier, 2003
Don Giovanni. Variazioni su un mito, Umberto Curi, Milano, Mondadori, 2002
Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno, Umberto Curi, Torino, Bollati Boringhieri, 2018
Don Giovanni, dal nome proprio al nome comune, Umberto Curi, 2013: video reperibile sul canale Youtube di Popsophia
Don Giovanni dalle fonti a Mozart. Metamorfosi di un mito, Eduardo Ciampi, Mino Freda, A.Rosa Porcheddu, Irfan, Roma, 2018
L’ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra, Tirso de Molina, Bur, Milano, 1956
Don Giovanni o il convitato di pietra, Molière, Marsilio, Venezia, 2011
Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni. Dramma giocoso in due atti, di Lorenzo Da Ponte, in Memorie, I libretti mozartiani, Garzanti, Milano, 1976
The Don Juan Theme. An annotated Bibliography of Versions, Analogues, Uses and Adaptions, Armand Edward Singer, Morgantown, West. Virginia University Press, 1993
Don Juan Tenorio, José Zorrilla, 1844, Editorial Oneness, 2016
Uomo e Superuomo. Commedia e Filosofia, George Bernard Shaw, Ghibli, Sesto San Giovanni, 2016
Don Giovanni. Tre saggi sulla leggenda, Gregorio Marañón, Gentile Paolo, Cacucci Editore, Bari, 1944
Don Juan. Un evento fantastico che è accaduto ad un entusiasta viaggiatore in Racconti di E.T.Hoffmann, Mondadori, Milano, 1942
Piccole tragedie, A.S.Puskin, Rizzoli, Milano, 1987
Il mito di Sisifo, Albert Camus, Bompiani, Milano, 1947
Sonetti, William Shakespeare, a cura di Lucia Folena, Einaudi, Torino, 2021
Finzioni: La biblioteca di Babele, Jorge Luis Borges, Einaudi, Torino, 1955
I fiori del male, Charles Baudelaire, trad. Luciana Frezza, Rizzoli, Milano, 1980
Il vero Don Giovanni, Marius Schneider, in Conoscenza Religiosa, 1974, poi in Edizioni di Storia della Letteratura, 2006
Le meraviglie della natura. Introduzione all’alchimia, Elémire Zolla, a cura di Grazia Marchianò, Marsilio, Venezia, 2017
Il fratello del fuoco in Il Romanzo di Mozart, Cristan Jacq, Cairo publishing, Milano, 2006
Una rilettura del “Don Giovanni” di Mozart in Preludi all’opera, Giovanni Bietti: video repereribile sul canale Youtube dell’Università di Catania
Il Don Giovanni, Lorenzo Da Ponte, a cura di Giovanna Gronda, Einaudi, Torino, 1995
Antico e moderno nel Don Giovanni di Mozart/Da Ponte in Don Giovanni e Faust: miti della modernità, Daniela Goldin: video reperibile sul canale Youtube dell’Accademia IISF
Bhahmasutra, Asram Vidya, Astrolabio, Roma, 1979
Bhagavadgita, Adephi, Torino, 1976
Così parlò Zarathustra, Friedrich Nietzsche, Adelphi, Torino, 1986
Aurora, Friedrich Nietzsche, Adelphi, Torino, 1978
Un viaggio da Mozart a Dionisio. Oltre il Don Giovanni. Essere per divenire, Domenico Alessandro Rossi, Gangemi, Roma, 2001
Dioniso immortale. Il Don Giovanni tra iniziazione e mito, Domenico Alessandro Rossi, Tipheret, Acireale, 2020
L’altrove della tragedia greca, Davide Susanetti, Carocci, Roma, 2023


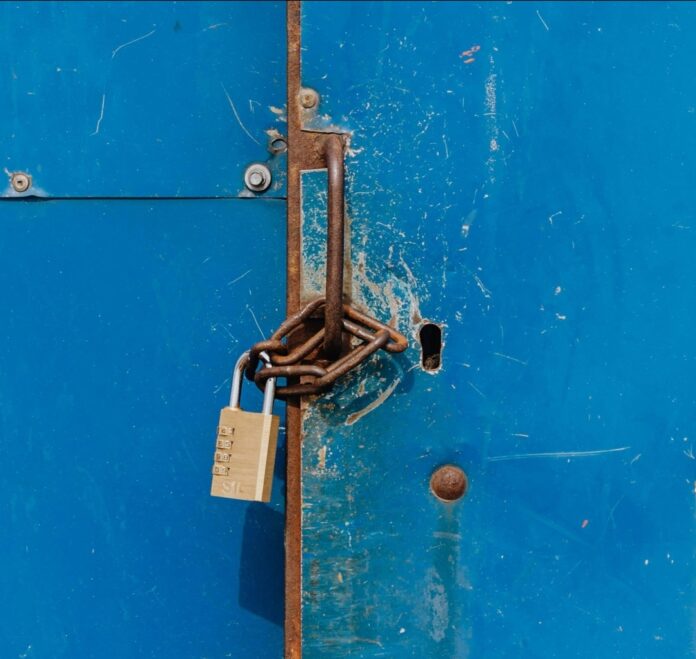



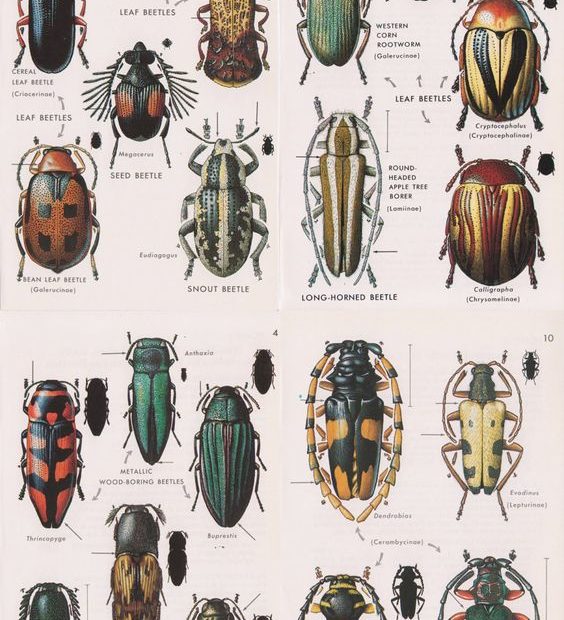






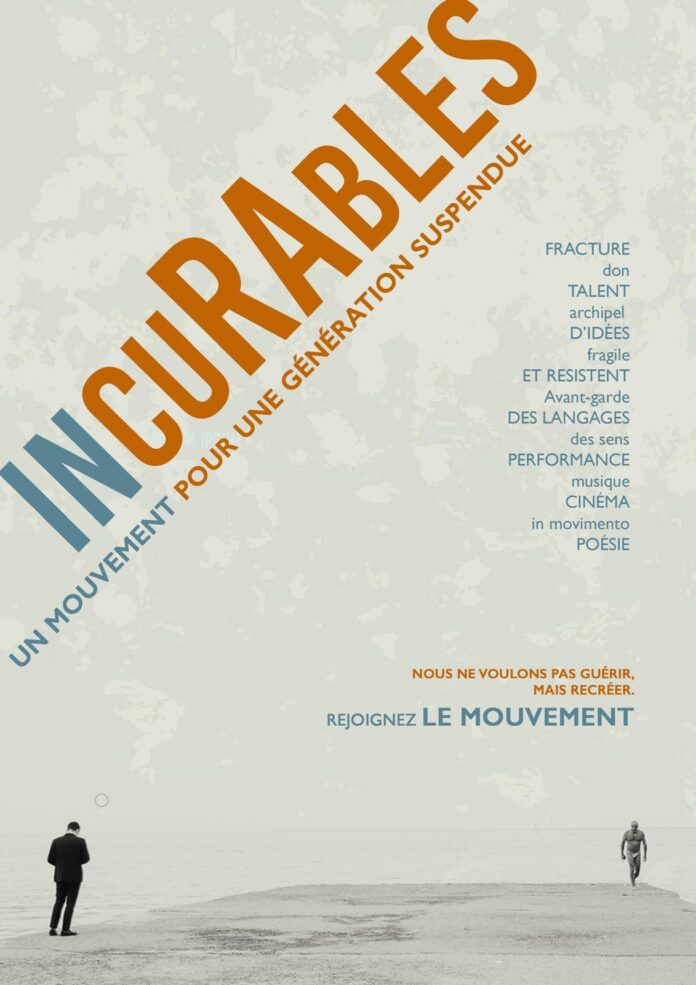
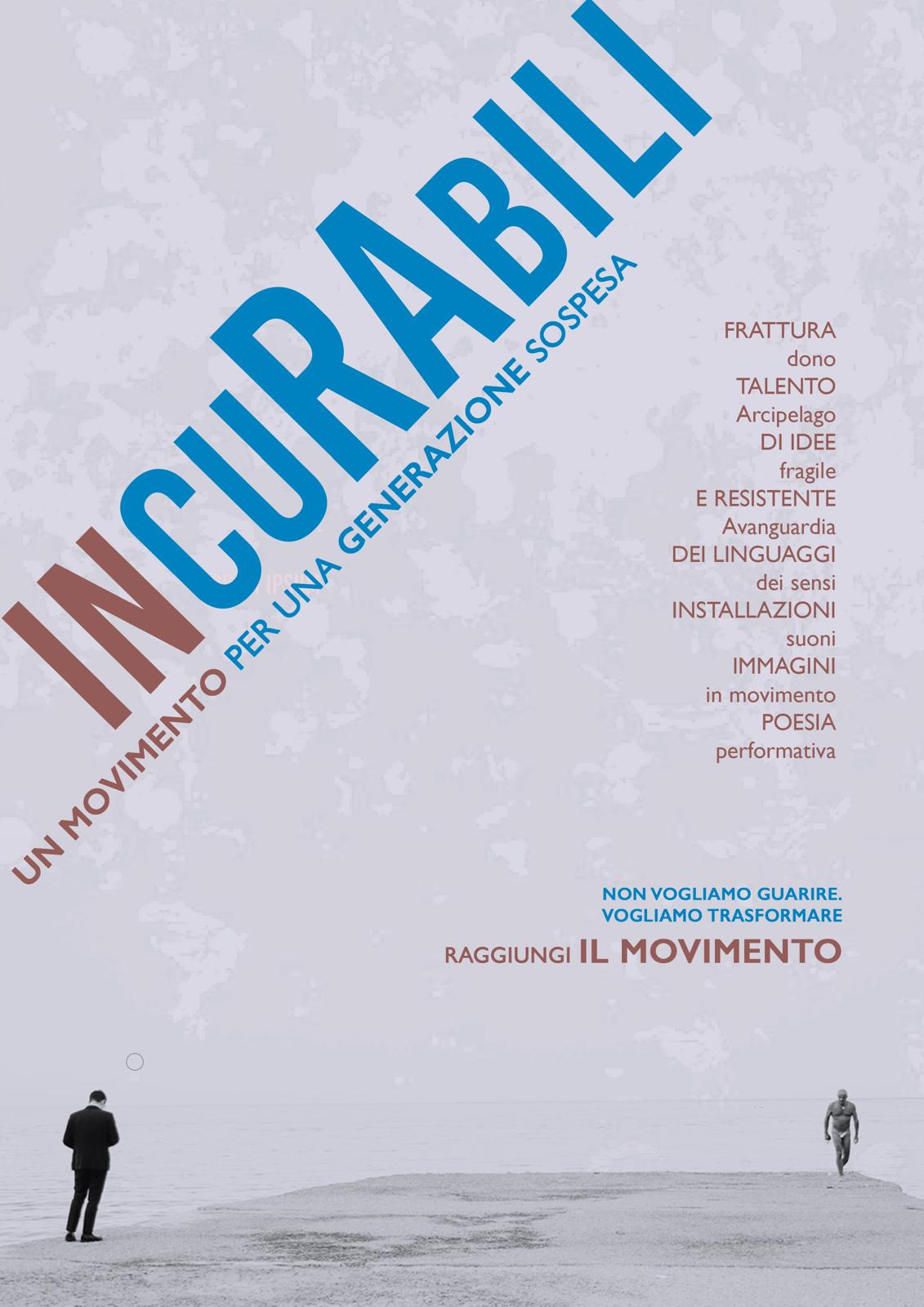 di
di