di Lorenzo Declich
Le cose, sul campo, erano già molto chiare all’inizio.
La violenza del regime ha iniziato a manifestarsi subito, anzi, la rivolta nasce simbolicamente come risposta “civile” a un atto di violenza: un gruppo di ragazzini, picchiati e torturati per aver scritto su un muro quello che pensavano di Bashar al-Asad.
La macchina della propaganda, allora, era già ben oliata, ma nessuno che avesse un po’ di senno pensò che video e immagini della repressione contro i manifestanti pacifici fossero dei falsi.
Cosa che, invece, diventò uno dei pilastri della disinformazione negli anni a venire.
Erano in divisa o in borghese, sparavano sulla folla inerme.
Al termine delle dimostrazioni rimanevano a terra in molti.
Qualcuno respirava, qualcuno si muoveva, altri no.
Alle dimostrazioni seguivano gli arresti, gli stupri, le torture, molte delle quali senza ritorno.
Gli attivisti lavoravano per far tornare a casa i prigionieri, o per avere loro notizie.
Nasceva il Centro di documentazione sulle violazioni in Siria, aprile 2011.
Documentavano le morti, le vessazioni subite dai prigionieri con racconti, fotografie, video di persone martoriate, smagrite, quasi in fin di vita.
Le proteste si organizzavano principalmente attorno a due eventi, uno programmato il venerdì, l’altro dipendente dall’intensità della repressione: i funerali.
***
Andò avanti così per un po’ e la rivolta, nonostante la repressione, si allargò.
Iniziarono gli assedi. Prima furono “morbidi”: blindati bloccavano le vie di fuga delle città ribelli.
La città di Deraa fu la prima.
Lo scopo del regime era silenziare le proteste, isolare i focolai di rivolta, non permettere il collegamento fra attivisti.
Quando c’era una manifestazione gli strateghi del regime mandavano l’esercito, i soldati dell’esercito di leva davanti a tutti, e ordinavano di sparare.
Se i soldati si rifiutavano di sparare venivano presi a fucilate alle spalle.
Morti e feriti aumentavano esponenzialmente.
Eravamo all’inizio di maggio 2011, le vittime erano centinaia.
Il regime parlava di “terroristi”, di complotto contro la Siria ma nessuno dalla parte dei manifestanti aveva ancora sparato un colpo.
A nulla servivano gli infiltrati, venivano isolati.
Si narra anche che la sicurezza lasciasse per strada armi da fuoco.
Era l’ennesima provocazione, i manifestanti erano dichiaratamente pacifici e lo rimarcavano continuamente nei loro slogan.
Ma lì si registrarono le prime defezioni di ufficiali dell’esercito.
Bashar al-Asad, il dittatore, decretò la prima di una serie di amnistie grazie alle quali mise in libertà criminali comuni ed esponenti dell’islam radicale.
Un cavallo di Troia utile a legittimare l’algoritmo della violenza che i suoi seguaci traducevano nello slogan: “O Asad o bruciamo il paese”.
***
Gli assedi si moltiplicarono nelle città che il regime ritenne essenziali dal punto di vista strategico.
Homs, Baniyas, Tafas, Talkalakh, Rastan, Talbiseh, Jisr ash-Shughur.
In giugno a Jisr al-Shughur, cittadina di frontiera con la Turchia nella provincia di Idlib, si registrò il primo caso di violenza da parte dell’opposizione.
La città era assediata dall’esercito governativo, uomini armati – secondo gli attivisti si trattava di soldati defezionari – attaccarono le forze della sicurezza e le postazioni della polizia.
L’assedio si concluderà la settimana seguente con una carneficina, almeno 120 manifestanti rimasero uccisi.
Fu un episodio premonitore, in tutti i sensi, ma prima ci fu il 22 luglio 2011, il venerdì delle manifestazioni di massa in tutta la Siria.
Il punto più alto della rivolta pacifica.
La cifra della rivoluzione siriana.
Le bandiere sventolate dai manifestanti erano ancora quelle ba’athiste, le bandiere panarabe della Siria degli Asad.
Successivamente i rivoluzionari, per segnare un punto di non-ritorno, adottarono la bandiera dell’indipendenza.
Le città coinvolte furono soprattutto Hama – città simbolo della repressione asadiana – e Deir Ez-Zor ma l’intero paese, dalla costa al nord-est curdo, pullulava di presidi e proteste.
L’esercito siriano venne dislocato al centro di Damasco, dove le manifestazioni vennero di fatto impedite.
Il 29 luglio, per iniziativa di un gruppo di ufficiali disertori dell’Esercito Siriano nasceva L’Esercito Siriano Libero, con lo scopo primario di difendere le manifestazioni pacifiche dagli attacchi delle forze di sicurezza, dei civili lealisti e dell’esercito governativo.
Due giorni più tardi, il 31 luglio, nel quadro di un’operazione di repressione su scala nazionale, l’esercito regolare entrava a Hama e a Deir ez-Zor con i carri armati senza incontrare alcun genere di resistenza.
Spararono sulla folla, a caso.
Poi piazzarono i cecchini appostati sui tetti.
Il “massacro di Ramadan” fece 136 vittime.
Passarono le immagini di corpi ammassati l’uno sull’altro, corpi senza testa, bambini arsi vivi.
***
A fine 2011 ci fu il primo attentato.
Esplosero due autobomba a Damasco, 34 morti secondo le autorità.
La televisione di Stato, giunta in loco pochissimi minuti dopo le esplosioni, inquadrava pezzi di essere umani sparsi sull’asfalto.
L’evento, che giungeva il giorno dopo l’arrivo degli osservatori della Lega Araba, fu il primo del genere nel conflitto siriano, non fu mai rivendicato.
Ne verranno altri, le modalità sono le stesse, lo spettacolo anche.
A partire dal 3 febbraio 2012 l’esercito governativo bombardò con l’artiglieria la città di Homs – snodo economico e strategico fondamentale per il regime – in particolare i quartieri della ribellione.
L’offensiva terminò il 14 aprile successivo, quando il regime affermerà di controllare circa il 70% della città.
Alto il prezzo pagato dalla popolazione.
La città sarà infine rasa al suolo, la sua anagrafe bruciata.
A marzo 2012 il campo profughi palestinese di Yarmuk, divenuto nei decenni un vero e proprio quartiere di Damasco, si unì alla rivolta.
Iniziò la repressione, in un’escalation che porterà al blocco totale del campo.
Come in altre zone calde la strategia del regime sarà il blocco degli accessi all’area e il martellamento tramite artiglieria.
Due anni più tardi Yarmuk sarà di nuovo in mano al regime.
Le immagini parlano chiaro, fu presa per fame.
Bambini e vecchi morivano.
Quelli ancora vivi erano ridotti a scheletri.
La stessa strategia venne messa in atto nelle aree liberate di Homs, che alla fine caddero.
Oggi il regime si esercita nella stessa pratica in altri quartieri di Damasco e ad Aleppo.
***
Nell’aprile 2012 un doppio attentato dinamitardo scosse la capitale.
55 le vittime secondo le fonti del governo.
Per la prima volta l’obiettivo era civile.
Pezzi di corpi sull’asfalto.
Il regime accusò “i terroristi” e qualche giorno più tardi su internet comparve una rivendicazione della Jabhat al-nusra, gruppo armato estremista che più tardi scopriremo essere affiliato ad al-Qa’ida, che immediatamente smentì.
Fu il mese di inaugurazione della “stagione delle stragi”.
Avvennero in paesi, piccole cittadine attorno a Homs.
Il regime faceva “pulizia” nelle aree che riteneva strategiche.
Quella di Hula è la più conosciuta, ne seguirono diverse altre, fra cui quelle di al-Buwayda al-Sharqiyya e al-Qubayr.
L’esercito chiudeva le via d’accesso all’area, bombardava con l’artiglieria.
Poi entravano in azione i “reparti speciali”, formati da civili lealisti, che facevano irruzione nelle case e uccidevano chiunque trovassero.
Le immagini fecero il giro del mondo.
Case distrutte, corpi ammassati, messi in fila.
Gli eventi vennero definiti dagli analisti un “punto di svolta” del conflitto.
Ma l’atteggiamento degli attori internazionali non mutò.
Nei fatti la strage di Hula determinò la fine del “cessate il fuoco” che, mai davvero rispettato, era stato annunciato dall’inviato dell’ONU Kofi Annan il 4 aprile precedente.
***
Il 17 luglio 2012 partì una grande offensiva dei gruppi ribelli, fra i quali figuravano già un buon numero di formazioni di spiccato carattere confessionale.
Gli obiettivi erano le principali città (il 19 luglio inizia la battaglia per Aleppo, ancora in corso).
Iniziò la guerra, una guerra asimmetrica e sempre più sporca.
Iniziò a manifestarsi, anche, il gioco della guerra per procura.
Iran (e poi Hezbollah e milizie sciite iraqene) e Russia con Asad, gli arabi del Golfo e la Turchia con la ribellione.
Polarizzazione in senso confessionale.
Gli Stati Uniti e l’Europa rimasero nel limbo.
La Cina alla finestra.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite immobilizzato.
***
Il 3 novembre 2012 l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani denunciava l’esecuzione sommaria di militari dell’esercito regolare siriano catturati dai ribelli.
Questo e altri fatti avvennero nonostante l’Esercito Siriano Libero si fosse dato in agosto un “codice di autoregolamentazione” per impedire eccessi di questo genere.
Il fondamentalismo intanto montava, le brigate si radicalizzavano.
I combattenti non siriani, da ambo le parti, erano ormai una realtà tangibile.
Entrava in scena l’aviazione del regime, coi razzi.
Bombardavano scuole, ospedali, istallazioni civili.
Nel gennaio 2013 venne colpita l’università di Aleppo.
Era giorno di esami, fu una strage.
Nello stesso mese, nella stessa città, corpi senza vita emersero dal fiume Qweyq.
Erano circa 80 persone giustiziate dai lealisti con un colpo di pistola, legate mani e piedi e gettate in acqua.
Più avanti iniziarono a manifestarsi le evidenze di attacchi chimici, bombe incendiarie, gas.
Caddero anche bombe a grappolo.
Corpi martoriati, persone che scavano, persone intossicate e poi morte asfissiate.
Il flusso dei profughi e degli sfollati aumentava esponenzialmente.
Pestaggi, umiliazioni, stupri, accanimento su corpi esanimi, processi sommari, fucilazioni ed esecuzioni efferate da ambo le parti.
Un combattente di Homs la cui famiglia era stata sterminata dai lealisti strappò il cuore dal corpo di un militare di Asad, lo portò alla bocca nell’atto di mangiarlo.
La spirale della vendetta sembrava non conoscere fine.
E fecero la loro comparsa i barili bomba: ordigni ciechi, senza propellente, armi di distruzione di massa destinati ad uccidere indiscriminatamente.
Le vittime erano quasi soltanto civili, puro terrore.
***
Nell’aprile 2013 infine fece la sua comparsa lo Stato Islamico di Iraq e Siria (ISIS) che operava inizialmente a cavallo fra le frontiere siriana e iraqena.
La situazione, lo avrete capito, era già ampiamente deteriorata.
L’Esercito Siriano Libero soccombeva, mancava di logistica e coordinamento.
Diverse brigate avevano cambiato bandiera, si rafforzavano e si federavano le formazioni jihadiste, meglio equipaggiate e foraggiate.
Altre, lasciate a se stesse, si abbandonavano a razzie, gestivano i traffici di armi, agivano come veri e propri gruppi criminali.
A Qusayr l’aviazione lealista bombardò i civili in fuga dalla città dopo la conquista della cittadina da parte dell’esercito siriano e del libanese Hezbollah.
Nella Ghuta di Damasco il regime bombardò col sarin.
L’ISIS occupò l’est del paese, abbandonato dal regime, e guerreggiò a nord.
Mentre Asad teneva l’esercito nelle caserme, ISIS prendeva possesso del territorio e dell’amministrazione.
Combatteva contro i gruppi armati anti-regime, si accaniva contro gli attivisti, incarcerava gli esponenti della società civile, li uccideva in piazza di fronte alla popolazione e poi esponeva in pubblico i loro corpi crocifissi.
Si apriva un nuovo fronte per l’eterogeneo fronte anti-Asad, anche l’ISIS era “il nemico”.
***
Ecco, questo ho visto io in questi anni.
Un colpevole: il regime di Bashar al-Asad, spalleggiato dai suoi complici d’oriente e d’occidente, avallato dai silenzi di chi nel mondo voltava le spalle e chiudeva occhi e orecchie.
Una risposta: l’aumento esponenziale dell’esercizio della violenza.
Un esito: la barbarie.
***
Il 16 aprile 2013 l’ONU invocava la pace in Siria, usando le facce di ben cinque responsabili di agenzia (OCHA, PAM, UNHCR, UNICEF, OMS).
Una di queste cinque facce, quella del Direttore dell’Alto Commissariato per i Rifugiati, che si chiama António Guterres ed è stato Primo ministro nel suo paese, il Portogallo, parlò con i giornalisti dell’Economist.
Spiegò loro che la guerra in Siria, secondo il suo modesto parere di uomo che di conflitti ne ha visti decine, era la più brutale dal 1989 – cioè dalla fine “dichiarata” della Guerra fredda – a oggi.
Lo era dalla prospettiva dell’impatto sulla popolazione e da quella della percentuale totale della popolazione in stato di bisogno.
In quegli stessi giorni tornava dalla Siria Amedeo Ricucci, cronista di guerra di lungo corso, una specie di Guterres italiano nel suo campo, dopo essere stato ostaggio di una brigata di qaidisti che, proprio in quei giorni, passava dalla Jabhat al-nusra all’ISIS.
La cosa più importante che disse, appena sceso dall’aereo, non riguardava la Siria in sé, ma il fatto che fosse diventato quasi impossibile raccontare la Siria.
Da una parte, già allora, c’era un regime che considerava “obiettivi militari” tutti coloro che entravano nel paese “illegalmente”.
Dall’altra un groviglio di fazioni armate che dimostravano di non aver più alcuna fiducia nel “potere della stampa” e di non farsi scrupoli di fronte alla prospettiva di qualche vantaggio economico (o nel caso dell’ISIS anche propagandistico).
In mezzo c’erano decine, centinaia di giornalisti, per lo più siriani “freddati con colpi di arma da fuoco alla testa, torturati a morte, sequestrati e mai più tornati a casa” (fonte).
***
Bene, prendete in considerazione le due coordinate della “brutalità” e del “silenzio” e consideratele in atto su una scala temporale sempre più ampia o, se preferite, su una scala di potenza sempre maggiore.
Su un tratto temporale breve incontreremo il tiro a segno del regime sui manifestanti e, poco più in là, il massacro di Hula o i “massacri del pane”, quei “punti di svolta” che, se ignorati (cosa di fatto avvenuta), rendono ancora più clamoroso il silenzio.
Su un tratto di media lunghezza – ad esempio dall’inizio della rivolta fino all’aprile 2013 – troviamo 70.000 morti e 6 milioni e mezzo di rifugiati o sfollati.
Parliamo di numeri, qui, di numeri in progressione, ovvero di qualcosa che ci “risveglia l’attenzione” in occasione di cifre tonde (100.000!) o di salti di scala (1:10!).
E su un tratto lungo?
Sul tratto lungo c’è un crimine di inaudita brutalità reso possibile da un silenzio ormai definitivo, una cosa così spaventosa da renderne addirittura scabrosa la menzione.
Sul tratto lungo c’è una cosa che si chiama sterminio.
***
Siamo arrivati a settembre 2014, è passato un anno e mezzo.
I morti sono triplicati.
Un terzo degli abitanti della Siria, 8 milioni di persone, è fuggita dal paese, vive la condizione di profugo.
Non si contano più gli sfollati interni.
Da gennaio, l’ONU ha smesso di contare i morti.
Noi però da queste parti parliamo solo dell’ISIS, e solo nella misura del fatto che l’Occidente “è in pericolo”.
E questo non lo dico per cercare di smuovere qualche coscienza.
Lo dico perché sono certo che a molti, oggi, sfugge un aspetto centrale del “problema mediorentale”: la Siria di Asad.
Però, per parlare dell’oggi, delle preoccupazione dei nostri Ministri dell’interno, dei tagliatori di teste anglofoni e delle teste mozzate in Iraq, uso le parole di Zanzuna (uno pseudonimo).
L’articolo, che qui riporto per intero, è apparso il 9 settembre su SiriaLibano.
Siria, in carcere chi chiede dei militari scomparsi
Non ha usato mezzi termini il presidente americano Barack Obama quando, nell’incontro Nato tenutosi venerdì a Newport in Gran Bretagna, ha parlato dei mezzi per sconfiggere lo Stato islamico. Non ha utilizzato l’espressione “linea rossa”. Né ha insistito sulla “necessità di trovare soluzioni politiche”.
Obama è sembrato deciso e chiaro: “Vi è una ferma convinzione che dobbiamo agire. (…) Lo Stato islamico è una grave minaccia per tutti. E nella Nato c’è una grande convinzione che è l’ora di agire per indebolire e distruggere l’Isis”.
Da Newport 2014 a Bruxelles 2013 è passato più di un anno. Allora, la tavola rotonda della Nato aveva altre priorità, e la situazione siriana presentava realtà diverse: la Nato respinse un “intervento nel conflitto siriano, nonostante il deterioramento della situazione”.
Non sembra essere molto utile mettersi a studiare cosa è accaduto in questo periodo per capire come mai la Nato abbia cambiato idea.
Non è stato per Raqqa, la prima città uscita dal controllo del regime nel marzo 2013 e capace di gestire la sua vita civile nel primo mese di libertà, prima dell’arrivo dello Stato Islamico. Non è stato per il massacro della Ghuta con i gas nell’agosto 2013.
Forse il caos creato dallo Stato islamico in Iraq è diverso da quello creato in Siria. Forse solo adesso “le minoranze del mosaico religoso sono a rischio”. Forse è stato a causa della morte dei due giornalisti americani James Foley e Steven Sotloff, barbaramente uccisi dallo Stato Islamico. In questo modo il video game funziona e convince il mondo a unirsi per combattere contro i terroristi.
Anwar al Bunni, avvocato siriano da decenni in prima fila per la difesa dei diritti umani, scrive sulla sua pagina Facebook: “Non so perché il mondo vibra di panico quando centinaia di teste vengono tagliate dalla spada, ma non vibra quando decine di migliaia di persone vengono uccise dai barili esplosivi lanciati dagli aerei, o dai missili, o dalle armi chimiche, o sotto tortura (…). La risposta ha a che fare con l’identità dell’assassino? O forse con l’identità della vittima? Se l’assassino indossa l’abito laico gli è permesso forse di uccidere chi vuole e nel modo in cui lui vuole? Ma se il boia indossa l’abito religioso gli è vietato anche di urlare?”.
Due facce della stessa medaglia. Una uccide il popolo con il coltello. L’altra col veleno. Una uccide e dice “sto uccidendo e sono così”. L’altra consegna alla prima il popolo che deve essere ucciso.
Il presidente siriano Bashar al Asad ha imparato dall’esperienza americana: creare il nemico terrorista serve per diventare il baluardo contro l’integralismo da combattere con tutti i mezzi, leciti o meno. A dire il vero, Asad figlio ha imparato bene dal padre.
Per fare funzionare questo gioco chiede ai suoi militari di ritirarsi da alcune aree, lasciando scoperti molti luoghi del fronte contro lo Stato islamico. Molti suoi soldati sono così lasciati impotenti da soli ad affrontare l’attacco della marea nera dei jihadisti. Solo allora, servirà l’intervento salvifico delle truppe di Asad.
Nadin, un’attivista siriana, racconta la sua storia nelle località attorno a Tartus: “Non ci sono più uomini nei villagi alawiti. Questi villaggi sono ormai famosi perché le donne che vi abitano non hanno più un uomo al loro fianco. Gli uomini che tornano, tornano morti”.
#Wainun(“Dove sono?”) è una campagna Web gestita da attivisti siriani per chiedere che sia fatta luce sulle sorti degli scomparsi come Padre Paolo, Razan Zaytune, Samar Saleh, Mazen Darwish, Yehya Sharbaji e molti altri.
Su modello di questa campagna, i siriani fedeli ad Asad, hanno cerato una pagina Facebook in cui campeggia la foto del raìs e chiamata: “Le aquile dell’areoporto militare di Tabqa, uomini di Asad” in riferimento alla battaglia avvenuta a fine agosto nella regione settentrionale di Raqqa tra lealisti e jihadisti.
Di solito questa pagina incoraggiava i soldati a combattere nel nome di Asad. Soprattutto quelli rimasti nella base militare area di Tabqa ad affrontare lo Stato islamico. Ma quelle “aquile” sono poi state abbandonate. Senza nessun sostegno di Asad.
Ecco perché i lealisti, autori de “Le aquile dell’areoporto militare di Tabqa, uomini di Asad”, hanno creato nella stessa pagina una sezione informativa chiamata #Wainun dove raccolgono notizie sulla sorte dei militari dell’esercito regolare scomparsi.
L’episodio di Tabqa non è stato certo l’unico. Ma è stato il più recente e quello più drammatico. Centinaia di soldati sono stati uccisi dai jihadisti. Il regime non solo non li ha difesi, non ha nemmeno parlato della loro morte nei canali televisivi governativi che hanno invece proseguito a trasmettere secondo il palinsesto regolare, con musichette e serie televisive.
I toni espressi nella pagina Web #Wainun dei lealisti mettono a nudo la rabbia e la delusione di molti sostenitori del regime: “Dove sono i nostri figli?”, hanno chiesto in molti. Come se questi seguaci di Asad si fossero accorti solo adesso del gioco e del fatto che il regime è capace di impegnare ogni energia per liberare dei rapiti russi o iraniani, ma è capace di lasciare al loro destino tragico centinaia di soldati semplici. Come carne da macello e niente più.
La pagina lealista #Wainun ha così superato la “linea rossa” indicata dal regime e dai suoi servizi di controllo e repressione. Ma non comprendete male: non è che gli agenti dei servizi sono andati a difendere i soldati di Asad al fronte contro i jihadisti. No… gli agenti sono andati ad arrestare l’amministratore della pagina Facebook e l’ideatore della campagna, Mudar Khaddur.
Khaddur è sempre stato un lealista. Poi ha perso uno dei suoi fratelli nella battaglia dell’aereoporto. E ha creato questa pagina per chiedere ad Asad e al ministro della difesa, Fahd al Frej, i motivi per cui i generali sono scappati, lasciando i soldati in mano allo Stato islamico, che prima li ha insultati e poi uccisi. Khaddur ha trascorso giorni e giorni per raccogliere informazioni sui soldati scomparsi e per dare la notizia alle loro famiglie.
Questa partita a scacchi il regime la vuole giocare fino all’ultimo. Ha capito di essere il re e di poter giocare col sangue. Non pensa di esser sconfitto solo perché fa la parte del cattivo. Non crede alle favole, dove i cattivi alla fine vengono sconfitti. A differenza di noi, il regime di Asad sa che non è “il protettore del Paese” e che non è “il protettore delle minoranze”. Lo sa bene e sorride di fronte ai proclami di Newport e Bruxelles, ai negoziati di Ginevra-2 e Ginevra-1, alle riunioni degli Amici della Siria e degli Amici del regime. Perché in questa partita a scacchi, nessuno vuole gridare “Scacco matto!”.




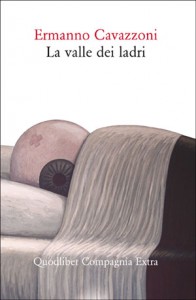








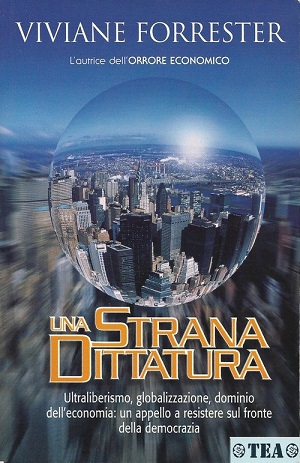
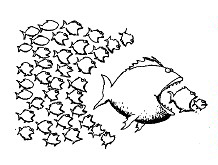

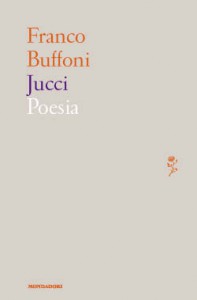 di Marco Corsi
di Marco Corsi

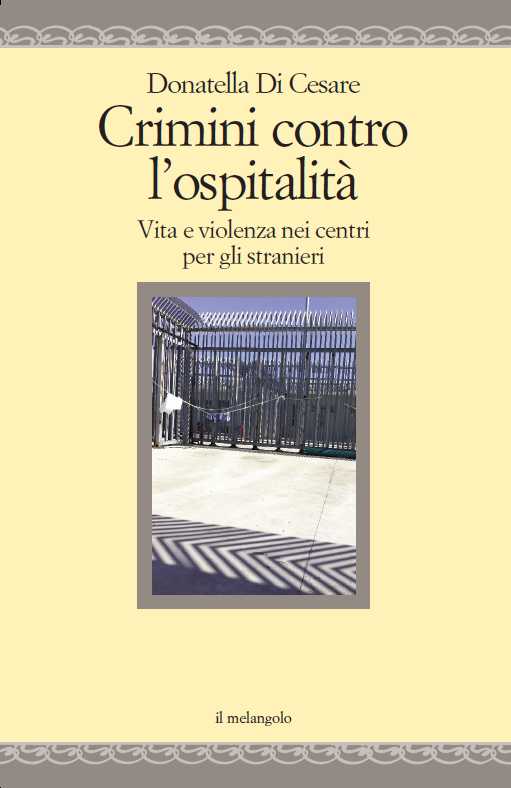 Nel mondo globalizzato il successo si misura con la possibilità di muoversi liberamente. L’immobilità è invece il segno della sconfitta: chi resta indietro è emarginato, escluso dai luoghi che gli altri possono attraversare, confinato a una dimensione locale.
Nel mondo globalizzato il successo si misura con la possibilità di muoversi liberamente. L’immobilità è invece il segno della sconfitta: chi resta indietro è emarginato, escluso dai luoghi che gli altri possono attraversare, confinato a una dimensione locale.


