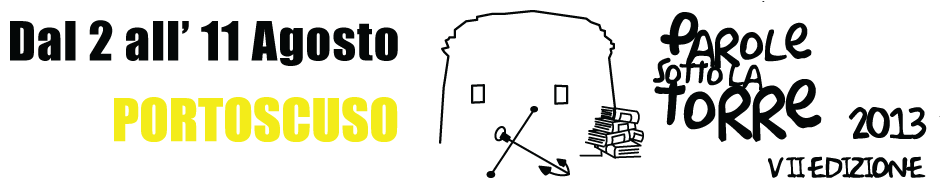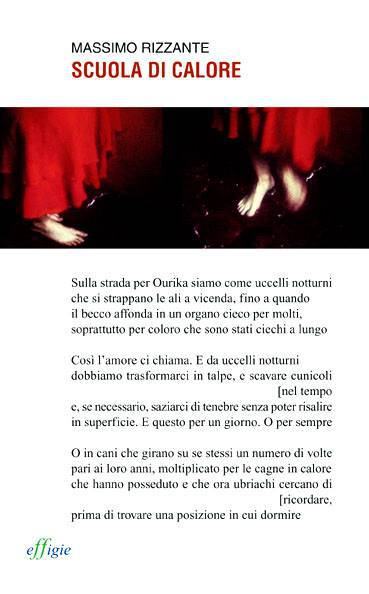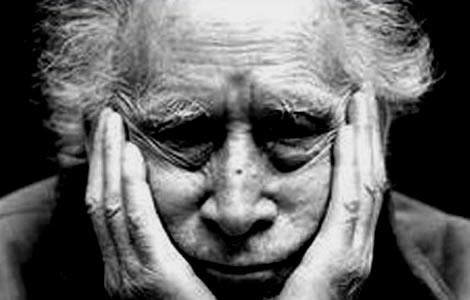
Mario Luzi e Valerio Nardoni
La ferita nell’Essere.
di
Alessandro Vincenti
“Valerio Nardoni è un fortunato incontro che questi tardi anni della mia vita mi hanno regalato. Ho potuto conoscere direttamente in lui alcuni aspetti vivi e franchi della gioventù di oggi e in più una tutta sua personale genialità. Quando le circostanze lo misero, per così dire, sulla mia strada, sapeva poco di me. Coscienziosamente volle acquisirne qualche notizia da conversazioni e letture; poi sollecitato da stimoli sempre meno casuali, decise di esplorare sistematicamente il mio lavoro poetico assai più che semisecolare, e poco più tardi di organizzarlo intellettivamente a suo sogno e libido. Nacque allora l’idea di una antologia non canonica, ma libera e attiva – spiritualmente e fantasticamente attiva – quale soltanto Valerio poteva concepire.”
Così scriveva Mario Luzi, in prefazione, di Valerio Nardoni, curatore de La ferita nell’Essere. Un itinerario antologico, uscito per Passigli Editori nel 2004 (in occasione dei 90 anni del poeta) e poi distribuito nel 2005 con il quotidiano “La Repubblica”.
L’antologia raccoglie l’amplissima opera poetica di Mario Luzi, uno dei massimi esponenti, insieme a Oreste Macri, Giansiro Ferrata e Luciano Anceschi dell’ermetismo fiorentino, suddividendola secondo le tre parti in cui il poeta stesso aveva diviso la sua opera: “Il gusto della vita”, dove si trovano poesie della primissima produzione luziana, appartenenti a raccolte poetiche come La barca (1935), Avvento Notturno (1940), Un brindisi (1946), Quaderno gotico (1945), Primizie del deserto (1952) e Onore del vero (1957); nella seconda parte, “Nell’opera del mondo”, sono raccolte poesie che vanno dal 1957 al 1978, appartenenti a Dal fondo delle campagne (1965), Nel magma (1963), Su fondamenti invisibili (1971), Al fuoco della controversia (1978); la terza parte, dal titolo “Frasi nella luce nascente”, raccoglie poesie dell’ultima fase della produzione del Luzi, con poesie appartenenti alle raccolte Per il battesimo dei nostri frammenti (1985), Frasi e incisi di un canto salutare (1990), Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994). Alle tre parti se ne aggiunge una quarta – titolo fino a quel momento inedito e concordato con il poeta, come ci dice Valerio Nardoni – “Rigenerazione dell’aria”, che contiene le poesie dell’ultimissima fase della produzione luziana, aperta con la raccolta Sotto specie umana (1999).
La ferita nell’Essere – titolo ripreso da un verso della poesia Bimbo, parco, gridi – esplora l’intera produzione artistica del grande poeta fiorentino, attraverso un’operazione di scavo e di dissodamento di vaste zone dell’esteso terreno poetico luziano, per giungere alla faticosa e suggestiva emersione di veri e propri lussureggianti giardini galleggianti dove la poesia di Luzi incontra la suggestiva prosa dei commenti di Nardoni, liberamente costruiti sullo scrosciare impetuoso della parola di uno dei più grandi e fecondi poeti del ‘900 italiano.
L’impossibilità di riassumere secondo un criterio uniformante una così vasta vicenda poetica, che attraversa più di cinquant’anni di attività letteraria, costringe questa antologia ad affidarsi, per tenere fede al suo compito, alla ricerca delle tracce che la parola ha disseminato su terreni più disparati, seguendo come unico criterio quello dell’Essere in rapporto alla sua esistenza, scandita da avori, orizzonti inquinati di provvisorietà, realite rugueuse, ferite; fino a giungere, a conclusione di questo rapporto, con la rigenerazione dell’aria, “perché la parola del suo significato in divenire possa volare e respirarsi, entrare in altri canti ancora, perché non è più parola di un uomo, ma necessità della sua imperturbabile origine”, come scrive lo stesso Nardoni.
Valerio Nardoni, oggi vive e lavora a Firenze, ed è un apprezzato critico e traduttore letterario di prose (Miguel de Cervantes, Javier Marías) e raccolte di poesia spagnola (Pedro Salinas, Federico García Lorca, Pablo Neruda, ecc.). Nel 2010 ha fondato il premio di poesia internazionale Premio Ciampi – Valigie Rosse, di cui dirige la rispettiva collana. Nel 2012, per le Edizioni E/O, ha pubblicato il suo primo romanzo Capelli blu (titolo di luziana memoria, dal primo verso della raccolta Un brindisi, che recita: “Ma i tuoi capelli blu dimenticati”). Dal 2003 fino alla morte del grande poeta di Castello, avvenuta nel 2005, ne è stato uno dei più stretti collaboratori.
1) Valerio, ci vuoi parlare di questo incontro con il maestro Mario Luzi?
Ho raccontato in più occasioni del mio incontro con Mario Luzi, in quanto si tratta di un evento davvero straordinario e non senza un lato comico, che permette in qualche modo di rievocarlo con umiltà, secondo quello che è stato veramente: l’incontro fra uno dei più grandi poeti europei del secolo scorso ed uno studentello appena laureato. Cercherò di essere breve, il fatto è questo: per pagarmi gli studi universitari, una volta arrivato a Firenze (da Livorno, la città dove sono nato) ho svolto vari lavori, molto umili, ma anche divertenti, come quello di fare le pulizie in casa di un alcolizzato, proprietario di un ristorante. Intanto, avevo iniziato a studiare spagnolo e come sempre, quando si inizia a scrivere in una lingua straniera, si deve cimentarsi con le cose più semplici, raccontando – come alle elementari – del proprio gatto, della propria stanza, e così via. Io raccontavo delle mie avventure nella casa di quell’eccentrico uomo con la barba bianca fino all’ombelico. La lettrice di spagnolo, per questo ed altri motivi (certo, anche il fatto che alla fine mi sono laureato a pieni voti), dopo la laurea mi propose un lavoro, ovvero mi chiese se fossi stato disponibile a fare assistenza ad un anziano, per qualche ora al giorno, arrotondando così le mie magrissime finanze.
Non sapevo che la stessa persona aveva tradotto in spagnolo delle poesie di Mario Luzi e che fosse amica della più stretta collaboratrice di Luzi in quel momento, così mi presentai per il colloquio pensando che, detta signora, fosse la figlia dell’anziano signore.
Tirai fuori tutte le mie doti più incredibili: so dare la cera, pulire una persiana, intonacare una parete… lei intanto mi diceva che ero perfetto per quel lavoro… e io proseguivo: so portare quattro tazzine da caffè con una mano… finché non mi chiede: ma tu sei laureato? Al che mi stizzisco: so fare di tutto, lavo, asciugo, stiro, ma anche laureato? Ma che vecchietto è?
“E’ Mario Luzi”.
2)Da dove nasce l’idea di “un’antologia non canonica”, ma attiva, pensante, dove ad ogni poesia fai coincidere una sorta di parafrasi che è può essere considerata pura ricerca delle tracce disseminate del testo ?
La stessa mattina che mi presentai a casa di Mario Luzi, dopo una lunga chiacchierata, scendemmo a fare una passeggiata, e non appena giunti alla fine delle scale, non potei più trattenermi e gli dissi in tutta sincerità: “io so chi è lei, è il più importante poeta vivente italiano, mi deve scusare, ma non posso non dirle questo: io non mai letto una sua poesia”.
Luzi mi abbracciò commosso, un po’ – credo – per la tenerezza della mia spontaneità, e un po’ per il fatto che, come naturale, era circondato da migliaia di petulanti che lo contattavano solo per chiedere, appellandolo di “maestro” e cose varie… sebbene, come me, non avevano forse mai letto un verso suo: alcuni gli inviavano delle lettere scrivendo Luzzi con due zeta!
Ebbene, da quel giorno, con estrema tenacia ed umiltà, ho letto poesia per poesia tutta la sua opera poetica, commentando insieme a lui le varie cose e i miei molti dubbi durante le nostre molte passeggiate…
3) Puoi parlarci del tuo rapporto con Luzi, e in particolare della genesi di questa antologia scritta a stretto contatto con il poeta?
In parte ho già risposto a questa domanda. Per dire ancora del mio rapporto con Luzi, voglio aggiungere soltanto che, nella vita, quando si incontra un uomo grande veramente, ci se ne accorge: a me è successo solo quella volta. Luzi era grande, oltreché nella poesia, in ogni altro singolo istante della sua giornata. Parlando, trasformava il mondo che io mi vedevo davanti agli occhi. Una volta, per fare una cosa carina, piantai due pinoli, da cui nacquero due pini e gliene regalai uno (il mio ce l’ho ancora). Mise il suo sulla sua bella terrazza e un giorno, che commentavamo insieme quanto fosse cresciuto, mi chinai per togliere un filo d’erba che era nato nel vaso. Mi fermò stupito e mi disse: perché lo togli? Non sapevo cosa rispondere, forse rimasi in silenzio a guardarlo, ma ricordo che lui disse ancora: come fai a sapere chi ha più diritto di stare in quel vaso? Dell’antologia voglio dire proprio questo: Luzi ha voluto che il lavoro fosse pubblicato per lo stesso motivo. Era un filo d’erba a fianco dei molti amici, critici e studiosi che lo circondavano, ma era verde.
4) Derrida dice che nella parola scritta non c’è l’essere, ma ci sono le tracce e le assenze dell’essere, che si disseminano nel e dal testo scritto. L’operazione di ascolto di queste tracce/assenze si sono trasformate in un altro testo, nella fattispecie le poesie di Luzi sono riecheggiate in te nella forma della prosa poetica. Una concatenazione potenzialmente infinita, dove lo scarto tra l’essere e il testo e tra testo e testo non potrà mai essere colmato. È questa la ‘ferita nell’essere’ a cui fai riferimento nel titolo dell’antologia? O meglio, se condividi il fatto che ci sarà sempre una distanza fra ciò che si è e quello che si scrive, una distanza tra quello che si vuole scrivere e quello che effettivamente si scrive, tra quello che uno scrive e quello che un altro legge, perché questa distanza è una ‘ferita’, cioè perché fa male?
Questa domanda è molto bella in sé, non vorrei rovinarla con una risposta banale, ritorno ancora all’oggettività dell’aneddoto. Non ricordo bene quando – se prima o dopo la pubblicazione – Luzi mi disse che a quell’antologia lui teneva molto. Io ero più o meno convinto di aver fatto dei commenti critici ai suoi testi, mentre lui mi disse proprio così: mi piace perché i tuoi non sono commenti critici, tu le rivivi le poesie, anche per scritto. Adesso che molto tempo è passato e leggo la tua domanda vedo anch’io la bellezza di quanto è accaduto, ma sarei bugiardo se non ti dicessi che allora, in qualche modo, ci rimasi persino male. Mi sembrò che mi dicesse che erano degli svolazzamenti, che io della sua poesia non avevo capito nulla. E in effetti è così: io c’ero entrato dentro per esplorarla, non per spiegarla, e le parole con cui ne ero uscito erano del tutto fresche, senz’altro imperfette, ma vive fino in fondo. Tutto sta nel fatto che per lui la poesia era forse proprio questo: la parola che sgorga da una ferita del pensiero. Non a caso il suo ultimo libro edito in vita, che stava allora preparando per la stampa si intitola Dottrina dell’estremo principiante. Oggi, per fare solo un inciso, fra una cosa e un’altra, ho circa un centinaio di pubblicazioni, allora ne avevo zero. Voglio dire che se avessi incontrato Luzi oggi, lui non avrebbe avuto motivo di accogliere un’antologia curata da me.
5) Da un punto di vista umano, cosa ti ha lasciato il rapporto con Luzi?
Spero che questo – proprio per quanto dici di Derrida – si deduca dal tono delle mie risposte precedenti; aggiungo soltanto il profondo stato di peggioramento, di mestizia e anche di miseria intellettuale in cui mi sono ritrovato negli anni successivi alla sua scomparsa. Non era morto solo lui, era anche svanita (per sempre) una grande parte di me che si vedeva soltanto quando c’era lui.
6) Tu sei il fondatore del premio di poesia Premio Ciampi – Valigie Rosse, qual è lo stato di salute della poesia , oggi, in Italia? C’è un autore che ti piace, che segui ?
Nell’ambito del Premio Ciampi – Valigie Rosse io curo la sezione di poesia straniera, non italiana, che è invece affidata a Paolo Maccari, lui stesso poeta, ma in questo caso impegnato per le sue straordinarie qualità di critico. Paolo, più che l’assegnazione annuale di una patacca, sta mettendo in piedi una mappatura della poesia italiana contemporanea: ogni vincitore viene premiato con la pubblicazione di una plaquette inedita. Sta nascendo così una collezione di piccoli libri (che potete vedere sul sito ) che dimostra meglio di qualunque altra mia affermazione che la poesia attuale ha ottimi rappresentanti e che la battaglia per la cultura, oggi più che mai, vale la pena di essere combattuta. Valigie Rosse è una collezione di libri totalmente no-profit, nessuno guadagna nulla, ma tutti contribuiscono affinché in circolazione ci sia un libro in più: un libro selezionato… e qui si aprirebbe tutt’altro ambito di discussione…
7) Progetti per il futuro?
In questo momento sto lavorando come docente a contratto presso l’Università di Modena, dove tengo un corso di traduzione dallo spagnolo. Spero che questa esperienza possa durare ancora un po’: effettivamente, insegnando, si impara molto. Il problema, come al solito, sono i soldi… non solo per studiare, purtroppo, ormai, anche per lavorare all’università spesso bisogna avere un altro impiego… ma non mi capiterà più un colloquio di lavoro altrettanto straordinario come quel misterioso vecchietto!
Passando ad un piano più personale, dopo Capelli blu, mi piacerebbe riuscire a portare a termine un altro lavoro di scrittura, ho alcuni progetti aperti, di cui uno in particolare mi ha impegnato molto negli ultimi mesi. Come tutte le cose che impegnano la persona, non è facile: c’è sempre qualcosa che si interpone e che disturba l’atmosfera intensa ma delicata della scrittura, che recupero con fatica e che spesso mi sfugge. Voglio dirlo diversamente, citando la tua bella domanda: la ferita continua a fare male, i punti di sutura tirano, il pensiero non si placa, ma non sempre produce parole.



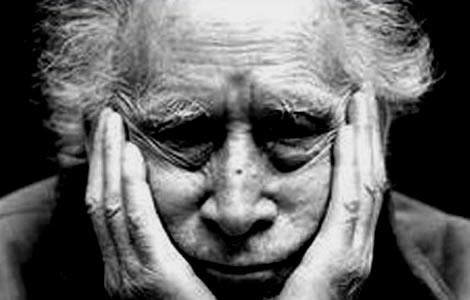
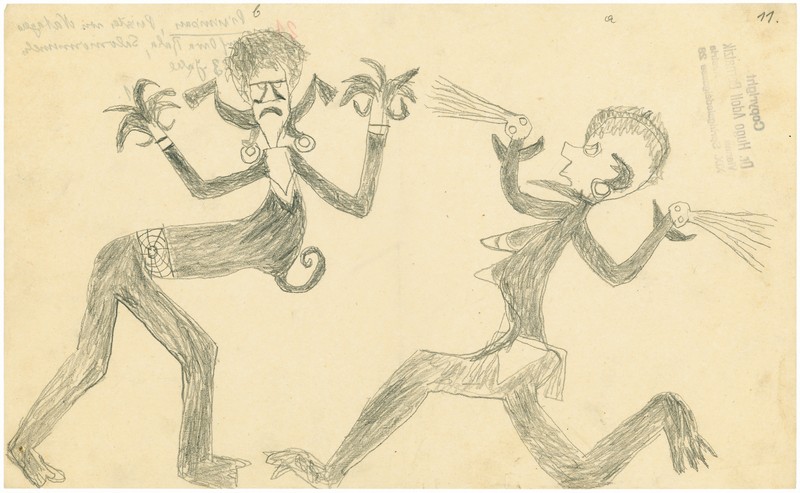
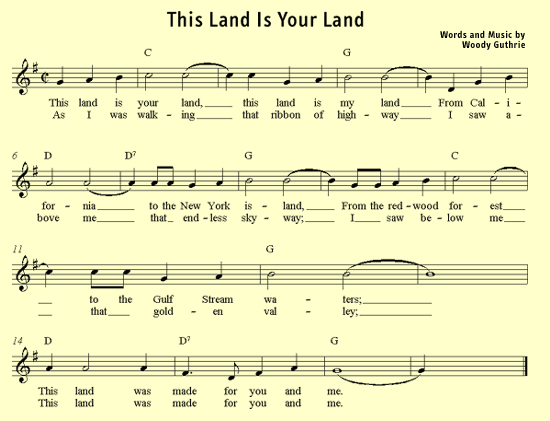




 Stringi stringi, la vita è tutta una questione di fuori e dentro
Stringi stringi, la vita è tutta una questione di fuori e dentro