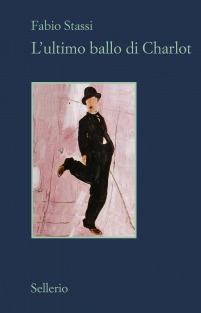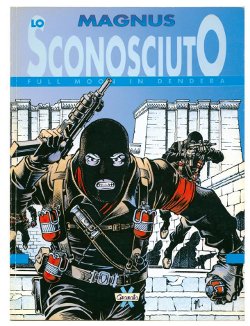Purgatorio di Raul Zurita
di
Antonio Arévalo
La dittatura di Augusto Pinochet operò nel paese una cesura drammatica nell’evoluzione dell’arte e della cultura. La repressione, il controllo sulle istituzioni culturali e sull’istruzione, la scomparsa o l’esilio di intellettuali, furono alcuni dei fattori che interruppero violentemente i percorsi della cultura e furono il detonatore per nuovi processi artistici. Questo periodo storico riguarda l’affermarsi in Cile di poetiche postmoderne e neoavanguardiste, che segnano l’arte che ha inizio durante il regime militare.
Si differenzia per le sue trasgressioni concettuali, le fratture nel linguaggio e l’esplorazione di nuove forme e generi (la performance, gli interventi urbani, la fotografia, il cinema, il video, etc.), puntando al contempo a rinnovare il lessico artistico e culturale; estese i supporti tecnici dell’arte al corpo vivo e alla città: che respingeva la censura imposta al linguaggio parlato e scritto, e la città come un paesaggio le cui abitudini percettive e comunicative si ritrovavano fugacemente alterate da un vibrante gesto di disobbedienza all’inquadramento militarista che cercava di omologare il quotidiano.

In questo contesto nel ’79 emerge il lavoro del Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.), che ideava strategie per prendersi gioco della censura degli apparati repressivi e fare arte. Realizza il primo lavoro, “Para no morir de hambre en el arte”, seguendo un orientamento artistico che resignifica, nel contesto della dittatura, il duplice anelito avanguardista della fusione arte/vita e arte/politica. Per il gruppo C.A.D.A, così come l’arte esce dai binari dello specifico istituzionale per dissolversi nel suo ambito, l’immagine dell’autore perde i tratti individuali fino a perdersi, moltiplicata nell’anonimato: “ogni uomo che lavora per l’ampliamento, anche se mentale, è un artista”, annuncia il pamphlet che sei piccoli velivoli fecero cadere sulla città di Santiago durante l’azione “ay Sudamérica!!” (1981), riprendendo il concetto del tedesco Wolf Vostell, che definisce l’artista “operaio dell’esperienza” e l’arte “vita modificata”.
Zurita è considerato uno dei più radicali di questo gruppo. Esegue varie azioni usando il corpo come un mezzo di espressione,: ammoniaca gettato negli occhi, o il bruciare la propria guancia con un ferro caldo. Ha anche condotto una performance masturbatoria nei confronti di un dipinto di Juan Davila.
In questo contesto viene pubblicato il suo libro “Purgatorio”, producendo un vero terremoto nel panorama non soltanto letterario. Da li in poi la poesia cilena pressi un altro cammino. L’epicentro Zurita si presenta davanti a noi con tutte le sue fratture, le sue ferite, per ricucire e ridare alla storia la possibilità che ci fossi un’altra storia: una mutilazione volontaria, una rassegnazione, e a una donazione, una dolorosa identificazione collettiva.
Da questo momento, effettuato varie attività volte a integrare l’arte e la estendere in modo critico e creativo le diverse concezioni di arte e di vita.
Nel 1982, il suo lavoro creativo assume un nuovo passo avanti con “la vita nuova”, poema, scritto nei cieli di “New York, con un aereo che scrive col fumo. Questa creazione è composta di otto frasi di quindici miglia di lunghezza, in spagnolo. Un’altra azione è stato quello di tradurre nel deserto del Cile il versetto “Né pietà, né paura”, nel 1993, in modo che possa essere letto dal cielo. Queste azioni sono il tentativo di superare il tradizionale concetto di letteratura, di avvicinarlo all’arte totale.

Titolo: “Per non morire di fame nell’arte”. [N.d.T]
IL DESERTO DI ATACAMA
di
Raúl Zurita
�CHI POTREBBE L’ENORME DIGNITÀ DEL
DESERTO DI ATACAMA COME UN UCCELLO
SI INNALZA SOPRA I CIELI APPENA
SOSPINTO DAL VENTO
�I
ALLE PIANURE IMMACOLATE
i. Lasciamo passare l’infinito del Deserto di Atacama
ii. Lasciamo passare la sterilità di questi deserti
Perché dalle gambe aperte di mia madre si
innalzi una Preghiera che incroci l’infinito del
Deserto di Atacama e mia madre non sia allora se non
un punto d’incontro sul cammino
iii. Io stesso sarò allora una Preghiera trovata
sul cammino
iv. Io stesso sarò le gambe aperte di mia madre
Per quando vedrete alzarsi davanti ai vostri occhi i desolati
paesaggi del deserto di Atacama mia madre si concentrerà
in gocce d’acqua e sarà la prima pioggia sul deserto
v. Allora vedremo apparire l’Infinito del Deserto
vi. Rigirato da se stesso fino a sbattere sulle gambe
di mia madre
vii. Allora sopra il vuoto del mondo si aprirà
completamente il verdore infinto del Deserto di
Atacama
�IL DESERTO DI ATACAMA II
Eccolo Eccolo
sospeso in aria
Il Deserto di Atacama
i. Sospeso sul cielo del Cile diluendosi
tra aure
ii. Trasformando questa vita e l’altra nello stesso
Deserto di Atacama auratico perdendosi nel-
l’aria
iii. Finché finalmente non ci sarà cielo ma Deserto
di Atacama e tutti vedremo allora le nostre stesse
pampas fosforescenti velami innalzarsi al-
l’orizzonte
�IL DESERTO DI ATACAMA III
i. I deserti di atacama sono azzurri
ii. I deserti di atacama non sono azzurri sì sì dimmi
quello che vuoi
iii. I deserti di atacama non sono azzurri perché per di
là non volò lo spirito di G. Cristo che era un perduto
iv. E se i deserti di atacama fossero azzurri ancora
potrebbero essere l’Oasi Cilena perché da tutti
gli angoli del Cile contenti vedeste fiammeggiare per
l’aria le azzurre pampas del Deserto di Atacama
�IL DESERTO DI ATCAMA IV
i. Il Deserto di Atacama sono puri pascoli
ii. Guardate quelle pecore correre sui pascoli del
deserto
iii. Guardate i loro stessi sogni ballare laggiù su quelle
pampas infinite
iv. E se non si sentono le pecore ballare nel Deserto
di Atacama noi siamo allora i pascoli
del Cile perché in tutto lo spazio in tutto il mondo
in tutta la patria si senta ora il ballo delle nostre
stesse anime su quei desolati deserti miserabili
�IL DESERTO DI ATACAMA V
Dillo tu il fischiare di Atacama
il vento cancella come neve
il colore di questa pianura
i. Il Deserto di Atacama ha sorvolato infintà di
deserti per essere lì
ii. Come il vento sentitelo passare fischiando tra il
fogliamo degli alberi
iii. Guardatelo trasparire laggiù e accompagnato solo
dal vento
iv. Attenzione però: perché se alla fine il Deserto di
Atacama non fosse dove dovrebbe essere il
mondo intero comincerebbe a fischiare tra il fogliame
degli alberi e noi ci vedremmo allora
nello stessissimo mai trasparenti fischianti
nel vento inghiottendo il colore di questa pampa
�IL DESERTO DI ATACAMA VI
Non sognate le aride pianure
Nessuno ha mai potuto vedere
Quelle pampas chimeriche
i. I paesaggi sono convergenti e divergenti nel
Deserto di Atacama
ii. Sui paesaggi convergenti e divergenti il Cile
è convergente e divergente nel Deserto di Atacama
iii. Per questo ciò che è là non è mai stato là e se quello
fosse ancora dov’è vedrebbe rigirare la sua stessa vita
fino a essere le chimeriche pianure desertiche
illuminate svanendo come loro
iv. E quando verranno a dispiegarsi i paesaggi
convergenti e divergenti del Deserto di Atacama
tutto il Cile sarà stato l’aldilà della vita perché
in cambio di Atacama si stanno distendendo come
un sogno i deserti della nostra stessa chimera
là su queste piane del demonio
�IL DESERTO DI ATACAMA VII
i. Guardiamo allora il Deserto di Atacama
ii. Guardiamo la nostra solitudine nel deserto
Perché desolato di fronte a queste facce il paesaggio divenga
una croce distesa sul Cile e la solitudine della mia faccia
veda allora il redimersi di altre facce: La mia stessa
Redenzione nel deserto
iii. Chi direbbe allora del redimersi della mia faccia
iv. Chi parlerebbe della solitudine del deserto
Perché la mia faccia cominci a toccare la tua faccia e la tua faccia
quest’altra faccia e così finché tutto il Cile non sia che
una sola faccia con le braccia aperte una lunga faccia
coronata di spine
v. Allora la Croce non sarà che l’aprirsi delle braccia
della mia faccia
vi. Noi saremo allora la Corona di Spine
del Deserto
vii. Allora inchiodati faccia con faccia come una Croce
distesa sul Cile avremo visto per sempre
il Solitario Spirare del Deserto di Atacama
�EPILOGO
COME UN SOGNO IL FISCHIO DEL VENTO
ANCORA PERCORRE L’ARIDO SPAZIO DI
QUELLE PIANURE
Purgatorio di Raúl Zurita è uscito in Italia presso l’editore Raffaelli di Rimini (traduzione di Claudio Cinti). Il volume inaugura la collana POESÍA diretta da Carmen Leonor Ferro, dedicata a noti autori ispanoamericani.
RAÚL ZURITA è nato a Santiago in Cile nel 1950, da madre italiana. Dopo gli studi liceali iniziò a studiare matematica all’università laureandosi in ingegneria civile, ma ben presto si dedicò completamente agli studi letterari. La sua opera è fortemente segnata dalla dittatura militare instaurata dopo il golpe dell’11 settembre 1973. Militante comunista fu arrestato, torturato e detenuto a lungo. In seguito farà parte del gruppo CADA (Collettivo d’azioni artistiche) e parteciperà a diverse iniziative e performance provocatorie.
Tra il 1979 e il 1994 scrive la trilogia Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982) e La Vida Nueva (1994), dove attraversa i paesaggi più diversi: montagne, spiagge, fiumi, deserti… L’opera è considerata tra le più importanti della sua produzione poetica. Nel 1989 riceve il premio Pablo Neruda. Si allontana dal Partito comunista e nel 1990 viene nominato addetto culturale presso l’ambasciata di Roma e più tardi, durante il governo di Eduardo Frei, entra al Ministero delle Opere Pubbliche e si dedica all’insegnamento universitario.
Nel 2000 pubblica Poemas militantes e Sobre el amor y el sufrimiento; lo stesso anno riceve il Premio Nazionale di Letteratura del Cile e nel 2006 il Premio di Poesia “Josè Lezama Lima” per il libro INRI (Visor, Madrid, 2004). Nel 2006 pubblica Los Países Muertos e nel 2007 dà alle stampe in Messico Las ciudades de agua e Cinco Fragmentos. Durante il 2008 continua a pubblicare parti della sua voluminosa opera inedita Zurita, con la quale vuole chiudere il ciclo del Purgatorio.
è nato a Santiago in Cile nel 1950, da madre italiana. Dopo gli studi liceali iniziò a studiare matematica all’università laureandosi in ingegneria civile, ma ben presto si dedicò completamente agli studi letterari. La sua opera è fortemente segnata dalla dittatura militare instaurata dopo il golpe dell’11 settembre 1973. Militante comunista fu arrestato, torturato e detenuto a lungo. In seguito farà parte del gruppo CADA (Collettivo d’azioni artistiche) e parteciperà a diverse iniziative e performance provocatorie.
Tra il 1979 e il 1994 scrive la trilogia Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982) e La Vida Nueva (1994), dove attraversa i paesaggi più diversi: montagne, spiagge, fiumi, deserti… L’opera è considerata tra le più importanti della sua produzione poetica. Nel 1989 riceve il premio Pablo Neruda. Si allontana dal Partito comunista e nel 1990 viene nominato addetto culturale presso l’ambasciata di Roma e più tardi, durante il governo di Eduardo Frei, entra al Ministero delle Opere Pubbliche e si dedica all’insegnamento universitario.
Nel 2000 pubblica Poemas militantes e Sobre el amor y el sufrimiento; lo stesso anno riceve il Premio Nazionale di Letteratura del Cile e nel 2006 il Premio di Poesia “Josè Lezama Lima” per il libro INRI (Visor, Madrid, 2004). Nel 2006 pubblica Los Países Muertos e nel 2007 dà alle stampe in Messico Las ciudades de agua e Cinco Fragmentos. Durante il 2008 continua a pubblicare parti della sua voluminosa opera inedita Zurita, con la quale vuole chiudere il ciclo del Purgatorio.