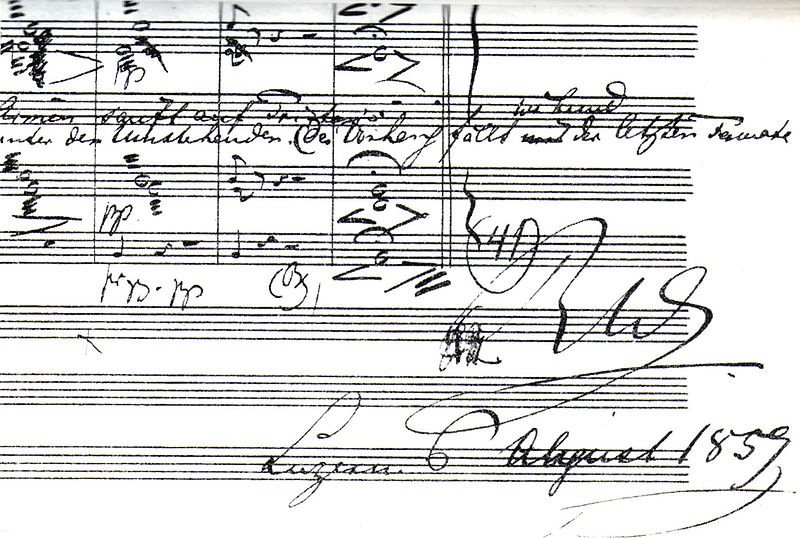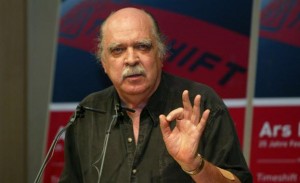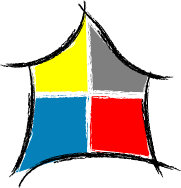Glossario del cronista onesto
L’uso sciatto e militante delle parole da parte dei giornalisti snatura il linguaggio e distorce la realtà, spacciando luoghi comuni e opinioni personali per verità universali. Ecco alcuni esempi. E relativi antidoti etimologici
di
Francesca Bellino
Tic verbali, parole usate a sproposito, superficialità diffusa, applicazioni improprie del senso, semplificazioni, stereotipi abusati e neologismi impregnati di pregiudizio dilagano sui media italiani soprattutto quando si parla di stranieri, minoranze e migrazione. Sfogliando i giornali e ascoltando radio e televisione si scopre che nel racconto dell’Altro si annidano numerosi vizi linguistici dai quali scaturiscono rappresentazioni falsate e fuorvianti che formano, di conseguenza, un’opinione pubblica distorta e giudicante. In primo luogo, come sottolinea la filosofa Daniella Iannotta, “il peggior vizio linguistico del giornalista è l’uso del giudizio che può esprimersi semplicemente usando il presente indicativo al posto del più corretto condizionale. Se il giornalista non esplicita il punto di vista e non si colloca all’interno della struttura narrativa è portato a generalizzare e universalizzare i fatti, facendo passare una verità, la sua, per la verità assoluta. In questo modo, dunque, abusa del linguaggio”.
Che la parola abbia il potere di creare realtà e che l’informazione contribuisca alla costruzione di nuove rappresentazioni sociali è indubbio, ma che succede quando termini neutri vengono intrisi di sensi aggiuntivi, spesso denigranti e devianti rispetto al significato originario, e giungono nel lessico comune attraverso i mezzi di comunicazione? “Quando uno stereotipo si diffonde non è mai isolato, ma avvia una catena che spinge a ragionare per deduzione” spiega la linguista Francesca Dragotto. Così, per esempio, dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 a New York gli stereotipi sull’Islam si sono arricchiti e rinvigoriti e un termine neutro come musulmano (seguace dell’Islam) è stato associato ad arabo, a omicida, a terrorista, a kamikaze e a jihadista (anche se un grande numero di musulmani non è arabo, ma indonesiano, senegalese o pakistano, e nella maggior parte dei casi non ha mai commesso atti terroristici), fino a coniare il termine islamopoli per definire le città che necessitano di moschee per i fedeli. Un’altra catena che sfocia nell’errore e nel pregiudizio scatta quando si parla della minoranza di cultura rom. Questa può comprendere: romeno (anche quando si parla di persone non provenienti dalla Romania, ma dai Balcani, dalla Bulgaria o dall’Italia stessa), extracomunitario (anche quando si parla di romeni, quindi europei), campo nomadi o zingaropoli (anche quando ci si riferisce a gruppi stanziali), fino a ladro e scippatore.
Un’altra catena molto diffusa è quella legata alla migrazione che come termine di partenza ha immigrato (da non confondere con rifugiato, richiedente asilo, esule) al quale si legano a cascata: irregolare, illegale, clandestino, lavoratore stagionale, fino a delinquente e stupratore, che sostituisce quella che un tempo scattava con emigrante, meridionale, napoletano, calabrese, etc. “Siamo di fronte a tipologie lessicali dell’esclusione accuratamente da evitare – sostiene il linguista Massimo Arcangeli – Il termine più rispettoso sarebbe migrante perché neutralizza l’alteritudine, limitandosi a marcare l’idea dello spostamento da un luogo all’altro, dunque l’idea del viaggio e della sua naturale provvisorietà, e non quella dell’estraneità dal punto di arrivo e quindi dell’essere intruso, alieno, solo perché straniero”.
“Le catene di termini si fondano sull’apparente sinonimia da un lato e su un processo consequenziale dall’altro. E’ come sgranare un rosario! – sottolinea Dragotto – Il problema è, però, che si arriva a usare i termini più per quello che evocano che per quello che significano. Ci troviamo, infatti, nell’era della plasticosità dove la parola diventa di plastica, perde significatività e vitalità perché troppo abusata, e viene poi caricata di nuovi significati frutto di ideologie e stereotipi. Insomma si narrano fatti veri ma con una semantica fasulla, meccanismo che rende verosimile il racconto pur portando con se significati deformati”. Per cercare di arginare questo tipo di distorsioni dell’informazione, nel 2008 è nata la Carta di Roma, un protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti redatto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con l’Unione Nazionale Cronisti Italiani, presente nei nuovi volumi “Studiare da giornalista”. “L’esigenza a intervenire è diventata urgente dopo la strage di Erba quando dall’informazione italiana emerse un riflesso incondizionato di tipo razzista nei confronti del tunisino Azouz Marzouk, considerato colpevole nelle 24 ore successive al dramma, mentre a uccidere erano stati gli italianissimi Olindo e Rosa, che destò serie preoccupazioni anche all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – racconta Roberto Natale, presidente FNSI -. In questi anni i giornalisti si sono trovati impreparati di fronte a certi temi e si sono lasciati strumentalizzare dalla politica, diventando spesso trasmettitori di germi razzisti e xenofobi. Per questo abbiamo avviato corsi di formazione in tutta Italia con la speranza che si ribalti anche l’antica regola del giornalismo per cui solo le cattive notizie sono buone notizie”.
L’ambito in cui ci muoviamo è ampio e delicato, ma di seguito proveremo a chiarire i termini maggiormente utilizzati dai media italiani per narrare l’alterità: sia parole italiane usate in modo discriminatorio, sia forestierismi entrati nella lingua ma con significato errato.
Badante: il termine nasce dal verbo badare. Si usa il participio presente per definire colui/colei che bada, così come si fa con insegnante (da insegnare). “L’origine dell’uso risale alla fine degli Anni ‘80 quando nel lessico della burocrazia fu necessario definire questo nuovo tipo di lavoratori, in sostituzione di infermiere/a, e con gli anni è entrato nel linguaggio comune e, nel 2002, è stato introdotto nel dizionario GRADIT” spiega Francesca Dragotto. Nell’uso quotidiano il termine, però, oggi si lega prevalentemente a lavoratrici straniere. Dire badante fa subito pensare alla nazionalità – alle donne dell’Est, soprattutto ucraine e bielorusse, che si occupano di anziani e malati – a differenza di altre etichette che si legano al mestiere. Dire filippino porta con se la professione: fare le pulizie. Lo stesso accede con polacco che diventa muratore, con bengalese che diventa venditore di rose, brasiliano che diventa trans o con nigeriana che diventa prostituta. Diverso è il caso di marocchino spesso usato indistintamente per chiunque venga dall’Africa sostituitosi al neologismo vu’ cumprà usato tra metà degli Anni ’80 e inizio dei ’90 per definire i venditori ambulanti (e abusivi).
Burqa: per parlare delle problematiche relative all’uso del velo delle donne islamiche nelle società occidentali si tende a usare indistintamente il termine burqa’ senza porsi il problema che esistono diversi tipi di veli. “Il Burqa’ è un capo d’abbigliamento indossato quasi esclusivamente dalle donne afgane e reso obbligatorio sotto il regime dei talebani – spiega l’arabista Lidia Verdoliva -. E’ di colore azzurro o nero e ricopre il corpo, con una griglia all’altezza degli occhi per permettere alla donna di vedere. Dunque non è un copricapo ma un abito”. Il termine con cui si dovrebbe indicare il velo è, invece, hijàb. “Questo è un copricapo adoperato già in epoca preislamica nelle società mediorientali per marcare lo stato sociale della donna – aggiunge Verdoliva -. La donna dei ceti superiori lo indossava per proteggersi dagli sguardi del popolo, mentre alla serva non era permesso tale privilegio. Con l’avvento dell’Islam, in base a quanto stabilito dalla shari’ah, è stato prescritto alle donne di mostrarsi in pubblico coperte da abiti che non mettano in evidenza le forme e che lascino scoperti solamente il volto e le mani. A tale scopo le musulmane indossano lo hijàb che si presenta in varie forme e colori a seconda delle diverse tradizioni dei paesi islamici, il quale è atto a coprire i capelli e il collo della donna incorniciandone il viso. Secondo alcune interpretazioni, tuttavia, è considerato buona norma per la donna particolarmente attraente coprire per intero la persona per salvaguardare l’integrità della comunità stessa. Per indicare il velo integrale, utilizzato in pochi paesi islamici, che nasconde anche il viso e talvolta gli occhi, si usa la parola niqàb e in alcuni casi khimàr, termine che compare nel Corano nella Sura 24 al versetto 31”. In passato sui media occidentali compariva anche il termine chador per designare il velo, per via del peso mediatico che ha avuto la rivoluzione islamica in Iran a partire dal 1979. Il termine, infatti, è di origine persiana e indica un foulard o una mantella dalla forma semicircolare che ricopre il capo e le spalle ma che lascia scoperto il volto.
Clandestino: è colui/colei che ha fatto ingresso in un Paese eludendo i controlli di frontiera. Per Fabrizio Gatti, giornalista dell’Espresso più volte fintosi migrante per narrare dall’interno l’esperienza della migrazione, il clandestino è “l’eroe contemporaneo perché rischia la vita attraversando deserti e mare su mezzi precari praticando un diritto soggettivo fondamentale: la ricerca del miglioramento delle sue condizioni di vita e dei familiari”. “Un paragone a noi vicino – spiega Gatti – sono gli esploratori, i campioni del trekking estremo, i velisti solitari. Se fosse nato in Europa, Nord America e Australia, il clandestino indosserebbe abiti e cappellino con marchi di sponsor e riceverebbe riconoscimenti internazionali. Poiché è nato in Paesi a basso prodotto interno lordo, una volta arrivato in Europa, Nord America e Australia rischia la detenzione senza processo in centri di isolamento, l’incarcerazione, l’espulsione o una vita di stenti. Il mancato riconoscimento dei diritti individuali pone il clandestino all’ultimo livello della scala sociale. In Italia la legge non gli riconosce nemmeno il diritto a presenziare al processo di cui è parte civile: se è vittima, anche di gravi reati, deve comunque essere immediatamente arrestato o espulso. Il clandestino, non l’autore del reato. Questo ne fa il modello di lavoratore preferito per lo sfruttamento nell’agricoltura, nell’edilizia, nell’industria e nei servizi. Anche se non viene pagato, il clandestino non può rivolgersi al giudice senza a sua volta rischiare l’arresto o l’espulsione. L’impiego strutturale di clandestini nell’economia ha consentito dal 1995 la riduzione verticale del costo del lavoro e il conseguente aumento dei profitti delle imprese. Profitti redistribuiti in dividendi per gli azionasti e in stock option per i manager. Il numero di clandestini sfruttati è inversamente proporzionale alla capacità dei cittadini di un Paese di provare vergogna”.
Etnia: è un termine che deriva dal greco ethnos, popoli e genti diverse da quelle che abitavano la polis, la città-Stato; popolazioni alle quali si attribuiscono comuni origini e una forma di organizzazione sociale anteriore, e implicitamente inferiore, a quella della polis. Sono, dunque, genti che si autogovernano alle quali manca la compiutezza delle istituzioni e i caratteri della civiltà. Quando la parola passa in latino ed entra nel linguaggio dei cristiani, le etnie diventano pagani, senza fede. Nell’era del colonialismo, poi, il termine viene usato per definire i popoli arretrati, non civilizzati, dunque da colonizzare. “Etnia ormai viene usata come sostituta di razza, diventata tabù, e denota il processo di etnicizzazione dell’Altro – spiega l’antropologia Annamaria Rivera, autrice de “L’imbroglio etnico” (Dedalo) – L’idea di razza, termine e concetto ormai in disuso, dunque, si continua a coltivare sotto il nome di etnia. Le etnie, nel linguaggio comune confuse anche con nazioni, in realtà non esistono, sono state inventate dai colonizzatori che hanno avviato il processo per cui oggi tutto diventa etnico. Il ristorante e la cucina etnica, o l’abbigliamento etnico, sono forme di esotizzazione di ciò che non è nazionale ed europeo. Ma è chiaro che si riferisce a popoli considerati inferiori. Per un ristorante americano, pur non essendo italiano, né europeo, non si direbbe mai etnico”.
Harem: è un termine preso in prestito dalla lingua araba usato con un significato inverso. “Harem, più correttamente harìm – spiega l’arabista Lidia Verdoliva – corrisponde a tutto ciò che è dotato di hurmah, ossia di un valore di inviolabilità, di sacralità, che rende quel luogo o persona inaccessibile a estranei e a chiunque non sia in possesso di determinati requisiti. Può essere considerato harìm il luogo di lavoro, in quanto prevede il rispetto di una serie di codici comportamentali, o la moschea in quanto chi vi accede deve rispettare alcune prescrizioni e trovarsi in una condizione di purità rituale, o la casa perché chi vuole entrare deve rispettare i suoi abitanti e attenersi alle sue abitudini. Anche le donne sono harìm in quanto possiedono delle connotazioni tali che impongono agli uomini di portar loro rispetto e il dovere di proteggerle da chi intenda approcciarle in maniera inappropriata”. Se si considera l’ harìm nella sua comune accezione di gineceo, dunque, ossia il luogo della casa in cui le donne si ritirano per non mostrarsi a uomini estranei alla famiglia, bisogna tener presente che esso nel mondo arabo è dotato di limiti morali e confini spaziali di natura quasi sacrale, in netto contrasto con l’idea che si è creata nell’immaginario occidentale, quale luogo in cui un uomo può trarre piacere da un certo numero di sue concubine sessualmente disponibili. “Tale concezione si è imposta nell’immaginario collettivo occidentale, secondo quanto sostiene la sociologa marocchina Fatema Mernissi in “L’harem e l’Occidente” – aggiunge Verdoliva -, a causa di un’errata rappresentazione di stampo esotista degli antichi ginecei arabi a opera dei pittori orientalisti dell’800 e dalla libera traduzione dei racconti delle “Mille e Una Notte” realizzata dal francese Antoine Galland che ha voluto mettere in evidenza soprattutto gli aspetti erotici di tali narrazioni. In opposizione a tale concezione dell’harìm, Mernissi sottolinea invece la condizione di semidetenzione cui erano costrette le donne che vivevano nelle abitazioni tradizionali dotate di gineceo (sistema ormai in disuso) in cui le donne avevano scarsa possibilità di movimento e di libera iniziativa.
Italieni: il termine nasce come dal nome di una rubrica pubblicata nel 2001 sul sito del settimanale “Internazionale”, e poi sul cartaceo, e contiene due parole: italiani e alieni. All’origine si riferiva ai giornalisti stranieri residenti in Italia che raccontavano la loro Italia e poi è stata estesa ad autori di seconda generazione, i cosiddetti G2, figli di immigrati nati in Italia, allargando il senso del termine. “L’idea del nome è della graphic-design Martina Recchiuti – spiega il giornalista Piero Zardo – . A distanza di anni la rubrica esiste ancora ed è affidata, come all’origine, ai giornalisti stranieri, un po’ italiani, un pò alieni, che si cimentano nelle recensioni di film e libri italiani”.
Irregolare: è colui/colei che ha perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale dei quali era in possesso nel momento d’ingresso. “Per il Ministero dell’Interno è il caso di chi è entrato per motivi turistici ed è rimasto oltre la scadenza del visto, di chi ha inoltrano la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno con tempi o modalità sbagliate che hanno portato al respingimento della domanda oppure di chi aveva un’autorizzazione per motivi di lavoro, ha perso il posto e non ha trovato altro impiego nei termini concessi – spiega l’invito Mediaset, Alfredo Macchi -. Ma per la legge italiana irregolari e clandestini vanno trattati allo stesso modo: se fermati devono essere immediatamente espulsi oppure, se questo non è possibile per mancata identificazione, devono essere trasferiti nei CIE (centri identificazione ed espulsione) dove possono restare fino a 18 mesi. Infine l’allontanamento, volontario o coatto. Ma si può dire che un’automobile in sosta oltre la scadenza del parchimetro o fuori dagli spazi regolamentari è clandestina?”.
Jihad: è un termine maschile che vuol dire sforzo, impegno. Sui media italiani, invece, viene reso al femminile e sottintende l’intenzione di tradurlo con “guerra santa” risvegliando nell’immaginario collettivo lo spettro delle crociate. “Esistono due tipi di impegno per il credente nell’Islam: il grande jihad (al-jihad al-kabir) e il piccolo jihad (al-jihad al-saghir) – spiega l’arabista Lidia Verdoliva -. Quello che maggiormente influisce sulla vita quotidiana dei credenti è il grande jihad che prevede un impegno da parte del fedele affinché le forze del bene prevalgano su quelle del male innanzitutto all’interno del suo animo, una lotta interiore spirituale contro il peccato e le tentazioni. Il piccolo jihad ha invece una connotazione di tipo collettivo e indica una battaglia che la comunità dei fedeli (ummah) può ingaggiare contro chi ne minaccia la stabilità. Si può fare ricorso al piccolo jihad solo per legittima difesa in caso di aggressioni e invasioni esterne”.
Sbarchi: è uno dei termini abusati dai media italiani soprattutto tra febbraio e l’estate del 2011 in riferimento agli arrivi di migranti da Tunisia e Libia. “Sembra un termine neutro e usato bene, ma in realtà esprime in maniera errata quello che è successo – sottolinea Giorgia Serghetti, ricercatrice Parsec –: le barche non sono arrivate quasi mai a riva, ma venivano intercettate in mare e i migranti venivano portati, nel caso specifico, a Lampedusa. Dunque non sono sbarcate”. Il termine sbarchi, inoltre, ha avvisato una catena denigrante perché associato a pericolo, allarme, invasione fino a “tzunami umano”. “Nei primi mesi del 2011 è emerso uno dei vizi dell’informazione: utilizzare il numero per argomentare un fenomeno – spiega Marco Bruno, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma –. Se prendiamo come esempio il talk-show “Porta a porta” si vede chiaramente che per sostenere un’argomentazione, in questo caso l’idea dell’invasione, si sono usati in maniera disinvolta e non accurata dati di ordini di grandezza differenti. Questo atteggiamento provoca lo svuotamento del significato aritmetico e ne fornisce uno retorico e, in questo caso anche sbagliato, se si pensa che ci sono stati più arrivi di migranti tra il 2007 e il 2008 e che la maggior parte degli ingressi normalmente non avviene via mare, ma con i camion e gli aerei”.
Zingarata: è un termine di tradizione ottocentesca che inizialmente, come voce di ambientazione letteraria, voleva dire maleficio, incantesimo, che poi ha preso il significato di goliardiche e dissacranti bravate collettive, usato nella lingua parlata soprattutto negli Anni ’70 dopo l’uscita del film “Amici miei” di Mario Monicelli. “E’ facile collegare il significato di bravata alla presunta “irregolarità” del comportamento degli zingari e alle loro azioni (spesso compiute in piccoli gruppi) per ingannare il prossimo – spiega il linguista Massimo Arcangeli -. In un dizionario ottocentesco (N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana […] con oltre centomila giunte ai precedenti dizionari […], Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino-Napoli) leggiamo alla voce zingaro: “Una razza di gente vagabonda, senza patria, che vive di furti e d’inganni, predicendo la buona ventura. Vanno a frotte di dieci o dodici, uomini, donne e fanciulli, e albergano sotto le tende”. E non andiamo meglio con altri repertori del XIX secolo: “Colui che appartiene a una razza di gente vagabonda, senza patria, senza religione, che vive di furti e di inganni, predicendo la buona ventura. Vanno a frotte di dieci o dodici uomini, donne e fanciulli; e ora dove si posano, danno voce di rassettare caldaie e vasi di rame, e albergano sotto le tende” (G. Rigutini, P. Fanfani, Vocabolario italiano della lingua parlata, nuovamente compilato da G. Rigutini e accresciuto di molte voci, maniere e significati, Firenze, Barbèra, 1891 e 1875)”. Il termine zingaro oggi è stato quasi del tutto sostituito da rom anche se, con il tempo, ha assunto la stessa connotazione negativa. “Rom – spiega Federica Dolente, che ha partecipato alla ricerca condotta dalla Fondazione Basso e da Parsec che in autunno pubblicherà una Guida sulle Alterità realizzata con Redattore Sociale – si riferiva originariamente ad alcuni gruppi che vivevano nei Balcani e nell’Europa dell’Est, ma attualmente è utilizzato come termine generico per indicare tutte quelle popolazioni che a livello locale si chiamano sinti, roma, kalè. L’origine di zingaro non è certa, ma di fatto si tratta di una denominazione che le principali lingue europee hanno utilizzato per secoli. Lo ritroviamo in francese (tsiganes), in tedesco (zigueneur) e in svedese (zigenare) e, secondo una teoria generalmente riconosciuta, il termine deriverebbe dal nome di un’antica setta eretica dell’Asia Minore”.
Articolo vincitore del Premio Talea 2013