
di
Francesco Forlani
al mio amico Alessandro Zannoni
(Salerno- Caserta)
August 3, 2012 at 8:18pm
Ci sono dei treni che nascono a Sud per raggiungere l’estremo Nord. E allora sono già settentrionali dalle prime battute. Questo treno va a Bolzano. Ecco perchè a differenza della tratta, di schiavi delle percorrenze uniche Campania, qui gli scompartimenti sono quasi vuoti, la temperatura sfiora i dieci gradi e il personale porta sul viso la stessa solarità di un animatore club MED, di un maestro di sci delle Dolomiti. Poteva allora sorprendermi il fatto che da Salerno a Napoli si percorresse un unico tunnel? come se stessimo valicando qualcosa, come se il Frejus, la sua galleria si fosse teletrasportata a sud. Da Salerno a Napoli abbiamo scavato una montagna e l’uscita dal tunnel è stata salutata da un’esplosione di luci, di azzurri, di mare, e a guardia del mare, feroce e silenzioso, il Vesuvio. Ci fermiamo per un buon quarto d’ora a Napoli. Tempo per una sigaretta, chiedo. E mi rispondono, anche per due. Bene. Fumo con lentezza. Risalgo. Mi attira l’attenzione di una signora decisamente bella, vestita di verde, che sulla banchina guarda qualcuno all’interno del treno. Sarà il figlio? Sarà l’amante? Il fidanzato? Un’amica? Dipenderà, mi dico da come saluterà alla partenza del treno. Si chiudono le porte, fischia il capotreno, mi volto a osservarla e la vedo che porta le dita alla bocca per appoggiare il bacio che s’involerà. Mi colpisce la discrezione e penso allora che sia il figlio o un amante. Sento che solo la birra ghiacciata che appoggerò alle labbra appena arriverò a destinazione, potrà ravvivarmi il ricordo del viaggio. E da mangiare Fasoi ‘n bronzon, Anatra alla Tirolese
(Agropoli- Salerno)
August 3, 2012 at 6:27pm ·
Come nel Processo di Kafka o in un terribile racconto di Buzzati, alla stazione non trovi nessuno che vesta, parli, si comporti come un funzionario. Le cose funzionano comunque, ci mancherebbe, perfino con la supplenza di una edicolante che ha modi gentili e due tipi di biglietti,o per Napoli o per Salerno, come in altri tempi una contrabbandiera ti vendeva le Marlboro sul rettifilo: morbide o dure? Così anche se il treno è annunciato su di un binario, è sull’altro che arriva e allora chiedi a chi è dentro se è quello giusto e lui ti risponde di sì anche se non ne è convinto. Un vagone su due ha l’aria condizionata, uno su due anzi uno su quattro e tra i passeggeri c’è chi giura di averne visto uno così, che si stava freschi e non accalcati, accaldati, ammassati come carne da macello sulle spiagge di Ferragosto. E mentre lo dice guardi la faccia che fanno gli altri che è come di chi non ci crede alla favola. O almeno. Non crede che sia possibile che lui, proprio lui, pendolare litoraneo non abbia quel posto. Eppure il paesaggio ristora l’anima come il sorriso delle due bimbe, le figlie di Carmine e Francesca, appena lasciate a casa. Un percorso che è dal mare poco distante, andante adelante, e il vento che viene da fuori conforta, rinfresca insieme ai ventagli delle signore, accelerati come turbine, mulini a vento. Non ho fatto la doccia dopo il bagno per conservare sulla pianta dei piedi qualche granello di sabbia. La sabbia è di una spiaggia su cui camminavano insieme alle promesse i sogni di due amanti. Et la mer efface sur le sable, Les pas des amants désunis, cantava Prévert e così è. Intanto i binari che accecano gli occhi e sembrano argento, accolgono il convoglio, gli fanno strada e allora mi preparo a cadere. Lasciarmi scivolare dai gradini per prendere una coincidenza che mi porti da lei.
(Taranto- Salerno)
August 2, 2012 at 5:22pm ·
Sono i nomi dei paesi lungo la strada ferrata che s’inerpica come un mulo da Metaponto in poi, a farti ricordare le pagine scritte del confino, le righe della cattività sul male, di Carlo Levi. Abbiamo da un po’ passato Grassano e a tratti su un solo binario il convoglio sembra un funambolo sospeso tra cime boscose, dirupi che lasciano intravedere le valli. Le regioni qui hanno nomi dolci, e la ragazza che mi siede accanto indossa la pelle e gli occhi di questa terra. Ci vorrebbe della musica House, un dj set per colpire nel segno la traccia che forma il nostro immaginario, fisso, terribilmente moderno e realista da guerra e dopoguerra, della Basilicata. Un crocevia di dialetti, di lingue, parlate, perfino paesaggi diversi e mentre si abbandona un mare, ad est già quello che è a ovest, il Tirreno prova a farsi sentire. Eboli. Un treno diagonale è questo proprio come la regione che percorre. I treni così è come se avessero una grazia speciale, una forma di estraneità all’abitudine e corrono silenziosi, cosa rara per un treno del sud, da una costa all’altra. Alla stazione di partenza ho lasciato un amico e un amico mi aspetta alla destinazione finale.
(Aversa- Minturno)
July 24, 2012 at 9:37pm ·
Ci sono dei treni che fanno allusione al passato e il viaggio è un illusione perché sai da dove parti ma nemmeno un poco dove mai si fermerà la traccia che lascia il convoglio. Al di là di dove scenderai, che già intravedi l’arco delle braccia delle tue sorelle, insieme al mare d’antan, di ragazzo infelice e felice di esserlo, ci sono delle esperienze che accadono con la stessa chiarezza di un colpo di fulmine, con una verità che non fai fatica a riconoscere. Al binario che non dice da nessuna parte dove va il treno, hai chiesto a lei con la burzatella leggera, gli occhi e i capelli chiari, se quello fosse il punto giusto, se da lì passava quello per Roma. Ti risponde in italiano, poi ti chiede in inglese che fai e ti dice che è olandese. Aveva la faccia pulita come l’anima e le mani sporche di chi reca con sè il segno di una disavventura. Mi dice che va a Milano, procedendo a singhiozzo, perchè non ha più nulla. La guardo e le dico che ho ancora qualcosa. Il qualcosa non lo do allo zingaro che distribuisce bigliettini sui ripiani che un tempo furno portaceneri. Vorrei darli a lei e infatti le chiedo di sedersi accanto a me, il tempo di capire come e fino a dove riuscire ad aiutarla. Lei si siede con una dignità che se Spinoza fosse stato donna così l’avrei immaginata, e per nulla intransigente con la propria sofferenza è rimasta pochi minuti. Perchè il tempo di seminare i bagagli, i trentamila pacchi che mi porto appresso per lo spettacolo di domani lei si alza dicendo che deve andare. Io le dico di aspettare che magari posso aiutarla e lei non vuole sentire ragione. Mi dice che le puzzano i piedi – capisco che da giorni dorme all’addiaccio e la doccia non le ha levato di dosso lo sporco di una disavventura- e non vuole disturbare nessuno. Mi alzo la inseguo lasciando tutto sui sedili ma l’ho perduta. Così sopra a un treno che recita come un rosario ognuno dei nomi delle piccole stazioni di non più Campania e non ancora lazio mi sento perduto. In totale soggezione le parole rimanevano mute ma nel mio treno, ora, qui nessuno parla.
(Bologna-Aversa)
July 20, 2012 at 10:59pm ·
Ogni volta che parti da quella stazione passi a vedere la breccia nella sala d’attesa. Non basta passarci con il treno, con un qualunque treno che da Milano a Reggio Calabria stabilisce una linea Gotica del viaggiatore, una linea verticale però che segui come un filo di piombo cade. Ci devi camminare intorno alla faglia, alla fessura e non certo per sbirciarci dentro quanto piuttosto per misurare la profondità del taglio nella pelle del tuo paese. L’assoluta divisione dello spazio della lingua accade nella hall centrale: da una parte gli italiani e dall’altra il resto del mondo, e la dicotomia si precisa, si fa particolare, quando ancor prima di salire a bordo, magari già nel sottopassaggio, senti l’accento e la faccia del meridione in un punto e poco oltre quella di chi è poco sopra e le fa da contro canto. Non ci sono monopoli nella stazione di Bologna, di una classe sull’altra e gli schermi che annunciano i binari sono ad altezza uomo e così non obbligano a tenere le facce quasi devote rivolte all’al di là, come a Milano o a Roma. La bellezza ti accoglie all’uscita sulla banchina di viaggio, e fanno capannello i fumatori che decidono che è meglio tentare da subito l’assalto alla sigaretta senza aspettare Firenze. Su e giù per lo scompartimento si vendono panini e birre come allo stadio e tra le gallerie che bucano l’Appennino lieve ma ben riconoscibile ti appare il profumo di lei. Passiamo oltre cortina con il mare di Formia e poco oltre l’orlo sbeccato delle montagne del Redentore.
(La Spezia-Genova)
July 10, 2012 at 8:46pm ·
Intercity è un nome che mi piace perchè fa antico, non vecchio e poi il fatto che sia una razza in via d’estinzione me li fa amare come se adesso che scrivo fossi a bordo di un tirannosauro, o più semplicemente di un Espresso, un Rapido.
Intercity non ti dice nulla della velocità con cui ti trasporterà a differenza di quelli, superati dall’alta rapidità del progresso, feriti a morte dalle frecce rosse, bianche, argento. Nel nome si indica semplicemente il destino, l’attraversamento, l’andare di città in città, electricity per come si diffonde, o sembra suggerire geocity, per la terra su cui affondano i binari e che vedi, calpesti con gli occhi se ti sporgi dal finestrino. Eppure questa tratta per prima cosa ti regala in sequenza, una dopo l’altra, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, cinque terre di mare, cinque lingue di pietra e sabbia che solo un inverno fa sembravano incespicare sulla parola inondazione e il treno sembra un idrovolante. Lo vedi il mare tra una galleria e l’altra e ti permane dentro, anche nel buio, l’azzurro del crepuscolo che quasi confondi con l’alba quando con un tonfo, un rumore sordo, il locomotore sferza l’aria all’uscita dal tunnel. C’è un silenzio da esame di maturità, da fine giornata al mare e cerchi di interrogare il silenzio senza la severità di un presidente di commissione d’altri tempi, ma con la grazia di un compagno di scuola che ti porga, senza farsi vedere, un appunto, una nota, un pettine in grado di sciogliere i nodi che ti cingono la testa e ti tengono le mani incollate sopra. I nomi delle stazioni delle città del nord sono di una dolcezza tale che le ripeti a voce alta, anzi le sussurri ogni volta che ci passi accanto, Levanto, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita, Camogli. E mentre ti avvicini a Genova, dove si cambia treno per Pavia, dove sei diretto, scendendo insieme al bagaglio di due notti appena, ricordi della domanda che t’eri serbato dentro, il quesito da porre ad un viaggio inaspettato, e lasci che la risposta ti raggiunga ovunque ci sia un capostazione, una bandiera da tenere dritta contro il cielo.
(Roma- Minturno/Scauri)
July 3, 2012 at 7:57am ·
La tratta Brindisi- Pescara, che sembra una partita di serie B, è un omaggio all’Oriente. Il mare , risalendo la penisola, è sulla destra. Anche a sinistra c’è, ma non si vede. Da Pescara a Roma ci arrivi con una corriera che viene su davvero veloce e come un aliscafo valica il dorso, il monte, il crine che separa i due mari. A Roma ci resto poco ma è un poco talmente denso che le parole rimangono dentro, risuona ancora la frase del Don Giovanni di PP, evocata al momento di lasciarci sulla soglia del giardino di una casa in cui vorrei abitare. “Non penso quindi tu sei questo mi conquista.”.
A Termini ti immagini sempre che qualcosa finisca. Il nome fa pensare al capolinea, all’ultima fermata, e invece è qui che si comincia e cerchi di capire in quali termini il viaggio accadrà facendo ricorso all’oracolo delle macchinette che tu ci metti la mano sopra e quella ti dice a che ora si staccheranno i piedi da terra, e quanto costa ma non se vale davvero.
Sulle frecce rosse è un florilegio playmobil di uniformi e personale. Ora una coppia di poliziotti, un controllore, addetti alla pulizia vestiti di arancione, e perfino ai passeggeri sembra abbiano dato una divisa, assai uniforme in verità. Sul regionale Roma Napoli la prima cosa che ti colpisce in una giornata torrida d’estate è la danza gitana dei drappi appesi ai finestrini che si distendono, smarrendo la loro funzione originaria, fino a diventare lembo di gonna impazzita, Carmen popolare che si lascia frustare emettendo dei gemiti di vento così selvaggiamente in tono con lo stridere delle rotaie sui binari e delle porte tra un vagaone e un altro, quando ci sono, quando funzionano.
Accanto a me c’è un ragazzo che è elegante perfino con la barba non fatta e di fronte, un’amica, la fidanzata, la sorella più giovane, che ha un volto così rinascimentale che quasi ti metti a cercare il titolo dell’opera, l’attrbuzione all’artista. Piange. In realtà accenna a farlo e le pupille si tengono a galla a malapena in un fiume che senti le sta per sgorgare dal petto. E non sai da quale fonte, falda sotterranea, monte, si stia riversando. Sembrerebbe una studentessa e allora immagini che il suo dolore sia in un mancato segno sul libretto, la nota stonata di un esame finito male. Oppure è un dolore nobile, un dolore non per sé, ma per qualcun altro, la sorte di una persona cara mortificata da un acciacco, da un referto medico, un’analisi impietosa. Ma nobile potrebbe essere la ragione di un distacco. Lui le prende le mani per incoraggiarla come fa chi vorrebbe dopo avere arrecato un dolore insormontabile, portare sollievo, servire prima il veleno e quasi subito dopo somministrare l’antidoto.
All’altezza di Fondi, perchè c’è un fondo in ogni superficie, accade una cosa. Chiudo lo sguardo per proteggere gli occhi e le cose che si dicono sono queste.
– Chiure sta cazz’e porte!
– Aggia scennere mo, strunz nu vire che è scassate
– Strunz, hai ritte strunze e ie te scasse ecccorne
– Mocca a mammete m’ea fa nu bucchine
– Vien, vien che te rong nu caucie in miezz’e ppalle
– Scinne e te scassa a cape strunze
– Vuie napulitane site na razz’emmerde
– Scinne mo ca t’arape a cape.
Riapro gli occhi quando senti che sta per esplodere il nulla. I due, uno con i baffi tarchiato, tracagnotto avrà una sessantina d’anni e l’altro pure, seppure di corporatura agile e imponente.
Scendo. Alla fermata che dice prima Minturno e poi Scauri. Scendo da un paese immobile in cui perfino le gonne alle finestre sembrano avere perduto la voglia di ballare.
Supplique feroviaria
June 17, 2012 at 6:29pm ·
Sto tran tran qui me strabuza li oci à luce à luce a noce à noce que la voz que te pare d’artri te sumiglia, t’encanta et s’alimente lo coeur par rollement de la vetura l’echange des regards figa quela figo quelo no pennient et se simula d’assonnarse pour un desìo de cullarse comme un bebè, un enfant, nu caruso, comme ça devant à tout le monde appustato A-B colli numeri de uno a centumila et alors que l’une apres l’autre se seguentan staziune de villes fameuses ou pennient piccerelle staziuncelle cum flores et faunas de barbun de sigarete accese sur le quais, se sbinaria lu tran tran et frina lorsque nu sibilo parait nu fisculo d’arbitro in miezz’o campe de ioco alors que financo lo controlor cambia d’acento de tono selon la region la ville lu village nu poco de stangheza te guadagna l’anema pe sta botta de vita de nomade genereuse ah la Boheme Boheme et puis el tran tran tout de subbète t’arridona el surriso la bocata d’oxygene comme si killo c’avive lassiat l’esta à nouveau de t’aspetarte à l’autre cap du monde du voyage et te strabuza li oci alors sta vida te fa sentrte vivo sta vida à luce à noce à noce que la voz que te pare d’artri te sumiglia, un peu

 di Gianni Agostinelli
di Gianni Agostinelli





 di Davide Orecchio
di Davide Orecchio di Manuela De Quarto
di Manuela De Quarto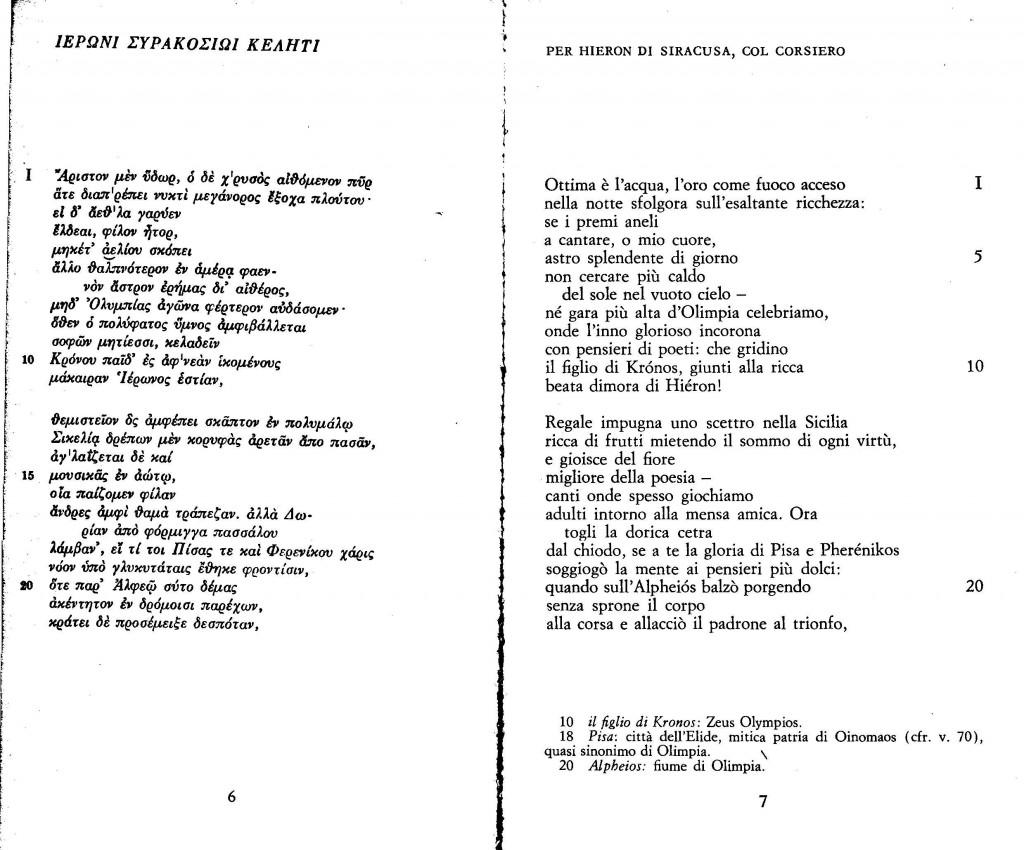

 di Davide Orecchio
di Davide Orecchio