
da Albert Camus, Actuelles II. Chroniques 1948-1953. (Éditions Gallimard,1953)
(Testo in lingua originale)
Creazione e libertà
La Spagna e la cultura
(30 novembre 1952)
di
Albert Camus
Intervento pronunciato alla Salle Wagram, 30 novembre 1952
traduzione di effeffe
Va celebrata quest’oggi una nuova e confortante vittoria per la democrazia. Ma è una vittoria che ha riportato su se stessa e sui suoi stessi principi. La Spagna di Franco è stata introdotta di nascosto nel tempio ben riscaldato della cultura e dell’educazione mentre la Spagna di Cervantes e Unamuno veniva gettata ancora una volta in mezzo a una strada. Quando sappiamo che a Madrid l’attuale Ministro dell’Informazione, ormai collaboratore diretto dell’ UNESCO, è lo stesso che fece propaganda nazista durante il regno di Hitler, che il governo che ha appena insignito con un’ onorificenza il poeta cattolico Christian Claudel è il medesimo che decorò con la medaglia dell’Ordine Imperiale delle Frecce Rosse Himmler, organizzatore dei forni crematori, è legittimo dire, in fin dei conti, che qui non sono Calderon né tanto meno Lope de Vega a essere accolti dalle democrazie nella loro società di educatori, ma Joseph Goebbels.
A sette anni dalla fine della guerra, questa magnifica ritrattazione dovrebbe valere le nostre congratulazioni al governo di Pinay. Non è tanto a lui, in effetti, che si potrà rimproverare di sentirsi in imbarazzo, di farsi degli scrupoli visto che qui è questione di alta politica. Tutti fin qui pensavano che le sorti della storia dipendessero un pochino dalla lotta degli educatori contro i carnefici. Però non si era pensato, tutto sommato, che bastasse nominare ufficialmente educatori i carnefici. Ebbene il governo Pinay ci ha pensato.
Ovviamente, l’operazione è un po’ fastidiosa e andava fatta in quattro e quattr’otto. Ma diamine, la scuola è una cosa, il mercato è un altro! Questa storia, a dire il vero, fa un po’ mercato di schiavi. Si scambiano le vittime della Falange con i sudditi delle Colonie. Per quanto riguarda la cultura, si vedrà poi.
Del resto non sono affari dei governi. Gli artisti fanno cultura, i governi la controllano a seguire e quando si presenti l’occasione fanno fuori gli artisti per controllarla meglio. Finalmente arriva il giorno in cui una manciata di militari e industriali può dire “noi” parlando di Molière e Voltaire o stampare stravolgendole le opere del poeta salvo averlo dapprima fucilato. Quel giorno, che è lo stesso in cui ci troviamo ora, dovrebbe ispirarci almeno un pensiero di compassione per il povero Hitler. Invece di uccidersi per eccesso di romanticismo, gli sarebbe stato sufficiente imitare il suo amico Franco e aspettare pazientemente. Oggi sarebbe delegato all’ UNESCO all’ educazione della Nigeria, e Mussolini in persona avrebbe contribuito ad elevare il livello culturale di quei piccoli etiopi i cui padri aveva massacrato non molto tempo fa. Così, riconciliati in Europa finalmente, assisteremmo al trionfo definitivo della cultura, in occasione di un’ enorme tavolata composta da generali e marescialli serviti e riveriti da una squadra di ministri, democratici sì, ma decisamente realisti.
La parola disgusto a questo punto è sin troppo debole. Ma mi sembra inutile esprimere ancora una volta la nostra indignazione. Dal momento che i nostri governanti sono abbastanza intelligenti e realisti per fare a meno dell’ onore e della cultura, non cediamo al sentimentalismo e sforziamoci di essere realisti. Dal momento che questa è la considerazione oggettiva della situazione storica che porta Franco all’UNESCO, otto anni dopo il crollo del potere delle dittature tra le macerie di Berlino , cerchiamo di essere obiettivi e ragioniamo con freddezza sugli argomenti che sono stati presentati per giustificare il mantenimento di Franco.
Il primo argomento si rifà al principio fondamentale della non-ingerenza. Lo si può riassumere come segue: gli affari interni di un paese riguardano esclusivamente quel paese. In altre parole, un buon democratico se ne sta a casa sua. Questo principio è inattaccabile. Indubbiamente ha degli inconvenienti. La salita al potere di Hitler riguardava solo la Germania e i primi ad essere rinchiusi nei campi di concentramento, ebrei o comunisti erano tedeschi, in effetti. Ma otto anni dopo Buchenwald, la capitale del dolore era una città europea. Tuttavia, il principio è il principio, il vicino è padrone in casa sua. Diciamoci la verità, e ammettiamo allora che il nostro vicino di pianerottolo potrà picchiare sua moglie e far bere del Calvados ai propri pargoli. C’è nella nostra società un piccolo emendamento. Se il vicino di casa esagera, gli verranno tolti i figli e lo si affida a un lavoro di pubblica utilità. Franco, quanto a lui, può esagerare. Supponiamo allora che il vicino di casa possa permetterselo senza alcun limite . Non potete farci nulla, si è capito. La punizione che merita l’ avete a portata di mano, ma vi mettete le mani in tasca perché tanto non sono affari vostri.
Però, se il vicino è allo stesso tempo un commerciante, non siete certo costretti a comprare da lui. Nulla vi costringe a dargli dei viveri, a prestargli del denaro, nè tanto meno a cenare con lui. Potete insomma, senza intervenire negli affari suoi, voltargli le spalle. E se pure abbastanza persone nel quartiere lo trattano allo stesso modo, quello avrà l’occasione di riflettere, di vedere dove sono i suoi interessi, e una possibilità almeno di cambiare la concezione che ha dell’amore familiare, senza contare il fatto che quella messa in quarantena potrà offrire alla moglie un “buon argomento”.. Sarebbe in questo, non ne dubitiamo, la vera non ingerenza. Ma a partire dal momento in cui con lui ci cenate, a lui prestate dei soldi, allora gli darete i mezzi, e la buona coscienza, necessari per continuare, e praticherete stavolta voi una vera ingerenza, ma a svantaggio delle vittime. E quando in conclusione incollerete surretiziamente l’etichetta “vitamine” sulla bottiglia di Calvados con cui riconforta i suoi pargoli, quando soprattutto deciderete sotto gli occhi di tutti di affidargli l’educazione dei vostri, allora, eccovi più criminali di lui, in conclusione, e due volte criminali visto che incoraggiate il crimine chiamandolo virtù.
Eccoci al secondo argomento che consiste nel dire che si aiuta Franco, nonostante gli inconvenienti della cosa, perchè si oppone al comunismo. Vi si oppone innanzitutto in casa sua. Vi si oppone successivamente fornendo le basi necessarie per la strategia della prossima guerra. Qui, nuovamente, non poniamoci la domanda se si tratti di un ragionamento animato dalla gloria e chiediamoci piuttosto quanto esso sia intelligente.
Notiamo innanzitutto che contraddice assolutamente il ragionamento precedente. Non si può essere per la non-ingerenza e voler impedire a un partito, quale esso sia, di trionfare in un paese che non sia il vostro. Eppure questa contraddizione non spaventa nessuno. Il fatto è che nessuno abbia mai creduto veramente, eccezion fatta forse per Ponzio Pilato, alla non ingerenza in politica estera. Siamo seri allora, sacrosanta che si possa immaginare anche soltanto per un secondo la ragione di allearsi con Franco per conservare le nostre libertà chiediamoci in cosa potrà aiutare gli strateghi atlantici nella loro lotta contro gli strateghi orientali. Si tratta innanzitutto di un’esperienza costante nell’Europa contemporanea l’idea che il mantenimento di un regime totalitario significhi a una più o meno breve scadenza rinforzare il comunismo. Nei paesi in cui la libertà è una pratica nazionale, oltre ad essere una dottrina, il comunismo non vi prospera.
Nulla gli è più facile al contrario, e l’esempio dei paesi dell’Europa orientale ce lo sta a provare, che mettere i propri passi sulle orme del fascismo. Certamente è in Spagna che il comunismo ha minori possibilità dal momento che ha davanti a sè una vera sinistra popolare e libertaria per non parlare dello stesso carattere spagnolo in tutta la sua peculiarità . Alle ultime elezioni libere in Spagna nel 1936, i comunisti ottennero soltanto 15 seggi su 443 alle Cortès. Ed è senz’altro vero che ci voglia ben altro dalla cospirazione internazionale della stupidità per fare di uno spagnolo un marxista. Ma se pure ipotizzassimo, il che è assurdo, che il regime di Franco sia l’unico baluardo contro il comunismo, e visto che siamo al realismo, che dire di una politica, che volendo indebolire il comunismo su un certo punto, lo rafforzerebbe in altri dieci? Perché nulla potrà mai impedire a milioni di persone in Europa, di pensare che il caso Spagna, come l’antisemitismo, i campi di concentramento o i processi farsa basati su confessioni estorte, sia un test per giudicare la veridicità di un sistema politico democratico.
E il mantenimento sistematico di Franco impedirà ogni volta a questi uomini di credere nella sincerità dei governi democratici quando pretendono di rappresentare la libertà e la giustizia. Questi uomini non acconsentiranno mai a difendere la libertà con al proprio fianco assassini della libertà. Una politica che metta in un tale vicolo cieco così tanti uomini liberi si può chiamare una politica realista? E solo una politica criminale, che consolida il crimine, portando alla disperazione tutti, spagnoli o altri che rifiutino il crimine, da qualunque parte esso provenga.
Per quanto riguarda l’importanza puramente strategica della Spagna, non sono tra i più qualificati a parlarne, da eterno principiante quale sono nelle arti militari. Ma credo che l’altopiano iberico non varrà molto il giorno in cui i parlamenti francesi e italiani conteranno centinaia di nuovi deputati comunisti. Per cercare di fermare il comunismo in Spagna con mezzi indegni, si darà una seria possibilità alla comunistizzazione dell’Europa, e se dovesse compiersi, la Spagna sarà comunistizzata a prescindere dai patti e allora, da quell’altipiano strategico, verranno fuori argomenti che convinceranno finalmente i pensatori di Washington. “Faremo dunque la guerra”, diranno questi ultimi. Senza alcun dubbio, e può darsi pure che la vinceranno. Ma penso a Goya e ai suoi cadaveri mutilati. Sapete cosa dice? « Grande hazana, con muertos », “Grande prodezza, in cambio di morti.”
Eppure questi sono i miserabili argomenti che giustificano lo scandalo che ci ha fatti incontrare quest’oggi. Non ho voluto far finta di credere, in effetti, che si trattasse di considerazioni culturali. Si tratta soltanto di una contrattazione dietro al paravento della cultura. Ma anche in tanto che affare, non può essere giustificata. Forse arricchirà qualche venditore di frutta e verdura, ma non servirà nessun paese e nessuna causa, se non alcune di quelle ragioni che gli uomini dell’Europa possono ancora avere da combattere. Ecco perché non sapranno esserci per un intellettuale due posizioni quando Franco sarà ricevuto all’U.N.E.S.C.O. E non basta dire che rifiuteremo ogni collaborazione con una organizzazione che ha accettato di coprire una simile operazione. Tutti, ognuno al suo posto, da ora in poi, la combatteremo a viso aperto, e con fermezza, affinchè si riveli quanto prima come il non essere quella che pretende di essere, ovvero un luogo d’incontro di intellettuali dedicati alla cultura, ma un’associazione di governi al servizio di qualsiasi politica.
Sì, nel momento in cui Franco è entrato all’UNESCO, l’UNESCO è uscita dalla cultura universale, ed è questo che noi abbiamo da dire. Ci è stato obiettato che l’ U. N.E.S.C.O. è utile. Ci sarebbe molto da dire circa i rapporti tra uffici e cultura, ma di una cosa almeno possiamo essere sicuri ed è che nulla può essere utile quando perpetua la menzogna in cui viviamo. Se l’ U. N.E.S.C.O. non è stata in grado di mantenere la propria indipendenza tanto vale che sparisca. Dopo tutto, le società della cultura passano e la cultura rimane. Di una cosa almeno possiamo esserne certi ed è che essa non scomparirà perché un’alta organizzazione politica sarà mostrata per quella che è. La vera cultura vive di verità e muore di menzogna. Vive sempre, del resto, lontano dai palazzi e dagli ascensori dell’UNESCO, lontano dalle prigioni di Madrid, sulle strade dell’esilio. Ha sempre la sua società, l’unica che io riconosca, quella dei creatori e degli uomini liberi che, contro la crudeltà dei totalitarismi e la codardia delle democrazie borghesi, contro i processi di Praga e le esecuzioni di Barcellona riconosce tutte le patrie servendone una sola: la libertà. Ed è in questa società che riceveremo, noi, la Spagna della libertà. Non facendola entrare dal retrobottega evitando così il dibattito, ma apertamente, solennemente, con il rispetto e l’affetto che gli dobbiamo, l’ammirazione che proviamo per le sue opere e per la sua anima, e in conclusione con il sentimento di gratitudine che nutriamo per il grande paese che ci ha offerto e ancora ci offre le nostre più alte lezioni.

















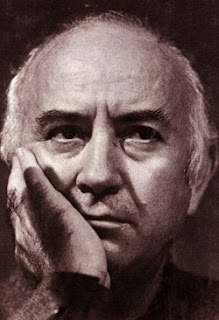

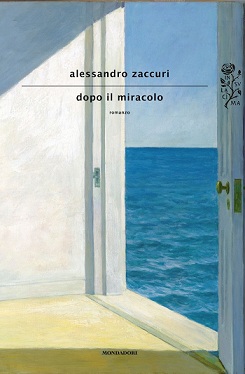 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo

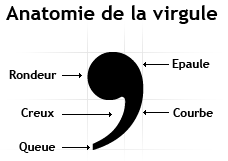 Il manuale di un apprendista sbruffone (1970)
Il manuale di un apprendista sbruffone (1970)

