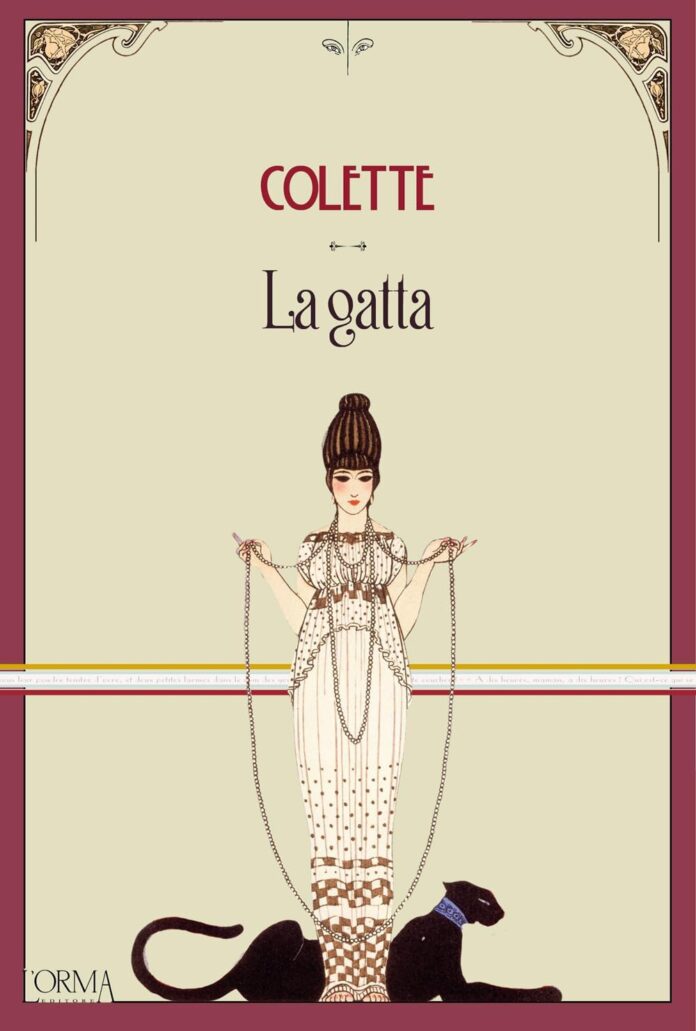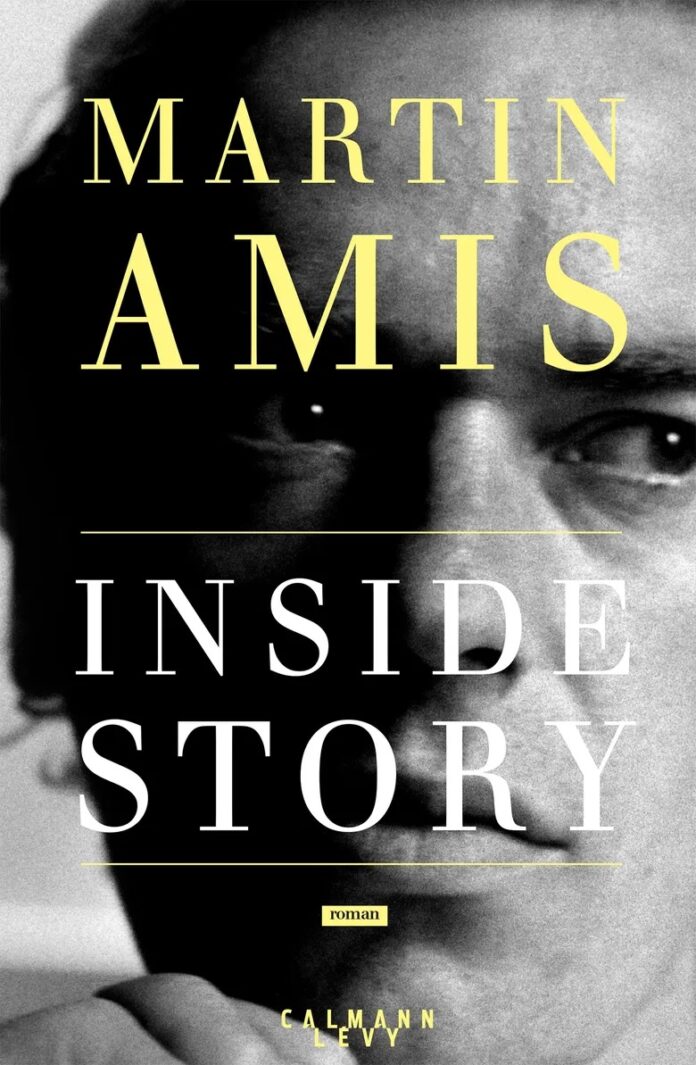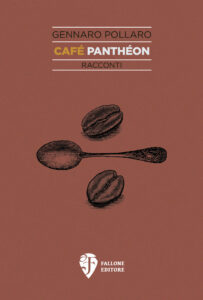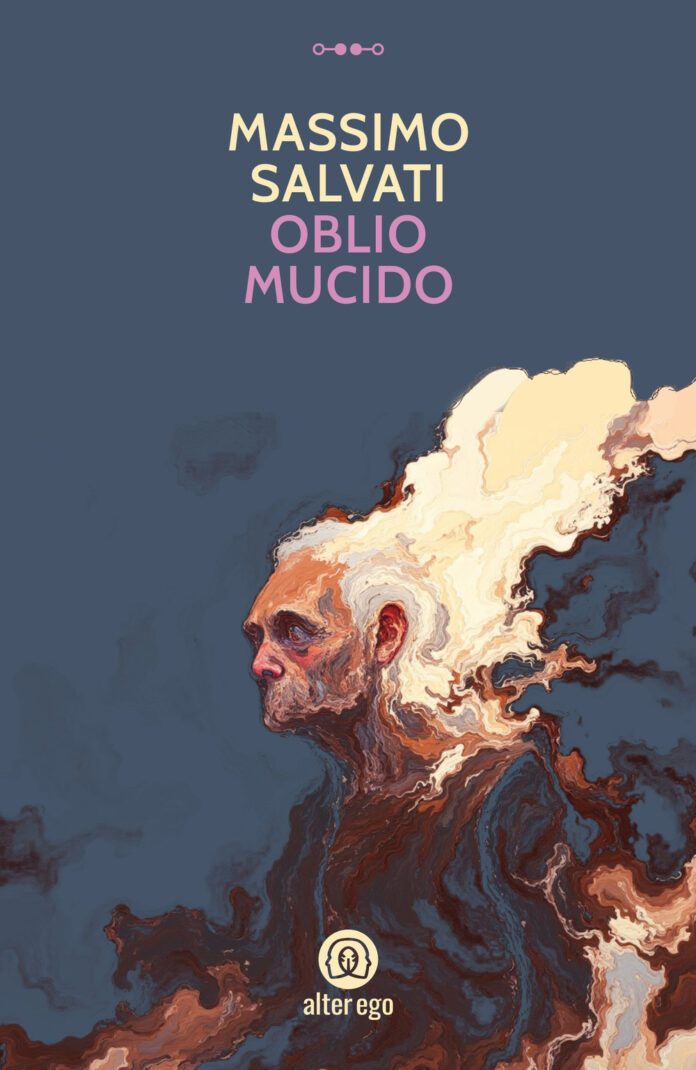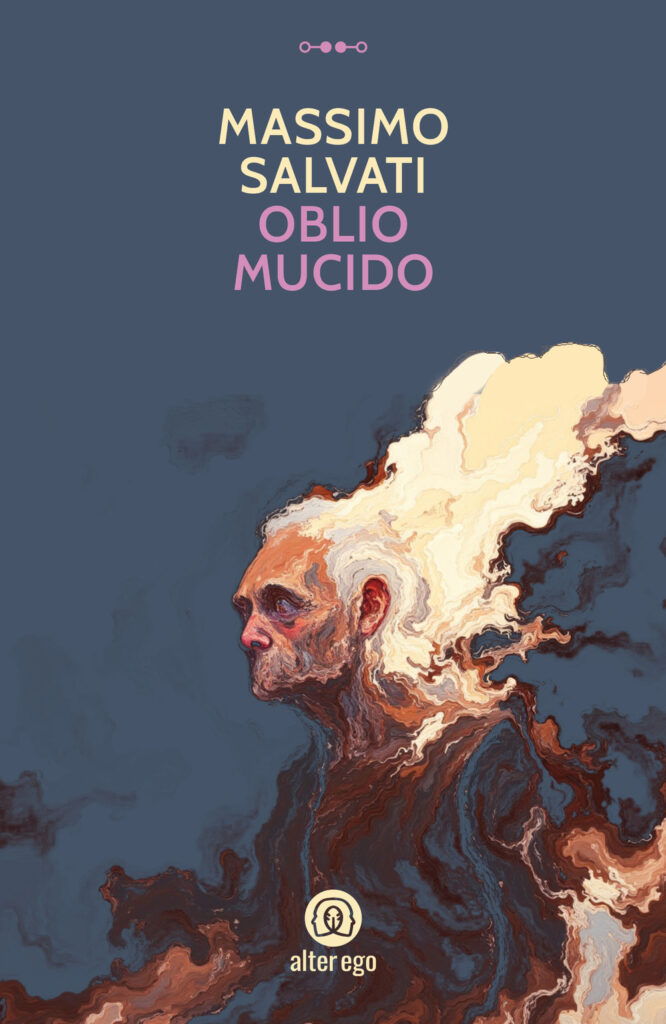di Leonello Ruberto

Vengo da un’altra epoca, o è meglio dire che sono sopravvissuto a un’altra epoca.
Ma non andrò oltre questa, come non ci andrete voi.
Io per motivi anagrafici, avendo superato ormai i cent’anni, voi, i più giovani, la maggior parte, perché ormai non si raggiungono più certe età.
Ci sono tante cose che non si raggiungono più.
Ricordo che, quando ero giovane, si parlava di come erano già nati individui che avrebbero vissuto fino a cento-centoventi anni.
A quanto pare io sono uno di quelli. Un po’ per fortuna, che ci vuole sempre. E il resto per i progressi della medicina.
Uno dei tanti progressi che si sono arrestati nell’epoca attuale che ho la fortuna e la sfortuna di vivere insieme a voi.
Quando ero giovane io, era credenza molto diffusa, e abbastanza ingenua, che il progresso fosse su una linea retta e crescente: l’epoca attuale era sempre più avanzata della precedente.
Be’, c’erano già delle avvisaglie che non fosse così. Intanto, il fatto che nella seconda metà del Novecento si fosse fatto un balzo tecnologico che non aveva precedenti nella Storia, che anzi aveva proceduto abbastanza lentamente nei secoli e secoli precedenti.
E poi altri esempi, come nelle arti: c’era qualcuno oggi capace di dipingere con tecnica pari a Michelangelo?
Certo ci potevano essere grandi artisti, come in ogni epoca. È questa la libertà dell’Arte.
Ma certe capacità oggettive si erano perse, tecniche che potevano crescere solo in un dato modo e in un dato mondo, anni di bottega, o influenza di altri artisti, insomma: il Tempo in cui si era calati.
Pensavo all’epoca, io, giovane uomo che ascoltava musica registrata quando a malapena erano nati i miei genitori: John Coltrane era venuto fuori così, da un tempo storico in cui una serie di irripetibili circostanze avevano creato un ambiente in cui lui era solo uno dei tanti grandi. Un tempo estremamente ristretto come è quello della musica jazz, a confronto per esempio della musica classica.
Un po’ come il Novecento in confronto alla Storia antica: un turbine che aveva travolto tutto e prodotto tutto in una manciata di decenni.
Nessuna scuola di musica avrebbe potuto creare un altro Coltrane. Tecnicamente era anche possibile imparare a suonare in quel modo, e sicuramente c’erano grandi musicisti.
Ma erano, appunto, nelle scuole. Dove stavano meno persone, che magari col tempo sarebbero state sempre di meno, finché certe tecniche si sarebbero perse come certe tecniche pittoriche, scultoree, architettoniche.
Non riuscivo a non vedere la bruttezza delle mie città, che nessuno era più in grado di pianificare e costruire con un minimo di gusto, senso artistico o proporzione.
Tornando alla musica, alle piccole questioni che potevano riguardare me, piccolo uomo qualsiasi, assistevo a una cosa singolare.
Non si trattava di tecnica, ma di tecnologia. Tecnologie audio più vecchie, e quindi arretrate secondo il sentire comune, erano a livello sonoro superiori alle tecnologie del presente.
Ascoltare la musica su dei piccoli dispositivi, in modo compresso e con diffusori minuscoli strideva con l’abitudine all’ascolto che mi ero fatto incappando nella musica jazz classica.
Era di certo più comodo, ma si era sacrificata la qualità. Possibile che non si fosse stati in grado di produrre tecnologie che mantenessero la qualità conquistata aumentando la comodità e la fruibilità?
Grande questione, e per il momento le mie orecchie si scontravano contro musica che era sempre più banale e: noiosa. Però se le orecchie delle persone non erano abituate, che ci si poteva fare? Una persona cresciuta con Lester Young avrebbe potuto cogliere la grandezza di Charlie Parker. E poi era arrivato Coltrane.
Ma quand’è che qualcosa si era fermato?
Quando l’arte, la musica, la letteratura, avevano perso la loro capacità didattica, di insegnare cose nuove, di tracciare la strada, di farli i gusti anziché seguirli?
Questioni troppo grandi per me e la mia vita quotidiana. Che però nel quotidiano potevo vedere peggiorare sempre di più.
La mobilità che tanto progresso aveva avuto, ora si era trasformata in un incubo.
Automobili sempre più ingombranti, scomode e inefficienti riempivano le strade e i marciapiedi rendendo le città, anche le più piccole e misere, un incubo.
Capivo che c’erano necessità economiche, si erano studiate tecniche di marketing per aumentare le vendite, perché il Mercato richiedeva un continuo aumento.
E questo era il funzionamento di tutta la Società, che si reggeva sull’equilibrio precario di una continua spinta al limite.
Le trovate tecnologiche, in pratica, cercando il profitto avrebbero prodotto anche il progresso.
Io pensavo che tra gli anni settanta e ottanta, mio padre, con un lavoro in fabbrica ben pagato aveva comprato una macchina comoda che giustamente era durata vent’anni.
Ora vedevo le fabbriche spostate altrove, gli stipendi abbassati, le auto cambiate ogni paio d’anni, quindi vendute in molte più unità, eppure le aziende sempre in crisi.
Con la mia matematica spicciola c’erano dei conti che non mi quadravano.
Ma io di economia, ammetto, non ci capivo niente e non la capivo, nel senso che non la approvavo, proprio.
Ero curioso e avevo anche sentito che veri economisti mormoravano tra di loro, ufficiosamente, ma i conti sembravano proprio dire questo, che col grado di sviluppo raggiunto la Società avrebbe potuto vivere dignitosamente nel suo complesso.
Eppure non accadeva così, come guerre e disuguaglianze d’altri tempi dimostravano a gran voce.
Semplicisticamente, mi chiedevo: quando la tecnologia aveva smesso di essere fatta a nostro vantaggio, per il nostro miglioramento?
Internet aveva annullato le distanze, i social network si erano innestati su questo definendo la nuova socialità, nonché la diffusione delle notizie, quindi del sapere. E dei gusti, in un passaparola globale.
Ma a me non sembrava la stessa cosa di prima, pur in un mondo tecnologicamente avanzato, che aveva già la tv, i telefoni, internet e i computer.
Non mi sembrava che il sociale si fosse semplicemente trasferito sulle piattaforme o nelle applicazioni.
Perché, anche se pure prima contava farsi notare ed essere presenti, ora chi aveva creato quelle piattaforme lo faceva per comprensibili motivi economici.
Quindi era essenziale che uno stesse sulla piattaforma più tempo possibile, e che non ne uscisse per andare altrove.
Non mi sembrava compatibile con la diffusione del sapere o anche di semplici gusti e mode che avevamo prima.
Una cosa simile vedevo accadere con l’arrivo delle intelligenze artificiali: servivano a fare operazioni complesse che noi umani non saremmo stati in grado di compiere, non a una certa velocità, praticamente nell’immediato.
Però le società che ci avevano investito le avevano programmate e continuavano a programmarle con lo scopo del profitto.
E allora se chiedevi una cosa all’intelligenza artificiale e non ti piaceva la risposta, facile che fossi attratto da un’altra intelligenza artificiale che magari ti dava ragione.
Rendendo di fatto le intelligenze artificiali bugiarde e quindi inutili. Nel frattempo avendoci pure privato della capacità di ragionare autonomamente.
Io assistevo a tutto questo inerme, come miliardi di persone, come se certe tecnologie non fossero state create da persone per le persone, ma come se vivessero di vita propria.
Una vita artificiale e quindi impossibile. Ma che in pratica si stava verificando.
Negli anni ho visto il sapere scomparire, tecnologie utili e funzionanti affossate a colpi di marketing per un cieco progresso che era solo e puramente economico.
Tanto da perdere, strada facendo, la capacità di farci qualcosa con quel progresso economico.
Così la Società si è sempre più impoverita culturalmente e tecnologicamente, restando con una montagna di denaro che in fondo era nato come umana convenzione per favorire gli scambi.
La medicina allora, quella che ha contribuito ad allungarmi questa vita, non è crollata per oscuri complotti economici, per compagnie farmaceutiche disposte a fare morire le persone per il proprio profitto.
No, è crollata proprio col contributo di questi complottismi, per mano delle persone che non volevano sentirsi dire che il medicinale era efficace ma con limiti e controindicazioni. Pazienti che sempre più si sono rivolti a rimedi facili e “naturali”, fregandosene dell’inefficacia assoluta.
È lì che le compagnie farmaceutiche hanno poi diretto le loro attenzioni, finché le medicine e la Medicina non sono diventate altro che i rimedi omeopatici venduti a caro prezzo che hanno riempito gli scaffali reali e virtuali, fino a scalzare tutto il resto.
Nessuno è riuscito ad arrestare il decadimento della Società e della popolazione mondiale, la riduzione dell’aspettativa di vita e la povertà diffusa.
Tutti, insomma, hanno preferito continuare a negare di essere poveri e malati, accompagnati da sontuose campagne pubblicitarie, fino alle estreme conseguenze della morte.
Quelli che non l’hanno fatto, e ci sono stati e ce ne saranno anche ora, non hanno contato e non contano niente.
Ma soprattutto non conteranno più.
Viviamo affamati nelle nostre fredde case diroccate in città bloccate da carcasse di vecchi veicoli inutilizzabili.
Siamo fermi in un presente di cui ormai non importa più a nessuno. Non dovrebbe nemmeno a me, che ho raggiunto un’assurda e venerabile età.
Eppure io vengo dai tempi in cui importava. Per questo mi affanno usando una vetusta tecnologia cancellata anni or sono: carta e penna.
Più che altro uso matite, visto che le penne sono rimaste asciutte ormai da qualche anno.
E i fogli che sono stati prodotti nell’altra epoca, servendomi di qualsiasi superficie su cui si possa scrivere.
Ricordo una vecchia pubblicità con le foto della penna bic nei vari anni: tutte uguali.
Una tecnologia nata già così efficiente da non necessitare cambiamenti, questo il messaggio.
Poi a un certo momento ne fu interrotta improvvisamente la produzione, non si sa da chi e perché.
Fu deciso, così, tra cessioni e acquisti di aziende da parte di aziende, per motivi economici. E bastava dire questo per non parlarne più.
Così non si è più parlato di tante altre cose. Né se ne è più scritto, ovviamente.
E a nessuno interessa leggerne.
O forse è solo che non c’è quasi più nessuno in grado di farlo?
Finché arriverà il giorno in cui effettivamente nessuno saprà farlo.
E, insieme a questo, nessuno sarà in grado di rendersene conto.
(foto di Daniele Muriano)





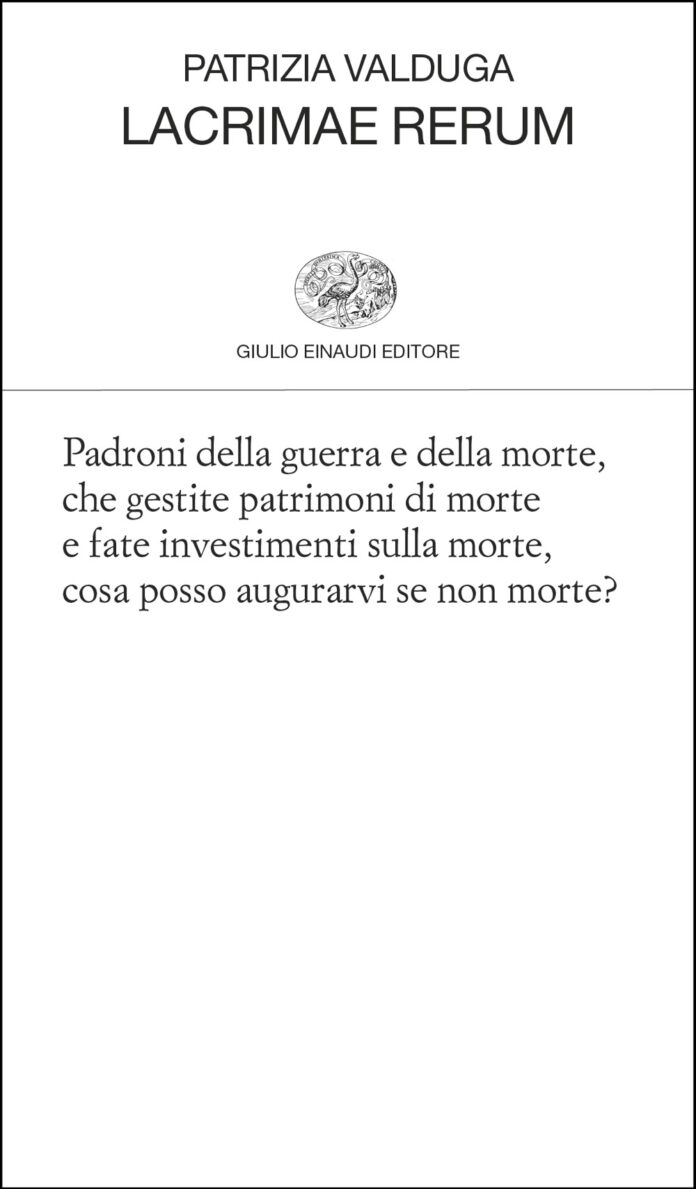
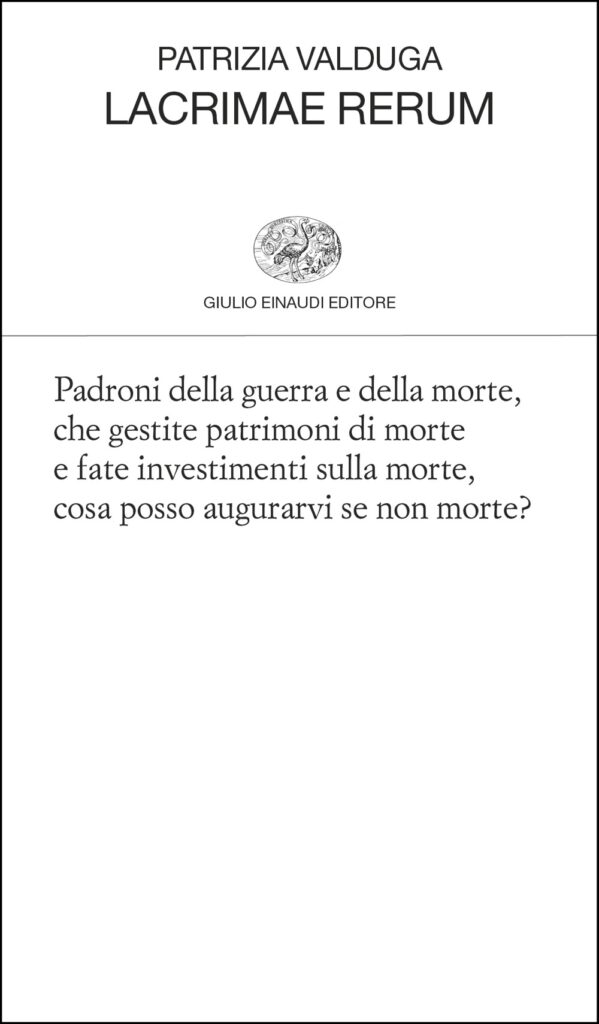



 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi