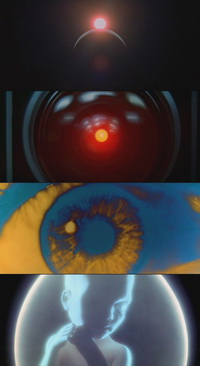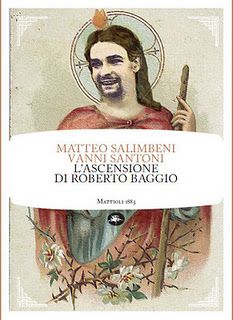di Chiara Valerio
Queste cose dette da nonna, che le ripeteva continuamente, avevano il sapore della maldicenza: per il bene, non per il male. Lei calunniava il bene, la grazia che aveva ricevuto, perché era il bene a essere latente, non il male. Qualcosa di enorme, la cui perdita era nientemeno che atroce, le era sfuggito nel tragitto dell’esilio. Il suono dei nostri passi di Ronit Matalon (Atmosphere 2011, trad. di E. Loewenthal) racconta di una famiglia ebrea egiziana con nonna sempre presente e padre ogni tanto, che, in seguito all’ascesa di Nasser e alla nazionalizzazione del canale di Suez, da un giorno all’altro deve lasciare il Cairo, insieme a una comunità di circa ottantamila persone, perché in Egitto non è più possibile lavorare, studiare e dunque vivere. È il millenovecentocinquantasei e la famiglia della voce narrante si trasferisce in un container in qualche Erez Israel tutt’altro che mitica, un prefabbricato anzi, senza fondamenta, appena appoggiato sulla sabbia. Paul Celan osservava Non si può scrivere fuori dall’Egitto e Ronit Matalon, ne Il suono dei nostri passi, aggira la questione mimando, con una scrittura in forma di nastro, il racconto orale. Sì, si può raccontare fuori dall’Egitto.