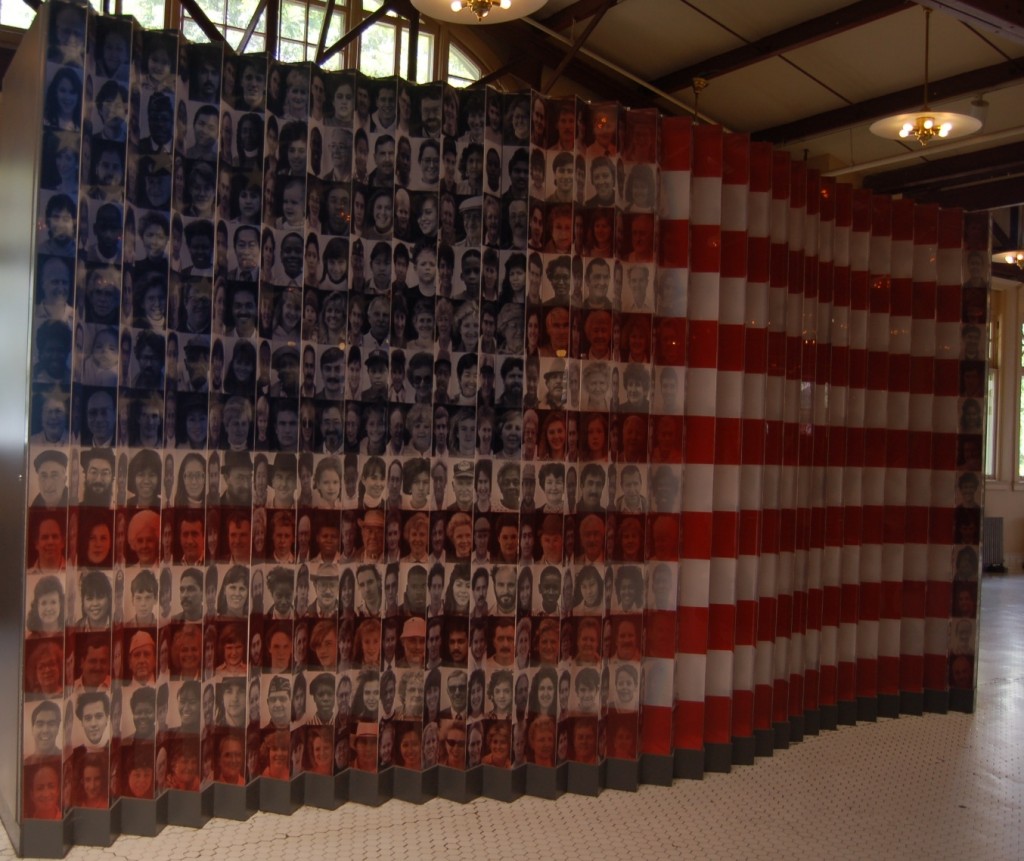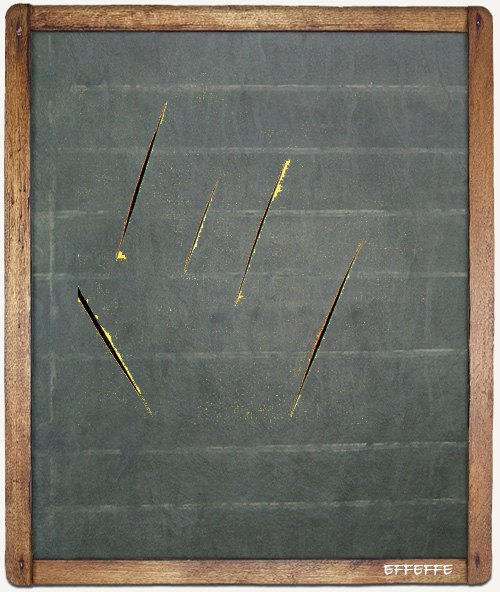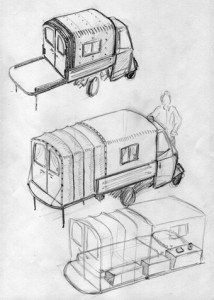di Peppe Fiore
Quando facevamo il liceo nessuno di noi s’azzardava a parlare di rivoluzione, avevamo tutti cose più importanti da fare. Eravamo un gruppetto di sei o sette persone che si erano trovate insieme più che per affinità per una certa strana congruenza a incastro delle reciproche storture caratteriali. Non so perché, ma se oggi ripenso agli anni della mia adolescenza l’impressione è quella di una lunga vacanza non cercata e non richiesta. Una di quelle vacanze senza fine dove si sta costretti a forza in un posto di mare, è sempre senza scampo dopopranzo, e pertanto ogni cosa che si fa sembra sempre la cosa sbagliata.
Sarà che ormai sono vent’anni che mi confronto con la natura intimamente letteraria del posto dove sono nato, sempre uscendone massacrato. In tutti questi anni, la mia città è stato un argomento di conversazione universale. Tutti gli sconosciuti che ho incontrato ovunque – università, lavoro, vacanze, treno, baretto di spacciatori a Monteverde – si sentivano in dovere di entrare in confidenza con me appena sapevano che ero di Napoli. Come se essere di Napoli mi garantisse automaticamente una forma di percezione delle cose più laterale e, in qualche modo, più fina. Perché poi? Boh.
Naturalmente dopo cinque minuti di conversazione sciolta, il commento a mezza bocca dell’interlocutore di turno era sempre lo stesso, e sempre un po’ deluso: – Cazzo però, non ci sembri proprio. Sicuro che sei di Napoli?