
di Maddalena Fingerle
Anche se ci sono cresciuto, questo non è il mio mondo. Mia madre è uguale a mia sorella che è uguale a mia cugina che è uguale a mia zia che è uguale all’altra mia zia che è uguale all’altra mia cugina che è uguale alla cugina di mia cugina che è uguale a mia madre e quindi a mia sorella, a mia cugina, a mia zia e all’altra mia zia e all’altra mia cugina. È che qui si tromba tra cugini. Non che ci sia niente di sbagliato, eh, se non fosse che io di cugine ne ho soltanto due, se non si contano le cugine delle cugine e no: quelle non contano. Una è molto bella e l’altra è molto brutta. Quella molto bella, Bertrud, sa di esserlo e ha la fortuna di avere molti cugini tra cui scegliere. Quella brutta, Heidrun, sceglierà ciò che le lascerà Bertud e io dentro di me fantastico che Bertud scelga me, anche se so che non sarà così: tra i cugini io sono quello strano. Sono l’unico che non sa il dialetto e mio fratello, Bert, è davvero bello e anche mio cugino Bertfried, quello biondo, è davvero bello. In realtà siamo tutti biondi, ma di un biondo tendente al castano, mentre lui è biondo biondo. Le donne invece sarebbero come noi, ma si tingono di un colore finto ed ecco: sono tutte uguali. Berthold invece è meno bello di me, ma ci sa fare e quando si vanta delle mucche che ha né io né Bert né Bertfried né gli altri cugini abbiamo la minima chance di gareggiare contro di lui. Berti invece è timidissimo e forse ci gioca su; mia cugina infatti si intenerisce quando lui diventa tutto rosso. Lo fa anche quando Berto balbetta e allora non so mica se ho qualche chance: io non sono né davvero bello né davvero misero.
Qui ci sono torte e rinfreschi, sedute infinite, discussioni su chi è morto, su chi è cresciuto, sui divorzi, e io non so proprio che dire. Finisce l’elenco dei vivi e dei morti, ed ecco il discorso sulle mucche, di cui scopro con sgomento il prezzo; un breve conto ed è ovvio che non posso competere con Berthold. Bertrud vuole Berthold, si vede, penso: che le posso offrirle io? Ho libri, sì, però qui se leggi sei solo un eccentrico con sogni eccentrici che vuole cose eccentriche, teoriche, inesistenti; un inetto che non vive nel mondo vero. Poi? Delle penne, sì, però Bertrud delle penne se ne fotte. Sì, ho pure CD e libricini pieni di scritte, però sono tutte cose che non servono. Sono invidioso di mio cugino Berthold e rifletto: forse non mi recherò lì, resterò qui e gli ruberò tutte le mucche oppure gliele ucciderò, eh, che scene! Così sì che si discuterebbe di me. Non più il cugino mediocre né scemo né sveglio. O forse no.
Quando finiamo, facciamo il solito giro, poi puliamo la tomba di famiglia. «Quando morirò voglio un’urna, non una tomba» dico io, provocando imbarazzo tra i cugini, zii, mamma, papà; tutti rossi di rabbia. «Dai, non si fa: occuparsi di una tomba, di fiori, di annaffiatoi, di un corpo morto: una cosa idiota!» Papà mi tira uno schiaffo. L’altro idiota schizza acqua santa con un ramo di ulivo: un dio. Sicuro, lui sa comportarsi. Poi mi si avvicina, mi sussurra: la nostra tomba – guarda, io una toccatina, quasi quasi – bisogna sia la più curata; sono uno stupido, non capisco la dinamica, quindi sto zitto con il capo chino.
Quando torniamo dai miei, mia cugina Bertrud, quella bella, viene con me in cameretta e mi dice che anche lei è per cremare i morti, ma qui mica lo puoi dire. È vero, ha ragione: perché l’ho detto? Il mio letto è perfetto perché mia madre l’ha fatto poco fa; mia cugina cade indietro, le coperte ripiene di penne d’oca, dice che non è vero quello che dicono gli altri: mi vede bello e intelligente e lei mi appoggia per la città e per la carriera. Dice proprio: io ti appoggio. Mi avvicino e cado anche io accanto a lei e le chiedo «Rimani qui?», lei mi guarda con l’aria dolce e quell’aria dolce mi fa finire il liceo e partire. Non mi guardo più indietro, non mi vergogno più perché quando vedo un vitello venire al mondo mi viene da vomitare e perché ho, a differenza loro, la vergogna del corpo nudo, perché utilizzo il congiuntivo quando va utilizzato e non me ne frega niente che non ho i piedi per terra, non faccio il miele e non mungo le mucche.
Qua però passo per strano uguale. Saluto la gente per strada. Che gay! Ok va bene; sono gay e arretrato, secondo loro, ok, va bene. Frequento un corso ed è un vero bordello, la gente parla strano; e sono ancora gay e arretrato. Ok, va bene: accetto e resto muto. La gente scopre però da dove vengo e ora non sono solo gay e arretrato: sono quello che deve farcela, deve assolutamente farcela perché sono qua da solo, e ora sono pure poveretto, oltre che gay e arretrato. L’esame va bene e sono contento quando prendo un bel voto, ma non lo racconto a nessuno perché va bene passare per gay e arretrato e poveretto, ma ora basta.
Al paese oggi al circolo del caffè siamo solo mio padre, mia madre, Bert e io. Deve essere successo qualcosa, credo, ma cerco di stare calmo. Mi siedo, bevo caffè e butto giù qualche morso della torta burrosa. A parlare è mio padre. Dice che Bertrud ha deciso: si sposerà. Lui lo sa dallo zio. Resta zitto, guarda mio fratello, poi me, scuote la testa e tace. Mi ricordo che Bertrud mi appoggia e sorrido, mio padre si alza, si risiede, sta per parlare, ma poi resta zitto. Mia madre gli tocca la spalla e lo guarda, lui le sorride e dice che Bertrud ha scelto me, dice che Bertrud sposerà me, ma lui come fa a dire di sì? Bert ha qualcosa da offrire, ha le idee chiare, lui sì che sa che cosa vuole, e poi si sa comportare, il dio. Io sto zitto. Pure mio fratello-dio tace, poi dice che, se voglio, posso lavorare da lui. Scuoto la testa e mia madre mi dice di essere saggio, ormai sei adulto, le dico che voglio studiare e lei mi dice basta, sempre queste cazzate, si tratta di cose serie e allora le dico che porterò Bertrud fuori di qui, la libererò, mio padre ride. La città posso scordarmela e allora dico che lei potrà scordarsi di me. Lo dico e vedo subito il terrore sui volti di mamma e papà.
«Guardate che anche lei preferisce essere bruciata.» La mamma dice un’Ave Maria e un’altra e un’altra e un’altra, sistema la cucina, mentre papà esce dalla stanza. Mi viene da ridere, Bert impallidisce. «Mi sembra che si è già bruciata» dice. Si sia, deficiente: si sia.
Foto di Ludmila Mottlova da Pixabay







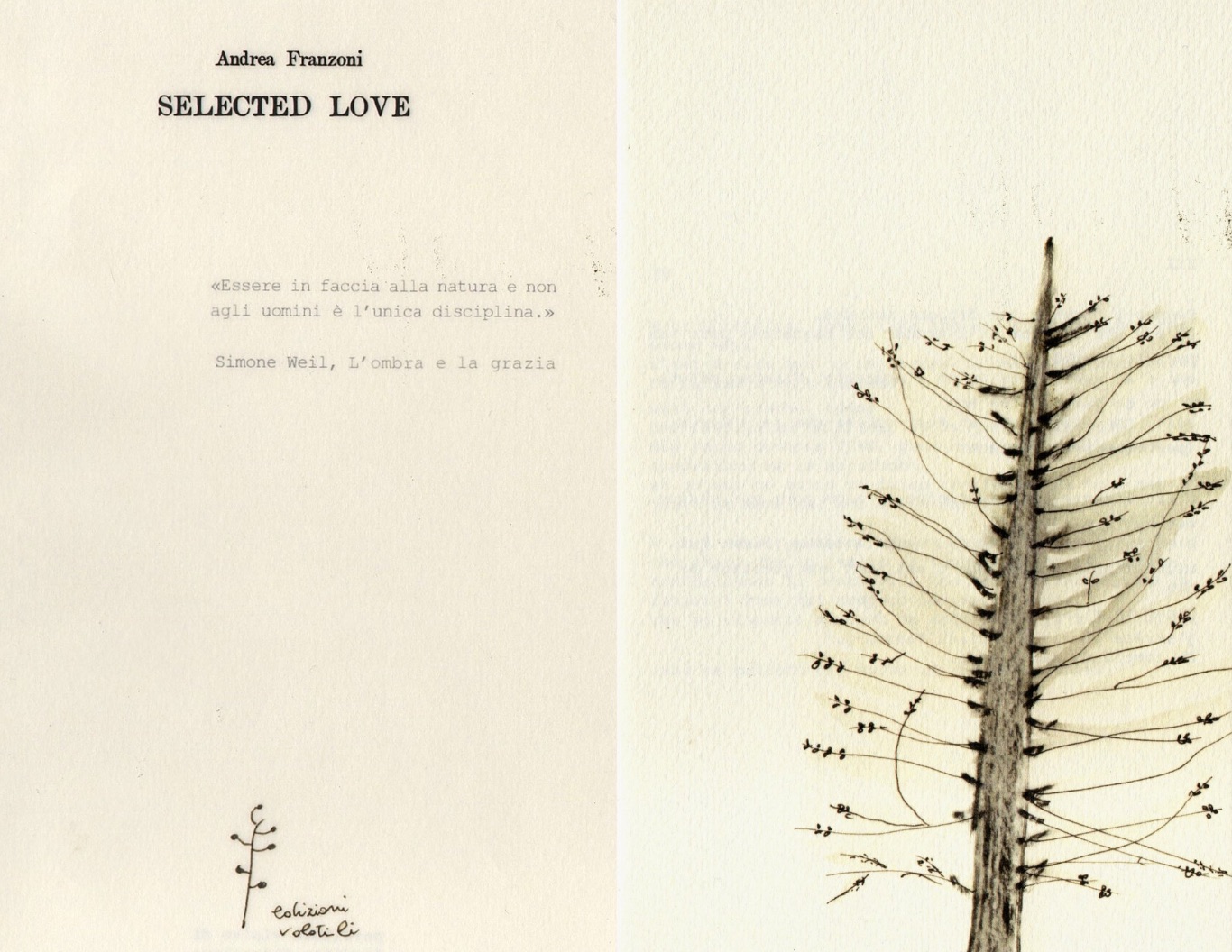
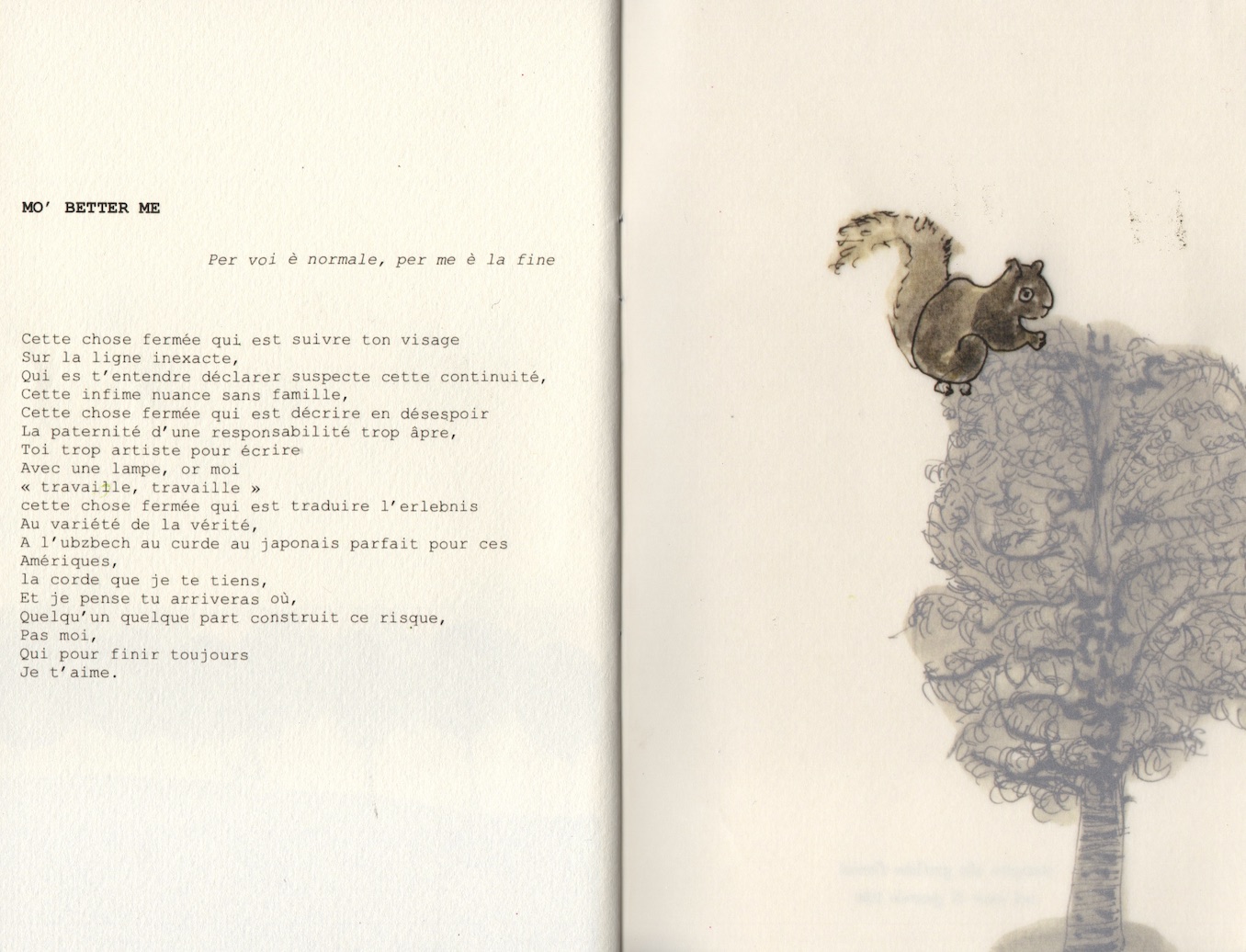
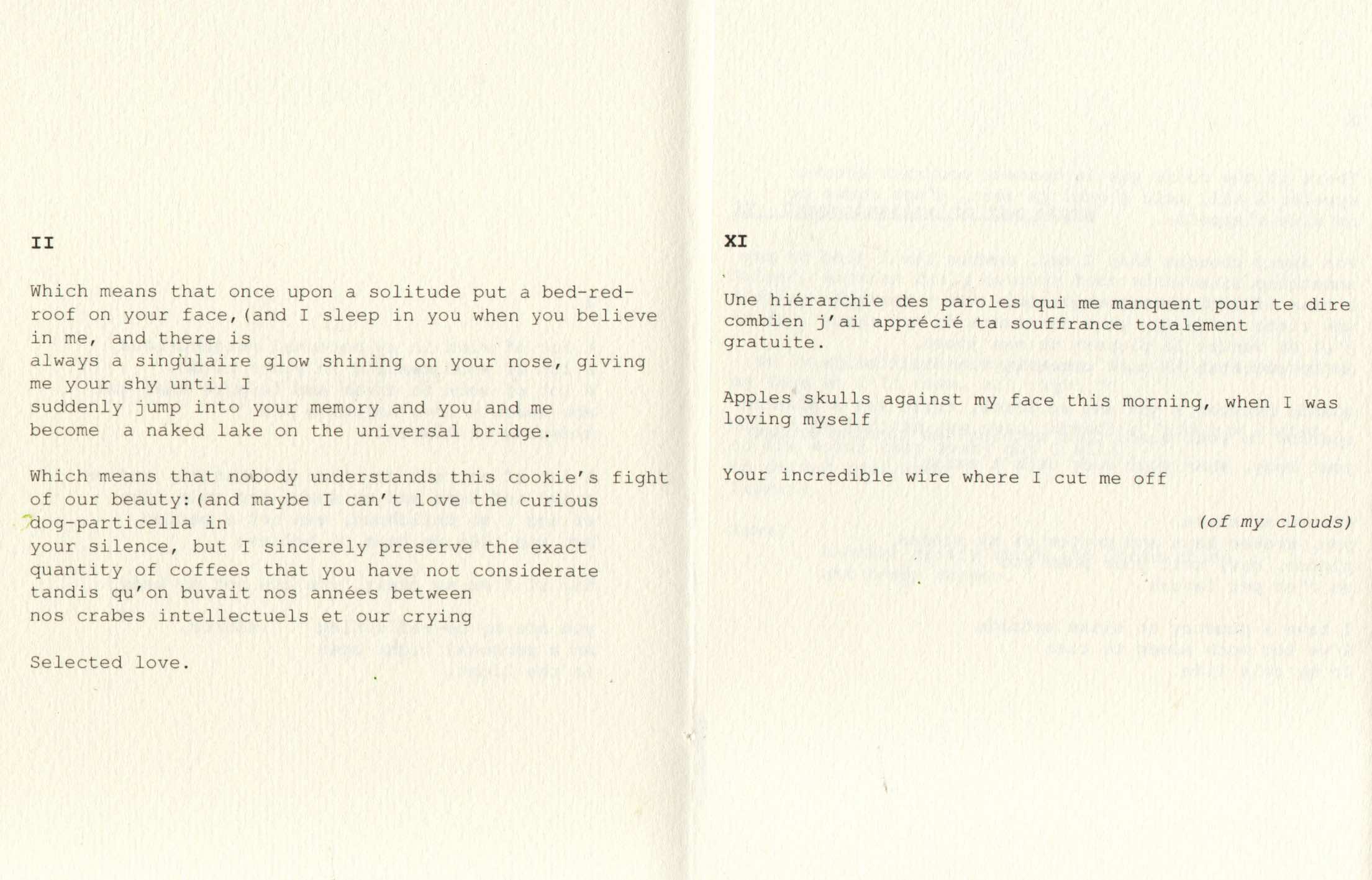












 nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte.
nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte. Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.
Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.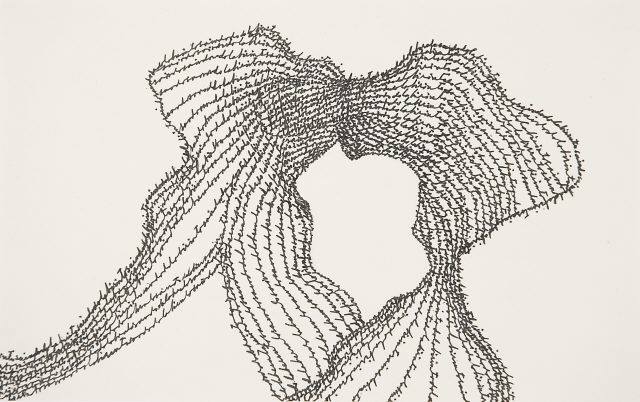
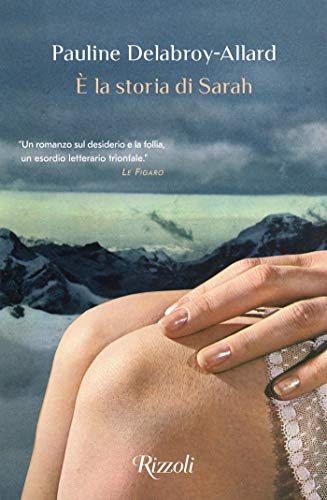







 Conversazioni a cura di Stefano Modeo
Conversazioni a cura di Stefano Modeo