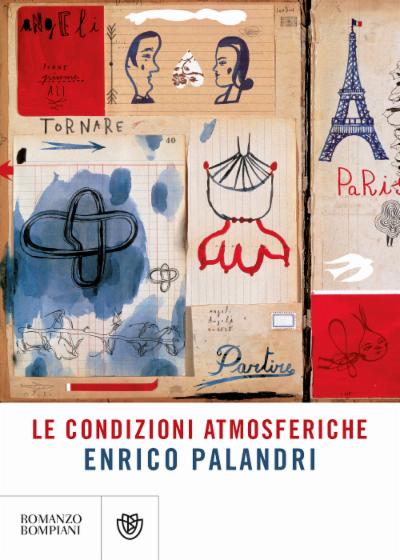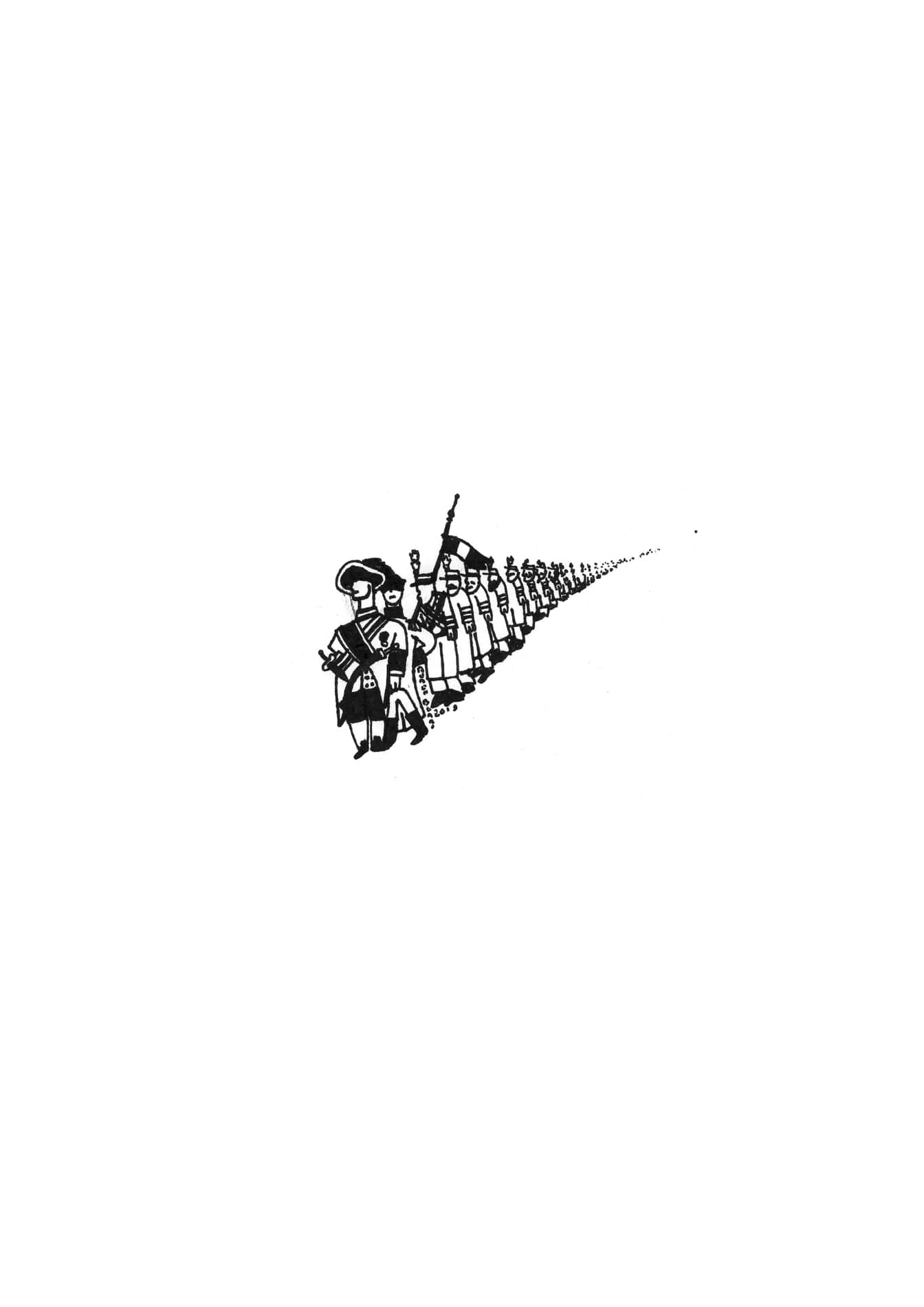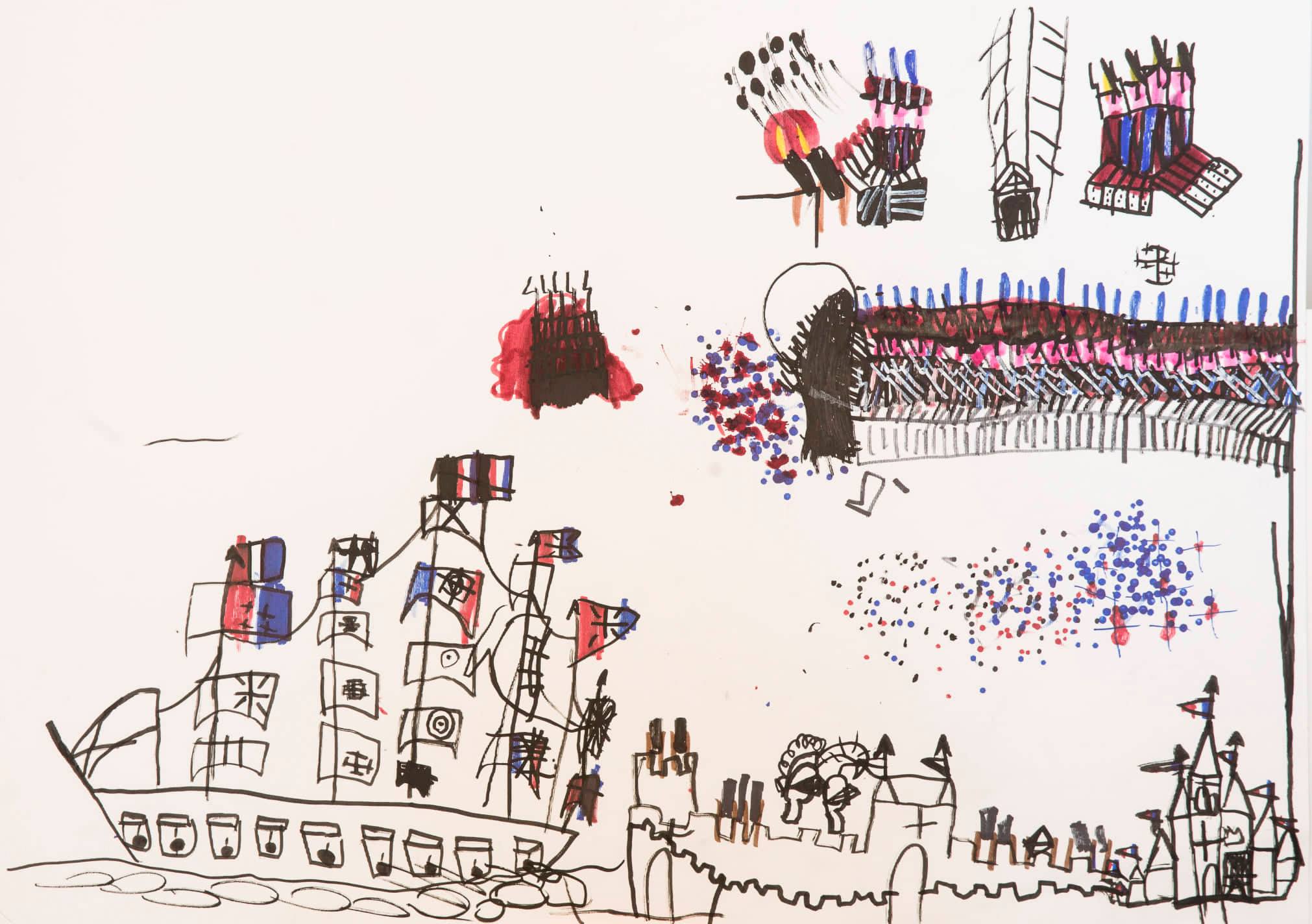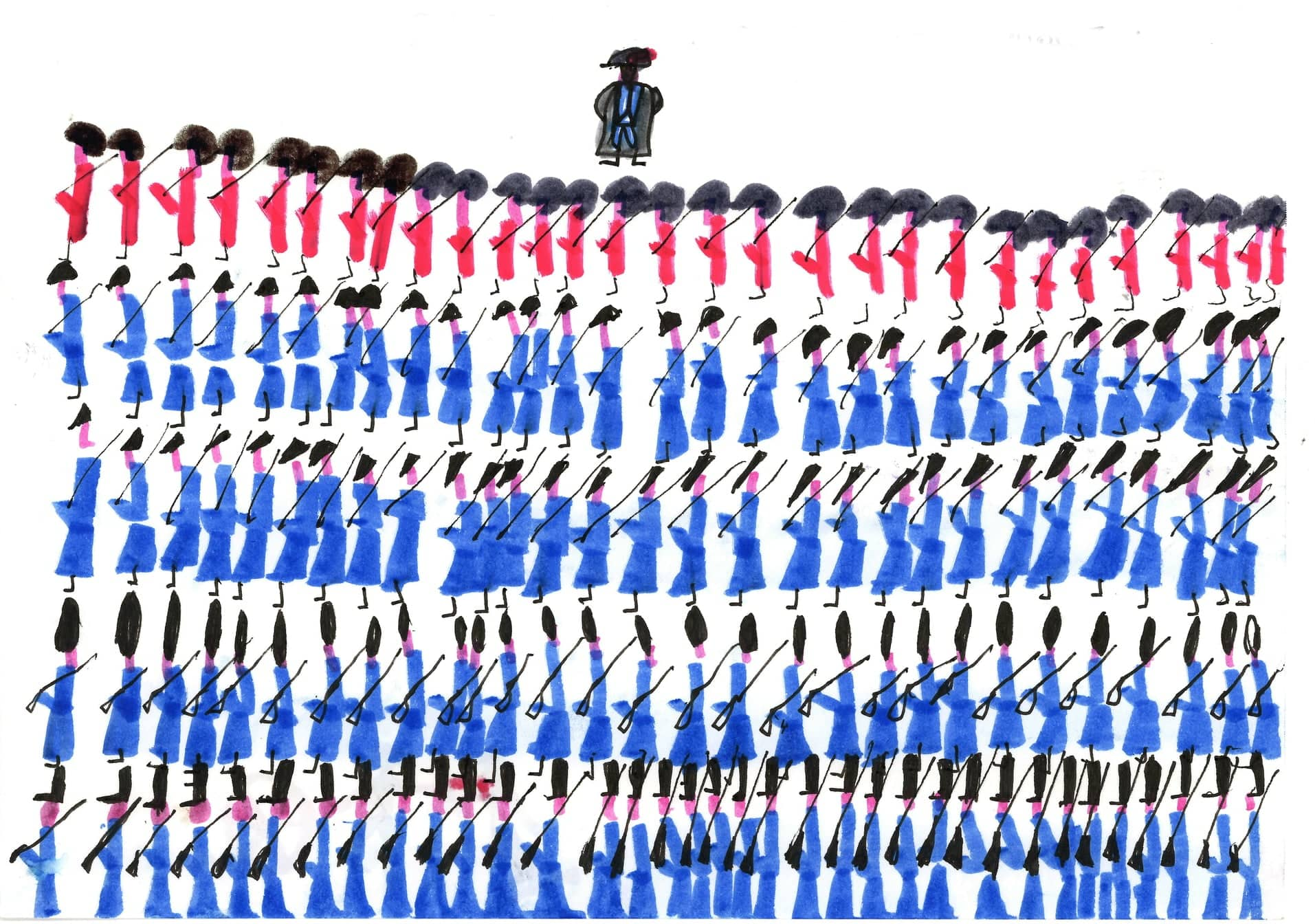di Francesca Genti
Le mamme delle poete
le mamme delle poete si siedono sul divano,
è tardo pomeriggio e aspettano le figlie.
le vedo dalla cima di una stella;
accendersi una sigaretta, farsi un bicchiere,
incrociare e scrociare le gambe,
girare gli anelli, mangiarsi le unghie.
le mamme delle poete sono inquiete,
è tardo pomeriggio e aspettano le bimbe,
poete appunto, non luminari della scienza,
né capitane d’industria né avvocati,
non donne che sanno organizzarti una casa,
una vacanza, un veglione per venti persone.
poete appunto, inabili alla vita,
perennemente offese dalla durezza della realtà,
le vene azzurrate da micro apocalissi,
e una passione smodata per le ciliegie sotto spirito
(ma niente soldi per il dentista!).
nell’attesa che le separa dalla visita
si chiedono veloci dove hanno sbagliato,
le rivedono in stellina dentro i cieli,
quando erano soltanto puro desiderio
senza ombra di dubbio, e una felicità,
morbida e tiepida, dalla nuca profumata,
quando dicevano le cose buffe a tavola
e aspettavano sveglie i topini dei denti.
forse le avevano allattate poco
o lasciate troppo davanti alla televisione,
saranno stati i campi steineriani?
o la sopravvalutata pedagogia montessoriana?
più acqua? meno acqua?
più luce, madre mia, ancora sulla terra.
le mamme delle poete sembrano marat,
nel celebre quadro all’oldmasters,
o vecchie ofelie preraffaellite,
nel famoso dipinto alla tate gallery,
sdraiate sui cuscini del divano,
confuse con i fiori dei tessuti,
il vino rovesciato lungo i polsi,
allorché queste figlie poete,
(un tempo così brillanti e allegre,
un tempo così belle e in salute),
si mettono comode, si tolgono le scarpe
e raccontano di problemi esistenziali,
o di come si sono fatte fottere marito e lavoro
da qualche campionessa più giovane e furba
(qualcuna la cui madre avrà allattato meglio
e di sicuro cucinato tutte quelle torte
che nell’abbaglio delle loro giovinezze
loro mai si sono sognate architettare).
le mamme delle poete reagiscono
ognuna a suo modo alla cattiva sorte.
se sono di indole frivola
partiranno per un lungo viaggio,
un grand tour di shopping compulsivo,
che neanche elton john nei momenti più bui.
se sono inclini alla saccenza
chioseranno l’avevo capito da quella poesia*.
se propendono per il lugubre
si chiuderanno in un atroce silenzio
e puzza amara sarà, fino ai prossimi natali.
le rivedono in stellina fluorescente,
trilli subacquee sulla spiaggia,
così carine nei loro costumi di sirena,
così della vita fiduciose,
pescioline nel brillare della luna,
di ogni marea, di ogni compleanno,
di ogni adorazione del piedino
(tutti gli altari d’oro dell’infanzia).
forse le avevano allattate troppo,
o quella volta giù dal fasciatoio,
sarà stata la baby sitter ninfomane?
o i racconti horror della zia?
più vino? un po’ di vino?
più luce madre mia, ancora sulla terra.
*
(le mamme delle poete infatti,
anche se hanno condotto studi umanistici
tendono a leggere l’opera delle figlie,
con approccio gossipparo,
una sorta di inesaurita Eva Tremila).
Malgaro elettrico
mio padre, he was a country boy
in un piemonte vertiginoso e fosco.
nella provincia cosidetta Granda
(la Shangri-lah dei fragoloni a Peveragno)
si fece largo, tra le gambe di mia nonna.
con un suo sacchettino di plasma
con un suo pacchettino di ossa piccole
nello zaino un sasso e una ricotta
e i suoi semini da piantare per il mondo.
insomma, nacque. come tutti i bimbi.
alla fine di una rovinosa guerra.
nella provincia cosidetta Granda
(dei partigiani a vocazione GL)
nacque, bimbo bello, in questa terra.
in amarezza e luce. e abbagli e cadute.
e nuvole che turbano lo sguardo:
in baratri di nostalgie cobalto
mia nonna infatti cadde
giù nel buco, proserpina borghese,
si ruppe la borraccia della serotonina;
fantasmi di giovinezza non sbocciata
minacciarono la vita dell’infante.
giorni e giorni di fitto temporale
fitte al cervello elettrizzato male
mani magre non riuscivano a tenere
l’autunno sconfinava nell’inverno
e questo fagottino, bimbo bello,
diventava triste e macilento
non riuscivano a trovare più l’azzurro
ma un pomeriggio più tenero degli altri
nella provincia cosidetta Granda
(quella effigiata da pittara e delleani)
su prati dai colori psichedelici
apparve una fata in forma di vacca
“non preoccuparti” disse alla ragazza
“riposati, riprenditi l’azzurro”
“io mangio l’erba e i fiori
do il latte io a tuo figlio”
“tu dormi, riposa nell’azzurro”.
e fu così che mio padre si riprese
e diventò mio padre, appunto.
oggi ancora lo è. he is, a country boy
che prende suo nipote sulle spalle
e per fargli ammirare meglio le vacche
e le loro boasse impastate di fiori
prende la scossa sul malgaro elettrico.





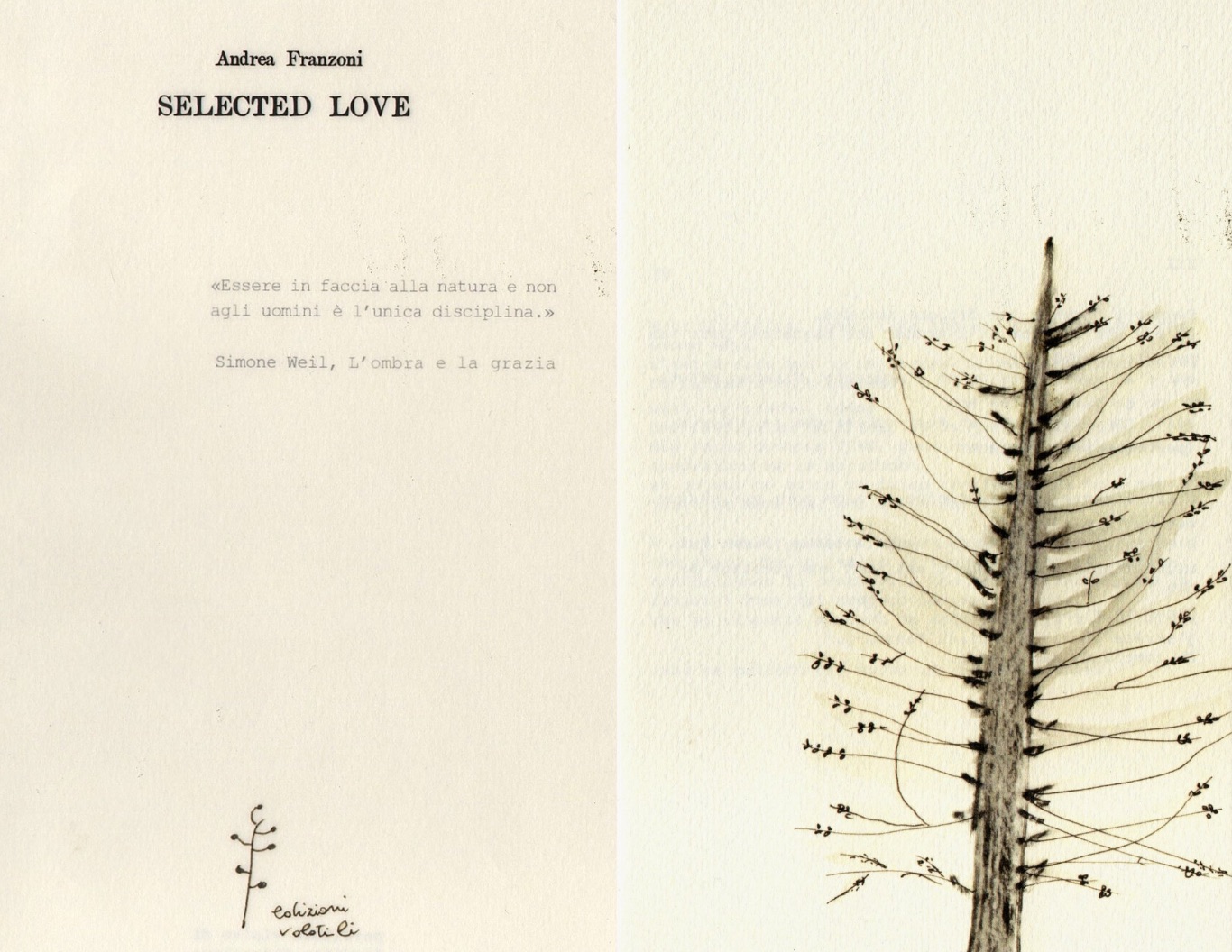
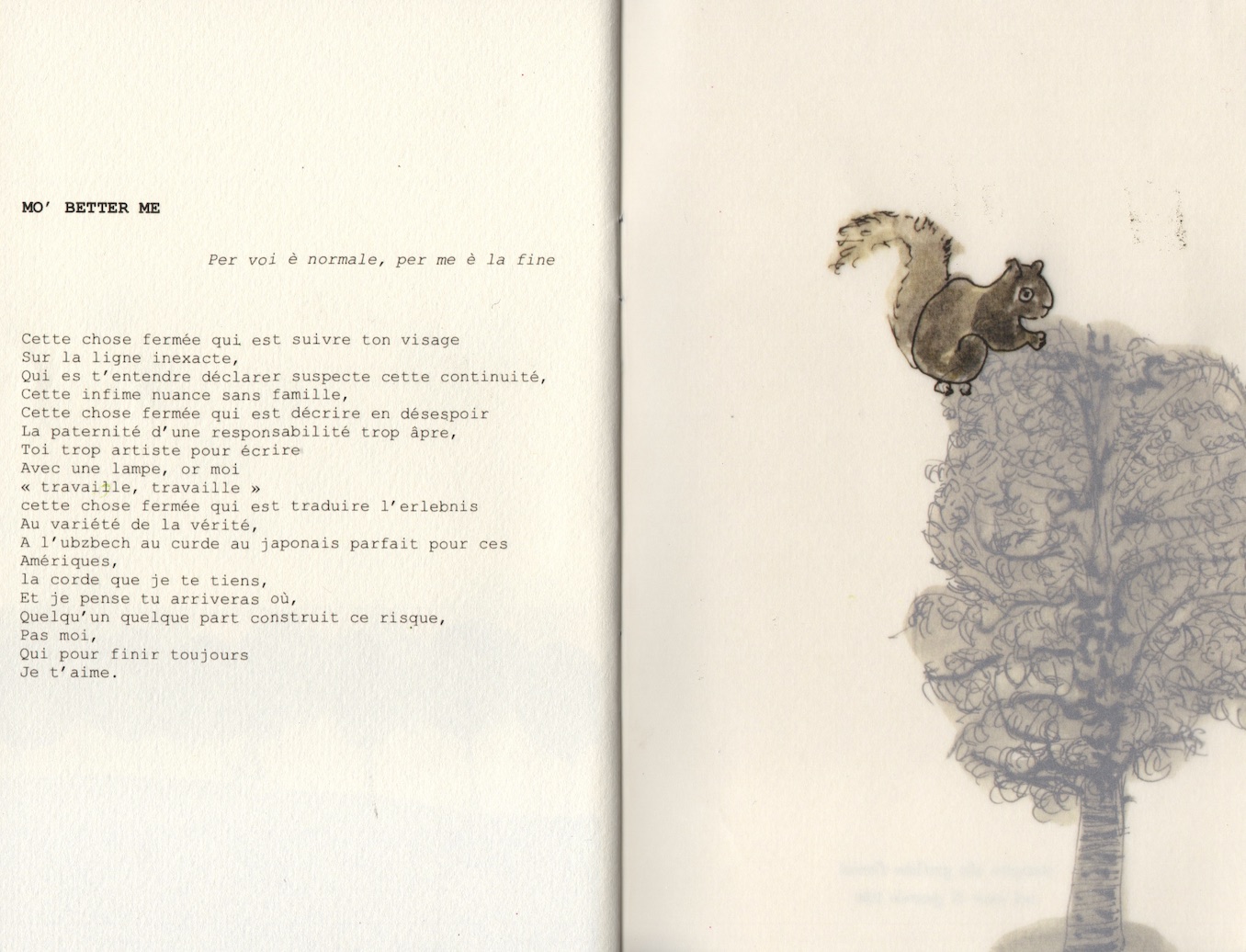
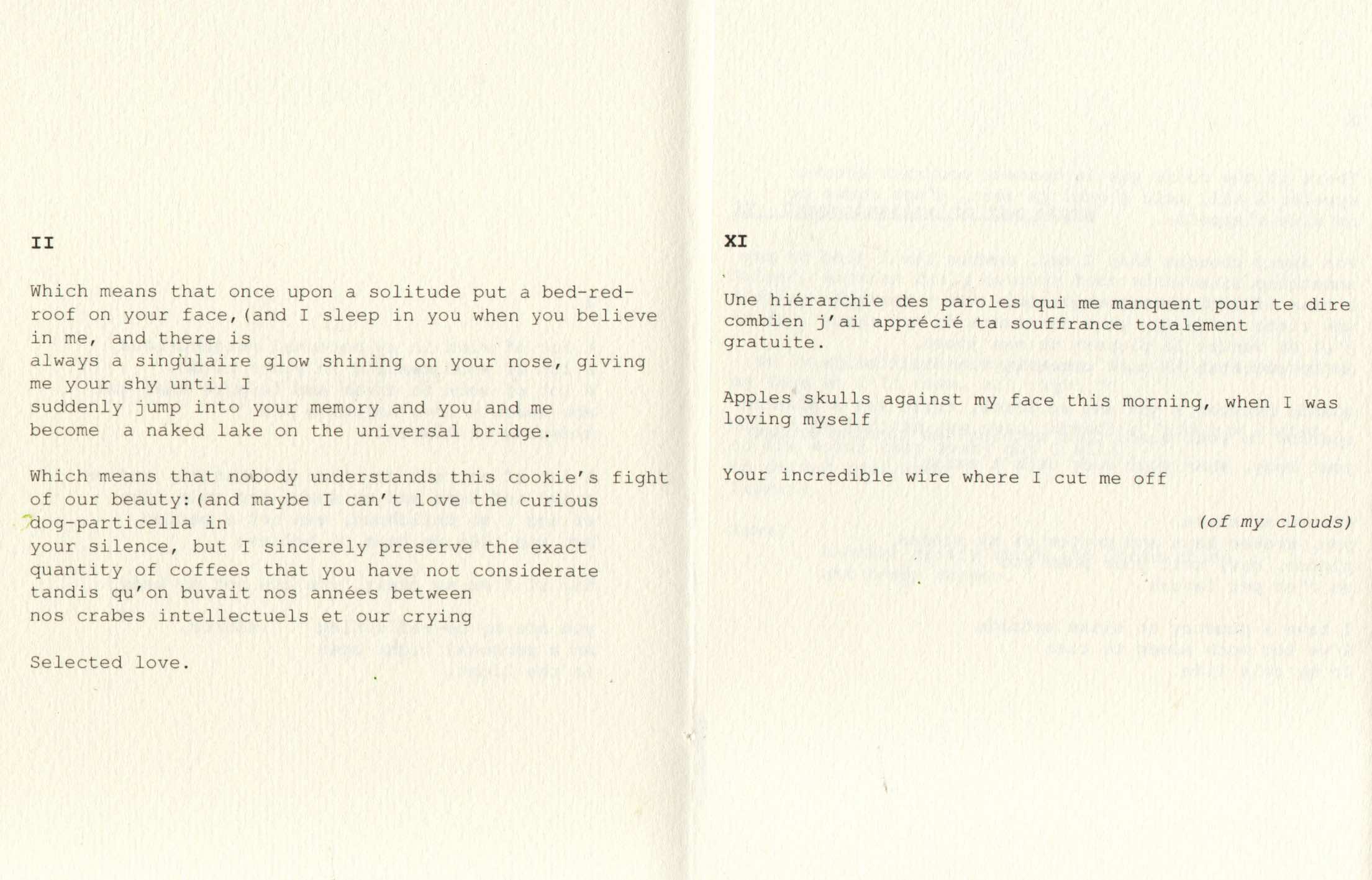












 nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte.
nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte. Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.
Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.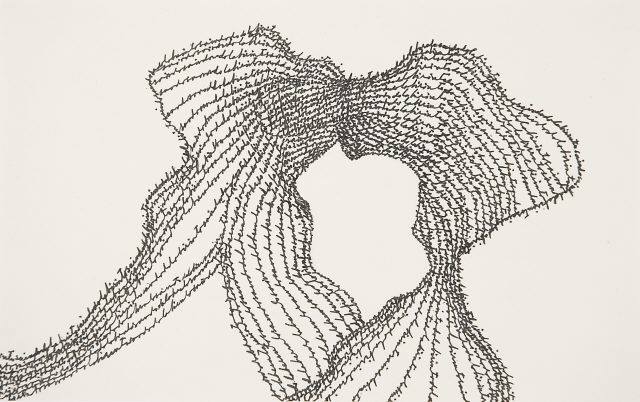
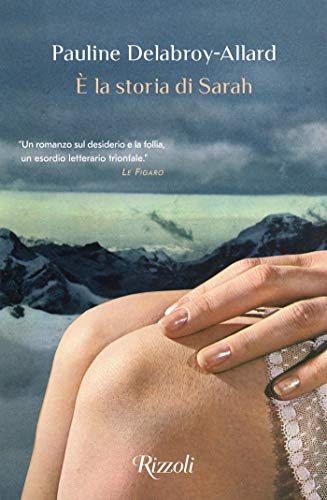







 Conversazioni a cura di Stefano Modeo
Conversazioni a cura di Stefano Modeo