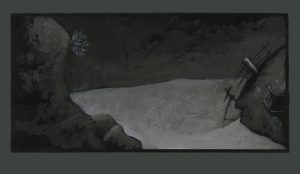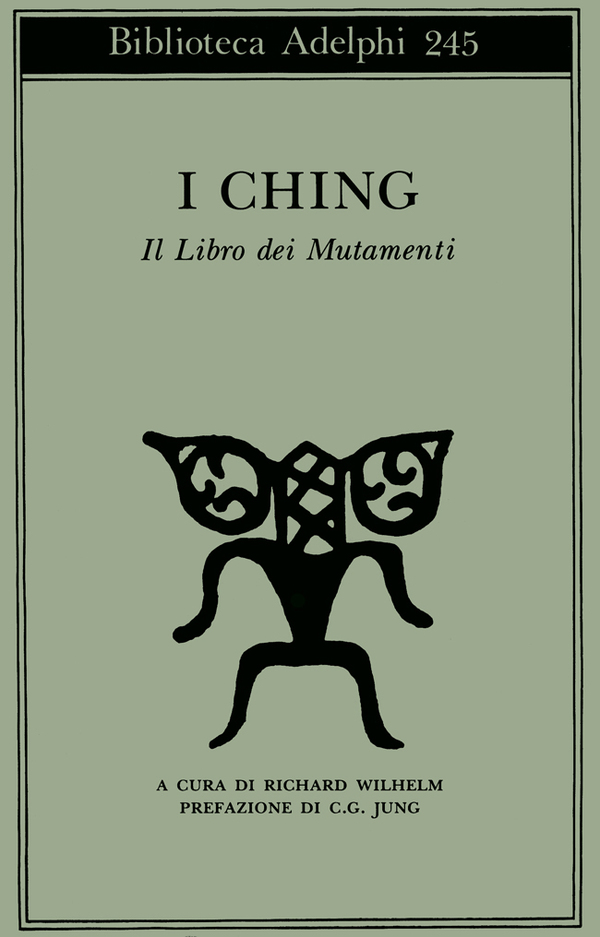di Daniele Barbieri
Questo breve libro delinea un lungo percorso, storico e teorico, attraverso cinque nozioni i cui reciproci collegamenti si sono molto trasformati da un’epoca all’altra: immagine (cioè rappresentazione visiva di un elemento del mondo), scrittura, oralità, serialità, romanzo. Ciascuna di queste nozioni ne comporta, implicitamente, una sesta, che è racconto. Potremmo pensare questo libro come una storia (molto parziale) del racconto in relazione all’immagine, alla scrittura, all’oralità, alla serialità, al romanzo.
Dare senso a una nozione come quella di letteratura a fumetti richiede questo percorso, che dà senso alla specificità del fumetto e del suo modo di comunicare e di raccontare. Il fumetto è una forma di scrittura, e il corpus di queste scritture forma una letteratura; ma, come vedremo, si tratta di una scrittura molto diversa da quella, alfabetica, che utilizziamo per memorizzare la parola, e produce di conseguenza una letteratura molto diversa da quella fatta esclusivamente di parole.
La storia che raccontiamo nelle prossime pagine parte da quando le distinzioni che a noi appaiono oggi naturali erano inesistenti o minime, e quelle che noi oggi chiameremmo arti e quello che noi oggi chiameremmo rito erano una cosa sola. La storia prosegue a cavallo tra improvvisazione omerica e scrittura, quando la scrittura non era una cosa sola, e anche la sua distinzione dall’immagine restava incerta. All’epoca di Omero e degli altri aedi, la narrazione aveva per sua natura caratteristiche che oggi definiremmo, sotto certi aspetti, seriali: solo la scrittura cambia – e solo in parte – le cose.
La separazione tra immagine e racconto viene sancita solamente nel Rinascimento, quando l’immagine arriva a conquistare un’autonomia concettuale che prima le era sconosciuta. È proprio nel Rinascimento, però, che si impone anche un’altra distinzione cruciale, quella tra alta cultura e cultura popolare. E alla fine della medesima epoca Miguel Cervantes inventerà la forma del romanzo, che sopravvivrà serpeggiando tra cultura alta e bassa per un paio di secoli, sino alla sua definitiva legittimazione nell’Ottocento.
La serialità rinasce, avviandosi verso le forme che conosciamo oggi, con la nascita della stampa periodica, nella Francia del XVII secolo. Il suo sviluppo è parallelo e intrecciato con quello del romanzo. A partire dal Settecento, anche la narrazione per immagini incomincia a uscire dalla marginalità a cui il Rinascimento l’ha condannata. Del resto, l’Ottocento è il secolo in cui le fondamenta dell’opposizione tra alta e bassa cultura iniziano a sgretolarsi: certo, lo sgretolamento non è ancora del tutto compiuto nemmeno oggi, ma molta strada è stata comunque fatta.
Il fumetto ha percorso questa strada nel corso del XX secolo, non senza difficoltà, e ha conquistato solo recentemente una dignità culturale condivisa. Ed è proprio guardando tra le maglie di questa conquista che se ne comprende l’ideologia, e il travestimento attuale del pregiudizio aristocratico che domina la nostra cultura da mezzo millennio.
Questo libro non racconta una storia del fumetto, ma una storia della cultura occidentale sotto quegli aspetti che hanno condotto il fumetto a essere quello che è.[i]
[…]
4. Narrazione per immagini
Le immagini restano. È per questo che possono essere considerate una sorta di protoscrittura o parascrittura, e si trovano comunque all’origine della scrittura in senso stretto.
Le immagini restano e possono permanere, nei luoghi adatti, per migliaia di anni. Ne bastano molti di meno per farle diventare qualcosa che persiste in un mondo in continua trasformazione, e soprattutto che persiste mentre la vita delle singole persone deperisce e trapassa.
Queste immagini permanenti, investite di racconti trasmessi e reinventati di generazione in generazione, si prestano bene a simboleggiare qualcosa che persista al di là di tutto ciò che fluisce. Alla fine, rappresentano ciò che permane all’interno di tutto quello che scorre, come i racconti. Ci vuole poco a vederle, prima o poi, come qualcosa di diverso da tutto il resto, come qualcosa che oggi noi, uomini della Storia, chiameremmo magari dei.
Si accostano in questo modo le due fondamentali funzioni storiche delle immagini (incluse le statue): supporto stabile del racconto e oggetto di adorazione. Sino a tutto il medioevo e ancora in parte nel Rinascimento (e poi ancora sino a oggi, in misura minore e parziale) statue e dipinti sono state sostanzialmente questo.
Le due diverse funzioni sono comunque collegate: l’idea di Dio è un prodotto del mito, che trova nelle immagini un supporto cruciale. Un’immagine di Dio è comunque il fulcro ideale di una galassia di racconti.
La nascita della scrittura trasforma progressivamente le cose. In Palestina la scrittura si concretizza in un libro, anzi nel Libro. In questo Libro (biblium, Bibbia) trova spazio una forma di pensiero astratto che non era concepibile prima della scrittura, e Dio può diventare qualcosa che si può esprimere attraverso una parola, perché ormai anche le parole sono diventate persistenti come le immagini. Esprimere attraverso una parola, sì, ma senza esagerare; perché siccome le parole, specie se scritte, ci permettono di controllare il mondo, se conoscessimo il vero nome di Dio potremmo magari controllare pure lui. E quindi a Dio, nella tradizione ebraica, ci si può riferire solo per appellativi.
Nessuna parola unicamente orale potrebbe godere di un tale privilegio, perché le parole unicamente orali fluiscono e si perdono in un momento. Ma se possono essere trascritte, diventando a loro volta immagine, ecco che restano per sempre, come i bisonti delle grotte del Paleolitico.
La nascita della scrittura porta la Grecia da Omero a Platone, dal mito alla filosofia, dagli dei come protagonisti di grandi narrazioni all’invenzione dell’anima, al regno delle idee, all’idea del mondo come una caverna dove percepiamo solo le ombre del mondo vero che gli sta fuori; sino ad arrivare all’aristotelico Primo Motore Immobile. Con la scrittura, la divinità può diventare una questione filosofica, astratta: Dio non è più un’immagine, è l’essere; e l’essere, in quanto tale, non si può certo vedere.
Non ci si può quindi stupire se le religioni del libro hanno perseguitato le immagini. La lotta iconoclasta che dilania l’Impero Romano d’Oriente tra il settimo e il nono secolo potrebbe essere interpretata come una lotta tra la scrittura e l’immagine, tra una concezione astratta e filosofica della divinità e una concreta e figurale. La tensione a Costantinopoli scoppia come risposta alle accuse di idolatria mosse dagli arabi, neoconvertiti all’Islam e in potente espansione, ma si basa su secoli di discussione precedente. La posizione, netta, dell’Islam rimette in gioco quella incerta dei Cristiani.
Il Concilio di Nicea, nel 787, condanna l’iconoclastia, ma ne recepisce le ragioni, affermando che le immagini possono essere venerate come simbolo della divinità, ma non adorate in quanto non sono né rappresentano la divinità stessa. In Oriente, dunque, si potranno continuare a realizzare immagini sacre, ma con una serie di limitazioni che ne impedisca un’eccessiva seduttività; e così, l’arte visiva bizantina, o quel poco che ne resta, si condannerà a secoli di monotone icone.[ii]
L’Occidente, per nostra fortuna, aveva problemi ben più gravi a cui pensare, e l’iconoclastia rimase un problema astratto e lontano. La ritroveremo in epoca di Riforma, quando il Libro farà la sua grande rientrata.
Il Medioevo nostrano è perciò pieno di immagini sacre, di immagini narrative e di immagini che sono un po’ l’uno e un po’ l’altro. A volte, nelle cupole decorate per sezioni, si trova al centro la figura di Dio, o dello Spirito Santo, una, immobile ed eterna; immediatamente intorno, al livello appena più basso, ci sono le figure dei beati e dei santi, molteplici ma anche loro immobili; più sotto ancora, occupando uno spazio più ampio e più periferico, ci sono le vicende del mondo umano, piene di movimento e di racconto.
Sappiamo che i cicli affrescati delle chiese del Medioevo erano fatti per essere accompagnati dalle parole di un predicatore, il quale, come i narratori di Altamira, raccontava le storie di Cristo o dei santi indicando l’immagine al momento pertinente. A volte, come nel caso degli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, realizzati da Giotto ai primi del Trecento, lo spettatore ritrovava sulle pareti le stesse scene che aveva appena visto dal vivo sulla pubblica piazza, in forma di Sacra Rappresentazione, ovvero di teatro. La pittura era insomma sostanzialmente la parte dell’immagine di una complessiva narrazione per immagini, in cui la componente narrativa rimaneva di solito orale – anche considerando la scarsa alfabetizzazione della popolazione.[iii]
Resta però il fatto che i pittori del Medioevo non hanno particolari remore a mescolare immagine e parole, e inseriscono con disinvoltura cartigli e filatteri tra le figure, creando comunicazioni sostanzialmente sinsemiche; qui, a dominanza di immagine, mentre magari in quelle contenute nei libri vi sono più facilmente dominanti le parole.
Certo, Giotto era tecnicamente molto molto più avanzato dei suoi colleghi di ventimila anni prima, e, soprattutto, la familiarità con la scrittura e le sue organizzazioni del racconto in libri, capitoli, episodi ecc. aveva reso del tutto naturale l’idea di organizzare lo spazio stesso della parete in maniera analoga, creando cornici che permettessero di distinguere un episodio dall’altro, e magari pure di riconoscere l’episodio stesso, una volta che ci fosse stato già raccontato. La sequenza degli episodi visivi riprende e riproduce la sequenza della scrittura. Pur continuando a essere supporto della parola, l’immagine diventa a sua volta almeno un poco parola; magari non dentro ciascun singolo riquadro, ma certamente nel rapporto temporale tra un riquadro e il successivo.
5. Gli aedi
Abbiamo parlato di immagine e di scrittura, ovvero fondamentalmente delle componenti visive di quello che nella grotta di Altamira già incominciava ad accadere. Tuttavia, come abbiamo detto, la fascinazione fondamentale per chi stava nella caverna non dipendeva da questo.
Facciamo dunque un salto avanti di molte migliaia di anni, e arriviamo alle soglie della nostra era, cioè a Omero, oltre 10.000 anni dopo la frana che occultò la caverna, e appena 3.000 prima di noi. Omero era un aedo, ovvero un cantore orale, in un’epoca in cui non esisteva la scrittura, non diverso da cantori orali che ancora esistono o sono esistiti sino a poche decine di anni fa, in Africa, nei Balcani, in India… Come tutti gli aedi, Omero improvvisava versi raccontando e riraccontando le stesse storie di eroi, quelle in seguito trascritte sotto i titoli di Iliade e di Odissea. Sempre che sia esistito, doveva essere molto bravo, il più bravo di tutti; al punto che gli aedi venuti dopo di lui hanno cercato di riprodurre al meglio quello che lui aveva fatto, e quelli venuti ancora dopo hanno sentito il bisogno di mettere al sicuro le sue parole così com’erano, adottando i segni fenici. È così che gli aedi, improvvisatori orali, si sono trasformati col tempo in rapsodi, abili vocalizzatori di testi comunque scritti.[iv]
Improvvisare in versi richiede una notevole competenza e abilità, ma non così straordinarie come si potrebbe credere oggi. Da un lato, la forma metrica fa da supporto alla memoria (come per le parole di una canzone che abbiamo ascoltato un paio di volte); dall’altro ci sono ricorrenze lessicali, sintattiche, narrative, che a loro volta aiutano. L’esperienza degli antropologi con gli aedi moderni mostra che i versi cambiano volta per volta, pur mantenendo caratteristiche simili; mentre ciò che si racconta è relativamente costante, pur subendo a sua volta modifiche e introduzioni tematiche.
In ogni caso, nelle saghe raccontate da Omero e dagli altri aedi della Grecia arcaica i personaggi e le situazioni ricorrevano, si ripetevano, si incontravano, interagivano. Era in atto, insomma, qualcosa di simile a quella che oggi chiameremmo serialità.
Chiameremo serialità primaria questa condizione narrativa in cui, oralmente e ricorrentemente, ma senza alcuna scansione preordinata, si costruivano o reinventavano storie basate sui medesimi personaggi, sui medesimi luoghi e le medesime situazioni. Si trattava, ovviamente, di molti personaggi, qualcuno più centrale qualcuno meno, di molti luoghi e di molte situazioni; ma era comunque un numero chiuso, e dotato di relazioni interne.
Se conoscete almeno un poco la mitologia greca, capirete che cosa intendo. Si comincia con la Teogonia, che racconta l’origine degli dei, e si finisce in un’area che, per noi, è praticamente Storia, con i Trecento delle Termopili, attraverso tutte le interallacciate vicende degli eroi, delle quali il ciclo omerico rappresenta un’importante ma piccola parte.
Che cosa distingue la serialità primaria da quella vera e propria, moderna? Direi, sostanzialmente, una serie di aspetti, comunque legati alla periodicità regolare di pubblicazione. I cantori orali, ovviamente, non pubblicavano; e non possiamo assimilare alla pubblicazione le loro esibizioni pubbliche, che avvenivano a intervalli irregolari di fronte a pubblici differenti. In assenza di scrittura non c’è garanzia sufficiente di omogeneità delle trasmissioni al pubblico, e in assenza di un apparato di distribuzione non c’è fidelizzazione dell’utente al racconto, e a una sua eventuale continuità. Di fatto, non esiste serialità moderna prima dell’invenzione della stampa.
Qualcosa di appena più simile alla serialità moderna si verifica qualche secolo dopo Omero, quando i drammaturghi riprendono il mito per creare, sulla scena del teatro, qualcosa di corrispondente alle gesta degli aedi. La differenza cruciale è che mentre gli aedi improvvisavano, gli attori recitavano un copione scritto; tuttavia, in un modo come nell’altro, quelle che al pubblico venivano raccontate erano sempre le stesse storie di dei ed eroi. Si tratta però di una differenza marginale rispetto a quello che separa la serialità antica da quella moderna: di fatto, il pubblico sapeva bene che si trattava, ogni volta, di un modo diverso per raccontare una storia esistente, e già nota ai più. Nella serialità primaria, insomma, i racconti di base non erano inventati: sostanzialmente, erano sempre quelli, e quelli dovevano essere. Al massimo potevano essere variati – e certo poteva accadere che le variazioni si stabilizzassero e che, così, variazione per variazione, i miti nel tempo si arricchissero e trasformassero.
Quello che avvicina maggiormente, invece, la serialità primaria dei drammaturghi alla serialità moderna è il fatto che i drammi venissero tradizionalmente organizzati in trilogie, nelle quali ciascuno degli elementi era dotato di una propria chiusura narrativa, salvo essere riaperto dall’episodio successivo, secondo un modello abbastanza tipico della serialità moderna. Per esempio, la tragedia Agamennone, di Eschilo (458 a.C.), racconta di come il comandante dell’esercito greco, di ritorno da Troia a Micene, venga assassinato dal cugino Egisto, con la complicità della moglie Clitemnestra. Nel secondo episodio della trilogia, Le coefore, il figlio di Agamennone e Clitemnestra, Oreste, torna a Micene per vendicare il padre, uccidendo la madre e lo zio. Nel terzo episodio, Le Eumenidi, Oreste viene perseguitato dalle Erinni, divinità del rimorso, sino a trovare soluzione in una purificazione rituale. Si racconta una storia ben nota al pubblico, certo, ma in tre episodi separati e parzialmente autonomi, da mettere in scena a breve distanza di tempo. Siamo in un contesto sociale e di consumo ben più strutturato di quello di mezzo millennio prima, e la presentazione al pubblico di un dramma di nuova scrittura ha in effetti caratteristiche di pubblicazione.
Per il momento, comunque, e per i duemila anni successivi, non si andrà molto più in là di così. Teniamo comunque presente che definire serialità primaria quella situazione è semplicemente funzionale a mostrare le somiglianze con la serialità moderna. Non bisogna però dimenticare che la nostra percezione della serialità è fortemente basata sulla contrapposizione a quello che seriale non è, come il romanzo, oggetto narrativamente unitario e autoconclusivo, dove si racconta tipicamente una vicenda del tutto autonoma. Niente di simile esisteva nell’antichità, dove le storie che si raccontavano avevano comunque radici in altre storie, e, di conseguenza, l’idea di narratività prevalente non era, come per noi, quella di un arco autonomo, dotato di un proprio attacco e di una propria conclusione; era piuttosto quella di un flusso complessivo, o, se preferiamo, una serie di flussi, da cui estrarre al momento del bisogno un eventuale arco narrativo dotato, per l’occasione, di attacco e conclusione, ma del quale erano comunque ben noti al pubblico i precedenti e le conseguenze. In parole molto povere e contemporanee, ogni singola storia dell’antichità era il sequel di qualche altra storia e il prequel di altre ancora.
Al di là degli specifici racconti del mito greco, che il Medioevo in gran parte dimenticherà, quello che permane ne è invece la struttura, il modello di narratività che abbiamo appena descritto. Se prendiamo il ciclo medievale di re Artù, vi ritroveremo il medesimo andamento a saga, il medesimo intrecciare e proseguire racconti parzialmente autonomi, dove i medesimi personaggi ricorrono con ruoli narrativi diversi. Quando noi pensiamo a Tristano, per esempio, lo associamo inevitabilmente alla sua storia d’amore con Isotta, al tradimento di re Marco, e alla sua nobile morte. Ma si tratta di un effetto del tutto moderno, probabilmente in larga parte dovuto alla grande e meritata fama del melodramma di Wagner. Se leggiamo i romanzi cavallereschi medievali, Tristano è protagonista o personaggio collaterale di innumerevoli gesta, e anche la storia d’amore con Isotta è molto più lunga, complicata, e costellata di altri eventi, di quanto non appaia nelle riduzioni moderne, Wagner primo tra tutti. Evidentemente, le esigenze narrative del pubblico del Medioevo sono differenti da quelle del pubblico moderno.
Ancora in pieno Rinascimento questo modello mantiene larga diffusione. I poemi cavallereschi rinascimentali (Pulci, Boiardo, Ariosto, e persino Tasso) sono reticoli di storie degni delle attuali soap operas. Al di là delle differenze di qualità (che evidentemente ci sono – e l’Orlando furioso non è meglio di Sentieri solo perché santificato dalla Storia) e di medium, l’articolazione complessiva delle singole vicende ha tanti tratti in comune ed è comunque discendente dal modello greco mitologico. Non a caso una narrazione del genere è fatta per durare all’infinito, perché non ci può essere una conclusione sensata a un flusso narrativo polifonico. Ariosto se la cava (perché deve pur mettere la parola fine) approfittando della morte di un cattivo, Rodomonte; ma qualcun altro poteva ben riprendere da dove lui aveva smesso, come pure lui stesso aveva fatto con l’Orlando innamorato del Boiardo.
Quello che un po’ distingue i poemi cavallereschi rinascimentali dalle saghe precedenti, avvicinandoli ulteriormente alle soap, è il fatto di limitarsi ad essere semplicemente ispirati alle mitologie cavalleresche, mentre si raccontano di fatto storie nuove, d’invenzione dell’autore. È una cosa che si fa già da un po’, magari con la precauzione – come nel nostro caso – di rifarsi comunque a una tradizione esistente: forse le storie di Orlando e degli altri paladini raccontate da Boiardo e da Ariosto non le aveva mai raccontate nessuno, ed erano quindi nuove, frutto di invenzione, ma rientrano nel modello narrativo cavalleresco, e potevano quindi anche essere tradizionali, e semplicemente riscoperte e riraccontate.
Benché Ariosto si muova in un contesto di scrittura assestato da millenni, le forme narrative dell’oralità continuano ad aleggiare in quello che scrive. D’altra parte, Ariosto scrive in poesia, e la poesia è quel genere letterario che meno ha tagliato i ponti con la vocalità. Vocalità e oralità non sono la stessa cosa ma, soprattutto in epoche di scarsa alfabetizzazione, conservano ampie aree di sovrapposizione.
_____________
[i] Poiché gran parte dell’argomentazione di questo libro è di carattere storico, è inevitabile e doverosa una quantità di riferimenti alle fonti. Per evitare di appesantire troppo la lettura, ho però cercato di ridurre il numero delle note, accorpando, quando possibile, diversi riferimenti vicini in un’unica nota. Ho evitato di introdurre riferimenti per i dati storici di facile verifica, in quanto assestati e sufficientemente noti. Le opere elencate in bibliografia sono indicate nel testo e nelle note con il nome dell’autore, l’anno ed eventualmente le pagine; l’anno è sempre quello della pubblicazione in lingua originale; le pagine fanno invece riferimento alla traduzione italiana indicata.
[ii] Sul Concilio di Nicea e sulle conseguenze delle sue decisioni per le culture europee, vedi, per esempio, Tagliaferri (2006).
[iii] Il libro fondamentale su questo tema è Bolzoni (2002).
[iv] Su questi temi, vedi Svenbro (1988 e 1995), Havelock (1986) e Detienne (1967). Sugli aedi moderni, vedi Goody (1986) o il grande classico Ong (1982).
*
Daniele Barbieri, Letteratura a fumetti? Le impreviste avventure del racconto, Roma, ComicOut 2019
Bibliografia e immagini sono liberamente disponibili sul Web all’indirizzo http://letteraturaafumetti.blogspot.com/
 di Andrea Inglese
di Andrea Inglese







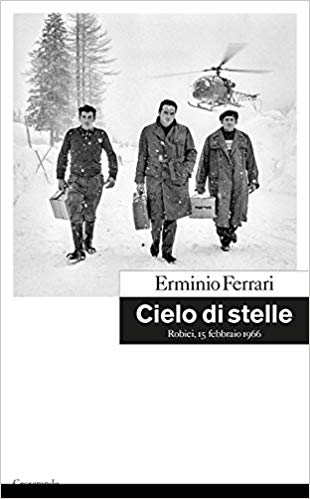

 La sala prove era alla fine di una strada bianca, in un casolare, fra i canneti che, come la casina di Yoda, emergeva dalla mota millenaria di quelle terre, aggrappato all’argine del canale in mezzo ai campi, dove la figlia zoppa e suo padre, il Martini, camminano eternamente scontrosi. Vanno da Cioni Mario, l’unico marito possibile per questa figlia sciancata; – …tanto son di famiglia moritura – le dice il padre, così che quando il povero Cioni ci rimarrà secco fiammifero durante l’amplesso, potranno riunire i poderi e andare in culo al mondo. Ma lei non ne vuol sapere. Mario è brutto. Il Martini la minaccia: – O chi vòi? Marlon Brando? …Sta’ zitta! Ti do uno schiaffo ti spoglio.
La sala prove era alla fine di una strada bianca, in un casolare, fra i canneti che, come la casina di Yoda, emergeva dalla mota millenaria di quelle terre, aggrappato all’argine del canale in mezzo ai campi, dove la figlia zoppa e suo padre, il Martini, camminano eternamente scontrosi. Vanno da Cioni Mario, l’unico marito possibile per questa figlia sciancata; – …tanto son di famiglia moritura – le dice il padre, così che quando il povero Cioni ci rimarrà secco fiammifero durante l’amplesso, potranno riunire i poderi e andare in culo al mondo. Ma lei non ne vuol sapere. Mario è brutto. Il Martini la minaccia: – O chi vòi? Marlon Brando? …Sta’ zitta! Ti do uno schiaffo ti spoglio.