di Margherita Marras
(Introduzione al volume Femminismi: teoria, critica e letteratura nell’Italia degli anni 2000, “Narrativa”, n. 37/2015)
Da cosa nasce l’esigenza di questo volume? Perché i Femminismi?
Si potrebbe partire dalla riattualizzazione su parafrasi di una celebre canzone del femminismo militante degli anni 70: “Noi siamo stufe”. In questo caso, però, non si tratta di rimettere in discussione la dominazione maschile nel quotidiano delle casalinghe, ma piuttosto di rivoltarsi al significato, al senso e all’uso mortificato (e corrente) attribuito al femminismo; innanzitutto, dai molti (troppi) dei non addetti ai lavori: circoscritto temporalmente a un periodo cominciato e conclusosi negli anni ’70, il femminismo è da costoro generalmente dipinto con dei tratti che, scolpiti in una (a)memoria storica deformata, rimandano alle forme sminuenti e grottesche di un’espressione gridata (se non isterica) e di opposizione virulenta al “maschio”, tendenzialmente androfobica o misandrica che dir si voglia.
Non meno fastidioso è l’appiattimento essenzialistico e distorto del femminismo: scarnificato, ridotto ai minimi termini e giocato a suon di slogan da tuttologi opinionisti nei vari talk show, da presentatrici “specialiste” della comunicazione televisiva con milioni di spettatori al seguito (si veda Barbara D’Urso) che liquidano la loro “militanza” in battute da bettola e, finanche, da cantanti e autori[1] di testi in cui la “specificità femminile” si perde nei meandri della facile e non problematizzata questione/equazione donna uguale donna. Una specificità Donna, dunque, conclamata con assurda fatuità e giustificata sulla base di una “natura” femminile di biologica ascendenza che, oltre a spazzare con frivolezza il salutare concetto della diversità tra donne, viene continuamente misurata su una contrapposizione stereotipica all’uomo: Donna dispensatrice di pace contro l’uomo guerriero, sensibilità femminile contro arroganza maschile, romanticismo contro nichilismo, sentimentalismo contro sessualità, educazione contro trivialità, ecc. E queste sono solo alcune delle tante facilonerie costernanti che alimentano i “pensieri” pseudo-femministi, creando disagio e disappunto presso tutti coloro i quali portano con sé la coscienza e la memoria della combattuta e contrastata storie delle donne e conoscono il prezioso apporto politico e culturale del femminismo. La constatazione prima che ne deriva è la leggerezza imperdonabile di chi, proclamandosi femminista senza conoscerne minimamente contorni e sfumature, dimostra di ignorare il fondamento stesso del femminismo: la complessità!
Il femminismo non è un fenomeno confinabile in semplicistici schemi, come dimostrato dal suo andamento carsico, dalla pluralità delle sue manifestazioni e forme, dalla sua capacità di attraversare e muovere nuovi saperi da un territorio all’altro e di situarsi e di confrontarsi con specifici contesti culturali e geografici. Il femminismo è un fenomeno all’interno del quale ci si muove (anche da esperti conoscitori) sempre con una certa cautela: per il funambolismo che sottende la sua vocazione a una differenza affermata e la sua volontà di distruggere le barriere; per le rivendicazioni avanzate di una diversità che si vuole precisa nelle sue connotazioni ma fluida se ricondotta alle sue multiple versioni; per la sua configurazione impura dovuta all’infinità dei pensieri e delle teorie nei quali si è espresso e si esprime (da cui il sempre più corrente uso plurale di “femminismi”), implacabilmente e forzatamente sottomessi alla variabilità e all’effimero temporale.
Il femminismo ha dunque fallito? Sì, se ci dovesse limitare alle facilonerie sopra menzionate e se si estendesse la nostra riflessione, rincarando la dose, a quella porzione di campo letterario/editoriale in cui a vincere sono gli stereotipi di genere – spesso ricuciti sulle basi del più becero fallogocentrismo –, trasformati in improbabili marcatori identitari e tesi ad affermare un “femminesco” essenzialismo (che niente ha a che fare con lo storico femminismo della differenza), chiamato a codificare un genere letterario minore – “femminile” per l’appunto – dispensatore di rosee vedute, di sciacquatissimi intrecci sentimentali e di amori controversi per “anime semplici” (si veda in questo volume l’intervista a Maria Rosa Cutrufelli). Difatti, a fronte di case editrici capaci di considerazioni lucide, obiettive e non sessualmente discriminanti, è copiosa la schiera di editori per i quali la promozione di questa edulcorata idea di “femminile” è del tutto speculare a una sua spendibilità sul mercato, giacché perfettamente corrispondente ad attese e bisogni di una fetta di pubblico ammansito e tautologicamente abituato a nutrirsi delle sue aspettative comode e rassicuranti. Purtroppo, declinare la grammatica dei ruoli allo sminuente ritmo della negoziazione commerciale significa orientare e disciplinare le scelte testuali, di ricezione e promozionali su un’identità di genere imbalsamata in anacronistici stereotipi che, all’origine di pericolose asimmetrie, scadono immancabilmente nell’assoluto discriminante, danneggiando le donne, alcune delle quali, peraltro, non sono sempre candide e innocenti in questa speculazione (si vedano le interviste ad Antonio Moresco e a Maria Rosa Cutrufelli).
Inutile negarlo: ci troviamo oggi nel pieno di una re-mistificazione del concetto Donna, circoscritto in un fortino anche se di sabbia, che per superficialità si iscrive nella chiave anti-femminista più radicale e, cioè, in un sistema stereotipato che supporta e alimenta non solo la marginalizzazione ma anche l’inconsistenza delle donne, la cui natura, costruita su una differenza biologica dozzinale, ritrova il peggio di quel senso universalizzante e universale della tradizione occidentale che molti femminismi, soprattutto dopo gli anni ’70, hanno tentato di demistificare e combattere.
Benché tutto ciò mostri chiaramente l’effetto “muro di gomma” del femminismo in Italia, sarebbe quanto mai ingiusto parlare di un suo fallimento. La sua poca penetrabilità e la conoscenza distorta di cui è oggetto si potrebbero invece ricondurre all’arroccamento di molte delle sue esponenti storiche nei circoli e luoghi ristretti delle loro formulazioni teoriche (prevalentemente fruibili a un pubblico di nicchia), ma soprattutto alla sua banalizzazione mediatica, alla poca sensibilizzazione sulle questioni di genere nelle scuole, alla scarsissima rilevanza e diffusione nell’istituzione accademica italiana di Women’s e Gender Studies[2] dalla quale dipende, d’altra parte, il ritardo degli studi accademici in materia di femminismo, e tanto altro. Da qui l’urgenza e l’esigenza di questo volume.
Tuttavia, malgrado ritardi e semplificazioni, sono comunque percettibili in Italia, negli ultimi anni, una pratica e una teorizzazione femminista sempre più feconde e di alta qualità, come confermato tanto dagli studi a opera di intellettuali e accademiche consolidate – sociologhe, linguiste, filosofe –, disciplinarmente sensibilizzate all’urgenza di rivedere i riposizionamenti nelle relazioni di genere alla luce dei nuovi schemi culturali e sociali profilatisi all’interno dello spazio femminile, quanto dalle pubblicazioni di giovani studiose formatesi in luoghi storicamente più consoni e inclini agli studi di genere e, quindi, alla costruzione di identità mobili, intersezionali, transessuali, queer, ecc.
Ed è proprio a questo femminismo, criticamente più attento alle nuove configurazioni della realtà e della società italiane, che abbiamo voluto guardare facendo appello ad alcune delle sue rappresentanti, consolidate e nuove.
A coloro i quali conoscono la rivista Narrativa, e dunque la sua vocazione prioritariamente letteraria, parrà strano ravvisare in questo volume lo sbilanciamento percentuale tra i testi di matrice sociologica, quantitativamente superiori, e gli studi di critica letteraria. Esistono delle precise motivazioni e altrettante risposte a questa evidenza. In primis, la vistosa carenza (praticamente assenza) in Italia, di studi critici o problematizzazioni letterarie che, in congiunzione con i pensieri femministi, abbiano abbracciato l’insieme della produzione delle donne. La seconda ragione, a essa strettamente legata, è la nostra profonda consapevolezza che i saggi e contributi di natura sociologica, filosofica ecc. offrono, in prospettiva interdisciplinare e comparata, spunti analitici indispensabili per comprendere la complessità della produzione letteraria delle donne e per suggerire l’adozione di possibili posizionamenti e prospettive critiche: da dove partire, come e cosa cercare. Ma esistono anche altre ragioni che saranno sviluppate nel corso di questo percorso introduttivo.
L’apertura del nostro volume è affidata a due studi, quello di Karine Bergès e quello di Alessandra Montalbano, che ci proiettano nelle peculiarità e conflittualità dei femminismi della terza ondata, rispettivamente in Francia e in Italia. Abbiamo voluto iniziare con la Francia per ragioni di prossimità socio-culturale e per i legami storici di stampo femminista con il nostro paese (la pregnanza teorica del femminismo della differenza in Italia, ancora ai nostri giorni, ne è esempio tangibile). In ambedue i testi, a emergere sono le ramificazioni multiple del femminismo, la sua eterogeneità e la sua plurivocalità, che mostrano chiaramente quanto esso sia poco incline all’immutabilità e refrattario a eterne categorizzazioni. Le due studiose pongono le basi per una riflessione che, se volessimo estendere in ambito critico-letterario, aiuterebbe sicuramente a una migliore valutazione delle articolazioni varie e possibili tra femminismi e creatività.
E di queste congiunzioni parla nel suo articolo Giovanna Zapperi riferendosi alla ripresa sperimentale dei testi di Carla Lonzi, icona del femminismo italiano degli anni ’70, effettuata da alcune giovani artiste. Zapperi rileva quanto il riadattamento di questi testi abbia consentito un’interessante attualizzazione dialogica con le pratiche del femminismo del terzo millennio e sottolinea la suggestiva proposta di cui è portatore: l’intreccio possibile tra arte, femminismo, creatività, linguaggio, soggettività.
Nonostante la persistenza di un’etica minimale comune rispetto al femminismo del passato, sono evidenti, come già precisato, i suoi adattamenti e le aperture alle nuove sfide che si sono imposte e si impongono in termini di mutazioni politiche, sociali e culturali. Infatti, molte delle particolarità dei femminismi della terza ondata riposano sulla complessità di fenomeni soggiacenti alla compressione-spazio temporale e all’intrecciarsi di reti e relazioni transnazionali specifici all’epoca globale, tra i cui effetti diretti si può menzionare il moltiplicarsi delle letture di problematiche contestuali su base trasversale e trans-storica. Così emerge dallo studio di Patrizia Violi che problematizza il fenomeno del femminicidio contestando l’interpretazione patriarcale – che lo riconduce a singole, diffuse e parcellizzate storie individuali – e indagandolo nella sua dimensione politica e transnazionale. Violi ci offre, in tal modo, una lettura geograficamente e culturalmente globale del femminicidio presentato come una sorta di costante universale, un filo rosso che ha le sue radici proprio nel patriarcato e, più precisamente, nel dominio del maschile sul femminile, individuando la misoginia come causa scatenante, trasversale e trans-storica, di queste uccisioni di donne perché donne.
L’infittirsi di reti e di relazione transnazionali propri alla globalizzazione è altresì dovuto al moltiplicarsi delle migrazioni dai Sud al Nord del mondo, che è all’origine, oramai da tempo, dell’arrivo massiccio anche in Italia di cittadini stranieri. La riflessione critica di Franca Balsamo porta alla luce i punti di forza e i punti nevralgici dell’incontro tra femminismi e donne “migranti”. A fronte dei risultati di integrazione e di collaborazione tra donne ottenuti dal femminismo attivista, politicizzato, associazionista e dall’apporto delle nuove generazioni di femministe militanti formatesi nelle università europee a sensibilità neo-femminista, la studiosa fa osservare che continuano a permanere per le “migranti” dei problemi di auto-rappresentazione ma anche di rappresentazione, visto che, nei luoghi preposti alle riflessioni teoriche e politiche dei femminismi italiani, esse sono ancora paradossalmente costruite come “‘straniere o immigrate’, anche quando siano nate in Italia e magari sono già cittadine italiane”.
Questa difficoltà italiana di rappresentatività sottolineata da Franca Balsamo, ci aiuta a comprendere le rigidità che sottendono, in ambito letterario, l’eccessiva categorizzazione critica delle scritture definite “migranti” che è oggetto, da tempo, di una rimessa in discussione proprio per l’evidente ambiguità di attribuzione indiscriminata dello statuto “migrante” a scrittori e scrittrici, spesso cittadini/e italiani/e o nativi/e di seconda generazione e/o culturalmente a cavallo di più culture. Tale questione si complica ancora di più se analizzata dal punto di vista delle autrici che, oltre a condividere con i loro corrispettivi di sesso maschile l’assimilazione a una data zona letteraria determinata da vincoli geografici e/o di anagrafe (o di presunta “non italianità”), devono fare i conti con altri accorpamenti legati, questa volta, a ragioni di identità biologica. La distinzione tra autrici italiane e italofone, spesso praticata, spinge di fatto verso la loro catalogazione nello spazio di un’identità al femminile fissa e gerarchicamente asimmetrica (rispetto alle scrittrici “italiane”) e, quindi, a un loro imprigionamento in un limbo letterario, una sorta di paradossale enclave dell’indistinto – perché si rischia di semplificare l’importanza delle diverse provenienze e esperienze, il talento e lo stile di ognuna di loro –, e del distinto – perché viene frequentemente applicata nei loro testi una compulsiva ricerca di elementi classificatori che possa giustificare l’esistenza di un marchio, di uno stile comune e quindi di un genere associabile alla doppia etichetta “migrante/femminile”. In tale procedere, ad apparire evidente è la mancanza di un’appropriata conoscenza delle dinamiche di variazione del genere e della soggettività femminile ripensata alla luce della complessità, della molteplicità, della contraddittorietà, della fluidità (si vedano Donna Haraway, Monique Wittig, Rosi Braidotti, Teresa de Lauretis, Susan Stanford Friedman, ecc.) che potrebbe indubitabilmente offrire un utile e giusto supporto d’analisi.
Con Krizia Nardini entriamo, invece, nel pieno di un dibattito che, soprattutto in questi ultimi anni, apre nuovi varchi all’interpretazione del femminile e del maschile. A ragion veduta, la studiosa sottolinea che gli uomini – benché analizzati sotto differenti angolazioni, criticati o ignorati – sono sempre stati indissociabili da tutte le teorizzazioni e le riflessioni critiche dei femminismi. Allontanandosi dai pericoli di essenzialismi al maschile, Nardini precisa che, nonostante l’indubbio avvicinamento degli uomini a problematiche femminili e femministe, esistono ancora delle difficoltà di dialogo rilevabili, in particolar modo, presso coloro i quali rispondono o si avvicinano maggiormente ai modelli normativi di maschilità, dominanti nelle società fondate sul sex/gender system eteronormatico di struttura patriarcale: biomaschio etero, bianco, occidentale e borghese.
E sulla non semplice questione relativa a “femminismo e uomini” ritorneremo per argomentare le nostre intenzionalità progettuali e le attese originarie – profondamente e pragmaticamente tradite – riposte in questo volume, concepito agli inizi sulla base di tre sezioni di cui la seconda avrebbe dovuto comportare una serie di studi incentrati su una lettura della produzione e della creazione letteraria delle donne.
Intenzionalità progettuali e attese originarie che avrebbero dovuto rispondere a due esigenze in particolare: da un lato, volevamo produrre dei materiali critici che, temporalmente, inglobassero la prima ondata femminista e si estendessero fino all’epoca iper-contemporanea e che, spazialmente, fossero circoscritti all’Italia giacché, come si è detto, mancano critici e teorici della letteratura che abbiano unito i femminismi a un’analisi dell’insieme della produzione letteraria italiana delle donne, e questo malgrado si sia registrata in questi ultimi tempi l’apparizione di monografie e di encomiabili studi prodotti dalla Società Italiane delle Letterate, e malgrado il proliferare di antologie e di collane di studi femministi; dall’altro lato, nutrivamo l’ambizione di poter apportare nuove riflessioni critiche che coniugassero i femminismi e la letteratura delle donne, naturalmente nella piena consapevolezza dei rischi che una tale impresa sottende.
Chiunque si interessi di letteratura sa bene che a ogni nozione di genere corrisponde una ricorrenza misurata sull’esperienza letteraria da cui, sovente, emerge la difficoltà di una sua schematizzazione e di una sua codificazione normativa. A giusto titolo, Alastair Fowler[3] attribuisce al genere le costanti della mobilità e della trasformazione e precisa l’impossibilità di racchiuderne l’identità tra un’origine e un punto di arrivo. Il risultato non cambierebbe se si cercasse di utilizzare come essenza normativa, in letteratura, l’appartenenza di genere. La stessa Virginia Woolf, quando in Una stanza tutta per sé (1929) affermava l’esistenza di una scrittura femminile sollecitando le donne a impegnarsi per una sua definizione, era ben conscia dei pericoli insiti nelle spiegazioni e attribuzioni di senso risolutive.
Non abbiamo, dunque, mai avuto la pretesa di “canonizzare” stili e modi di scrittura “propri” alle donne, né di proporre un “genere (letterario) del genere”, dato che è sempre stata forte in noi la convinzione dell’impossibilità, nonché inutilità, di definire una “letteratura femminile” in opposizione a presunte modalità di “scrittura maschili”, ben consce dei rischi di caduta secca nell’indistinto universalizzante e/o dell’attivazione di nuovi luoghi comuni. Nelle nostre intenzioni iniziali si intendeva piuttosto interrogare i testi sul vasto crinale delle relazioni di genere con l’obiettivo di individuare pratiche di scritture antagoniste o convergenti rispetto a modelli egemonici patriarcali, con uno sguardo possibilmente diacronico che permettesse di tracciare evoluzioni e cambiamenti; ed anche di valutare l’incontro/scontro tra pensieri, scritture e pratiche narrative/artistiche delle donne e le teorie femministe, nonché di sottolineare i rapporti possibili tra genere e creatività artistica anche alla luce delle preziose acquisizioni delle revisioni postulate dal gynocritism o dai nuovi femminismi interculturali.
Insomma, volevamo cogliere nell’esperienza letteraria e nella critica aspetti e sfumature del genere, facendolo valere euristicamente, senza snaturare la variazione insita e intrinseca alla sua dinamica evolutiva, come criterio possibile di leggibilità della letteratura delle donne.
Ma l’ambizione più coraggiosa è stata sicuramente, come già accennato, quella di aver voluto affidare questa seconda sezione quasi esclusivamente a mani maschili. Non sarebbero mancate donne di esperienza, competenti in materia e capaci di affrontare questi discorsi, ma per una serie di ragioni abbiamo voluto puntare soprattutto sui critici uomini. Intanto perché molti colleghi hanno prodotto studi letterari di grande interesse su autrici o personaggi femminili (eroine, madri, figlie ecc.), mentre negli studi relativi ai femminismi la loro è una (quasi) totale assenza. Con Silvia Contarini ci chiedevamo, da tempo, se dietro quest’assenza si celasse un’esclusione dovuta a retaggi culturali o, seppure, si trattasse di una volontaria auto-esclusione. Coinvolgere i colleghi uomini è stata quindi una sfida, con sottesa però l’ingenua certezza che l’avremmo vinta: ai nostri occhi appariva paradossale che i femminismi potessero (ancora) scoraggiare gli otto colleghi sollecitati a partecipare al volume. Tanto più che la scelta dei critici in questione è stata mirata e cioè rivolta a studiosi di letteratura italiana contemporanea di grandi capacità, muniti di strumenti teorici e di conoscenze critiche spesso, fatto da non sottovalutare, “imparentati” con i femminismi: specialisti di postcoloniale, di postmodernità, esperti conoscitori delle critiche post-strutturaliste e decostruzioniste o di letteratura della migrazione. Con grande candore, già immaginavamo il loro fruttuoso apporto epistemologico di revisione ispirato al New Historicism o applicato a quell’abietto “orientalismo” che è stato presente anche in casa nostra, evincibile non nella forma imperialista (o non solo) denunciata dalla critica saidiana, ma negli assiomi di un sistema letterario – organizzato, per lungo tempo, sulla base della più classica delle dicotomie: centro (i maschi) e margini (le donne) – in cui tanto indecorosi quanto numerosi sono stati gli ostracismi e gli sbarramenti all’accesso alla scrittura subiti e posti alle donne, dei cui destini sono state costanti ricorrenti l’inespugnabilità dei territori di produzione culturale e la derubricazione del femminile, evidente nella moltitudine di rappresentazioni stereotipate e di formule generalizzanti, quando non disumanizzanti (tra mostro e madonna, diceva Woolf a proposito dell’immagine deformata della donna data dall’uomo).
Ci sarebbe piaciuto conoscere il punto di vista dei colleghi più vicini al post-strutturalismo riguardo alla controversa questione dell’identità autoriale che ha opposto i teorici fautori della morte/rimozione/neutralità dell’autore (“Cosa importa chi parla?” diceva Michel Foucault) e le femministe dei saperi situati e della politica del posizionamento (Adrienne Rich, Donna Haraway, Susan Stanford Friedman, ecc.) che, consapevoli dell’importanza referenziale a un’identità femminile così come dei pericoli insiti nelle teorizzazioni di un io dato universale ed essenzialista, si schierano per il mantenimento di un’idea di soggettività femminile, ma sempre in divenire e ripensata sulla base della plurivocalità e della pluridimensionalità.
Ci sarebbe piaciuto se i colleghi, in prima linea su questioni letterarie afferenti al postcoloniale e/o alla migrazione, avessero portato il loro contributo allo studio del fenomeno letterario italiano delle cosiddette “scrittrici migranti”, valendosi, per esempio, delle numerose suggestioni provenienti dai femminismi postcoloniali, intersezionali, transnazionali – di cui sono state promotrici Kimberlé Williams Crenshaw, Chandra Talpade Mohanty o Caren Kaplan – epistemologicamente definiti dall’idea di un’alleanza al femminile tesa alla valorizzazione delle differenze tra donne (genere, razza, etnia, ceto sociale, livello culturale, storia personale, orientamento sessuale, ecc.).
E queste erano solo alcune delle nostre attese che, tradite, hanno portato a un ridimensionamento dei disegni iniziali. Un solo studio generale appare in quella che sarebbe dovuta essere la seconda sezione di critica letteraria. E la firmataria, guarda caso, è una delle rare donne invitate a partecipare, Lucilla Sergiacomo, che ci offre una dettagliata cartografia letteraria indagando particolarità e contraddizioni di donne-personaggio create da donne-scrittici dell’Italia novecentesca.
Ritorniamo ora ai colleghi che hanno declinato il nostro invito, con tempi e ragioni diverse: c’è chi, oberato di lavoro, ha detto no già da subito; chi ha dovuto fare i conti con impegni improvvisi abbandonandoci a metà percorso; e chi ha dimenticato di onorare i tempi preposti alla consegna. Il risultato finale è la non presenza in questo volume della seconda sezione, un’assenza che, tuttavia, non resta priva di significato, ma, al contrario rappresenta ossimoricamente un silenzio che parla. In effetti, come è spesso accaduto nella storia delle donne, a parlare è anche l’assenza. Senza cadere nelle facili trappole di un essenzialismo al maschile e senza mettere in discussione la buona fede di parte dei colleghi riguardo a reali impedimenti materiali, la percentuale massiccia di abbandoni ci autorizza a interrogarci, a mettere in luce e a toccare con mano il fatto che non si possa categoricamente escludere l’esistenza di una reticenza maschile, cosciente o inconsapevole, da addebitarsi alla generale difficoltà di dialogo degli uomini con i femminismi, tra l’altro ben rilevata da Nardini.
Nel 1979, Sandra Gilbert e Susan Gubar in The Madwoman in the Attic[4] mettevano in evidenza il doloroso percorso intrapreso dalle donne per giungere a una scrittura autonoma, indicando come difficoltà prime il superamento dell’angoscia dei “padri fondatori” (“the anxiety of influence”), i condizionamenti sociali e le frustranti complicità che i ruoli maschili hanno loro imposto (“the anxiety of authorship”). Parafrasando, si potrebbero trarre delle ipotesi di lettura sul diniego e sull’abbandono dei nostri colleghi e lasciare aperte una serie di questioni e conclusioni.
Esiste forse presso taluni uomini un’ansia di confronto con il femminismo e con le sue “madri fondatrici”? O forse è possibile credere che, ancora oggi, alcuni retaggi storici e condizionamenti socio-culturali continuino ad alimentare un’idea “separatista”, ossia un’idea di distinzione sessuata dei ruoli (in questo caso intellettuali) e della praticabilità o meno di certi campi? O si tratta, forse, semplicemente di condizionamenti dovuti all’accezione riduttiva e negativa del femminismo che ancora in alcune menti campeggia sovrana?
Comunque sia, almeno un critico ha fatto eccezione. Si tratta di Massimo Onofri, il cui contributo su Grazia Deledda trova spazio, insieme a quello di Silvia Lutzoni sulle Madri, madonne e premi Nobel: ipotesi di un itinerario deleddiano nell’opera delle narratrici sarde degli anni Duemila , in una rubrica appositamente dedicata a studi sul caso sardo; a scanso di equivoci, è bene precisare che la presenza di questo piccolo spazio sardo non è da mettere sul conto di sensibilità anagrafiche (le mie) o di affinità a un campo di ricerca ampiamente battuto da molti studiosi del laboratorio a cui fa capo la rivista Narrativa. Entrambi i saggi rispondono, invece, all’esigenza di offrire delle letture testuali su tematiche di genere, a complemento dei percorsi letterari, inizialmente previsti, più analiticamente centrati sul rapporto tra autrici/creazione artistica e femminismi.
Il volume si conclude con una significativa apertura alle questioni di genere affidata a sei scrittori, scelti sulla base della diversità di sesso, età, provenienza, formazione, e di poetiche, che abbiamo voluto sollecitare nella triplice veste di autori, lettori e di soggetti (in)direttamente coinvolti nelle politiche editoriali. C’è sembrato interessante conoscere il punto di vista di chi i libri li scrive attraverso delle interrogazioni d’ordine generale tese a misurare la loro sensibilità su considerazioni inerenti al genere, alternate a altre domande più pragmaticamente orientate a conoscere i loro posizionamenti sul rapporto tra genere e creazione artistica.
Non abbiamo voluto risparmiare agli autori domande spinose, talvolta maliziosamente finalizzate a oltrepassare la semplice ammissione (o non ammissione) dell’esistenza del genere e a entrare nel merito dei paradossi del “femminile e maschile”; altre volte, calcando provocatoriamente la mano sulla polivalenza del genere, inteso come dispositivo legato alla creazione ma anche alla negoziazione del rapporto tra sessi in termini di ricezione, di politiche di marketing e di strategie editoriali.
Senza togliere ai lettori di queste interviste il piacere della scoperta, ci limiteremo a segnalare che in tutti gli autori è unanime l’allarmismo sui pericoli determinati dalle perniciose cristallizzazioni culturalistiche (considerate alibi per pregiudizi) o sui facili paternalismi psicologici e culturali dovuti alla tendenza d’uso di ricondurre la natura “femminile” al biologicamente determinato e normato.
Come si è più volte detto, nei progetti iniziali questo volume avrebbe dovuto essere più ampio, ma non si è mai avuta la presunzione di potere affrontare in maniera esaustiva il femminismo. Troppe le interrogazioni, troppe le teorie e poco lo spazio a disposizione.
A volume ultimato possiamo però dire di essere un po’ meno “stufe” e più ottimiste. Forse perché rassicurate nella convinzione che il femminismo, o meglio, i femminismi possano ancora federare nella diversità di opinioni, nella condivisione ma anche nella speranza. Nella speranza che si possa arrivare a distruggere le idealizzazioni senza ideali, i pensieri senza pensare, i discorsi sull’altra senza conoscenza dell’altra, ossia quelle perversioni di senso che ancora sussistono riguardo al femminismo e alle donne.
Fermo restando che non tutti i femminismi sono portatori di progresso né di aperture, come è spesso il caso di quelli più radicalmente nazionalistici e conservatori[5], possiamo solo augurarci che, in Italia[6], la diffusione e la presenza pubblica[7] sempre più capillare di femminismi progressisti, dalle tante forme e variabilità direzionali, oltre a rompere quel continuo e insidioso scivolare nell’antico ordine simbolico, continuino a offrire nuove risorse concettuali e politiche e a creare nuove dinamiche d’interlocuzione per il dialogo nazionale e transnazionale, che saranno sicuramente salutari anche per una migliore e più proficua comprensione dei nuovi (o meno) fenomeni letterari.
[1] A questo tipo di essenzialismo piatto non sfuggono neanche celebri e stimati cantautori (Gianna Nannini, Giorgio Gaber, Zucchero Fornaciari, Luciano Ligabue, ecc.). Sicuramente, la più conosciuta e emblematica delle canzoni che riflette questa tendenza italiana è Quello che le donne non dicono (1987) di Enrico Ruggeri.
[2] Secondo Raffaella Baccolini e Vita Fortunato, questa mancanza “ha provocato ritardi non solo nel processo di visibilità e di legittimazione della ricerca in campo femminista, ma anche gravi disfunzioni nella reta didattico-scientifica europea ed internazionale che le donne italiane hanno, in questi anni, cercato faticosamente d’intrecciare. Al pericolo più volte sottolineato da alcune donne che l’istituzionalizzazione degli studi femministi provoca inevitabilmente una perdita della loro radicalità, si può controbattere che la loro mancanza ha voluto dire in Italia un pericoloso ritardo da parte dell’accademia dei presupposti teorici della critica femminista”; Raffaella Baccolini e Vita Fortunato, “Metamorfosi e permanenze nella critica femminista”, in Baccolini, Raffaella, Fabi, M. Giulia, Fortunato, Vita, Monticelli, Rita (a cura di), Critiche femministe e teorie letterarie, Bologna, CLUEB, 1997, p. 15.
[3] Cfr. Fowler, Alastair, Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres ans Modes, Clarendon, Oxford, 1982.
[4] Gilbert, Sandra, Gubar, Susan, in The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven, Yale UP, 1979, p. 17.
[5] Sugli effetti devastanti del femminismo nazionalista e conservatore potremmo citare l’esempio italianissimo relativo all’indisponente recupero realizzato da certune esponenti della destra italiana (per esempio Daniela Santanché), esperte in concettuali manipolazioni dei diritti delle donne finalizzate a cristallizzare differenze gerarchiche su base etnico/sessuata.
[6] Così come emerge da alcuni contributi, il femminismo in questi ultimi tempi, anche in Italia, sembra aver conquistato una nuova visibilità e così come si evince anche dal moltiplicarsi di archivi, di centri e di associazioni culturali, di libri e di gionali culturalmente orientati a favorire le politiche di genere.
[7] Il riferimento è al proliferare, in quest’ultimo decennio, di manifestazioni e incontri, tra i quali ricordiamo la costituzione nel 2011 di Se Non Ora Quando (SNOQ), l’incontro femminista di Paestum dei primi di ottobre 2012 o quello di aria femminista transnazionale tenutosi a Firenze nel novembre 2012.
 All’età di quattordici anni il nonno usava portarmi con sé e il suo asino nella casa di campagna della nostra famiglia, ché vi dormissimo e l’indomani raccogliessimo le olive. L’asino del nonno si chiamava Notte.
All’età di quattordici anni il nonno usava portarmi con sé e il suo asino nella casa di campagna della nostra famiglia, ché vi dormissimo e l’indomani raccogliessimo le olive. L’asino del nonno si chiamava Notte.







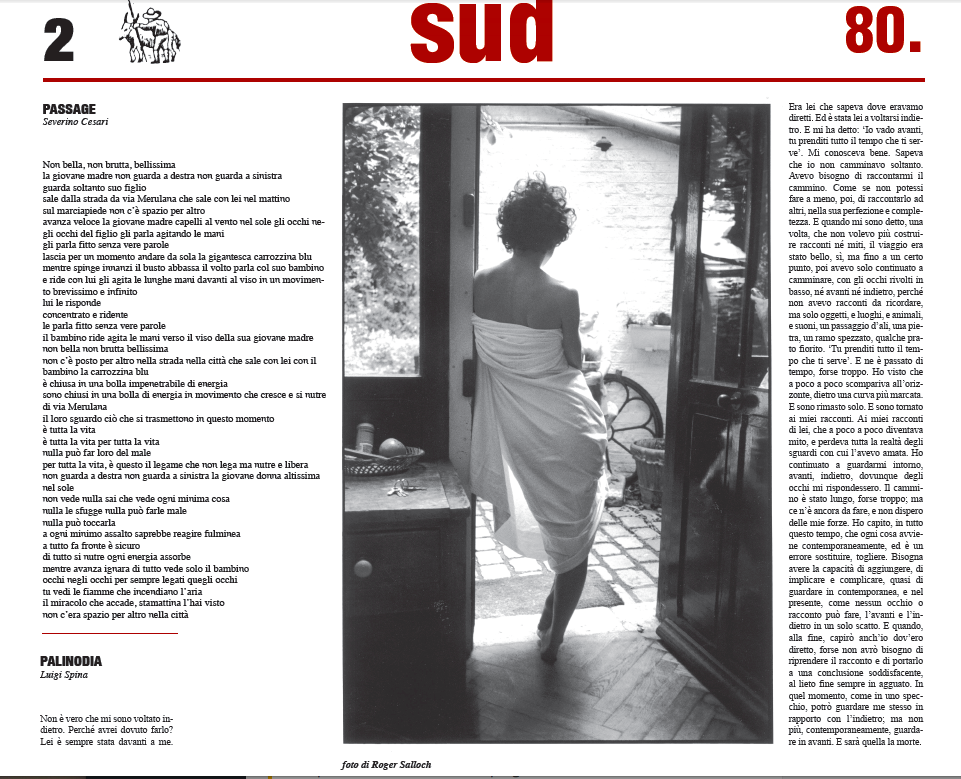

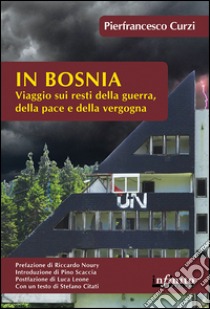


 hé siano serbi. Militari fuori controllo al comando di lugubri personaggi: Ante Gotovina, Ivan Čermak e Mladen Markac, ufficiali di “sua maestà” Franjo. I vertici militari serbi, venuti a conoscenza della barbarie, non sono certo rimasti con le mani in mano applicando lo stesso trattamento ad altri innocenti, croati residenti nelle zone al confine con Serbia e Ungheria.
hé siano serbi. Militari fuori controllo al comando di lugubri personaggi: Ante Gotovina, Ivan Čermak e Mladen Markac, ufficiali di “sua maestà” Franjo. I vertici militari serbi, venuti a conoscenza della barbarie, non sono certo rimasti con le mani in mano applicando lo stesso trattamento ad altri innocenti, croati residenti nelle zone al confine con Serbia e Ungheria. di Mario Galzigna
di Mario Galzigna Dal finestrino passa veloce il paesaggio: campi spogli, gialli, appiattiti dal sole.
Dal finestrino passa veloce il paesaggio: campi spogli, gialli, appiattiti dal sole.




