di Luigi Socci
La gente è perfettibile.
La gente è migliorabile.
La gente non è male.
La gente cammina in modo innaturale.
di Luigi Socci
La gente è perfettibile.
La gente è migliorabile.
La gente non è male.
La gente cammina in modo innaturale.
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Lorenzo. Gli ultimi eventi, che si sono puntualmente verificati in un tempo ovviamente brevissimo ci danno forse l’occasione per mettere al vaglio alcuni nostri ragionamenti. La domanda è: ha ragione Libero quando scrive più immigrati uguale più attentati? Seconda domanda: ricordare – come hanno fatto a suo tempo alcune organizzazioni – che il 40% dei profughi ha problemi mentali è buonista?
Anatole. In effetti c’è questa cosa che il tema lupo solitario si collega a quello del rifugiato per via il disagio mentale in età adolescenziale. Ma la cosa andrebbe approfondita. Cioè, è evidente che se a diciassette anni scappi da una guerra, ti sei fatto una traversata folle in mezzo a tutti gli orrori che possano venire alla mente, sei sopravvissuto per miracolo, o hai una solidità estrema, o ti tempri nel corso degli eventi, oppure non sorprende che vai fuori di brocca. È una cosa che trascende il piano su cui stiamo provando a ragionare noi, perché le uniche persone intitolate a parlare di questo genere di cose sono quelle che fanno ricerca e assistenza sul campo. Quello che però si può dire sul piano della formalizzazione concettuale di questo genere di problemi per il modo in cui affiorano in superficie è la costante di una reazione alle procedure di esclusione. Nei tre casi degli ultimi tre giorni sembrerebbero pesare molto, dal rifiuto sociale in assoluto per il ragazzo di Monaco, a quello del permesso di soggiorno nello specifico, per quello di Ansbach. Il ragionamento che fa Bascetta sul Manifesto a partire da Il Perdente Radicale di Enzensberger è giusto, c’è un radicalismo degli sconfitti che si trasforma in rabbia omicida, ma manca una riflessione approfondita sulla soggettività delle vittime, dalla quale la natura di film horror da Fantafestival sembrerebbe emergere con struggente evidenza.
Lorenzo. Era chiaramente più facile sviluppare un ragionamento del genere a seguito dell’attentato a Charlie Hebdo: radicali di sinistra che fanno satira sul profeta. Si poteva arrivare a cogliere la perversa logica secondo la quale un fuggiasco del commando si asserragliasse in un supermarket kosher, bersagliando gli ebrei, secondo un canovaccio noto. Ma già dall’attentato al Bataclan il bersaglio tende a divenire ancor più generico. Certo, il proprietario è un ebreo, così come i padroni del Carillon erano Harkis, certo ai festeggiamenti del 14 Luglio a Nizza c’erano dei “patrioti”, ancorché musulmani in gran copia, certo tutto quello che vogliamo, ma la sostanza del discorso è che la rabbia cieca degli esclusi colpisce nella sostanza la società nelle sue manifestazioni di più disinvolta spensieratezza. Che se poi vai a vedere chi sono le vittime di Monaco ti prende davvero il coccolone: ragazzini, per lo più figli di immigrati, che davvero almeno agivano come individui che ci provano a essere spensierati, aderendo magari forse con più entusiasmo a una dinamica del tipo mall-bighelloneggiare-darsi un tono di qualche tipo. Esattamente come a Nizza dove fra le vittime troviamo decine di quei franco-trattino-qualcosa ansiosissimi di celebrare sto 14 luglio nel modo più pop che ci sia.
Anatole. E anche lì la situazione ha tutto del film horror catastrofista. Se c’è una guerra santa in corso, sembrerebbe quella tra apocalittici e integrati, i primi nella parte degli assassini stragisti, i secondi in quella delle vittime. Sarebbe da approfondire l’occidentalismo in base al quale i bersagli vengono selezionati e colpiti. Infatti sembrerebbe che l’occidentalismo dello stato Islamico, così come quello di coloro i quali trovano anche una fugace ispirazione in questa istituzione, sia perfettamente sovrapponibile allo schema ideologico reazionario dei nazi, omofobi, razzisti, antilibertari occidentali.
Lorenzo. Sì occidentalismo nell’accezione di Buruma e Margalit. L’Occidente visto con gli occhi dei suoi nemici. Nemici nel senso di persone che vedono un Occidente al tramonto, privo cioè delle sue supposte virtù di luogo fondativo di una civiltà forte e identificabile. E che covano odio perché nella “cosa nuova” che c’è non hanno posto, sono marginali. Questa “cosa nuova”, che poi è un miscuglio male assortito di entità statale che non funziona più e globalizzazione che si mangia tutto, ti respinge, ti mette in una posizione di subalternità insanabile. Un fatto che spinge alcuni a sparare o comunque far danni. Ideologicamente parlando Salvini e Baghdadi sono occidentalisti. E il legame fra le due cose è chiarissimo. FB l’altro giorno mi ha ricordato una cosa agghiacciante: Borghezio al tempo di Breivik disse che le sue idee erano condivisibili (ah, gli algoritmi di FB!). Però penso che su Europa e Occidente alcuni dei tuoi filologi qualcosa l’abbiano detta. Qualcosa di molto più sensato dei vari Toynbee, quegli storicisti che pensavano alle civiltà come entità viventi. Mi viene in mente Curtius, voglio dire.
Anatole. Personalmente penso che anche quella visione dell’Europa, che cerchiamo di tenere in vita, in realtà sia una cosa molto ‘novecentesca, tutto sommato già utopica al tempo in cui veniva concepita. Ho passato un anno intenso, nel corso del quale ho partecipato all’organizzazione della mostra dei Lincei sui «Libri che hanno fatto l’Europa» ed il convegno della Societé Internationale de Linguistique (et Philologie) Romane qui a Roma. Confrontando i ragionamenti che facevamo con la realtà che ci braccava quotidianamente, ho avuto davvero l’impressione dell’accanimento terapeutico. Io continuo a pensare che il modo in cui Auerbach e Curtius si proiettano oltre la crisi determinata dai dilanianti conflitti mondiali fosse in realtà ideologico e velleitario e di sicuro non offre una risposta a un punto nodale che aveva visto bene Ortega y Gasset nel 1930 in La rebelión de las masas, da rileggere da cima a fondo, soprattutto nel capitolo sulla «vida noble y vida vulgar, o esfuerzo e inercia». In particolare è fondamentale il passo in cui dice: «mientras en el pretérito vivir significaba para el hombre medio encontrar en derredor dificultades, peligros, escaseces, limitaciones de destino y dependencia, el mundo nuevo aparece como un ámbito de posibilidades prácticamente ilimitadas, seguro, donde no se depende de nadie». Si badi bene al verbo aparece, perché questa visione, propagandata in lungo e in largo nella nostra contemporaneità da tutti i mezzi di comunicazione di massa, non ha in realtà il minimo fondamento. Ciò malgrado, ci abbiamo creduto tutti, non solo in Europa e in America, ma anche in Iran, in Egitto, in Siria. Si dice che questo «mundo nuevo» configurato «como un ámbito de posibilidades prácticamente ilimitadas» sia venuto meno insieme agli assetti determinati dall’esito della Seconda Guerra Mondiale, ma Ortega y Gasset vedeva già il problema prima della Seconda Guerra Mondiale! Insomma, c’è un problema di distanziamento tra l’ideale e la realtà, nel quale risiede il pericolo per la democrazia, oggi come nel 1930. Né un’idea di realismo basata sul modo in cui le masse parlano, né la condivisione di un sistema di strutture di pensiero basate sui luoghi comuni della retorica aiuteranno a combattere questa minaccia facendoci davvero sentire eredi a diverso titolo di una tradizione culturale condivisa di lunga durata, che mescola al suo interno tutto il mescolabile. Il problema è sottrarre il filtro ideologico e guardare la realtà per quello che è: un gran casino dal quale si vorrebbe uscire senza una lucida visione d’insieme, che può trovare una sua attualità soltanto in un posto: la scuola.
Lorenzo. … (ragiona)
Anatole. L’idea dei modelli culturali condivisi e vicini alle dinamiche della vita, almeno quelle linguistiche, ma si può dire culturali in genere, si regge sostanzialmente su un pilastro che è attualmente minato, se non proprio esploso, cioè la forza di un sistema educativo che smussi le distanze e faciliti le transizioni, garantendo la promozione sociale. È da discutere se in Europa questa cosa abbia mai veramente funzionato e se sì dove, ma di sicuro ora siamo di fronte ad un problema epocale, che cioè non funziona di sicuro. La paideia è il modello culturale, per molti versi se vuoi anche ideologico, che supporta l’idea di Europa, dalla riforma carolingia, più o meno mitologizzata, in poi.
Lorenzo. La scuola dovrebbe essere la cinghia di trasmissione tra il sapere e la vita, ma cos’è la scuola oggi in realtà, dopo che i modelli tecnocratici, i maggiori nemici della democrazia, hanno operato per marginalizzarne la funzione sociale e, appunto, democratica? Di sicuro venendo in crisi l’idea della promozione sociale tramite lo studio, viene anche meno l’ipotesi educativa che smussa le distanze sociali e culturali. Come fai a crederci, se poi non è vero?
Anatole. E soprattutto come fa a crederci un diciannovenne francese di origini algerine, se per primi non ci crediamo noi? Quando penso al mio lavoro in una Università di provincia, soprattutto al livello triennio, immagino sempre di avere come avversario Amici di Maria de Filippi. Un osso duro, siamo d’accordo, ma stiamo descrivendo un conflitto che si consuma all’interno di uno spazio democratico, l’università contro il modello televisivo. A Saint-Etienne-de-Rouvray immagino un conflitto ben più estremo, tra la scuola di base e una moschea salafita. Alle condizioni attuali non sorprende che vinca la seconda forza in campo. Chi di noi può dire che con le armi attuali, quelle di cui disponiamo, potrebbe combattere davvero quella battaglia? Come si pensa di contrastare un’ideologia, quella salafita, con un’altra ideologia, il laicismo della république? Se questo è lo schema, è inevitabile che i costrutti ideologici più forti prendano il sopravvento. riesci ad immaginarti che andrai all’ENA? Che diventerai deputato? Difficile, no? Riesci ad immaginarti come un soldato di dio nell’improbabile jihad dello stato islamico? Più facile. Anche se ti rimandano indietro, ti rimpatriano, ti ingabbiano, ti mettono il cinturino elettronico, trovi modo di progettare un’azione militare, che riflette i costrutti ideologici di cui sei diventato vittima. Sembrerebbe un’azione da manuale, quella che tutti aspettavamo da una vita: un commando irrompe in una chiesa, finalmente la crociata combattuta come si deve. Malgrado il prete sgozzato, le foto dell’attentatore bambino con il cappello di lana della nazionale algerina, aleggia comunque un senso di inappropriatezza. Come se, cioè, anche in questo caso il bersaglio si dimostri inappropriato, fasullo, poco pertinente. Come se lo sforzo sia più quello di convincerci che si tratta davvero di una guerra santa, piuttosto che di combatterla davvero. Perché, più che ad un film sulle Crociate, sembra di stare al Fantafestival, ma debutto, tipo quei film che davano il pomeriggio alle quattro quando ci stavamo solo noi. Tutta questa situazione intrattiene con la religione un rapporto analogo a quello che può avere, che ne so, l’Armata dei Poracci o La Nebbia che Accide.
Lorenzo. Esatto. Su un altro fronte – quello della conferenzistica su ISIS, Islam&co, potrei portare su questo un po’ di casi. Ma forse è più importante che mi concentri un attimo su questa cosa della salafiyya contemporanea – nel cui brodo il terrorista impazza – avendone ragionato un bel po’ in diversi modi. Partiamo da qui: c’è questo lavoro di Arjun Appadurai, Fear of smalll numbers. Lui dice una cosa essenziale: soprattutto a partire dai ‘novanta si stava instillando in ogni paese questa percezione della violenza e dell’insicurezza su base quotidiana. Una specie di guerra a bassa intensità permanente che modifica le relazioni sociali in un contesto di disorientamento dato dai tempi della globalizzazione, velocissimi nel procurare cambiamenti, e tempi degli Stati, delle politiche, della democrazia, molto più lenti e quindi poco incidenti sulla realtà che cambia. Un meccanismo stritolante in cui alla fine vince la concezione identitaria nazionalista antica e vieta di chi si accanisce contro tutto ciò che anche vagamente possa dare l’idea che sia possibile un’ibridazione, una mescola di qualche tipo (e qui mi viene in mente contro le patrie di Fernando Savater nel senso seguente: “ce lo dovevamo aspettare che sta cosa degli stati nazionali sarebbe finita male in questo modo”). O vince, anche, una ricerca di identità che vada bene nella globalizzazione, buona per tutti i luoghi e tutti i tempi, quindi fortemente destorificata e stereotipata e in buona misura mercificabile. La nuova salafiyya è sostanzialmente questo – una roba che funziona nel nuovo paradigma – mentre i salafiti “storici”, quelli che associamo genericamente ai modernismi nati in reazione alla modernità “occidentale” dei coloni, sono tutta un’altra cosa e diciamo che qui non li consideriamo, facendoci anche a questo punto un po’ tenerezza. Questi nuovi salafiti, come i loro colleghi neocatecumenali, funzionano benissimo, fanno sfracelli, nel senso che all’interno dei rispettivi raggruppamenti confessionali – islamico e cristiano – sono quelli che fanno più proseliti. Tanto che i loro “concorrenti interni”, ad esempio i sunniti “vecchio stile”, quelli legati al sapere tradizionale, alle “università islamiche”, alle scuole giuridiche ecc., che fra l’altro spesso sono “a servizio” di sistemi nazionali tirannici, fanno davvero fatica a star loro dietro. E questo contesto “neosalafita” è il parco giochi dei terroristi. In campo cristiano assistiamo a dinamiche diverse, un buon esempio è l’Africa subsahariana dove il vecchio comboniano è perdente rispetto all’aggressivo pastore protestante che convince i legislatori ugandesi a emanare leggi contro gli omosessuali. In un contesto del genere è ovvio che il “prete freelance” dell’Huffington post, Don Aldo Antonelli, scriva: «Se dovessi essere sgozzato o decapitato o sventrato da un delirante di “Allah Akbar!”, vi prego, per favore, non uccidetemi due volte: non confondete l’Isis con l’Islam. E se il mio uccisore dovesse essere un nero o un emigrato, vi prego, per favore, davanti alla mia bara non uccidete anche la mia memoria: non confondete il delinquente con l’emigrante». Non sono i cristiani come lui – né i musulmani con cui lui ha a che fare – a far guerre.
Anatole. Certo fa un po’ ridere che siano i religiosi gli unici a dire che non è in corso nessuna guerra di religione. Addirittura il papa pare l’ultimo rimasto dei marxisti quando dichiara che «Il mondo è in guerra, ma non è una guerra di religione», soggiungendo che «Dietro i conflitti, ci sono i soldi, gli interessi, le risorse naturali, non le fedi». L’imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, fa eco che «Gli autori di questo attacco barbaro si sono spogliati dei valori dell’umanità e dei principi tolleranti dell’Islam che predica la pace e ordina di non uccidere gli innocenti». Parrebbe in corso anche un’altra strisciante polarizzazione che schiaccia il dibattito, quella tra laici e religiosi, nella quale tutto sommato siamo caduti tutti ai tempi dell’attentato a Charlie Hebdo. Cioè, quando si diceva che la religione non c’entra e «Pray for Paris», veniva spontaneo rispondere che invece c’entra eccome e andatevene a pregare a casa vostra, che di religione ne abbiamo avuta abbastanza, grazie. Anche qui si tratta dunque di andare ancor più per il sottile. Cioè, la religione in ultima istanza c’entra eccome, nel senso in cui c’è sempre entrata. Specialmente se le tecnocrazie al potere fanno in modo che il potere laico sia irraggiungibile. Vale l’esempio di cui sopra: la religione è accessibile, l’ENA molto meno, anzi in taluni casi proprio per niente. Entrare in una chiesa o in una moschea non costa niente, iscriversi alla Bocconi o alla Luiss molto di più. Se vuoi creare un sistema in cui studiare costa, perché vuoi erogare gli student loans anche in Europa, poiché capisci che è l’unico modo di far cacciare soldi alle famiglie per una cosa che adesso hanno quasi gratis, è evidente che la religione c’entrerà sempre di più. Si ritorna al problema del laicismo in un continente che restringe l’accesso allo studio. Allora avoja a parla’ della riforma carolingia come momento fondativo della cultura europea, avrà sempre ragione il Papa quando dice che «L’Europa ha nel Cristianesimo le sue radici più solide». E il primo imam salafita che ti spiega come non hai speranza in un mondo come quello in cui vivi in mezzo ai palazzoni di una ville nouvelle (che poi ormai so’ vecchie), tipo quella vicino dove finimmo nel remoto capodanno 1990, avrà ragione lui, punto.
Lorenzo. Sì, c’entrerà sempre di più la religione, in quel senso che dicevo, penso. Anche se poi a ben vedere occorre un supplemento di ragionamento, appunto, e un laicismo vecchio stile, adatto per i paradigmi vecchio stile, diventa asfittico e inutile e in ultima analisi forse anche peggio dell’Imam di al-Azhar, di Papafrancesco&co. Se uno fa il discorso anticlericale, ad esempio, sbaglia bersaglio perché per il clero non c’è guerra di religione ecc. E inoltre, quel tipo di laicismo è molto reazionario, crea personaggi come gli Atei Devoti: Fallaci in testa, Ferrara… insomma un incubo. Ma ora dovremmo parlare del complottismo, dei sistemi di pensiero cospirazionisti, come avevamo promesso ai nostri lettori.
Anatole. No, guarda, s’è fatta una certa, ne riparliamo alla prossima puntata, giuro. E poi se non chiudiamo rischiamo che capita qualcos’altro invece pare che oggi sia successo soltanto che il papa è inciampato. Cioè, dai, ci sono le elezioni americane, Carosello che torna dopo 40 anni sul web, il DJ spagnolo picchiatore seriale a Milano. Oddio, forse questo è a cavallo tra Fantafestival e Complottismo…
Lorenzo. Al giapponese che fa strage di disabili, comunque, je spiccia casa.
Anatole. Winter is coming.
Lorenzo. As father said.
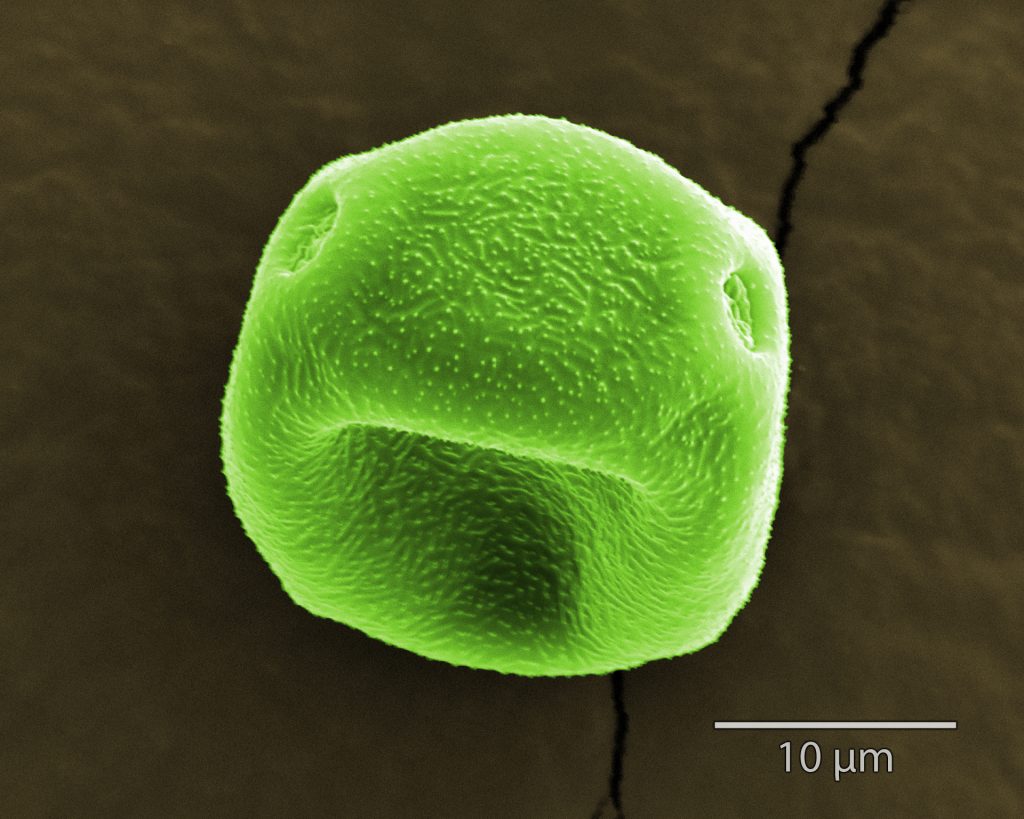
di Mirko Bay
Log In #1
Nella periferia di un piccolo monolocale fronte metro riapro gli occhi dopo pranzo. Quello che si direbbe un Riavvia agevolato. Mi butto addosso Killing in the name dei Rage Against the machine. Ragazzo Budweiser liscio i piatti al lavello.
Il monitor aperto sul tavolo, la connessione arranca affastellando pixel che denunciano immagini incerte. Lancio lo sguardo nell’appartamento che trema di tanto in tanto agli orari dei pendolari. Rigiro tra le mani la spugnetta che spumeggia. La canzone l’aveva persa dalle dita la barista. Ieri sera è stata dura uscire.
di Andrea Amoroso
Vedere il visibile
Come un volume gnostico, come una mistica, Adieu au langage è un tentativo verso l’impossibile. Non di raggiungere quell’impossibile, Godard non è così ingenuo, ma di indicarlo; è un film che lavora per indicazioni, anzi per indici, indici dell’indicibile. È un viaggio da fermo, privo di indicazioni, ma cosparso di segnali vuoti, vacanti, da sempre mancanti, che declinano in mille modi il nome di un dio invisibile e – probabilmente – inesistente.
di Antonio Sparzani

Guerra e pace non è soltanto la complessa storia della bella Nataša, del principe Andrej, del conte Pierre Bezuchov e del loro rutilante contorno di aristocrazia russa, è anche in molte occasioni una riflessione sui più svariati temi della cultura dell’epoca e in particolare sulla storia in generale, che Tolstoj introduce descrivendo e ripercorrendo le vicende dell’esercito russo comandato da Kutuzov durante la disastrosa campagne de Russie intrapresa da Napoleone nel 1812.
L’inizio della parte terza del terzo libro dell’opera suona così «La mente umana non riesce a concepire l’assoluta continuità del moto», che sembra un’affermazione a metà tra meccanica e psicologia, ma che fornisce all’autore lo spunto per una riflessione, tra l’altro non priva di risvolti matematici, sulla questione discreto/continuo che a quel tempo (Guerra e pace usci per la prima volta completo nel 1869) era attivamente dibattuto negli ambienti della matematica tedesca: Richard Dedekind pubblicò nel 1872 il primo sistematico risultato di questo dibattito, sistemando finalmente in maniera precisa la questione della continuità.
Tolstoj (vedi già un accenno qui) certamente aveva sentito parlare e anzi in qualche misura appreso i progressi dell’analisi, come si capisce anche da quanto aggiunge poche righe dopo quell’inizio citato; eccolo:
«Questa nuova branca della matematica, sconosciuta agli antichi, nel momento in cui ammette, a proposito dei problemi del moto, grandezze infinitamente piccole come quelle in cui si ripristina la condizione principale del moto (cioè l’assoluta continuità), corregge l’errore che la mente umana commette inevitabilmente quando esamina singole unità del moto invece del moto continuo.
Nella ricerca delle leggi degli avvenimenti storici accade esattamente la stessa cosa.
Il movimento dell’umanità, essendo l’espressione di un numero infinito di volontà umane, si compie in modo continuo.
Impadronirsi delle leggi di questo movimento è lo scopo degli storici. Ma per afferrare le leggi del movimento continuo costituito dalla somma di tutte le volontà umane, la mente dell’uomo utilizza unità arbitrarie e discontinue. Il primo passo di ogni ricerca storica consiste nel prendere una serie arbitraria di avvenimenti continui e nell’esaminarli separatamente dagli altri; mentre nessun avvenimento ha, né può avere, un principio a sé, giacché ogni avvenimento scaturisce, senza soluzione di continuità, dall’altro. Il secondo passo consiste nell’esaminare l’azione di un uomo, re o condottiero, come una somma di volontà umane, mentre la somma delle volontà umane non si esprime mai nell’attività di un solo personaggio storico.
La scienza storica, nel suo evolversi costante, esamina unità sempre più piccole, e per questa via tende ad avvicinarsi alla verità. Ma, per quanto piccole siano le unità che essa prende in considerazione, noi sentiamo che valutare un’unità separatamente dall’altra, o ammettere che sia possibile il principio di un qualsiasi fenomeno, è falso così come è falso ammettere che la volontà di tutti gli uomini si esprima nelle azioni di un solo personaggio storico.
Ogni deduzione della storia si sfalda come polvere al minimo sforzo critico, senza lasciare nulla dietro di sé, per il solo fatto che la critica scelga come oggetto d’osservazione un’unità discontinua maggiore o minore. cosa che può sempre fare, dal momento che l’unità assunta dalla storia è comunque arbitraria.
Solo sottoponendo all’osservazione un’unità infinitamente piccola, un differenziale della storia, vale a dire le tendenze omogenee degli uomini, e riuscendo ad integrare, cioè ad esprimere la somma di questi valori infinitamente piccoli, noi possiamo sperare di comprendere le leggi della storia». (Lev N. Tolstoj, Guerra e pace, trad. it. di P. Zveteremich, Garzanti, Milano 1982, pp. 1237-39)
Significativamente Tolstoj dice «possiamo sperare di comprendere le leggi della storia», non dice che si possa arrivare a farlo. E anzi, sembra a me che tutto il suo ragionamento tenda a far capire come sia in verità impossibile raggiungere questo risultato.
Ammesso naturalmente che esistano queste misteriose “leggi della storia”.
Anche perché, e qui vorrei arrivare a riflettere sul tipo di “informazione storica” cui siamo quotidianamente esposti nella nostra epoca, nella quale sembra che “tutte” le informazioni facciano il giro del globo in pochi secondi: l’altro fattore che impedisce una vera conoscenza storicamente affidabile è proprio che queste informazioni son ben lontane dall’essere “tutte”: l’informazione che abbiamo, mediamente, è frammentaria, parziale, deformata, labile, e anche, inevitabilmente, controllata. Ed è questo che, terribilmente, produce ignoranza, talvolta ingenua, talaltra arrogante.
Guardiamo i fatti che consideriamo rilevanti della nostra epoca, le guerre, i colpi di stato, i fanatismi estremi dai quali siamo ormai circondati: qualcuno sa chi davvero progettò l’assassinio di Kennedy? Forse c’è ancora qualcuno che lo sa, ma, una volta morto lui, nessuno più ne avrà idea. O le torri gemelle? Oppure quest’ultima ignominia della Promenade des Anglais? Certo i “servizi” trovano telefonate, messaggi, appunti, contatti, ma sapremo mai davvero chi e perché ha armato la mano del killer di turno? Sappiamo, o sapremo mai, chi e con quali mezzi ha organizzato il cosiddetto colpo di stato in Turchia?
Abbiamo molte ipotesi, congetture, ogni tanto si scopre qualche nuovo documento che “getta nuova luce” su avvenimenti del passato, il che è bene, naturalmente, significa che magari ci approssimiamo di più a qualcosa che non sapevamo, ma se guardiamo alla mole di avvenimenti anche solo della storia moderna, c’è di che disperarsi: nel nostro particulare basta pensare a tutta la “strategia della tensione” che ha fatto centinaia di vittime qui da noi e sulla quale ancora nessuna “piena luce” è stata fatta.
È come un grande mare pieno di onde: vediamo le onde e ciò naturalmente è molto utile per poterci navigare un po’. Ma sotto le onde ci sono le correnti, le maree, un complesso di movimenti dell’acqua che mai perfettamente conosciamo. Qualcuno che conosce le correnti sottomarine, almeno localmente, ci sarà certo, ma questa è la conoscenza che non si propaga.
Accade come nella scienza: le vecchie teorie spariscono e vengono soppiantate da altre perché muoiono i loro migliori sostenitori. Nella storia invece muoiono quei, pochi, che sanno davvero cosa è successo perché l’hanno fatto succedere loro.

di Francesca Fiorletta
come cometa non sono niente, se non i nomi e le motivazioni che mi danno al passaggio, non ho volontà, non ho spiegazioni, non ho alcun fine, non ho memoria, ogni volta è una novità, come cometa, mentre mi osservano, me ne sto andando…
Sono esattamente come comete I Racconti di Daniele Del Giudice, raccolti e pubblicati da Einaudi questa primavera, con la prefazione di Tiziano Scarpa.
Come comete conservano e innalzano la forza dirompente dell’immaginazione, trascinano chi sta a guardare in un universo parallelo fatto di gioco e magia, fatto di luci e soprattutto ombre, di apparizioni e soprattutto fughe, di molteplici assenze e, evidentemente, di altrettante presenze umane, ingombranti, corporali.
Tutti i giorni esco e cerco l’Altro sempre.
F. Hölderlin

L’importanza di essere piccoli
poesia e musica nei borghi dell’appennino
VI edizione dal 2 al 6 agosto
un progetto associazione arci “SassiScritti”
riabitare il luoghi marginali con la poesia e la musica
LA POESIA CERCA L’ALTRO
con
GNUT, NADIA AUGUSTONI, GIUSI QUARENGHI, IACAMPO, MOTTA, MATTEO PELLITI, TÊTES DE BOIS, GIOVANNI NADIANI, ALESSANDRA RACCA, ERICA MOU, TIMISOARA PINTO, LUCIA MAZZONCINI
“Tutti i giorni esco e cerco l’Altro sempre” è l’incipit scelto per la VI edizione del festival l’Importanza di essere piccoli, verso enigmatico e profetico del poeta Holderlin che connota la poetica e il senso di un progetto culturale nato nel 2011 da un’idea di Azzurra D’Agostino e Daria Balducelli dell’associazione SassiScritti e sostenuto da Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Polimero di Arci Emilia-Romagna, Distretti Culturali, Città metropolitana di Bologna e i Comuni di Alto Reno Terme, Castel di Casio, Grizzana Morandi, Pistoia e Sambuca Pistoiese, Arci Bologna e il contributo di Coop Reno, Banca di Credito Cooperativo Alto Reno, Helvetia Thermal SPA Hotel. Non solo quindi un festival ma il coronamento estivo di una serie di attività che l’associazione, affiliata Arci, intesse durante l’anno: da InRitiro, un calendario di laboratori in residenza con scrittori, attori, illustratori e musicisti, collaborazioni con enti locali quali la Fondazione Santa Clelia Barbieri di Vidiciatico, l’Associazione Porretta Cinema e recenti sinergie con il festival pistoiese Leggere la città e il Progetto T della compagnia teatrale Gli Omini. Non da ultimo lo scambio di energie e di pensiero avvenuto lo scorso inverno al presidio dei lavoratori Philips-Saeco, mobilitati contro un previsto licenziamento di quasi metà degli operai. SassiScritti ha affiancato a questa manifestazione un presidio culturale che ha portato davanti alla fabbrica decine di artisti in un programma dal titolo Poesie per farsi coraggio. Gli operai, a conclusione della lunga contrattazione, hanno devoluto a SassiScritti un contributo derivante dai fondi raccolti a sostegno delle famiglie dei lavoratori.
Il filo rosso che lega queste proposte è l’attenzione e cura dei luoghi “marginali” intesi non solo come periferie, ma come condizioni esistenziali fragili e minoritarie, quindi potenzialmente cariche di una bellezza eversiva e innovatrice.
Poesia e musica in luoghi ancora da scoprire, riluttanti alla fama ma generosi nell’accogliere, poesia come l’Altro che è in noi ma anche come l’altro che arriva da fuori e che l’arte continua a cercare con lo slancio del bambino che esplora il mondo. L’immagine scelta, quella di una cavalletta che si rispecchia in una figura aliena, ci rinnova l’antica promessa con il nostro essere più autentico, verso un’alterità fertile che fa accadere gli incontri e salda l’amicizia, qualcosa che oggi forse più che mai si rende urgente.
Ancora una volta SassiScritti sarà felice di accogliere dal 2 al 6 agosto gli ospiti nei luoghi del Festival, in una terra di mezzo fatta di castelli, pievi, boschi e borghi semi-abbandonati dell’Appennino. Mediatori tra il mondo e quei pianeti marziani evocati dalla poesia saranno come sempre i luoghi che permettono l’incontro tra artisti e pubblico, resi ancora più belli dalla cura e dalla dedizione degli abitanti, delle proloco, delle associazioni locali, che da settimane si preparano a questo appuntamento.
I cantautori Gnut, Iacampo, Motta, têtes de bois, Erica Mou si incontreranno per la prima volta con i poeti Nadia Augustoni, Giusi Quarenghi, Matteo Pelliti, Giovanni Nadiani, Alessandra Racca. Poesia e Musica arriveranno e si intrecceranno a Tresana, Castelluccio di Porretta Terme (BO), tra le sue case costruite con le pietre locali che sbucano dal bosco di castagni; tra le romantiche rovine del Castello di Sambuca Pistoiese (PT) o nel festoso borgo di Castagno di Piteccio (Pistoia) che incontra la linea transappenninca della Porrettana; presso l’antico e bellissimo borgo La Scola a Grizzana Morandi (BO) e infine approdare sui prati del circolo culturale ippico Scaialbengo a Castel di Casio (BO).
Gli eventi sono a ingresso libero in caso di pioggia si svolgeranno ugualmente nei luoghi indicati.
PROGRAMMA
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si terranno anche in caso di pioggia nei luoghi indicati
Martedì 2 agosto inizia il viaggio dentro la natura, la poesia e la musica in uno dei borghi più segreti e più suggestivi dell’Appennino: Tresana, non lontano da Castelluccio di Porretta Terme, piccolo agglomerato di case immerse in un castagneto secolare tra grandi fioriture di ortensie e case in sasso dai tetti in arenaria. L’appuntamento è per le 18:30 quando Lucia Mazzoncini, aiutata dalle riprese video di Eleonora Chiti, accompagnerà il pubblico nelle stanze di una antica casa contadina regalando con l’ installazione audio-visiva CREATURE CUSTODI DI STORIE momenti di sosta e ascolto attraverso le voci di poeti e le storie di infanzia degli abitanti del borgo e dei viandanti che lo hanno attraversato…
A seguire si terrà la presentazione del libro UN PONTE GETTATO SUL MARE, realizzato dal festival di poesia sardo Cabudanne de sos poetas di Seneghe con cui l’importanza di essere piccoli è gemellata si rinnova in questo modo la vicinanza a festival di là dal mare attraverso questo volume antologico che raccoglie le poesie create durante un laboratorio di scrittura poetica nei centri psichiatrici dell’oristanese a cura di Francesca Matteoni e Azzurra D’Agostino. Dopo una cena a buffet (su prenotazione) dalle 21:00 si entrerà nel vivo della relazione tra parola e musica con l’inedito incontro tra Nadia Alba Augustoni e GNUT. Poetessa dal percorso certamente non accademico, Nadia Augustoni vive una vita da operaia: da sempre per necessità a contatto con lavori manuali e fuori dal mondo intellettuale, si forma da autodidatta studiando di notte i grandi poeti e saggisti della nostra tradizione. Ne esce una produzione cospicua e variegata, arricchita da una lingua consapevole ma diretta, che si occupa delle questioni dell’umano nelle sue varie declinazioni: da temi più impegnati civilmente a quelli più strettamente intimi, quali quelli trattati nel recente Lettere della fine uscito per Vidya nel 2015. A duettare con lei GNUT, al secolo Claudio Domestico, delicatissimo cantautore napoletano che con il suo primo album “Prenditi quello che meriti” è stato acclamato come una delle migliori realtà cantautorali della sua generazione. Presenta al festival brani anche da Domestico, il suo ultimo album, caratterizzato sino dal titolo da una poetica intima, potremmo dire quasi ‘casalinga’, che perfettamente si ricollega all’atmosfera della serata.
Altra caratteristica de l’importanza di essere piccoli è il piacere di scoprire e far scoprire nuovi borghi, così da quest’anno inizia la collaborazione con il borgo toscano di Sambuca Pistoiese, dove mercoledì 3 agosto pubblico e spettatori si ritroveranno ai piedi del ‘Castello di Selvaggia’. I ruderi sono su uno sperone di roccia che controlla le valli del Limentra, dove sorge una fortezza che un tempo fu l’ inespugnabile culla della storia e della tradizione poetica dell’Appennino. Qui, nel 1200, si combatterono le città di Pistoia e di Bologna e qui un secolo dopo si rifugiò, dove visse i suoi anni più felici, Selvaggia Vergiolesi, nobildonna di famiglia ghibellina cantata dal poeta Cino da Pistoia. E come le parole del poeta ci giungono attraverso i secoli, così la poetessa che ospitiamo ha parole ‘per tutti’: non è possibile infatti limitare l’opera di Giusi Quarenghi alla sola ‘poesia per ragazzi’. I suoi albi illustrati, le sue filastrocche, i suoi racconti, le sue poesie (come quelle raccolte in E sulle case il cielo ed. Topipittori, inserito nella IBBY International honour list) sono un mondo ricco dove è bello passeggiare insieme. Con lei, il cantautore IACAMPO, una voce delicata che accarezza temi e atmosfere di un immaginario composto di dediche e riflessioni, canzoni che a partire da racconti di esperienze personali diventano bacino di domande, attese, grandi dubbi e piccole certezze universali. Un cantautore dallo stile immediatamente decifrabile, che gira l’Italia commuovendo i pubblici più diversi attraverso una musica in qualche modo ‘poetica’ che, come una fioritura, il titolo del suo ultimo album Flores la richiama – si fa esplosione silenziosa.
Si resta in Toscana anche giovedì 4 agosto con l’ appuntamento nella stazione più piccola d’Europa, ovvero Castagno di Piteccio (Pistoia). Un solo binario, tra due gallerie, una casupola sotto l’ombra di una radura di castagni: ecco dove si potrà ascoltare la poesia di Matteo Pelliti e la musica di MOTTA. Laureato in filosofia e autore di varie raccolte in versi, Pelliti dal 2005 collabora stabilmente con il cantautore Simone Cristicchi, assieme al quale ha firmato spettacoli, musical, racconti. Una poesia che riesce a coniugare la leggerezza dell’ironia con i grandi temi della contemporaneità, una scrittura ricca e frizzante che coinvolge i pubblici più diversi. Gli stessi che stanno seguendo il fortunatissimo tour di MOTTA, ex Criminal Jokers, in cui presenta il suo album d’esordio come solista La fine dei vent’anni. Un disco prodotto da un “artista amico” del festival, Riccardo Sinigallia, indimenticato protagonista di una delle scorse edizioni. La scoperta dell’età adulta raccontata in dieci brani che verranno presentati al festival in una versione più intima rispetto alla formazione classica che comprende alcuni tra i più interessanti musicisti della scena indie-rock italiana. Sarà poi possibile condividere tutti insieme, a fine serata, alcune ottime specialità preparate in casa offerte dalla Pro Loco di Castagno, realizzate con tutta la sapienza e l’amore dei custodi delle tradizioni.
Si torna in Emilia venerdì 5 agosto, quando sarà l’incantevole e curatissimo borgo La Scola, nel comune di Grizzana Morandi (BO), ad accogliere gli ospiti già dalle 18:30. Anche in questa occasione, come per la serata di apertura del festival a Tresana, gli spettatori sono i benvenuti prima di cena per seguire una visita guidata del borgo condotta da Pietro, attivissimo e informatissimo abitante del borgo e animatore dell’Associazione La Sculca artefice di tante attività come mostre, feste, visite e concerti. Verrà poi presentato alle 19, sotto un pergolato di vite, il libro di Timisoara Pinto Lavorare con lentezza (Squilibri editore). Giornalista e conduttrice radiofonica esperta di musica, Timisoara accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio incredibile che narra l’incontro con Enzo Del Re, l’interprete più autentico di una stagione di impegno civile nella quale le canzoni di lotta e di protesta animavano il sogno di una società diversa. Su prenotazione sarò poi possibile mangiare le piadine e le tigelle montanare preparate dalla Sculca, per condividere un po’ di tempo all’ombra del cipresso millenario del borgo prima dell’incontro tra poeta e musicisti. Giovanni Nadiani, poeta romagnolo, ha del resto molta dimestichezza con la musica: per anni ha infatti presentato le sue letture con i ‘Faxtet’, gruppo jazz divertente e poliedrico. Autore eclettico, Nadiani ha all’attivo oltre a svariate raccolte di poesie, testi teatrali e cabarettistici. Il suo ultimo libro aNmarcurd (‘Non mi ricordo’), mantiene il dialetto romagnolo tipico della sua scrittura, ma si vela di un’ombra approfondendo il lato più riflessivo e volgendo lo sguardo alla memoria e alla morte. Freschi di premio sono i musicisti che si avvicenderanno sul palco con il poeta, ovvero i TÊTES DE BOIS – targa Tenco come migliori interpreti nel 2015. I Têtes de Bois hanno avuto questo riconoscimento per l’album realizzato su Léo Ferré, dodici anni dopo il fortunatissimo Ferré l’amore e la rivolta. Due anni trascorsi a pensare e a lavorare per le vie dei poeti, sui passi di Léo Ferré, uno dei grandi geni del Novecento che i Têtes de Bois non riescono a smettere di amare, hanno generato un nuovo disco e una nuova avventura ‘Extra’ che molto ha a che fare con la poesia. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud musicati da Ferré, Ferré musicato da Ferré e Ferré musicato e ri-arrangiato dai Têtes de Bois.
Sabato 6 agosto, l’ultima serata del festival, sarà un ritorno in un luogo caro ai piccoli: il Centro Culturale Ippico di Scaialbengo nel Comune di Castel di Casio (BO). Qui, tra cavalli cresciuti e educati secondo uno stile rispettoso della loro natura e della necessità di libertà in spazi aperti, si incontreranno due donne brillanti e potenti. La poesia sarà affidata alla voce di Alessandra Racca, anche detta ‘la signora dei calzini’ – come recita il titolo del suo primo libro e quello del popolare blog da lei curato. Appassionata di poesia “ad alta voce”, fermamente decisa a dimostrare che la poesia non è una noia, è autrice di reading nei quali mescola poesia e teatralità a una dose massiccia di ironia e musica. La musica, in questa serata, sarà invece quella di Erica Mou, già acclamata con la sua Nella vasca da bagno del tempo presentata a San Remo qualche anno fa. A causa di un incidente fortuito subito lo scorso aprile, Erica ha avuto una lunga pausa che si è interrotta in luglio per riprendere l’incontro con il suo pubblico, un incontro rimodulato su nuove esigenze e nuova poetica. L’impossibilità di imbracciare la chitarra ha potenziato il suo rapporto con la voce e ha alimentato l’energia creativa e altre qualità musicali di Erica. Emerge la voglia di lavorare sulla voce, e di mettersi in accordo con altri strumenti, come le corde del violoncello. Come è nella filosofia del festival, anche in questo caso è il limite ad amplificare le potenzialità, è il confine che si fa soglia affacciata su una più ampia visione – di necessità virtù è proprio il titolo del tour estivo della cantautrice pugliese.
Anche quest’anno il festival presenterà una serie di creazioni originali e uniche da parte di vari artisti e artigiani che hanno realizzato opere specifiche per l’evento. Borse in lino e cotone cucite a mano, abbinate a portachiavi, astucci e papillon di stoffa imbottita che riprendono i colori dell’immagine di questa VI edizione sono la proposta di Carohandmade, una creativa della provincia di Livorno che ha preparato una serie ridottissima di questi oggetti unici il cui acquisto darà una parte dei proventi a sostegno del festival. Saranno presenti poi i taccuini cuciti a mano delle sarte di MaVà di Padova, che pensa, disegna, stampa e rilega quaderni realizzati interamente con stoffe di recupero, che per il festival riportano i versi scelti come epigrafe-amuleto del festival e il logo dell’associazione SassiScritti. Altri quaderni, di altro materiale – ovvero carta e cartone assemblati in creativi collage riportanti immagini, poesie, ritagli di giornale – saranno rilegati interamente a mano e presentati dalle ‘sarte utopiche’ e poetesse Manuela Dago e Francesca Genti di Sartoria Utopia di Milano. Per gli impervi campi è bene avere sempre l’occasione di trovare stuoini dove sedersi con più agio e ve li proponiamo nella veste cucita e realizzata da Integra, cooperativa sociale di Quarrata (PT), che ha realizzato per noi alcuni capi cuciti a mano, stuoini da pic nic che potrete usare per tutte le vostre gite in campagna. Candele colorate e originalissime realizzate a mano dalla poetessa Francesca Matteoni, oltre a acquerelli (cartoline e quadretti raffiguranti gli animali della foresta) dell’artista e sostenitrice del festival Margherita Cambi.
Ritroveremo poi i ‘miniquadri’ di Cifone, al secolo Simone De Berardinis, di cui il fumettista Maicol Rocchetti (il noto autore degli ‘Scarabocchi animati’ di maicol&mirko) ha detto “Cifone è uno dei più grandi artisti che mi è capitato di conoscere. La potenza dei suoi disegni, dei suoi modellini di cartone e delle sue foto ricordo è devastante. Cifone riesce a stupirmi da ormai trent’anni. Le sue cose sono sempre vere, giuste, entusiasmanti, commoventi. Soprattutto non sono mai una truffa”. Ci saranno poi alcuni esemplari di poster d’arte numerati, pezzi unici realizzati appositamente secondo le antiche modalità di lavoro tipografico dalla tipografia d’arte bolognese Anonima Impressori. Tutti questi specialissimi piccoli grandi oggetti verranno proposti al pubblico in una raccolta fondi a sostegno delle attività del festival.
Ad arricchire la rassegna sarà presente il bookshop de “LO SPAZIO di via dell’ospizio” di Pistoia e “L’ARCOBALENO” di Porretta Terme, oltre allo stand della straordinaria BIRRA DEL RENO, un prodotto artigianale, sano, gustoso, realizzato con i cereali delle aziende agricole della montagna e spinata fresca sul momento.
INFO
www.sassiscritti.wordpress.com
fb: L’importanzaDiEsserePiccoli
mob: 349 5311807 | 333 5837354
ufficio stampa SassiScritti: Azzurra D’Agostino/Daria Balducelli mob. 349 5311807; azzurradagostino@gmail.com
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Lorenzo. Avevamo detto che ci sarebbe sembrato il caso di approfondire la questione del complottismo ma l’allarme continuo sta determinando un prevalere della cronaca su qualunque spazio di ragionamento, quindi si tratta di reagire in modo rapidissimo ad un concatenarsi di eventi che rende impossibile seguire un filo non emergenziale. Si vorrebbe svolgere un pensiero approfondito, costruendo categorie che possano servire a demistificare l’idea che siano in corso un jihad e una crociata, ma sono all’opera forze che, più o meno consapevolmente e intenzionalmente, lavorano allo scopo di confermare questa idea su base quotidiana.
Anatole. Il problema che ponevamo, probabilmente in modo troppo implicito, è che il terrorismo polarizza in maniera drammatica. Da una parte si schierano quelli che danno ragione al terrorista, dicendo che è in corso uno scontro di civiltà, anche se in apparenza sembrerebbe che stiano dandogli contro, dicendo che l’Islam è cattivo e medievale e integralista. Dall’altra parte ci sono coloro i quali dicono che il terrorista ha torto a configurare il suo antagonismo contro l’occidente come uno scontro di civiltà, perché in realtà non è in corso nessuna guerra di religione, e per questa ragione vengono etichettati come quelli che sono dalla parte del terrorista.
Lorenzo. Se poi nel mezzo di una sparatoria, come a Monaco in queste ore, arrivi a sentire una vittima che urla all’attentatore «Kanake», un insulto razzista vecchio stile per gli immigrati del sud, sentendosi rispondere «Ich bin Deutscher!» con un accento marcatamente tedesco, il cortocircuito è totale. Se poi, l’attentatore ha davvero aggiunto di essere cresciuto nelle case popolari del quartiere dell’attentato, di esser stato vittima di bullismo per anni, concludendo con l’insulto «Scheisstürken!», cioè « turchi di merda», comincia a diventare abbastanza problematico venire a capo delle varie modalità di svalvolamento che si contendono la scena. L’unica costante parrebbe il fatto che il bersaglio sono sempre e comunque coloro i quali non vogliono essere implicati in questo conflitto, combattuto da improbabili figure che provano ad accreditarsi come jihadisti, sgommando in camion per la Promenade des Anglais il 14 di luglio a Nizza, e altre altrettanto improbabili, che si cuciono addosso ruoli ancor più enigmatici sparando per strada a Monaco.
Anatole. È un quadro flippato, in cui non si sa più chi imita chi, chi agisce perché. Il giorno dell’anniversario del massacro di Utoya un diciottenne tedesco nato a Monaco di origine iraniana emula il terrorismo jihadista, insultando pubblicamente i turchi, a pochi giorni dal fallito colpo di stato in Turchia. In uno scenario del genere, da romanzo di Ballard, che ne so, l’idea di Islam e di crociata alle quali i soi-disant soldatini dello stato islamico fanno riferimento appaiono con evidenza ancora maggiore come invenzioni basate su suggestioni rimasticaticce, prive di ogni fondamento storico e culturale in genere. Dall’attentato omofobo al Pulse la cosa è andata avanti in direzioni assurde, fuori controllo, non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche da quello dell’analisi. La situazione ha preso una piega paratattica, non più riconducibile ad una ragione rassicurante. Fino a Nizza si poteva osservare, come facevamo, che i terroristi cosiddetti islamici ripetano la loro cosa, poiché trovano continue conferme alla loro idea sbagliata, approssimativa, infondata che essi stiano davvero animando un vero jihad contro i “crociati”. Infatti, quella modalità di funzionamento terrorista ha innescato un meccanismo di risposta tale che coloro i quali si schierano contro i terroristi dicendo che l’islam è cattivo, danno loro ragione, confermando l’idea che sia in corso una guerra santa, finendo appunto per dimostrare l’argomento falso sostenuto dai terroristi, che appunto il loro sia un jihad contro i “crociati”. Ma nel momento in cui un diciottenne tedesco di origine iraniana ammazza la gente a caso in mezzo alla strada alla maniera dei soi-disant jiahadisti, il cortocircuito del terrore che si è prodotto va anche oltre queste categorie di analisi.
Lorenzo. Di fronte a fatti di questo tipo e alla quasi afasia che producono diventa davvero evidente al punto in cui si è arrivati ci si rende conto con sbigottimento che in realtà ognuno sta parlando per conto suo, diciamo che “parla ai suoi”, mentre chi ci rimette, sia in occidente che in oriente, sono gli inermi. È una guerra che ha come bersaglio chiunque non la combatta e non la senta propria, come si capiva dagli attentati al Bataclan, al Carillon, ma anche ad Utoya.
Anatole. Negli speciali di approfondimento ti ritrovi lo psichiatra che ti spiega la differenza tra il quadro dell’attentatore e la depressione, un’amico nostro scrittore che, siccome scrive bene di adolescenti flippati, allora chiediamogli come può succedere che uno a diciotto anni invita gli amici al Mc Donald per ammazzarli, la giornalista tedesca, alla quale domandano come ci si senta ad essere tedeschi oggi, uno tornato dall’Iran tre anni fa che non ha idea come spiegarti cosa significhi essere bullizzato in un ex quartiere operaio del centro di Monaco per un tedesco di 18 anni di origine Iraniana. Non si capisce che risultato dovrebbe venire fuori dalla somma di queste argomentazioni.
Lorenzo. Il problema è che questa emergenza funzionerebbe bene dal punto di vista dell’informazione se ogni fatto rispondesse ad una matrice logica di carattere gerarchico, cosa che, come s’è visto già al Pulse, non è. Lo schema del jihad contro i crociati viene male, non torna, e allora salta tutto, anche tra i cosiddetti “buonisti”. Cioè, non puoi dire che “NOI andiamo da LORO e li distruggiamo, gli rubiamo tutto, facciamo i nostri interessi senza meno, annientiamo la loro cultura, insomma abbiamo da sempre rotto il cazzo a LORO e quindi LORO ora rompono il cazzo a NOI”. Primo perché non è chiaro chi siano LORO e chi siamo NOI, secondo perché quelli a cui rompiamo il cazzo NOI non sono gli stessi LORO che ci vengono a rompere il cazzo.
Anatole. Il caso di Monaco è prototipico. Per quanto ci si voglia sforzare di ricondurre il fatto a categorie già precostruite, cioè i cattivi jihadisti che ammazzano gli occidentali inermi, non si riesce a situare le ragioni del gesto fuori dal contesto in cui maturano, cioè la Germania stessa, segnatamente il quartiere centrale un tempo operaio nel quale l’attentatore era cresciuto. Non è, per capirci, uno di quelli che NOI occidentali siamo andati a sfruttare a casa sua in oriente. Pare confermato che la strage non sia il gesto impulsivo di un pazzo, essendo stato pianificato, anche se in maniera molto approssimativa. L’attentatore aveva certamente intezione di commettere una strage e faceva ricerche su come fare, magari in una scuola, ma non deve aver trovato motivazioni sufficienti nel libro che stava leggendo, sulle ragioni dei mass killer di studenti. Piuttosto era venuto alla conclusione che un centro commerciale sarebbe stato preferibile. Pare anche confermato dall’investigatore Robert Heimberger che l’attentatore avesse inviato un post fasullo da un account Facebook hackerato per invitare i contatti ad una promozione di Mc Donald. Con tutta evidenza non aveva nessun collegamento con lo Stato Islamico, cosa d’altra parte abbastanza comprensibile, trattandosi di un tedesco nato a Monaco di origini iraniane, l’antitesi per eccellenza del jihadista “sunnita”. Si può dire che non avesse motivazioni di carattere politico in assoluto e fosse, piuttosto, aggravato da un punto di vista psichiatrico. È evidente che quando uno configura il discorso nei termini di un generico NOI e di un ancor più generico LORO viene fuori un argomento necessariamente banalizzante non solo di chi sono LORO, come si vede bene sulla base del caso di Monaco, ma anche di chi siamo NOI. Cioè, il diciottenne che ha sparato a Monaco non era né LORO, né NOI, chi era allora? Anche il collegamento diretto tra lo sfruttamento delle materie prime, del petrolio, della forza lavoro dislocata nel cosiddetto terzo mondo in generale e il benessere dello studente che si sta facendo un bicchiere al Carillon mentre viene crivellato di colpi di arma automatica è tutto da dimostrare. Cioè, i NOI che andrebbero a rompere il cazzo a LORO non sono gli stessi NOI che vengono messi sotto sulla Promenade des Anglais da un camion impazzito. Il semplice fatto di esser nata a Nizza piuttosto che a Aleppo non rende automaticamente una bambina di due anni responsabile del colonialismo, delle guerre o della sospensione delle libertà in Siria. L’argomento secondo il quale siamo l’occidente quindi siamo tutti colpevoli è evidentemente ideologico e rimanda ad una visione della storia che mescola in maniera sincretistica il peggio del meccanicismo idealista con il più becero storicismo tradizionalista, arrivando a conclusioni speculari rispetto a quelle consuete della modernità, cioè la colpevolizzazione a trecentosessanta gradi dell’imperialismo coloniale, invece della sua legittimazione celebrativa. Ma si vede alla fine la debolezza di questo post-colonialismo postmoderno, che si riduce ad argomenti terzomondisti dei ‘settanta, quando alla orrenda mensa della scuola ti dicevano che dovevi mangiare tutto perché eri fortunato che non morivi di fame in Africa.
Lorenzo. Prendiamo il caso della Siria (e dei siriani). Per diversi anni un efferato dittatore, Bashar al-Asad, ha fatto un massacro, ha distrutto il suo paese per rimanere al potere. Gli si opponevano dapprima molti attivisti, quasi tutti ormai uccisi, incarcerati e torturati o fuggiti dal paese, poi uomini armati che, dapprima animati da propositi nobili, sempre di più – ricevendo soldi da paesi come Arabia Saudita e Qatar – viravano verso il jihadismo. Un jihadismo la cui agenda era però sempre “siriana”, cioè l’obiettivo era abbattere il tiranno. A un certo punto di questa macelleria ha approfittato l’ISIS, un’organizzazione di natura criminale-mafiosa a guida iraqena che ha messo in piedi la sua agenda in siria sfruttando, in termini di propaganda, i crimini del regime così come tutta la retorica anti-occidentale nel momento, molto tardivo, in cui l’Occidente è effettivamente sceso in campo. Ma l’’ISIS come prima cosa ha iniziato a sparare contro quegli uomini in armi, anche quelli che pure si erano jihadizzati un bel po’ (li chiamano “sahwa”, ma non mi metterò a spiegare il perché). Il suo primo obiettivo furono all’inizio tutti gli attivisti e tutti i combattenti che si opponevano ad Asad. Non a caso Asad li lasciava fare. Loro dovevano fare egemonia e ci riuscirono a Raqqa, la terza città della Siria, a suon di esecuzioni sulla pubblica piazza e “gestione della barbarie” ma non in altre aree, dove furono espulsi e dove tuttora non hanno grandi appigli (sebbene poi, dai e dai…). Ora, questi dell’ISIS, cioè quelli che rivendicano attentati in Occidente, sono quei LORO di cui parlano i semplicioni di cui sopra? Rappresentano davvero LORO? Cioè, sono LORO quelli da cui NOI andiamo e che NOI distruggiamo? Mi sembra di no. Quelli dell’ISIS che terrorizzano l’Occidente sono semplicemente degli infami rosiconi spesso imbevuti di una retorica che suona così: “VOI avete sempre rotto il cazzo a NOI e quindi NOI ora rompiamo il cazzo a VOI”. Molti ci cascano dentro come degli allocchi. Ricordo ancora tal Oussama Abu Musab, un operaio del varesotto simpatizzante dell’ISIS che si era messo a commentare sulla mia bacheca e poi, dopo essere stato espulso dall’Italia, essere andato prima dai nonni in Marocco e poi in Svizzera dalla moglie per essere infine espulso anche dalla Svizzera e finire in Siria dove sembra sia morto in circostanze che non conosco. Questo Oussama, quando postavo cose sulla Siria, mi seguiva fin se riportavo i crimini di Asad. Metteva proprio dei làic. Poi quando riportavo i crimini dell’ISIS partiva per la tangente, diventando cospirazionista e affermando esattamente ciò che la vulgata di cui sopra vuole. Il fatto è che lui non era minimamente uno di LORO, uno di quelli che moriva sotto le bombe. Al massimo empatizzava, ma attraverso il filtro sbagliato, il filtro dell’ISIS. L’ISIS gli aveva spiegato che quelli erano suoi fratelli, dei musulmani come lui vessati da un Occidente diabolico, e lui ci credeva, non capendo che quelli lì con l’ISIS non avevano niente a che fare, che l’ISIS stava usando quella carneficina, ci stava mettendo su il cappello. Quello dell’ISIS è un discorso speculare a quello fatto in principio. E continuare a farlo, quel discorso, significa dare ragione all’ISIS. Il problema insomma, ancora una volta, è sdoganare quelli dell’ISIS quando quelli dell’ISIS non sono affatto quelli che si pensano di essere né che qualcuno da queste parti pensa che siano: non sono dei vendicatori degli sconfitti, anche se si atteggiano come tali. Quelli dell’ISIS, parlo dei capi e di quelli che gli credono, non della soldataglia locale che segue tutto un altro treno, sono invece efferati e cinici pezzi di merda che con quei LORO non hanno niente in comune se non per il fatto che rubano a LORO la terra, la libertà, il pane e la speranza. Esattamente come i NOI della vulgata.
Anatole. Anche secondo certa “sinistra” ancora oggi qualsiasi forza si contrapponga all’occidente cattivo diventa in qualche misura spiegabile e tutto sommato accettabile in base al paradigma della vendetta degli sconfitti della storia, che ha come esempio caratteristico il tifo per gli indiani contro i caubbòy. E le categorie devono essere quanto più possibile inclusive, cioè tutti gli indiani da una parte, tutti i caubbòi dall’altra, perché da bambini quando giocavi a acchiapparella era così che funzionava.
Lorenzo. Certo. E intanto quei LORO che NOI abbiamo sfruttato davvero continuano a prendersi le bombe di Asad in testa, a farsi sgozzare per motivi futili, a morire di fame, di stenti e di guerra. E, quando smettono di vessarli, ci hanno anche il coraggio di uscire di nuovo in piazza coi cartelli per chiedere libertà e dignità. Quelli a cui chiudiamo la porta in faccia quando arrivano dai Balcani o che lasciamo morire in qualche barcone.
Anatole. Sì, l’unica costante è il fatto che le vittime vere di questa follia sono tutti quelli che per ovvie e comprensibili ragioni vorrebbero vivere la loro vita a modo loro, senza farsi coinvolgere in una guerra anacronistica. Ma questo lo diciamo ormai da anni invano.
Lorenzo. Fausto, non so se ti ricordi chi è, ha definito le persone che fanno quei discorsi riportati sopra dei “giustificazionisti”. Io non so bene come definirli. Secondo me lui non coglie il punto della trasversalità. Invece il problema è questa suddivisione farlocca fra noi e loro, a mio modo di vedere esiziale, che prende nel mucchio. Ciò che cambia è la reazione psicologica a quel pensiero. Da un lato abbiamo chi dice: “E’ naturale, ce lo dovevamo aspettare, ora ce la becchiamo in pieno e basta”. Dall’altro ci hanno invece per esempio una paura smodata dei profughi siriani, fanno muri, chiudono le frontiere o intensificano i controlli, pensando questa cosa: “ora LORO verranno a distruggerci perché è colpa nostra”. Ma LORO chi? Venire a distruggerci? I siriani sono per un terzo profughi, si parla di milioni e milioni di persone. I morti civili (centinaia di migliaia) nella guerra siriana sono 10 volte tanto (decine di migliaia) dei morti in combattimento. Quanti siriani si sono fatti esplodere in Europa? Quanti hanno eseguito attacchi terroristici? Zero. Forse uno. A Parigi hanno ritrovato un passaporto siriano allo stadio. Era falso. Una testimonianza del business dei passaporti falsi.
Anatole. Se ci pensi è un problema di carattere identitario, che ci rimanda alla polarizzazione del discorso sulla crociata: si bipartisce il mondo in noi e loro, senza tenere conto delle infinite articolazioni, anche contraddittorie, di questi due concetti. Perché, in fondo, dietro tutto questo discorso di estremismo buonista si nasconde lo stesso spettro che campeggia sui vessilli dei sostenitori della Fallaci, la madonna sanguinante del nuovo crociato. Cioè il fatto che loro sono loro e noi siamo noi, siamo due “civiltà” diverse, configuriamo proprio due campi antropologici non contaminabili. Questa è la cosa che ho sempre trovato irritante del modo in cui il ragionamento si polarizza, che anche i buonisti “di sinistra” alla fine sono in imbarazzo rispetto al velo, alle usanze alimentari diverse, alle mosche che ti ronzano intorno tutto il giorno in Marocco o in Turchia, a tutta quella polvere, al fatto che a una certa, insomma, non è come da noi.
Lorenzo. Esatto. Al netto della buonistizzazione della sinistra ad opera della destra – su questo punto assolutamente vincente – di cui parlava Luigi Manconi qualche tempo fa, i buonisti – che si dichiarino di sinistra o meno – sono così: li si rintraccia proprio nel momento in cui tracciano questa linea noi-loro. Che poi questa cosa avviene a una certa, a partire dai ‘90 e molto di più ovviamente dall’11 settembre in poi. E’ figlia del rimosso “internazionalista”, forse. Cioè: per essere di sinistra non era proprio assolutamente fondamentale essere internazionalisti? E se poi il mondo è cambiato e quindi parliamo di Europa cambia qualcosa? Non credo. Mi ricordo che a metà degli anni ‘90 andai come inviato per un piccolo e benemerito giornale, Confronti, a un incontro a Strasburgo fra le realtà antirazziste europee giovanili, organizzato dall’UE. Fui molto orgoglioso di partecipare a una specie di ribellione: gli organizzatori volevano parlare di razzismo all’interno delle frontiere europee, noi volevamo aprire le frontiere contro ogni razzismo. Stiamo ancora messi così, forse peggio.
Anatole. Io mi ricordo di una volta che stavamo noi due in Tunisia, a Tozeur, ed è venuto a piovere. C’era un’umidità allucinante e non si riusciva a stare. Ci siamo rifugiati all’Hotel des Palmes, evidente baluardo del colonialismo francese, l’unico posto all’epoca dotato di aria condizionata. Si stava una bomba, una cifra meglio che fuori. Il fallacismo mi fa sempre l’effetto di quando senti il bisogno di rintanarti nella tua conforzòn, tipo quella volta, ma devi spiegarlo per forza, cioè giustificarti, sentendoti un po’ in colpa perché te lo puoi permettere e quelli fuori no. Soprattutto non si capisce perché dovresti giustificare il fatto che stai agonizzando di caldo e ti rifugi in un posto condizionato dicendo che LORO, quelli fuori, sono incivili e pregano per la pioggia e riescono a campare con quel clima solo perché sono tribbali. Quindi configuri la tua ricerca di benessere come l’effetto di un inevitabile scontro di civiltà e ti fai pure un negroni alla faccia loro, che sono incivili perché non bevono, ma poi quando vengono da NOI diventano tutti alcolisti e violentano le nostre donne perché sono repressi dalla religgione. In finale la verità è solo che senti caldo e non si capisce perché te la dovresti pigliare con chissà chi perché non sei all’altezza del clima. È allucinante. Si poteva dire “vattene al Club Mèd”, un tempo. Oggi no, perché se vai al Club Mèd LORO ti sparano, perché c’è la crociata e lo scontro di civiltà, eccetera.
Lorenzo. Assolutamente. E anzi per tracciare una linea di discrimine su questo tema ricordo altri due eventi di quell’estate tunisina. Quella volta che ci facemmo a piedi tutta la spiaggia di Mahdia: ci fermavamo nei resort e atteggiandoci da ospiti ci mettevamo sulle sdraio o scroccavamo un caffè – un atteggiamento che ancora oggi giudico molto sano. E quella volta che ci prendemmo uno pseudo-bungalow (leggi cubo di cemento surriscaldato senza finestre ricolmo di scarafaggi) a Kerkenna e la mattina dopo ci svegliammo al suono di “Talking about the revolution” di Tracy Chapman circondati da burrosi tedeschi che sorseggiavano bevande colorate. Cioè: si poteva parlare di rivoluzione con questa bevanda colorata in mano e qualcuno – laffuori – chiaramente rosicava, avendone anche un motivo. Era evidente il fatto che qualcuno rosicasse, mi chiedevo quando mai uno di LORO avrebbe aggredito il burroso tedesco o anche – per somma sfiga – anche me. Sono passati vent’anni e qualcuno ha pensato bene di dare un mitragliatore al rosicone, mentre quelli che sta cosa l’avevano capita, cioè i giovani rivoluzionari tunisini, dei resort si disinteressarono vieppiù perché il problema era il dittatore tunisino, non il burroso tedesco.
Anatole. Che poi il serio problema del mare a Kerkenna è che non ti puoi fare il bagno. Cammini tra i sassi con l’acqua alle caviglie per chilometri. Neanche se ti sdrai lungo fai veramente il bagno. Ma quanto è meglio Lido dei Pini?
Lorenzo. Vabbene, ora basta co sti ricordi. Riprendendo il filo, una variante del tema “rompere il cazzo” è: “noi abbiamo delle responsabilità e non facciamo niente”. Ma non è vero che non facciamo niente. Abbiamo delle responsabilità e diamo ragione a quelli sbagliati. E’ deprimente.
Anatole. Certo, non è che se invece fai il fricchettone restandotene a sudare nella branda di quell’albergo allucinante a tremila lire a notte dove dormivamo noi, allora devi tifare che qualcuno faccia esplodere l’Hotel des Palmes con tutti gli occidentali dentro, perché è colpa loro che fa caldo. E nessuna teoria del complotto potrà mai traformare un qualunque ospite dell’Hotel des Palmes in un responsabile del fatto che hai caldo.
Lorenzo. Io direi, inoltre, che ti poni il problema di sudare (il meno possibile) in branda quando è evidente che all’Hotel des Palmes non ci potrai stare tre mesi di fila. Ad esempio quando vai a fare un lavoro o a studiare, a fare una ricerca. Ci ho questo esempio paradossale. A Zanzibar conobbi un giovane antropologo americano che veniva ogni giorno all’Archivio Nazionale perché era l’unico posto, al tempo, in cui poter godere dell’aria condizionata senza sembrare un colonialista stronzo. Studiava “l’identità araba in Africa Orientale”. Faceva ricerca sul campo, lui.
Anatole. Ti faccio notare che l’antropologo americano è un ricordo.
Lorenzo. Ci hai ragione. Ma l’antropologo può servire come esempio per partire su un altro tema collegato. Urge un qualche ragionamento sul far politica in questo contesto.
Anatole. I tempi della politica non stanno appresso all’emergenza, quindi ogni iniziativa politica sembra segnare il passo. Solo il volontariato sembrerebbe funzionare come reazione automatica all’allarme costante, ad esempio nel caso dei rifugiati o delle guerre che si combattono davvero, quelle che di santo hanno davvero pochissimo, da una parte e dall’altra.
Lorenzo. La cronaca ti piglia sul presente e non lascia spazio all’approfondimento, che sarebbe sostanza dell’agire politico finalizzato a trovare soluzioni durature ai problemi. Invece i problemi coi quale ci confrontiamo, guerre, rigugiati, terrorismo, investono una dimensione di protagonismo emergenziale. Molto volontariato si spiega così, come una risposta all’emergenza. La politica ha i tempi lunghi e morti della militanza, quindi non acchiappa più, mentre il volontariato è rapido, adrenalinico, molto diretto, va sul bisogno concreto, dà soddisfazione immediata, come una botta di qualcosa di buono. È antidepressivo, mentre la politica è depressiva, troppa autocritica, troppe chiacchiere, poca azione, poca concretezza. Ma solo la politica basata sull’elaborazione critica di profondità può contribuire a demistificare i collegamenti abusivi tra i vari problemi, che risultano da sintesi di carattere ideologico.
Anatole. In effetti, la visione egemonica al momento condivide molti aspetti del complottismo tradizionale, proprio nel senso che vuole collegare a tutti i costi cose che non hanno un collegamento tra loro, o ne hanno uno davvero labilissimo.
Lorenzo. Certo, la visione egemonica, come i deliri complottisti, mira ad identificare una ipotassi dove in apparenza si registra una paratassi. È il bisogno di trovare un collegamento gerarchico tra i fatti, una ragione che spieghi tutto in maniera coerente, piuttosto che sforzarsi di immaginare uno meccanismo lineare di sviluppo in grado di far emergere il significato. Se l’attentatore omofobo di origini afgane del Pulse, quello tunisino di Nizza, quello tedesco di origini iraniane di Monaco che ce l’ha coi turchi e il golpe turco istesso fossero soltanto le pedine di un complotto mirato ad un qualsiasi fine, ecco che la spiegazione suonerebbe rassicurante. C’è una regia, non preoccupiamoci. Cioè, non è che può davvero accadere di tutto ovunque in qualsiasi momento, ecco.
Anatole. Abbiamo anche gettato delle basi per affrontare la questione del complottismo, che non siamo riusciti a discutere. Speriamo davvero che prima della prossima puntata nessun altro inerme debba rimetterci la pelle in mezzo alla strada mentre prova a vivere la propria vita. Né in Europa, né in Medio Oriente, né altrove nel mondo.
Lorenzo. Hai detto bene: altrove nel mondo. 80 morti a Kabul. E raccontarne il senso significherebbe aprire il file Afghanistan. Per oggi è troppo. Faccio solo notare che i giornali non aprivano con l’Afghanistan da almeno tre ziliardi di click.
Anatole. Magari salta fuori anche chi ti collega l’attentore del Pulse di origine afgana al fatto che un gruppo di poveri cristi manifestava a Kabul per avere l’energia elettrica. Magari intervistano il levriero afgano di un ex marine, che ne sai. Roba che alla fine è meglio il sano complottismo.
 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
Massimo Zamboni, L’eco di uno sparo , Einaudi, 2015, 186 pagine
È il febbraio del 1944, la guerra fratricida nel cuore dell’Emilia sta vivendo forse il suo momento di massima recrudescenza. Ulisse, fascista della prima ora, viene ucciso in una imboscata da un gruppo di partigiani. Nelle stesse terre, pochi mesi prima, erano morti i sette fratelli Cervi, fucilati dai repubblichini. Molti anni appresso, in pieno boom economico, quei fatti troveranno un nuovo epilogo con un altro omicidio. Un regolamento di conti, forse, fra appartenenti dello stesso schieramento.
Nulla di inventato, semplice verità storica. Eppure il racconto di Massimo Zamboni ha il passo e il respiro della migliore letteratura nazionale. Forse proprio perché l’autore ha deciso di non camuffare la storia della sua stirpe in un abito accattivante. Scrive non da storico, essendo coinvolto in prima persona, ma neppure da agiografo familiare. L’eco di uno sparo è un libro inclassificabile, in questo sta la sua forza. Sa avvincere come un romanzo, ma non cade mai nel romanzesco, consapevole di quanto una deriva finzionale possa depotenziare la verità storica.
Zamboni si porta adosso, persino nel primo e secondo nome ereditati dai nonni, l’adesione alla parte sbagliata della storia dell’intera sua famiglia. La sua storia personale si allontanerà da quelle scelte, ma l’affetto per le persone, per i corpi quasi, sa rendere umani e compassionevoli i ricordi. È della terra grassa emiliana che si parla in questo libro. Dei suoi contadini e artigiani, delle bestie e degli animali (cose ben diverse). E lo fa grazie ad una voce che fa fatica a stare compressa in un italiano pacificato, cercando nel parlato dialettale il ritmo necessario per raccontare una autentica epica del territorio.
(pubblicato su Cooperazione n° 20 dell’ 11 maggio 2015)

di Bernardo De Luca
Emergenza Napoli. Questo sintagma s’è attagliato alla città come una vera e propria seconda natura; è noto come ogni aspetto della vita civile a Napoli diventi una emergenza: che si parli di miseria o classi dirigenti, malavita o urbanistica si arriverà prima o poi a quel punto di crisi dopo il quale i media sono autorizzati a parlare di “emergenza”, per cui nella mente di ogni individuo, e prima di tutto in quella dei suoi abitanti, si strutturano due rappresentazioni della città ben cristallizzate nell’immaginario comune. La prima è la Napoli da salvare, per la quale ci si rivolge ad un indeterminata entità plurale e gli s’ingiunge: «Fate presto», come recitava un celebre titolo giornalistico all’indomani del terremoto dell’Ottanta. L’altra è la Napoli dannata, insalvabile, perché alla fine di ogni emergenza ne sorgerà un’altra, oppure perché quell’emergenza vive della sua eccezionalità, e non è pensata per risolversi ma per cronicizzarsi: la dannazione è appunto l’unica sua condizione d’esistenza, come un malato che vive della sua malattia.
La definitiva solidificazione del concetto emergenziale intorno allo spazio urbano è stata forse “l’emergenza rifiuti” che cominciò nel 2008, portando a galla le conseguenze antropologiche di un disastro urbano e naturale che riguardava, in ultima istanza, tutti: molta differenza c’è tra l’interramento dei rifiuti e la loro fuoriuscita sulla terra emersa. Proprio quest’aspetto pone dei problemi sullo statuto di verità del concetto emergenziale; nella maggior parte dei casi, la parola emergenza falsifica e nasconde i processi carsici che hanno portato all’evento catastrofico.
Alla luce di questo irrigidimento semantico, se associo il concetto di emergenza al campo della poesia che si scrive oggi a Napoli (o che si scrive altrove, ma provenendo da Napoli) non posso che tradire il suo significato; o meglio, non posso che collocarmi tra i territori incerti delle sfumature semantiche, recuperando da una parte la radice etimologica della parola “emergenza”, dall’altra evidenziando i tratti semantici che condivide con suoi sinonimi. Da osservatore, ad esempio, prendo in prestito gli occhi del geologo e vedo nella buona stagione poetica che si vive a Napoli le conseguenze di un’emersione lenta che vede i suoi inizi alla fine degli anni Ottanta con il Gruppo 93 e sfocia poi negli anni zero e oltre. Questo non perché ci sia una linea diretta tra quella esperienza e le attuali, ma perché gli anni Ottanta hanno rappresentato un primo momento di indipendenza di Napoli dalle città egemoni (semmai di alleanza con altri centri periferici, vedi Genova), a favore della creazione di un humus da cui poi sarebbero nate diverse e varie produzioni, fosse anche solo in contrapposizione alle istanze del Gruppo 93. Inoltre, se includiamo nel fermento degli anni Ottanta la presenza di autori addentro al dibattito come Gabriele Frasca, deduciamo che è proprio in quegli anni che comincia a circolare un’aria in città con la quale, bene o male, bisogna fare i conti.
Ad esempio, alcuni autori si sono posti nel solco del postmodernismo critico del Gruppo 93; basti pensare alla produzione di Ferdinando Tricarico che nei suoi Precariat 24 acca e La famigliastra, ritraduce le istanze comico-critiche del movimento collegandole all’esperienza novecentesca di un Palazzeschi. Oppure, sebbene di non immediata evidenza, l’influenza della stagione neometrica, di cui Napoli fu uno dei centri propulsori, ha di sicuro agito sulla produzione di Vincenzo Frungillo, poeta nato e formatosi a Napoli e poi emigrato a Milano. Uguale discorso può farsi per un altro poeta, Daniele Ventre, che aggiunge però al neometricismo un surplus di scavo archeologico: oltre a prosodia e schemi della tradizione italiana, infatti, troviamo nel suo repertorio metrica barbara e traduzioni isometre dei classici antichi latini e greci. Dunque, la prima declinazione del concetto “emergenza” è quella che di primo acchito va in direzione opposta al senso comune: l’emersione della scena poetica attuale è un processo lento che in almeno due-tre decenni s’è nutrito dei fermenti culturali e sociali della città.
Passando ora alla seconda accezione dell’emergenza, bisogna notare come, a differenza del romanzo, di rado Napoli diventi la protagonista nelle opere di poesia. Probabilmente, ciò è dovuto alla diversa natura del genere letterario, difficilmente adatto a descrivere lo stato di cose urbano: è molto raro, cioè, che lo sfondo assurga a primo piano. Quando ciò accade, tuttavia, la città sembra farsi allegoria di qualcosa che la trascende, un sintomo che non riguarda più gli abitanti di uno spazio circoscritto, ma dinamiche generazionali e quantomeno occidentali. È il caso, ad esempio, della Napoli di La zona rossa di Francesco Filia, la città che ospitò il Global Forum il 17 marzo 2001 e le proteste contro l’assetto politico mondiale: nel poemetto, i protagonisti si muovono sì tra i «ciottoli di pietra lavica» della città, ma sono immessi in un meccanismo che supera di gran lunga lo scenario locale in cui si svolgono i fatti. Oppure, si pensi alla poesia di Carmen Gallo, che con la sua raccolta Paura degli occhi pare voler obnubilare l’esterno, cancellarlo dalla percezione dell’organo della vista; eppure, quanto fumo di roghi penetra negli interstizi degli interni in cui si trova il soggetto poetico. In sostanza, ciò che fa Gallo non è molto differente da ciò che fece un Zanzotto all’indomani della guerra con l’esordiale Dietro il paesaggio, nel quale l’apparente idillio celava il brulicare dei traumi storici. E questo è un nodo che mi pare centrale: Napoli è uno spazio urbano che ancora si presenta come fattore scatenante traumi individuali e collettivi. Ciò mi dà la possibilità di delineare il campo della seconda accezione di emergenza: l’urgenza, il premere della città e dei suoi traumi; un’urgenza che, al pari dell’emersione, si presenta come processo lento e cronico, come accumulazione di vicende e narrazioni che sedimentano nella psiche dei suoi abitanti e possono trovare una più o meno problematica formalizzazione poetica.
Molti sono i nomi che in questa prima analisi mancano; tuttavia mi pare che ci sia del materiale per affrontare una discussione nella prossima manifestazione di Tu se sai dire dillo, al di là dei campanilismi e cercando di comprendere se effettivamente le voci che scrivono o si sono formate a Napoli abbiano, al di là della mappa della città, un terreno comune.
[Questi appunti sono stati richiesti a Bernardo De Luca per presentare la serata dedicata ai poeti napoletani nell’ambito della quinta edizione della rassegna Tu se sai dire dillo prevista a Milano, presso Bioforme,via Aosta-2, tra il 21, il 22 e il 23 ottobre 2016. Il titolo di “Emergenza poetica a Napoli” è stato formulato da me in seguito ad una serie di incontri a Napoli con alcuni poeti della città. La rassegna prevede altri temi, tra cui una riflessione critica su ciò che è stato il Gruppo 93 a ventitrè anni dalla sua conclusione. Su questi due argomenti rimando alle registrazioni sul blog Poesia da fare, precisamente per il Gruppo 93 qui e qui e per la poesia a Napoli oggi le riflessioni a partire dall’articolo di De Luca qui Per il programma in dettaglio della rassegna si può leggere qui B.C.]
Elba Book Festival SECONDA EDIZIONE
FESTIVAL DELL’EDITORIA INDIPENDENTE
26-29 luglio 2016
Rio nell’Elba
http://www.elbabookfestival.com/
MARTEDÌ 26 LUGLIO | primo giorno
ORE 18.00 – 24.30 APERTURA BOOKSHOP | PIAZZA DEL POPOLO
ORE 18.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | APERTURA DEI LAVORI
Saluto del Sindaco di Rio nell’Elba Arch. Claudio De Santi
Saluto del Comune di Ferrara, Assessore Dott.ssa Caterina Ferri
Saluto Università per Stranieri di Siena
Saluto Presidente Acqua dell’Elba, Arch. Fabio Murzi – Main Sponsor
Saluto degli Organizzatori di Elba Book Festival
ORE 19.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | PREMIO APPIANI
PRESENTA:
Paolo Chillè, giornalista di Tenews
ORE 20.30 – 24.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | DEGUSTAZIONI
Aperitivo con prodotti tipici elbani:
VisitElba
Aperitivo con prodotti tipici ferraresi:
VisitFerrara
ORE 21.30 – 22.00 | PIAZZA MATTEOTTI | MAIN SPONSOR
A sharing experience.
Presentazione del Social Book “Essenza di un’Isola”
Intervengono:
Fabio Murzi, Presidente Acqua dell’Elba
Norman La Rocca, Direttore Marketing Acqua dell’Elba
ORE 22.00 – 24.00 PIAZZA MATTEOTTI | DIBATTITO
BIBLIOTECHE, GRANAI CONTRO L’INVERNO DELLO SPIRITO
PRESENTA:
Elena Maestrini, giornalista di ElbaReport
INTERVENTI:
Andrea Kerbaker, giornalista e scrittore
Giuseppe Marcenaro, giornalista e scrittore
Matteo Codignola, editor e traduttore di Adelphi Edizioni
MODERA:
Gloria Peria, Responsabile degli archivi storici comunali dell’Isola d’Elba
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO | secondo giorno
ORE 10.00 – 12.00 COLAZIONE CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
10.00– 10.40 Bar Cipolla, spazio a cura di Red Star Press.
10.40 – 11.20 Bar Il Rifugio del Nottolo, presentazione di Srebrenica. La giustizia negata di Luca Leone, Infinito Edizioni (2015).
11.20 – 12.00 Bar La Piazza, spazio a cura di Edicola Ediciones.
ORE 10.00 – 12.00 IL LABORATORIO DEI BIMBI | SCUOLA “EMILIO AGOSTINI”
ALLA SCOPERTA DEI GEROGLIFICI, a cura di Edizioni Saecula.
ORE 18.00 – 24.30 APERTURA BOOKSHOP | PIAZZA DEL POPOLO
ORE 18.30 – 19.30 APERITIVO CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
18.30 – 19.30 Bar Cipolla, presentazione di Morte di cioccolato di Michela Gecele, Forme Libere (2016).
18.30 – 19.30 Bar La Piazza, presentazione de Isola d’Elba. I taccuini dell’arcipelago toscano, EDT (2016). A cura di Elbadautore e Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
ORE 19.30 – 20.45 SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | TAVOLA ROTONDA
LIBRO, SCUOLA, NUOVE CITTADINANZE
RELATORI:
Tahar Lamri, scrittore
Mihai Butcovan, scrittore
Carla Bagna, Università per Stranieri di Siena
Silvia De Marchi, editor e collaboratore parlamentare
MODERA:
Luca Lunedì, giornalista di Qui News Elba
ORE 20.30 – 24.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | DEGUSTAZIONI
Aperitivo con prodotti tipici elbani:
VisitElba
Aperitivo con prodotti tipici ferraresi:
VisitFerrara
ORE 21.45 PIAZZA MATTEOTTI | SPONSOR
Saluti del Dott. Montalbetti, Direttore Generale del Consorzio COMIECO
ORE 22.00 – 22.45 PIAZZA MATTEOTTI | LETTURE DAL CARCERE
ORE 22.45 – 24.30 PIAZZA MATTEOTTI | FILM DOCUMETARIO
ASMARINA di Alan Maglio e Medhin Paolos
(durata 69 min. – Italia 2015)
I registi saranno presenti alla proiezione
GIOVEDÌ 28 LUGLIO | terzo giorno
ORE 10.00 – 12.00 COLAZIONE CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
10.00 – 11.00 Bar il Rifugio del Nottolo, spazio a cura di Edizioni Myra.
11.00 – 12.00 Bar Cipolla, spazio a cura di Exorma Edizioni.
ORE 10.00 – 12.00 IL LABORATORIO DEI BIMBI | CASA DEL PARCO “Franco Franchini”
ALLA SCOPERTA DEI FONDALI MARINI a cura di Chiara Luciani, biologa marina.
ORE 18.00 – 24.30 APERTURA BOOKSHOP | PIAZZA DEL POPOLO
ORE 18.30 – 21.45 APERITIVO CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
18.30 – 19.30 Bar Cipolla, Le migliori 99 maison di Champagne, a cura di Luca Burei e Alfonso Isinelli, Edizioni Estemporanee (2016)
19.30 – 20.30 Bar La Piazza, presentazione di Andalù di Vittorio Cotronei, postfazione di Paolo Ferruzzi, MdS Editore (2015)
20.30 – 21.45 Piazza Matteotti, reading musicale poeti Persephone e laboratorio di scrittura creativa, chitarre (Francesco Saverio Porciello e Alessandra Emprin Gilardini), regia di Marinella Da Roit.
ORE 19.00 – 20.30 SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | TAVOLA ROTONDA
DIRITTO D’AUTORE E NUOVE CONFIGURAZIONI DELL’EDITORIA INDIPENDENTE IN ITALIA.
RELATORI:
Roberto Caso, Università degli Studi di Trento.
Simone Aliprandi, docente, avvocato e fondatore del progetto Copyleft-Italia.
Paolo Primavera, editore
MODERA:
Mario Sileo, docente e responsabile del progetto ComunEbook
ORE 20.30 – 24.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | DEGUSTAZIONI
Aperitivo con prodotti tipici elbani:
VisitElba
Aperitivo con prodotti tipici ferraresi:
VisitFerrara
ORE 22.00 – 23.00 PIAZZA MATTEOTTI | TEATRO
THE RAVISHING BALLAD
Compagnia di Teatro KUBLAKAN, regia di Elisabetta Bianca
ORE 23.15 – 24.15 PIAZZA MATTEOTTI | GIOCOLERIA
META’ E MAVA’
VENERDÌ 29 LUGLIO | quarto giorno
ORE 10.00 – 12.00 COLAZIONE CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
10.00 – 10.40 Bar Cipolla, spazio a cura de Editrice Il Sirente
10.40 – 11.20 Bar La Piazza, spazio a cura di NN Editore.
11.20 – 12.00 Bar il Rifugio del Nottolo, presentazione di Migrando di Giulio Gasperini, END (2014).
ORE 10.00 – 12.00 IL LABORATORIO DEI BIMBI | SCUOLA “EMILIO AGOSTINI”
Presentazione di Scacciapensieri – Poesia che colora i giorni neri, AA.VV., Mille Gru Edizioni (2015).
Laboratorio “Poesia e pop-up” (dai 6 anni in su).
ORE 18.00 – 24.30 APERTURA BOOKSHOP | PIAZZA DEL POPOLO
ORE 18.30 – 19.30 APERITIVO CON L’EDITORE | PIAZZA DEL POPOLO
18.30 – 19.30 Bar Cipolla, presentazione di Sorgenti che sanno. Acque, specchi, incantesimi, AA.VV., a cura di Francesca Matteoni e Cristina Babino, La Biblioteca dei Libri Perduti (2016).
18.30 – 19.30 Bar il Rifuglio del Nottolo, presentazione di Con un piede in acqua e l’altro sulla terra— Acquarellando lungo la costa da Roma a Luni di Claudio Jaccarino, La Memoria del Mondo (2010).
18.30 – 19.30 Bar La Piazza, spazio a cura del Gruppo scrittori senesi.
19.30 – 20.30 Piazza Matteotti, presentazione di Demone dentro di Mattia Iacono, Tunué Edizioni (2016).
ORE 15.30 – 22.30 SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | ILLUSTRATION MARATHON
FERRO a cura della casa editrice Kleiner Flug e di D’Uva Srl.
ORE 20.30 – 24.30 | SALOTTO BUONO | TERRAZZA DEL BARCOCAIO | DEGUSTAZIONI
Aperitivo con prodotti tipici elbani:
VisitElba
Aperitivo con prodotti tipici ferraresi:
VisitFerrara
ORE 21.00 – 21.15 PIAZZA MATTEOTTI | PREMIO DEL PUBBLICO
ORE 22.30 – 24.00 PIAZZA MATTEOTTI | CONCERTI
FILARMONICA PIETRI dirige il Maestro Manrico Bacigalupi
di Giuseppe Cossuto
Una delle istituzioni più importanti degli Ottomani fu quella degli “Schiavi della Porta”, i kapikulu. Furono costoro a conquistare e sostenere una formazione statale che amministrava tre continenti fin dai tempi del sultano Murad I (1326-1389).
Erano un’efficientissima macchina burocratica e da guerra, sotto diretto comando del Sultano.
La particolarità di questa istituzione è che i membri della stessa provenivano essenzialmente dal devsirme, ovvero dalla “raccolta” periodica di ragazzi cristiani, da educare nella religione islamica e da selezionare, a seconda delle capacità e delle attitudini dei singoli, per i diversi servizi, sia militari che amministrativi.
L’istituzione venne fondata da Murad (probabilmente di madre greca) per avere una struttura di fedelissimi al fine di contrastare gli altri signori turchi che potevano mettere in discussione il suo potere e, nei primissimi tempi, quando ancora la Casa di Osman era una piccola dinastia turcomanna anatolica, nei ranghi dei kapikulu entravano i ragazzi rapiti durante guerre e, soprattutto, durante le scorrerie.
Gli “Schiavi della Porta” avevano generalmente l’obbligo del celibato, il che permetteva allo Stato di disporre dei loro beni alla loro morte.
Una macchina efficientissima, quindi, che aveva come punto di forza una particolare fanteria, quella dei giannizeri (yeni çeri: la nuova milizia).
Tuttavia, con la crescita dell’impero, i membri del devsirme, che condividevano comuni caratteri morfologici, culturali e linguistici (dal XVI secolo erano ormai quasi prevalentemente di origine slava), erano diventati una vera e propria “nuova etnia” che si differenziava da tutte le altre dell’impero e che incarnava e rappresentava l’impero stesso, ovvero gli Ottomani (osmanli).
Questa consapevolezza si diffuse tra di loro, pienamente, verso la fine del XVI secolo e, nei primissimi anni del XVII già abbiamo delle testimonianze scritte da membri kapikulu che si identificano come unici “ottomani”. Sono uomini dello Stato, differenti dagli altri sudditi dell’impero, sudditi che essi amministrano e controllano militarmente come burocrati, poliziotti e persino vigili del fuoco.
E’ in questo stesso periodo che i giannizzeri riescono ad ottenere la fine dell’obbligo del celibato, a non fare più esclusivamente vita cameratesca, e a dedicarsi anche ad attività parallele, come il commercio. Allo stesso tempo fanno entrare nei ranghi dello Stato i propri figli.
In parallelo alla perdita di forza di combattimento, vengono autorizzati alcuni arruolamenti di turchi etnici e, nel 1683, il sultano Murad IV, abolì del tutto il devsirme.
Oramai tutto il sistema di controllo dello Stato era basato quasi esclusivamente sull’ereditarietà di una vera e propria casta di salariati dallo Stato capace di imporre il proprio volere, anche violentemente, addirittura ai Sultani e di organizzare colpi di Stato o di ritagliarsi territori da governare autonomamente.
Altresì, questa casta praticamente impermeabile di statali, era fieramente refrattaria a qualsivoglia innovazione, specialmente per quanto riguardava le istituzioni ed i costumi sociali.
In un impero che segnava il passo alle innovazioni tecnologiche dell’Occidente, costoro continuavano ad opporsi a qualsivoglia necessario cambiamento e miglioria.
Stanco di questa situazione il Sultano Mahmud II organizzò un’azione molto simile ad un colpo di Stato contro questi statali, il 16 giugno 1826.
Il Sultano inalberò lo stendardo del Profeta, e i muezzin chiamarono dai minareti il popolo per riversarsi nelle strade al fine di sostenere il rinnovato esercito imperiale ispirato alle armate europee e porre fine al secolare potere dei giannizzeri, che in quell’anno erano circa 135.000.
La strage dei giannizzeri fu terribile, e così le epurazioni successive nei ranghi dello Stato e, come atto fortemente simbolico vi fu la distruzione tramite cannoneggiamento delle caserme occupate dai giannizzeri.
Venne altresì dichiarato fuorilegge il loro ordine religioso, quello dei Bektashi, i confratelli dei quali vennero perseguitati e banditi, ma continuarono ad esistere vivendo in ambienti religiosamente sincretici, soprattutto nei Balcani, nei luoghi da dove gli antenati dei giannizzeri provenivano.
Questa sollevazione popolare diretta dall’alto venne chiamata Vaka-i Hayriye “Il Fausto Evento” a Costantinopoli mentre, al contrario, in alcune località balcaniche venne detta Vaka-i Şerriyye, “L’Evento Sfortunato”.
Dopo la distruzione delle caserme dei giannizzeri, la concezione di “ottomano” cambiò abbastanza velocemente ma quasi sempre traumaticamente: dapprima incluse i soli musulmani sunniti, in seguito tutti i sudditi dell’Impero, senza distinzione di confessione religiosa che poterono entrare gradualmente nei ranghi dei dipendenti dello Stato.
di Giorgio Mascitelli

( l’incendio della camera dei comuni e dei Lord e dei Comuni di William Turner)
Benché sia una fin troppo facile profezia che le turbolenze a cui la Brexit darà luogo alla fine verranno pagate dagli indifesi, dagli ultimi, da tutti coloro che non vogliono o non possono avere successo in questo mondo e l’unica incertezza consista nell’invenzione dell’acronimo con il quale l’apparato mediatico li ribattezzerà sarcasticamente, può essere una magra consolazione, o almeno lo è per me, provare a imparare qualcosa da questa vicenda.
Da questo punto di vista l’aspetto più interessante di questo referendum è stato lo spettacolo di sorpresa e di impreparazione per la vittoria del leave che hanno offerto i promotori dello stesso referendum, i quali, giova ricordarlo, non sono gli improvvisati capi di un movimento populista fondato da un ex comico o da un ex star televisiva o sportiva, ma i membri del governo britannico e del gruppo dirigente del partito conservatore: gente che ha studiato nelle migliori università del mondo, ha rapporti privilegiati con il mondo della finanza internazionale e conosce tutte le regole del gioco politico. In questo senso si potrebbe definire il risultato che essi hanno ottenuto, ossia quello di far ballare un intero paese intorno a un gioco di potere interno al loro gruppo, come il trionfo della meritocrazia.
L’aspetto più sorprendente della loro sorpresa, sia quella di Cameron sia quella di Boris Johnson, è che tutti i sondaggi parlavano di distanze risicate e di incertezza sull’esito finale della votazione, dunque era abbastanza evidente che potesse vincere anche il leave e non solo il remain. Non sono in grado di dire sulla base di quali elementi fossero sicuri di quest’ultimo esito ( sondaggi riservati considerati più attendibili oppure una cieca fiducia nell’attendibilità dei sondaggi pubblici), ma il fatto che non fosse stato previsto neanche un abbozzo di linea politica nel caso avesse vinto il leave è indicativo di un certo modo di pensare.
Si potrebbe dire che la scelta di convocare un referendum sulla Brexit si basava sulla scommessa che la maggioranza della popolazione inglese razionalmente non avrebbe rinunciato ai vantaggi che l’appartenenza all’Unione Europea comporta, consentendo però ai leader conservatori di giocare il ruolo spericolato dell’euroscettico moderato e pragmatico ( Cameron, Osborne, Theresa May) o di quello duro e puro ( Johnson, Gove, Leadsom). E’ una tipologia di ragionamento molto vicina a quello probabilistico che fa un broker di borsa quando decide di puntare sul ribasso o sul rialzo di un titolo o dell’intero indice, contando sul fatto che il normale risparmiatore, quello che alla borsa di Milano veniva chiamato il parco buoi, agirà secondo linee razionalmente prevedibili, senza preoccuparsi particolarmente delle conseguenze sociali o politiche della sua scelta se il calcolo si rivelerà sbagliato, grazie alla convinzione che tale opzione d’investimento sia reversibile o agevolmente compensabile con altre occasioni. E’ verosimile che un modo di ragionare siffatto si basi su un senso di onnipotenza determinato dalla consapevolezza di appartenere a un’élite, ma siccome non sono particolarmente esperto nella psicologia dei conservatori britannici può darsi che mi sbagli; quello che invece è evidente è che esso è possibile in virtù di un senso di irresponsabilità rispetto alle conseguenze sociali delle proprie scelte, come se esse fossero solo fatti individuali, e di una profonda ignoranza della prospettiva storica, ossia dell’irreversibilità di certe azioni e delle loro ripercussioni sul medio periodo. Niente di strano in tutto ciò: è una cultura abbastanza diffusa nella globalizzazione neoliberista, specie tra le élite, che ha anche delle curiose ricadute nella mentalità collettiva: il successo della petizione on line che chiedeva di rivotare perché forse qualcuno non aveva capito o si era pentito è un interessante esempio di questa incapacità di pensarsi storicamente.
La propensione di un gruppo dirigente a giocare d’azzardo con i fondamenti di un sistema che favorisce già la propria classe sociale è classificabile a pieno titolo come una forma di avventurismo delle élite. Tra l’altro quella dei conservatori inglesi non è l’unico esempio, perché anche in Germania Schäuble e la Bundesbank si dimostrano sempre più attratti da una prospettiva di distruzione dell’euro e dunque del sistema europeo, che è stato letteralmente costruito sui bisogni e gli interessi dell’industria tedesca.
Per spiegare i motivi di questa propensione delle élite all’avventurismo si potrebbero elencare numerose ragioni culturali e sociologiche, tutte assolutamente pertinenti, ma in un’ottica un po’ veteromilitante, forse però più realistica di tante altre, essa appare come il sintomo più eloquente di una difficoltà politica strutturale. Quelle classi dirigenti che avevano promesso ricchezza e libertà per quasi tutti grazie al neoliberismo, ora che è assolutamente chiaro ai più che questi beni saranno goduti da una piccola minoranza, per mantenersi in sella non possono che ricorrere al mito: sia esso quello di una contea rurale in cui la vita scorrerebbe deliziosamente tranquilla se non fosse minacciata da orde di forestieri, come già in Tolkien, o quello di un laborioso artigiano tedesco che deve mantenere milioni di sfaccendati sulle rive del Mediterraneo.
Usare il mito significa giocare con il populismo, regolarmente prodotto dall’apparato mediatico, che negli anni d’oro della società dello spettacolo, quando bastava la contemplazione delle merci, era uno scarto di lavorazione, che poteva essere tranquillamente gettato nei rifiuti; ora che la situazione si fa più vacillante, diventa invece preziosa materia prima. Quindi l’avventurismo delle élite non è nient’altro che le forma che assume questo gioco obbligato per conservare il proprio primato.
Molti commentatori, all’interno di una crescente nostalgia neoliberale e tecnocratica per il suffragio per censo, hanno ricavato dal referendum inglese la lezione che su certi argomenti è meglio che il popolo non si pronunci ritenendo evidentemente che il popolo bestia pazza per eccellenza non debba disturbare chi sa più di lui. Al contrario, se si vogliono evitare nuovi scoppi irrazionali come la Brexit, l’unica possibilità è quella di una ripoliticizzazione della cittadinanza che dissuada le élite dall’intraprendere altre iniziativa avventuristiche sulla pelle degli altri.
di Daniele Ventre
Caratteristiche essenziali della tarda antichità:
sul piano sociale, incapacità di gestire i flussi migratori crescenti delle popolazioni barbariche, incapacità di integrare stabilmente i barbari nella società, permanenza e ingravescenza di atteggiamenti elitari razzistici, che portano all’eliminazione di personalità chiave, come Stilicone, vincolismo delle caste sclerotizzate e fine degli ascensori sociali che avevano caratterizzato l’alto impero, azzeramento del potere contrattuale dei lavoratori, diffusione dell’analfabetismo e restrizione dell’accesso all’istruzione, regressione della parziale emancipazione femminile che aveva caratterizzato l’età tardo-repubblicana e l’età imperiale fino ai Severi, dilagare della criminalità;
sul piano militare, l’espansionismo incontrollato a oriente ai danni dei Parti determina il crollo di questi ultimi, che vengono sostituiti, a partire dal 224 a.C., dai persiani Sasanidi, una teocrazia aggressiva; in contemporanea, si assiste alla pressione montante dei barbari, si riscontrano porosità delle linee di difesa, costi crescenti e invadenza dell’esercito, che è più inefficiente;
sul piano politico, moltiplicazione dei centri di potere (governo di più augusti) e dei costi collegati, crescente instabilità, progressiva recessione del controllo territoriale, perdita di credibilità della classe politica, capace solo di vuoti proclami;
sul piano economico, crisi produttiva, crisi monetaria, effetto della crescente instabilità politico-militare, iperfiscalismo, diffusione della disoccupazione, crollo del potere d’acquisto dei salari, conio di monete forti in pro dei grandi patrimoni e a svantaggio dei piccoli risparmiatori (il solidus aureus di Costantino);
sul piano sanitario, oltre alla sempre più diffusa insicurezza alimentare e alle sue conseguenze, si riscontra la comparsa di nuove malattie epidemiche legate alla crisi delle città e occasionate da un’espansione militare senza accurata pianificazione (l’ingresso in occidente del vaiolo, portato dalle truppe di Marco Aurelio e Lucio Vero dopo la campagna partica);
sul piano culturale, declino della conoscenza scientifica e abbandono della tecnologia, stigmatizzazione sociale della conoscenza razionale, crisi del politeismo civile, dilagare di religioni fanatiche (cristianesimo, manicheismo), di sette religiose con connotati criminali, di esoterismi truffaldini, porosità delle filosofie e delle visioni del mondo, persecuzione della diversità culturale e religiosa (persecuzione dei cristiani da parte delle autorità politeiste; poi assassinio ed emarginazione di intellettuali politeisti da parte dei fanatici cristiani venuti al potere), abbandono delle politiche di sostegno alla cultura -a fronte dell’indifferenza crescente della classe dirigente romana, se ne fanno occasionalmente carico personalità eccezionali di origine barbarica (Stilicone con Claudiano).
Caratteristiche essenziali della tarda modernità:
sul piano sociale, incapacità di gestire i flussi migratori crescenti delle popolazioni extra-comunitarie in Europa, asiatiche in Australia e sudamericane negli USA, incapacità di integrare stabilmente i migranti nella società, permanenza e ingravescenza di atteggiamenti elitari razzistici, creazione di caste chiuse e crisi degli ascensori sociali, criminalizzazione o delegittimazione del dissenso e delle ideologie di riscatto sociale che avevano caratterizzato i secc. XIX e XX, messa in discussione dell’emancipazione femminile, azzeramento del potere contrattuale dei lavoratori, diffusione dell’analfabetismo funzionale e abbassamento progressivo della qualità dell’istruzione pubblica;
sul piano militare, crescenti problemi nelle aree di confine e di marginalità sociale, in cui dominano mafie e organizzazioni terroristiche transnazionali, porosità delle linee di difesa, costi crescenti e invadenza degli apparati di controllo, che sono sempre meno adatti ad arginare la marea montante del terrorismo; inoltre, una strategia egemonica avventuristica in medio-oriente determina come contraccolpo il nascere di movimenti politici e dittature improntati al fanatismo integralista;
sul piano politico, moltiplicazione dei centri di potere e dei costi collegati, crescente instabilità, progressiva recessione del controllo territoriale, perdita di credibilità della classe politica, capace solo di vuoti proclami, azzeramento della sovranità e del primato della politica, in presenza di poteri economici transnazionali fuori controllo;
sul piano economico, crisi di iper-produttività, crisi finanziaria, causa e poi anche effetto della crescente instabilità politica, prevalenza dell’economia virtuale e del formalismo gestionale sull’economia reale, effetti devastanti dell’iperfiscalismo, diffusione della disoccupazione, crollo del potere d’acquisto dei salari, conio di monete forti in pro dei grandi capitali e a svantaggio dei piccoli risparmiatori (l’euro);
sul piano sanitario, oltre alla sempre più diffusa insicurezza alimentare e alle sue conseguenze, si riscontra la comparsa di nuove malattie epidemiche legate a un’espansione demografica incontrollata e a una distruzione cieca delle foreste pluviali, senza alcun rispetto per gli equilibri ambientali;
sul piano culturale, declino della conoscenza scientifica e stigmatizzazione sociale della conoscenza razionale, a fronte della centralità fattuale della tecnica (tecnicismo acritico), compromissione del politeismo culturale dei valori (definizione di Popper -e peraltro l’occidente è figlio di un politeismo pratico, imperfetto), dilagare di varianti fanatiche delle religioni tradizionali, di sette religiose con connotati criminali, di esoterismi truffaldini, porosità delle filosofie e delle visioni del mondo, persecuzione della diversità culturale e religiosa (persecuzione dei cristiani e dei musulmani dissidenti da parte delle autorità di molti paesi islamici; emarginazione ideologica o economica di masse di islamici -migranti allocati nelle periferie urbane- da parte dei populismi venuti al potere o dei regimi iperliberisti in occidente), abbandono delle politiche di sostegno alla cultura e alla ricerca scientifica.
Ecco perché questa è la tarda modernità. Non la modernità liquida, non l’ipermodernità, non la postmodernità: semplicemente, la tarda modernità*.
_________
* Paradossalmente, l’unica vera differenza sostanziale fra il tardo-antico e il tardo-moderno è data dal fatto che la civiltà tardo-antica era molto più esposta ai cambiamenti climatici naturali che connotarono i secoli III e IV, di quanto non siamo esposti noi ai cambiamenti climatici di origine antropica che connotano il secolo XXI. Nella tarda antichità, i nemici primari erano la natura e le invasioni; nella tarda modernità il peso che schiaccia la civiltà è da riconoscersi essenzialmente nelle tare culturali e politiche di una élite politico-finanziaria intimamente immobilista, autoritaria e timorosa del cambiamento.
di Noemi De Lisi
Non aveva dormito per tutta la notte ma aveva comunque deciso di rimanere sdraiato sul letto, immobile. Quando finalmente sentì la porta d’ingresso chiudersi, accese l’abat-jour sul comodino, si alzò e guardò il cellulare: erano le 8:00. Si girò a guardare il letto: le grinze del lenzuolo e il solco sul cuscino facevano sembrare tutto diverso, come se avesse dormito davvero. Aprì la porta della stanza, fece un passo in avanti e la richiuse dietro di sé. Rimase fermo nello stretto corridoio in penombra: «Buongiorno», disse anche se non c’era nessuno. Sua madre gli aveva insegnato a salutare la casa: “Le case vuote si salutano sempre”, gli diceva. Andò in cucina, spinse l’interruttore del lampadario a neon che singhiozzò tre volte e poi si illuminò. Il piccolo televisore sopra al frigorifero; i pensili sopra al lavello, l’armadio delle pentole, la libreria usata come dispensa, la cucina a gas attaccata alla bombola, la lavatrice, e al centro, l’ampio tavolo rustico rettangolare circondato da quattro sedie con la seduta di paglia. Erano mobili vecchi, diversi fra loro, raccattati dalle case di parenti defunti; perché come diceva sua madre: era un peccato buttarli. A lui non piacevano, lo facevano diventare una bestia. Una volta aveva urlato a sua madre: “Lurida accattona!”, le aveva detto che un giorno avrebbe preso i mobili e li avrebbe fatti volare dal balcone, anzi, che un giorno li avrebbe bruciati, avrebbe bruciato tutta la casa. Eppure, adesso non gli capitava più di innervosirsi in quel modo, si era distratto, non ci pensava così tanto. I mobili fradici, spaiati, il disordine; solo ogni tanto tornavano a disturbarlo, ma sempre meno, ci si era abituato: non c’era nulla di male in questo.
I suoi genitori erano usciti come tutte le mattine. Sua madre puliva le case di diverse signore delle quali lui non ricordava i nomi ma solo le lettere finali: Etta, Dia, Esa, Ela. Suo padre, invece, aveva perso il lavoro da quattro anni, faceva l’operaio. Così, adesso, per tenersi occupato, andava in giro per la città fino all’ora di pranzo: andava al sindacato, a fare la spesa, a fare la fila alle poste; oppure ogni tanto faceva l’autista a una signora anziana, che lui chiamava “Ursula” come la strega del mare.
Aprì uno dei pensili sopra il lavello: se non fosse stato per le lunghe antenne che si muovevano, non si sarebbe accorto dello scarafaggio fermo sull’anta. Prese un bicchiere, guardò ancora lo scarafaggio, e richiuse piano. Aprì il frigorifero, prese una bottiglia d’acqua, riempì il bicchiere fino all’orlo, lo portò alle labbra, bevve e strizzò gli occhi perché ebbe una fitta ai denti. Sapeva bene qual era il pensiero. Non aveva dormito due notti per quel pensiero. Lo sapeva ma voleva fare finta di niente. Scrocchiava le dita stringendo il pugno, ridacchiava e si diceva: «Ma no… non sarà mica per quello!». Lucia lo aveva lasciato e lui la amava ancora. «È mai possibile?», diceva scuotendo la testa con gli occhi sgranati, «è mai possibile?». Erano stati insieme otto mesi, non faceva che ripensarci. Ci pensava così tanto che i fatti cominciarono a mischiarsi fra di loro. Così, lui non sapeva più ricordare se il Primo Maggio avesse cominciato a piovere sul loro picnic. Se avessero dovuto raccogliere tutto in fretta, se fossero corsi in auto imprecando. Se chiusi là dentro, con i capelli umidi e scombinati, avessero comunque deciso di mangiare quello che avevano preparato; restando a masticare in silenzio, senza guardarsi. Oppure, se stesse già diluviando fin dalle prime ore mattutine, nonostante fosse maggio; e loro avessero deciso di rimandare il picnic a un altro giorno. E quando per la prima volta ricordò la festa di carnevale, non aveva dubbi sul fatto che Lucia avesse indossato un lungo kimono a fiori e lui una ridicola divisa da marinaretto con un fiocco blu sul petto. Ma già la seconda volta che lo ricordava, non ne era più sicuro. Fra i coriandoli e la musica della festa, ricordava bene i baffi finti sotto il naso di Lucia, e quanto lui avesse sudato sotto la parrucca che lei lo aveva costretto a indossare. Strizzava gli occhi nello sforzo di capire cosa fosse vero. Forse era stato tutto in un altro modo, forse era stata Lucia a travestirsi da marinaretto; mentre lui, invece, aveva indossato l’elegante kimono, e tutti alla festa gli avevano fatto i complimenti.
Nelle ultime due settimane, da quando si erano lasciati, aveva continuato scriverle su Whatsapp tutti i giorni. Poi lei lo aveva bloccato; così lui aveva cominciato a inviarle sms. Le aveva scritto tutti i loro ricordi, li aveva descritti uno per uno, e quando finirono, ricominciò daccapo, anche se ormai Lucia non rispondeva più. Cinque volte aveva provato anche a chiamarla, e dopo aveva smesso, perché non voleva disturbarla. Quelle volte, aveva sperato che rispondesse fino all’ultimo squillo, finché non era caduta la linea. Se lei avesse risposto, lui avrebbe cominciato a parlare subito: “Amore mio, senti qua: tu ti ricordi il Primo Maggio cosa abbiamo fatto? E com’eravamo vestiti a carnevale? Io com’ero combinato, te lo ricordi?”. Quando non muoveva i pollici veloci sul display del cellulare, trascorreva lunghe ore chiuso nella sua stanza, con la luce spenta, davanti al computer. Guardava e riguardava le loro foto insieme; leggeva e rileggeva le conversazioni della chat di Facebook. La schiena curva, la faccia vicinissima al monitor: l’unica parte di sé strappata dal buio.
Quella mattina era il 19 ottobre. Uscì dalla cucina, aprì la porta del bagno, la richiuse dietro di sé, fissò lo specchio e cominciò a strizzarsi i brufoli con due dita avvolte nella carta igienica. Si voltò, aprì il primo cassetto in alto del mobiletto bianco, prese la crema contro l’acne e lo richiuse; poi spinse anche il secondo cassetto, perché sporgeva un po’ in fuori rispetto agli altri: “Succederà qualcosa di terribile se non lo faccio”, pensava. Spalmò la crema sul viso, insistendo in massaggi circolari sui bozzi arrossati. Poi spalancò la bocca e cominciò a guardarsi la lingua come faceva da bambino. La piegava tenendo la punta sull’arcata superiore dei denti per guardarne la parte inferiore: i filamenti bluastri, lucidi di saliva. La mordeva, la sollevava, l’abbassava, l’allungava a destra, a sinistra, finché non si stancava. Lucia usciva da scuola alle tredici. Aveva deciso di aspettarla davanti al portone di casa. Finalmente l’avrebbe rivista dopo quelle settimane. Le avrebbe detto di nuovo che l’amava, glielo avrebbe detto in faccia: non c’era nulla di male in questo.
Tornò nella sua stanza e cominciò a vestirsi: la sensazione del tessuto sulla pelle la percepì lontana; come se a vestirsi fosse qualcun altro, come se lui fosse affacciato alla finestra e stesse guardando un ragazzo che si veste nel palazzo di fronte. «Lucia, Lucia, Lucia, Lucia», cominciò a ripetere, cambiando ogni volta il tono con cui pronunciava il suo nome: ora supplicante, ora infastidito, ora commosso, ora eccitato. Finì di vestirsi, indossò l’orologio e il giubbotto nero di cerata, quello che si chiudeva al collo con una fibbia. Prese il pacchetto di sigarette dalla scrivania, lo aprì per contarle e lo infilò nella tasca sinistra del giubbotto; prese l’accendino e lo mise nella stessa tasca dei jeans. Prese le chiavi dello scooter dal porta oggetti di legno a forma di mano; una volta gli era caduto a terra e si erano rotte due dita, lui ci aveva messo lo scotch ma continuavano a staccarsi. Prima di uscire dalla stanza si voltò indietro, spense l’abat-jour, aprì l’ultimo cassetto in fondo del comodino, ne estrasse il serramanico modello butterfly e lo richiuse.
Uscì per strada. La luce e l’aria fresca lo stordirono. Si strofinò gli occhi, non dormiva da due giorni. C’era stato quell’incubo e da allora non si era più addormentato per paura che continuasse. Aveva sognato di correre per strada, e di sentire la fatica dei muscoli scomparire mentre si trasformava in un animale: una bestia verde, forte, veloce, della quale poteva vedere solo le zampe che si allungavano e ritiravano nella corsa. Poi si era fermato ed era tornato a essere un uomo. Aveva visto Lucia in una chiesa vuota, l’aveva raggiunta accanto al confessionale, e aveva cominciato a urlarle in faccia che sapeva del suo segreto, che ci doveva essere per forza un segreto, che lei doveva dirglielo. Lucia aveva cominciato a piangere, e sottovoce gli aveva detto di avere avuto una bambina quando aveva sedici anni, e che questa bambina le somigliava molto, che questa bambina era come lei da piccola. Lui allora aveva cominciato a picchiarla: «Come puoi avere una figlia?», urlava. Allora tutto quello che si erano detti quando stavano insieme non era vero. Chi aveva badato a questa figlia per tutto il tempo? Come faceva Lucia a stare con lui come se non avesse una figlia? Lui piangeva, urlava e stava perdendo la voce. Lei aveva il viso tumefatto e gli aveva detto: «Mi fa impressione quella bambina ma le voglio bene lo stesso». Si era svegliato con gli occhi bagnati e le lenzuola sudate.
Mentre camminava, la strada cambiava a ogni passo. C’erano persone che gli venivano incontro, che lo seguivano, che lo superavano: “Sono tutti molli, sembrano ancora addormentati”, pensava. I passanti andavano a destra, a sinistra, alzavano le braccia, parlavano fra loro, sorridevano. Ma nonostante questo, lui non era in grado di cogliere in loro nessuna voce, nessuna espressione che non fosse disumana. Raggiunse lo scooter, tolse il bloccasterzo, aprì il bauletto per prendere il casco, lo indossò, divaricò le gambe per salire su, si diede una pacca sulla tasca destra del giubbotto, e accese il motore con un colpo di polso.
Aveva sempre avuto paura di perdere o dimenticare qualcosa. Ricordava bene, fin da bambino, le scenate che faceva sua madre quando non trovava il mazzo di chiavi. Buttava in aria tutta la casa per cercarlo: prima imprecando, urlando, con le vene del collo rosse e gonfie, poi piangendo sempre più sommessamente. Finché il lamento non si trasformava in una filastrocca, ma anziché recitare: «Gesù mio, vorrei fare un grazioso discorsino ma son tanto piccolina che ho paura di sbagliare. Io lo so che tu sei buono e sai leggermi nel cuore, Gesù mio, chiedo perdono se ti ho dato del dolore… », diceva: «Gesù mio, per favore non mi devi più punire, altrimenti poi mi viene subito di morire. Sono io la peccatrice e dai cani son mangiata. Gesù mio, non farmi più soffrire, tanto all’inferno sono destinata.» Lui a quei tempi era piccolo, si andava a nascondere nello spazio stretto fra il letto e il comodino, e rimaneva lì con le ginocchia contro il petto, la testa bassa e le mani premute sulle orecchie. Finché sua madre non si calmava, e con il viso tutto scombinato dal pianto, lo andava a cercare, lo trovava, lo prendeva in braccio e gli diceva: «Le ho trovate, vita mia, guarda, guarda dove sono! Mi pareva di averle perse. Non è successo niente, non è successo niente… ».
Spense lo scooter in via Uditore, davanti il portone di Lucia. Immaginò di vederla arrivare come sempre, come quando stavano insieme e lui l’aspettava proprio lì. Poteva fare finta di non ricordare più che lei lo avesse lasciato. Se lui avesse cominciato a parlarle come quando stavano insieme, allora forse anche lei lo avrebbe fatto. Avrebbe vinto la sorpresa, l’imbarazzo iniziale, e avrebbe anche lei detto frasi come: “Dobbiamo passare in quel negozio dell’altro giorno, ti ricordi? Quello dove c’era quella maglietta scontata. Dai, dai, non ti seccare.”, oppure: “Allora stasera sali a mangiare da me? Ti piace il cuore con la cipolla e il pelato, vero?”. Scese dallo scooter e si mise ad aspettare. La scuola di Lucia era vicina e lei sarebbe arrivata una decina di minuti dopo le tredici. Cominciò a passeggiare nelle vicinanze. Si allontanava dal portone, si fermava e tornava indietro. Si appoggiava al cofano di un’auto posteggiata, ma subito dopo si alzava. Si guardava attorno, si allontanava nuovamente, fantasticava, parlava da solo. Tirò fuori il pacchetto di sigarette dalla tasca, lo aprì e lo avvicinò alle labbra per prenderne una. Prese l’accendino e si toccò l’altra tasca. Bruciò la punta della sigaretta e aspirò il fumo profondamente. Sentiva gli occhi asciutti, come se le palpebre nel chiudersi sfregassero sulla pupilla. Un signore si avvicinò e gli domandò qualcosa, lui sobbalzò:
«Come?»
«Che ore sono?»
Guardò l’orologio: «L’una, adesso», rispose, gettò a terra la sigaretta, e la calpestò.
Fissò il signore allontanarsi. Fra poco avrebbe rivisto Lucia. Sentì lo stomaco scombussolato, come se avesse dentro qualcosa. Così, si ricordò di quel vecchio libro di favole senza copertina e con la rilegatura sfilacciata che c’era in casa. Da bambino lo andava a sfogliare spesso anche se le storie e le illustrazioni gli facevano impressione: una principessa con l’enorme testa di rospo dai bulbi sporgenti; una regina che partoriva un serpente. Si avvicinò al portone, si chinò a guardarsi nello specchietto di un’auto posteggiata, e si pettinò i capelli con le dita. Poi pensò che avrebbe potuto nascondersi dietro l’angolo del palazzo. Così, avrebbe potuto calmarsi senza che lei lo vedesse; poi avrebbe aspettato che si fosse avvicinata, avrebbe fatto un balzo in avanti e detto: “Buh!”. Lei prima si sarebbe spaventata, lo avrebbe chiamato “scemo”, poi sarebbe scoppiata a ridere e lo avrebbe abbracciato.
Si appoggiò al muro accanto al portone e rimase immobile. Nell’attesa, si preparò il dialogo in testa, tutto quello che lui e Lucia avrebbero detto. Decise le battute e le volle provare. Da una parte c’era la sua voce normale, dall’altra la sua voce in falsetto per fare Lucia. Mise una mano davanti alla bocca e cominciò a parlare freneticamente, in un mormorio; tossendo qualche volta, per non fare capire ai passanti cosa stesse facendo:
«Ciao, Samu ma com’è che sei qui?»
«Ma niente. Stavo passando, stavo sbrigando delle cose… e mi sono ricordato che uscivi da scuola.»
«Sì. Ti ricordi quando mi venivi a prendere sempre?»
«Certo che me lo ricordo.»
«Che ne so. Magari ora hai la tua vita… dopo che ci siamo lasciati.»
«Che c’entra la mia vita? Mica si possono scordare queste cose.»
«Lo so. Però non ci pensavo che te lo ricordavi.»
«E secondo te che altre cose mi ricordo?»
«Non lo so.»
«Dai, Lu… dinne una.»
«Non lo so… Ti ricordi che mi ami?»
«Me lo posso scordare mai?»
«Manco io, Samu.»
«Però mi hai lasciato.»
«Ma che vuoi, sono stata una cretina. Me ne sono pentita due giorni dopo, te lo giuro. Ma mi vergognavo a chiamarti, a dirtelo… che poi mi prendevi per pazza, che prima ti lascio e poi ti voglio di nuovo.» Quando finì di dire l’ultima battuta, sentì qualcosa negli occhi. Ci passò su il dorso della mano e vide che era bagnato. Incrociò le braccia sul petto, alzò gli occhi e vide Lucia arrivare in lontananza. Era magra e alta, sembrava un filo di fumo. Lui sorrise e si trattenne dal farle un cenno di saluto, dall’andarle incontro; continuò ad aspettare fermo, ancora. Lucia camminava insieme a Carmela, sua sorella. Frequentavano la stessa scuola ma in classi diverse, viste da lontano o di spalle, sembravano uguali. Avevano anche la stessa voce, e certe volte, lo avevano preso in giro; lui chiamava Lucia ma rispondeva sua sorella, e lui continuava a parlare senza accorgersene finché Carmela non scoppiava a ridere e lo rimproverava: “Ma com’è che non riconosci la tua fidanzata?”.
Lucia indossava una maglietta che lui non aveva mai visto: era bianca con dei fiori rossi e gialli sul petto, circondati da piccole farfalle nere. Appena Lucia lo vide, diventò seria e abbassò gli occhi. Lui aspettò che le due sorelle fossero a pochi passi dal portone prima di infilare la mano nella tasca destra del giubbotto. Lucia gli passò accanto senza guardarlo, cercò in fretta la chiave del portone nello zaino, la trovò, la infilò nella serratura, ed entrò, seguita dalla sorella. Lui diede una spinta a Carmela ed entrò nell’androne del palazzo insieme a loro. «Che cazzo vuoi, Samuele?», gli gridò Lucia, afferrando per un braccio la sorella e indietreggiando, «non l’hai capito, mi devi lasciare stare!». Lui tirò fuori la mano dalla tasca, mosse tre volte il polso per aprire il coltello e lo sollevò sopra le loro teste.
Vedeva le ragazze agitarsi, e le loro braccia colpirlo sul petto, sulla faccia. I loro occhi erano sgranati e le bocche spalancate. Quando Lucia cercava di scappare, lui la afferrava per i capelli e affondava di nuovo il coltello nella schiena. Carmela gli tirava calci, gli afferrava la mano che stringeva il coltello, lo strattonava, lo picchiava sul braccio, gli si aggrappava al collo, lo graffiava. Mentre lui tutte le volte la spingeva via, facendola cadere davanti all’ascensore, e abbassava il coltello su Lucia continuamente. Carmela gridava, si rialzava, e si metteva fra di loro: una coltellata le finì nel collo, così profonda che un fiotto di sangue lo colpì in faccia. Lui strizzò gli occhi e si asciugò con la manica del giubbotto; Carmela cadde al centro dell’androne, e non si mosse più. Anche Lucia era per terra, ma scossa ancora da singhiozzi. Lui la guardò: era supina, il volto anemico, il labbro squarciato, una guancia bucata, i capelli lunghi sparsi sul marmo tutto sporco di sangue. Le si inginocchiò accanto, alzò ancora una volta il coltello ma si fermò. Sentì delle voci provenire dalle scale: alzò gli occhi e vide che qualcuno stava scendendo, e che la pulsantiera dell’ascensore era accesa. Allora, si alzò, scivolò, si rialzò, e uscì correndo fuori dal portone, mentre qualcuno dal palazzo gli urlava: «Che hai fatto? Fermo! Fermo!». Salì sullo scooter e partì. Sceglieva le vie a caso e accelerava. Gli bruciavano gli occhi, i denti gli battevano, sentiva le braccia molli: «Se come gli altri vorrai sembrar, questa rima dovrai recitar…», prese a ripetere, cercando di tenere i piedi paralleli fra loro, la schiena dritta, il mento sollevato e i denti fermi. Quando si trovò davanti lo svincolo per l’autostrada, lo imboccò.
Raggiunse la stazione di Bagheria nel tardo pomeriggio. Aveva buttato il giubbotto e il coltello dentro un cassonetto isolato, si era lavato la faccia in una fontana, aveva strofinato forte per fare sparire quell’alone rossastro sulla guancia. Si sentiva stanco. Aveva l’urgenza di dovere pensare a qualcosa, qualcosa che aveva perso, forse, e che doveva ritrovare: «Ce l’ho sulla punta della lingua…». Comprò un biglietto del treno e si mise ad aspettare insieme alle altre persone, dietro la linea gialla. Controllava spesso il tabellone sopra la sua testa; doveva partire, aveva fretta: “Ma perché me ne devo andare…”. Poi la gente attorno a lui cominciò a gesticolare, a spostarsi e a voltarsi incuriosita verso un gruppo di poliziotti che stava arrivando. Anche lui si girò e non appena notò le divise, cominciò a correre. I poliziotti lo raggiunsero, lo bloccarono e lo ammanettarono urlandogli di stare fermo: “Ma perché stavo correndo…”. Al suo passaggio la gente sgranava gli occhi e si domandava: «Maria santa, ma che ha fatto? Chi è? Tu lo conosci? No, manco io». Lui camminava a testa bassa tra due poliziotti. Pensò che poteva fare finta di essere anche lui fra la gente che lo stava fissando. Era la prima volta che vedeva un arresto dal vivo. Avrebbe telefonato a Lucia per raccontarglielo: «Indovina che mi è successo? Ero alla stazione di Bagheria e ho visto che arrestavano a uno! Lu, ma tu t’immagini, che ce lo avevo messo accanto mentre aspettavo il treno? Poi si è messo a correre, quelli ci sono andati dietro come pazzi, due l’ hanno buttato a terra, e lui pareva tutto mollo, in faccia era bianco, bianco, ti giuro pareva già un’altra persona. Ora gli hanno messo le manette e se lo sono portato. Ma tu t’immagini se questo aveva una pistola e si metteva a sparare? Ci ammazzava a tutti. Uno non può stare tranquillo appena esce di casa, succedono troppe cose brutte. Lui chissà che ha fatto, forse per cose di droga. Stasera lo diranno al Tgs». I poliziotti lo trascinarono fuori dalla stazione, lo spinsero sul sedile posteriore di una volante e partirono. Mentre osservava la città scorrere sui finestrini dell’auto, finalmente si addormentò.

di Marco Giovenale
La mostra Faccioni, di Eva Macali, installa e dispone a Roma, nelle stanze del Centro Luigi Di Sarro (dal 16 giugno, e ora fino al 22 luglio su appuntamento), e poi in autunno presso la Casa internazionale delle donne, un numero parco ma tutt’altro che avaro di opere: grandi sagome di visi di donne; figure per lo più sottratte alla cartellonistica pubblicitaria, icone dagli occhi sfuggiti-sfuggenti.
“Gli occhi, tradizionale sito semiotico dell’unicità, sono in parte tolti” (Jonathan Mullins, in un breve imprescindibile testo sulla mostra).
Il taglio del supporto di cartone o plastica, infatti, e dunque la sagomatura del volto femminile esposto, staccano-eludono-elidono gli occhi dalla nostra visione dell’immagine. Gli occhi, tolti o intaccati, vengono inoltre privati di un ulteriore ventaglio di materia, in modo che questa assenza di sguardi finisca per mimare in negativo il darsi di (quasi) fasci di luce irraggiati proprio dagli incavi orbitali.
Pudicizia post-pop o/e irraggiamenti anti-pop, suggerisce questo Fayyum accecato: comunque una raffica di laser mancanti. (La suggestione dei laser è evocata da Roberto Gramiccia).
Sguardi in meno, tracciati ed esaltati dal più di evidenza dato dalla sagomatura. Al punto da non offrire chiarezza sullo statuto di quell’osservare (il) (volto) femminile: c’è ironia su queste sottrazioni di sguardo (e materia)? Ironia sul guardare ed essere guardati? O frontalità e affermazione? “Messaggio”? (Qualcosa del genere: dopo esser state ‘salvate’ dalla pubblica anzi pubblicitaria impiccagione, le teste di veneri si vendicano negando la fascinazione degli occhi per sostituirla con un’assenza raggiante, quindi con una diversa modalità del positivo). (Che dialoga con lo spazio che le contiene e sostiene, cioè il muro, suggerisce Mullins). (E l’artista stessa precisa: “Restituisco lo sguardo a queste donne e quello che vedono è il mondo intero che abbraccia lo spettatore. In questo modo ribalto la relazione gerarchica tra chi guarda e chi è guardato”).
Non tutto, però, è detto, è dato, così. E negli spazi del non detto/dato sta una ulteriore parte – appunto ambigua polisemica sfuggente – del senso della mostra. Da rintracciare forse nel silenzio definitivo dei visi, definitivamente parlante, interrogativo.
Il senso e silenzio non afferrato si accresce forse – e si reimposta – in forma di prassi-performance suggerita da altri elementi aggiunti, non meramente accessori. Eva Macali ha infatti conservato le scocche degli sguardi, le sagome arcuate dei pannelli, dov’era ed è immaginabile il fascino-”fascio laser” originato dalle occhiate. E di queste ondulazioni ha fatto maschere, mascherine asimmetriche per coprirsi (occhi, viso) con non diversa …pudicizia di spettatori.
Oppure ha ricavato – dalle stesse scocche – delle lenze-macchine celibi, multimateriche, da azionare daccapo in guisa di (più articolate) maschere. Canne da pesca per acciuffare o celare o disturbare – oscillando – il gesto del vedere. Che, come si sa, sempre risponde ad altro sguardo: legge e scrive ciò da cui è letto e scritto.

Sul sito dell’autrice:
http://www.evamacali.info/index.php/faccioni
http://www.evamacali.info/index.php/faccioni/centro-di-sarro/
Album:
http://www.evamacali.info/index.php/faccioni/album/
Centro Luigi Di Sarro:
http://www.centroluigidisarro.it/eva-macali-faccioni-2/
di Jacopo La Forgia
I sogni esagerano sempre.
La notte prima ho sognato la capitale di uno stato molto povero, e la guerra civile. I combattenti arrivavano a mangiarsi a vicenda, per quanto si odiavano, o per altre motivazioni che non conosco. I palazzi erano ammantati da una polvere ocra e le donne si vendevano per un dollaro. Io ero intrappolato in un bus. Era invisibile, ma i guerriglieri lo vedevano lo stesso, e uccidevano tutti i passeggeri. Tranne me. Sfuggivo al massacro grazie all’aiuto di un uomo che mi veniva a prendere e mi sussurrava di seguirlo, per condurmi, attraverso uno sporchissimo mercato di carni, a un ampio ascensore dalle pareti blu. Lì ci sdraiavamo e andavamo giù.
di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
(Il dialogo aiuta. Ci siamo messi a parlare, ci siamo dati una grammatica. Che poi da piccoli volevamo essere Wu-Ming pure noi. Di recente abbiamo scoperto che invece eravamo Arya Stark, ma non ci abbiamo più l’età per fondare un collettivo)
Lorenzo. Stavolta l’assassino ha detto “Allah akbar” proprio alla fine, prima di venire ucciso. Beveva, amava la salsa, non faceva il digiuno, nessuno l’ha mai visto in moschea, a Nizza. Era un violento che picchiava la moglie, era stato in prigione per reati comuni, aveva debiti. Ciò che lo lega all”integralismo islamico” sarebbe suo padre. Il quale, rivelano, in Tunisia è iscritto a Ennahda, cioè quel partito che dopo la rivoluzione del 2011 ha governato la Tunisia per qualche anno, ha perso le elezioni, è passato all’opposizione, ha formato un governo di coalizione coi vincitori, ha sancito nelle ultime settimane la propria separazione dalla famiglia dell’islam politico, da cui proviene. O sarebbero non meglio identificati “parenti” – con i quali non aveva più rapporti da anni – che “sarebbero stati condannati durante il regime di Ben Alì, e avrebbero poi approfittato dell’amnistia per uscire di prigione” (cit.). Incidentalmente dal padre dell’assassino veniamo a sapere qualcosa che un padre generalmente sa: suo figlio era un depresso. Forse avremo contezza di cosa c’era in casa sua, nel suo computer. Troveremo certamente qualcosa che riguarda lo Stato Islamico, il suo “percorso di radicalizzazione” che, ancora da quanto dichiarava ieri Cazeneuve, sarebbe avvenuto “très rapidement”.
Anatole. Il profàilin del terrorista che emergeva già nelle prime ore di venerdì da un articolo del Guardian lascia in effetti piuttosto disorientati. Innanzitutto non si capisce bene se Lahouaiej Bouhlel fosse cittadino francese di nascita tunisina o tunisino con permesso di lavoro in Francia. Secondo poi emerge che trattavasi di avvenente criminale da strapazzo, vagamente somigliante a Clooney, con una confermata passione per la salsa e la figa. In terza istanza, ma forse è il dettaglio fondamentale, scopriamo anche che “non salutava mai”, anzi era spesso piuttosto imbronciato.
Lorenzo. Né la cosa ha preso un aspetto più spiegabile col tempo. Alla fine si è capito che era tunisino con ex-moglie francese di origini tunisine. Divorziato e incazzato per questo. Ma appunto diciamo che il profilo non cambia di molto. Capiamo che andare a vedere cosa diceva nel 1938 il fratello di suo nonno non porta a granché, cioè, non viene fuori il ritratto morale di Saladino tracciato da Ibn Shaddad nel Nawadir Sultaniyya, diciamo. Forse serve a rafforzare il pregiudizio di conferma di qualche islamofobo. Certo potremo provare a farne letteratura, a un certo punto, con risultati sicuramente discutibili. È la sindrome del cronista che voleva fare lo scrittore di gialli hard boiled.
Anatole. Nel disperato tentativo di collegare questo personaggio equivoco al Califfato, a poche ore dai fatti e senza alcuna rivendicazione pervenuta, Le Figaro si affretta a spiegarci che «en septembre 2014, un important cadre de l’Etat islamique appelait ses partisans à utiliser n’importe quel moyen pour tuer, y compris des véhicules-béliers». Quello che a noi sembrava una versione sbroccata debbrutto di GTA San Andreas, è in realtà quasi una fatwa di un importante “quadro” dello Stato Islamico, che con tutta probabilità scoatta pure lui al celebre videogioco sul telefonone. La notizia è l’Isis e ce lo devi mettere per forza, roba che davvero, paradossale quanto possa sembrare, Guglielmo di Tiro nel XII secolo mantiene margini di maggiore obiettività deontologica, fin dal titolo, forse proprio perché mette i fatti in prospettiva storica.
Lorenzo. Di sicuro se in Francia fosse in ruolo il reato di “integralismo islamico” così come viene definito da Meloni&friends in una petizione popolare che avrebbe l’ambizione di essere discussa in parlamento, propagandata in pompa magna con tanto di poster giusto il 14 luglio, non avremmo evitato la strage. Certamente avremmo dato un argomento in più a uno come Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Avrebbe pensato che questa sua radicalizzazione lampo poteva avere ancora più senso. Avesse connotati di realtà, a fronte di un crimine che stava per commettere.
Anatole. Comunque la Francia, nel suo tentativo di voler somigliare all’idea che la Francia vorrebbe avere di sé stessa, se ne avesse una, coniuga la Marianne con Luigi IX, in un sincretismo che definirlo postmoderno è riduttivo. Secondo la scaletta della narrazione a una certa Méssier le Presidànt deve orientare lo storitèllin dei tragici fatti, spiegandoci nei seguenti termini come un corriere sui trent’anni alla guida di un TIR abbia ammazzato circa ottanta persone: «la France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14-Juillet, symbole de la liberté, parce que les droits de l’homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible». Siamo già apertamente nel campo dello scontro di civiltà, anzi, della civiltà conquistata liberando la Bastiglia, contro la barbarie di chi nega la validità della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Fa seguito un rinnovato appello allo stato di emergenza, prolungato oltre il 26 luglio: «j’ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c’est-à-dire à tous ceux qui à un moment ont été sous les drapeaux ou dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes, a-t-il ajouté». Ad esso si abbina con pertinenza veramente labile un discorso sulla sicurezza delle frontiere: «nous pourrons les déployer sur tous les lieux où nous avons besoin d’eux et en particulier pour le contrôle des frontières». Pareva infatti di capire che l’attentatore avesse regolare permesso di lavoro, mentre quelli quelli operativi contro Charlie Hebdo, al Bataclan, al Carillon, allo Stade de France avevano proprio il passaporto. Sennonché, con tutta evidenza, l’associazione tra il terrorismo dell’Isis e l’emergenza dei profughi che scappano dalla guerra in Siria è troppo ghiotta perché anche il presidente di uno degli stati più potenti del mondo possa sottrarsi. È questo il trampolino logico che Hollande impiega per tuffarsi nel proclama della guerra santa: «nous allons renforcer nos actions en Syrie et en Irak». Sottolineando che «nous allons continuer à frapper ceux qui nous attaquent dans leur repaire», ci ricorda che noi europei stiamo facendo questa cosa da un bel po’ di tempo, così da aver qualcosa da dire quando ci domandano cosa si stia facendo per impedire che ottanta persone trovatesi là per caso muoiano così, senza un vero motivo che le riguardasse davvero, neanche remotamente, come d’altra parte centinaia di migliaia di altre in ogni parte del globo terraqueo, soprattutto in Siria e in Iraq. E bisognerebbe ricordare a Hollande che Luigi IX avrà anche conquistato Damietta, ma è morto di diarrea nel 1270, dando battaglia all’emirato di Tunisi per dar retta a Carlo d’Angiò.
Lorenzo. E chiaro che la Francia, nonostante le mutatissime caratteristiche di questo suo popolo, non è riuscita a definirsi mai altro che una Nazione compatta e coesa su ideali e concetti cristallizzatisi ormai da troppo tempo: patriottismo, laicité ecc. Il coro francese era già stonato dopo Charlie Hebdo, quando alcuni facevano notare che in certe aree di Parigi, e anche altrove, le marsigliesi non risuonavano affatto e le retoriche unitarie proprio non facevano breccia. In questa cosa Hollande o Figaro sono uguali. E spasmodicamente cercano in qualche paffuto criminale che si diverte a fare i Bignami del terrore una conferma al loro argomento. Il ché finisce per dare un rilievo gigantesco al criminale stesso, il quale poi se la ride sapendo che domani potrà ruttare su Twitter trovando un certo riscontro. E comunque tutto ciò non significa che abbia ragione chi dice che questa non conformità debba essere cancellata. Significa invece che occorrerebbe uscire da un vicolo cieco in cui gli unici a giocare sono i Le Pen e i terroristi.
Anatole. Certo i picchi di svalvolamento che si toccano in Italia, da nessuna parte mai. Esempio top è il mirabile scambio twitter tra Paola Ferrari, giornalista sportiva, e Rita Dalla Chiesa, presentatrice e giornalista, forse, pure lei. La prima delle due s’inalbera affermando che “loro fanno a pezzi donne e bambini, noi rispondiamo con le cerbottane”. Loro chi? Gli “slamici”? Noi chi? Veramente boh… Poi arriva a proporre di revocare il passaporto europeo ai magrebini arrivati negli ultimi vent’anni, figli compresi, senza che sia chiaro cosa sia il passaporto europeo (ogni Stato rilascia un passaporto nazionale, poi l’accordo di Schengen regola il transito transfrontaliero), né quando e in quale paese europeo si sia deciso di conferire così, scialla, la cittadinanza a un magrebino sopraggiunto negli ultimi vent’anni. È il paradigmatico caso raccontato da Guzzanti nel famoso sketch de Il caso Scafroglia, al telefono col solito ascoltatore che confonde una parola per l’altra, nel caso specifico “la Fallaci” con l’ipotesi che la guerra al terrorismo “la fa l’ACI” (ma anche le “leggi laziali” invece che “razziali” in altro meraviglioso analogo sketch).
Lorenzo. Se anche volessimo prendere per buoni questi vaneggiamenti, che peraltro riecheggiano cose dette da Donald Trump, se cioè anche ci si mettesse con la tigna a cacciare tutti i musulmani o supposti tali dall’Europa ci ritroveremo un tedesco squilibrato che accoltella gente nella metropolitana di Monaco urlando “Allah akbar”. E allora, forse, procederemmo alla eliminazione di qualsiasi “contenuto islamico” (qualsiasi cosa ciò voglia dire) dal web, dal mondo dell’informazione, dai libri. Bandiremmo qualsiasi cosa che potenzialmente serve a una donna per coprirsi la testa, anche. Non so, fate voi, il fatto è che così non si va da nessuna parte, o meglio: si dà ragione a una infame banda di criminali che ha capito come farsi pubblicità a gratis. E, in cambio, si diventa Israele.
Anatole. Ad ogni modo, non si fa in tempo a provare tutto lo scoramento del caso che, fermi tutti, alle 12:30 arriva a Uno Mattina l’intervista al classico “italiano a Nizza”. Secondo la sua rivelazione scùp pare che non sia per niente bello trovarsi inseguiti da un TIR guidato da uno che spara, mettendo sotto chiunque trovi sulla sua strada. E comunque, se non ce ne fossimo accorti, la polizia è intervenuta male e in ritardo. Grazie, era venuto anche a noi il sospetto che altrimenti il “camion della morte”, già così battezzato a quel punto, difficilmente sarebbe arrivato sulla Promenade des Anglais durante la festa del 14 luglio (dopo averla perlustrata col camion nei giorni precedenti, come si scopre in seguito) così, andando a passeggio, in una città che il sindaco ha trasformato nella casa del Grande Fratello, installando 1000 telecamere. Dopodiché, nel pomeriggio, il sistema infomediatico ci giudica pronti per le analisi sociogeopolitologicomilitari, tra le quali merita certamente una menzione Bremmer, che intervistato dal Corriere della Sera, ci spiega come «circa l’8% della popolazione non si sente francese». Viene fatto di pensare che a Castropignano, invece, si sentano tutti molto molisani e per questo nessuno ammazzi ottanta persone alla festa del santo patrono col trattore.
Lorenzo. Ma dice che bisogna fare qualcosa, sennò non sai cosa ti puoi aspettare quando esci di casa. Ma come fai a prevenire il fatto che magari uno, a una certa, decide di andarsi a suicidare in maniera stragista chissà dove? Semplice: lo devi integrare. Integra l’integralista. A forza proprio: adesso ti integro, faccio proprio una legge, speculare rispetto a quella che vuole Meloni. Che così arriviamo a fare come in Israele: “un Paese democratico dove però popoli di diversa origine vivono in modo separato” (cit.). Stranissima idea di integrazione, ma se ci evita di morire sotto un TIR, e non lo so se funziona eh, che ti devo dire, stiamoci…
Anatole. … (riflette)
Lorenzo. Altri ancora riportano che il modello israeliano “va per la maggiore”. Dopo gli attentati di Bruxelles il mantra era la debolezza del Belgio, stato fallito che fa finta di essere Europa. Stavolta il coniglio dal cappello è il “modello Israele”. Come dice l’esperto di sicurezza Carlo Biffani, “bisogna sviluppare una mentalità diversa per la propria sicurezza, proprio come avviene in Israele”. Diciamo che di fronte al rischio Eurabia si paventa un rimedio: Eusraele. Ma davvero?
Anatole. Ad ogni modo, a concludere questo delirante percorso nell’infotainment di un comune venerdì estivo, uno dei tanti possibili nella giungla digitale, tutti ugualmente deliranti, ecco che arriva il video di quando la polizia spara il terrorista, presentato con entusiasmo dal New York Post, ma probabilmente da infinite altre testate di analogo spessore in giro per il mondo.
Lorenzo. … (riflette)
Anatole. Quando tutti hanno detto tutto, cioè praticamente niente, e si profila l’arrivo della sera, con l’inevitabile profluvio di demenza politica televisiva, ecco che provvidenzialmente piove la notizia del colpo di stato in Turchia. È come quando stai per rassegnarti al Processo del lunedì e invece scopri che la Roma gioca il posticipo. Folle che sia, pare che la cronaca permanente sta sostituendo l’approfondimento giornalistico e la politica. È una continua emergenza, alla quale non si fa neanche a tempo a rispondere. Dacca, Brexit, Nizza, la Turchia e adesso qualcosa d’altro, speriamo, così da poter evitare di pensare. Mentre a quel punto si rincorrono le speculazioni sul colpo di stato turco, si rimane di fatto con l’impressione che si aveva ieri o l’altrieri, o il giorno prima e quello prima ancora, almeno da quando abbiamo scoperto che potevano spararti per strada mente cazzeggiavi così con una birra in mano, al Carillon, per esempio. Che cioè questo terrorismo, forse tutto il terrorismo, funziona che il terrorista afferma una cosa non vera sparando a qualcuno o tirando giù un palazzo con una bomba o un aereo o in tutti quei modi molto terroristici. Se nell’ambito del consesso democratico colpito dall’azione terroristica si fosse tutti d’accordo che la cosa affermata dal terrorista è falsa, non perché affermata in maniera terroristica, ma perché proprio falsa, si potrebbe catturare il terrorista, punirlo secondo la legge e la cosa con grande probabilità finirebbe là. Invece all’interno del consesso democratico comincia un dibattito surreale tale che, paradossalmente, quelli che si presentano come i maggiori avversari del terrorista sostengono che il terrorista abbia ragione.
Lorenzo. E qui torniamo a Meloni. Seguendo la sua fine logica giuridica potremmo promuovere una legge sul reato di Meloni. Torniamo anche a Trump, le cui immaginate espulsioni di nonsisacchì, sono auspicate dal portavoce del Neocaliffo proprio per eliminare tutto quello che c’è in mezzo fra Trump e Stato Islamico, cioè noi. Come dice Francesco Strazzari: ”Vogliono fare di tutto l’Occidente un gigantesco Israele”. E noi che facciamo? Diciamo: “Sì, in effetti è una buona idea”. Ma questa visione del terrorista che vuole israelizzare il mondo è una cosa mezza matta, come se il terrore avesse come scopo il terrore e basta, la vendetta magari. Da GTA San Andreas a Game of Thrones, praticamente.
Anatole. Certo, tanto da questo dibattito il terrorista è completamente escluso, non solo come interlocutore, la qual cosa è inevitabile, ma anche come soggetto portatore di un argomento dotato di una qualche concreta validità, o meno. All’interno del consesso democratico che era originariamente l’obiettivo del terrorismo si creano due partiti che configgono tra di loro. Da una parte si schierano quelli che danno ragione al terrorista, anche se in apparenza sembrerebbe che stiano dandogli contro, dall’altra quelli che dicono tutto il resto, qualunque cosa pensino, ma vengono etichettati come coloro che sono dalla parte del terrorista, anche se dicono che ha torto.
Lorenzo. I leggendari buonisti. Il cancro dell’Occidente. Quelli che Breivik vuole genocidare avendo già dato prova di saperlo fare. Oggi su Facebook mi è capitata una tipa che, sotto sotto, mi riteneva responsabile del massacro di Nizza perché ho scritto un libro divulgativo sull’Islam. Le spiegavo che nel libro si racconta dei primi attentati suicidi ma niente, era fissa su Nizza, anche osare un argomento rimontante al giorno prima era per lei una specie di dichiarazione di colpevolezza, di correità. Come se non avesse senso ragionare su come tutto ciò ha avuto inizio. Come se il terrorista non lo si debba studiare, per provare a sconfiggerlo bene. Sempre che il vero nemico continui ad essere il terrorista, perché dopo un tot, quando la minaccia si abbassa, viene più spontaneo prendersela col buonista.
Anatole. Il terrorista, volendosi mettere per un istante dalla parte sua, se non altro per capire come possa confrontarsi con questa paradossale situazione, non aveva naturalmente capito nulla del consesso democratico che egli ambisce a terrorizzare, che cioè si trattasse in ultima istanza una gabbia di matti, ed è altamente probabile che rimanga molto disorientato lui stesso. Sulla base della reazione ai suoi gesti, può fare una cosa e una sola, cioè ripetere la cosa falsa che aveva detto allo stesso modo in cui l’aveva detta, magari tirando ottanta persone sotto a un camion mentre spara a quelli intorno, alla maniera di uno di quei videogiochi che l’iconoclastia del suo mal recepito credo, ben abbinato, si diceva, alla salsa e alla fica, dovrebbe vietargli, ma, come anche s’è accennato, una botta di GTA San Andreas sul telefonone di sicuro ogni tanto gliela dà. Dagli e dagli, coloro i quali si sono costruiti un personaggio schierandosi ferocemente contro di lui, anche se in realtà gli danno ragione, vincono la battaglia all’interno del consesso democratico, dimostrando, paradossalmente, che l’argomento falso sostenuto dal terrorista è invece vero.
Lorenzo. E quindi va a finire, ripeto, che dobbiamo fare come Israele, Bremmer appunto. Cioè, sempre ammesso che il terrorista abbia davvero come finalità il terrorismo e nient’altro, cioè, non è che gli diciamo “fatti una vita” in qualche modo. No, anzi, gli creiamo il contesto ideale per continuare a fare il suo terrorismo, come se piacesse anche a noi. Cosa che in un certo qual senso è anche vera. Cioè, non a noi, ma a quelli che di casa non vogliono proprio uscire, animati dallo stesso rosico sociale del terrorista nei confronti di chiunque abbia una vita.
Anatole: Certo, il terrorismo è la situazione ideale per quello che “ci aveva judo”, che alla festa non l’avevano invitato. Quindi questa di “e noi fare-emo / come Isdraele” è una nuova, che va ad aggiungersi alla grandissima al conflitto di civiltà, alle nostre donne da difendere, allo scandalo del velo, all’isolamento delle periferie, all’islam moderato che non si schiera, alla minigonna, al crocefisso in classe e tutti i santi in colonna, alle abitudini alimentari difformi, al colonialismo, al postcolonialismo, al transpostcolonialismo, alla barbetta del profeta, alla tunica e i jeans del ricchissimo armamentario degno di un sussidiario delle elementari degli anni sessanta. Solo noi non avevamo capito che erano chiari indizi di una guerra di religione, che in realtà nessuno sta veramente combattendo. Però suona così facile al pubblico dei canali generalisti, alla gente comune, a coloro i quali, in ultima istanza, non hanno idea di cosa si stia parlando, né gliene frega niente, perché trattasi di fenomeno che riguarda nei fatti solo chi esce di casa sua ogni tanto, cioè pochissimi, che alla fine “vabbene, dai, facciamo che era una guerra di religione e diciamo che la stavamo combattendo davvero”. “Io ero Goffredo di Buglione e tu Pietro l’Eremita, andiamo a liberare il Santo Sepolcro”, anche se non sappiamo chi fossero né l’uno, né l’altro e trattasi di fatti capitati circa mille anni fa’ (“e comunque Pietro l’Eremita fallo te, che io voglio lo spadone +5, tu pigliati la mazzarocca +3 contro gli infedeli o il bastone che diventa un zerpente”).
Lorenzo. Certo, i martiri di Otranto, l’assedio di Vienna, Marco da Aviano, la battaglia di Lepanto, la Lega santa. Tutta roba che ritorna in circolo al netto della critica storiografica, che in questo presente non esiste più (con eccezioni come questa). Se vuoi raccontare una crociata deve essersi svolta una crociata, o almeno dovrà essere in corso, altrimenti devi inventarti una serie di cose che ci somigliano, senza nemmeno sapere come dovrebbe essere una crociata. E se vuoi raccontare una crociata che non c’è, se proprio vuoi cimentarti nell’arte dello storitèllin, almeno leggiti come la raccontavano i professionisti, che ne so, Usama bin Munqidh, Ibn Wasil. Abu Shama al-Maqdisi e così via: c’è la traduzione di Gabrieli per Einaudi, si tratta di aprire un libro, daje…
Anatole. Ma anche Guglielmo di Tiro, o la sua traduzione francese nel manoscritto francese 22495 della Bibliothèque Nationale de France, ci sono pure le figure. Evidentemente la vulgata postmoderna si figura e rende meglio la crociata come il mischione del videogioco d’azione in cui corri forte sul camion, possibilmente armato, con un’avventura di Dungeons & Dragons narrata male. Forse se te la devi leggere sul telefonone a colori viene meglio così. Certo, se vuoi raccontare una crociata che non c’è senza nemmeno sapere cosa sia, è naturale che fai fatica, ecco. E qui si apre una volta ancora il capitolo dell’emarginazione dei saperi storici dal dibattito su tutto, dunque dello schiacciamento sul presente di ogni riflessione sul presente, esclusivamente spiegato sulla base del presente, col risultato che le minacce del presente certo ci appaiono molto presenti.
Lorenzo. Mmmsì… Effettivamente questa cosa di trovarsi a dover raccontare una crociata che non c’è senza saperla spiega molto dell’affanno giornalistico. La cosa ha a che fare anche coi tempi dell’infotainment e i tempi della storiografia, che sono ormai asincroni. Chi scrive sul giornale, oggi, non si sogna nemmeno di poter fare della storia, la cosa non è alla sua portata, e neanche una sua ambizione. Non era così prima dei telefononi. Quanto ai destinatari della monnezza che ne deriva sono immersi in una situazione paradossale: la globalizzazione li sovrasta, li determina, e loro possono solo incazzarsi con le persone sbagliate, ad esempio i politici, che effettivamente decidono ben poco e quindi, by the way, fanno al massimo storitellin. La scappatoia esistenziale che rimane, quando non ci si vuole raccontare questa verità, è teorizzare complotti. Ma vabbene, questa cosa esula un po’. Bisognerà tornarci però.
Anatole. Si, c’è anche, forse, la questione del genere letterario. La cronaca succede in sostanza quando devi fare storia di fatti contemporanei, presenti. Evidentemente il divorzio tra lo storico e il cronista non viene bene quando devi parlare di crociate, un fatto storico, che ti proietta di necessità dentro la storia. La cosa del genere letterario va approfondita perché anche la cronaca, come tutti gli altri generi, nasce nel medioevo e, come il romanzo, è una degenerazione del racconto storico. Lo storico e il cronista e il romanziere erano tipo la stessa persona. Solo adesso il cronista non sa la storia, e il romanziere non sa niente.
Lorenzo. (dopo una lunga pausa) Vabbene. Pare a questo punto che il colpo di stato in Turchia sia stato sventato. C’è chi inneggia alla democrazia salvaguardata dal popolo, chi invece tifava golpe, chi parla di autocolpodistato (tutta una parola come autogol?), chi suggerisce che sia stato organizzato dal think-tank di Fassino, mentre il Ministro del Lavoro di Erdogan dichiara pubblicamente che sono stati gli amerikani.
Anatole. Per oggi facciamo che stiamo?
Lorenzo. Ci possiamo stare. Il complottismo e anche questa cosa del genere letterario la facciamo quando ci abbiamo un attimo. Mo gna famo, veramente.
 Lecture on Nothing di Robert Wilson al Festival dei 2Mondi
Lecture on Nothing di Robert Wilson al Festival dei 2Mondi
di Maria Anna Mariani
Lecture on Nothing: quali aspettative si schiudono per lo spettatore davanti a un titolo così, un titolo che ostenta il niente come tema di una conferenza presentata a teatro? Chi compra il biglietto e poi una sera di luglio si incammina su per le salite di Spoleto verso il teatro Caio Melisso, perché lo fa? Forse perché sa che c’è Robert Wilson a portare in scena quel testo di John Cage che pretende di articolare il nulla, di plasmarlo con le parole e srotolarlo nel tempo. E dunque anche se il contenuto della rappresentazione minaccia di essere vuoto, il contenitore – il corpo sonoro di Bob Wilson – dovrebbe valere, di per sé, la scalata su per i vicoli puntuti di sassi e la sosta a teatro per un’ora e poco più, a slogarsi il collo da un posto disgraziato, da dove non si vede nulla, nulla.
Il quinto racconto della rubrica Bracciate è «Il polpo in insalata», testo vivo e fresco di Manuel Almereyda Perrone, svizzero di origine napoletana, di stanza a Marsiglia, dove ha fondato l’Agence de l’Erreur (www.lerreur.fr), con cui sviluppa i suoi progetti teatrali e cinematografici.
Il polpo in insalata

Mia nonna non la chiamo tutte le domeniche.
E quando la chiamo, so che prima devo fare stretching, rilassare la respirazione, sorridere allo specchio, dopodiché prendo la cornetta, compongo, dico “ciao-nonna-sono-io-Manuel” tutto d’un fiato e ascolto, per dieci buoni minuti, un flusso ininterrotto di lamentele.
Sono momenti in cui mi sento responsabile dei mali del pianeta, anche se i mali in questione sono solo quelli di mia nonna.
“Tu non chiami mai. ”
Sto chiamando- penso.
“Tu mi fai morire! ”
Strana forma di omicidio l’assenteismo- penso.
“Pensa alla buon’anima di tuo padre! ”
Ancora? Son venticinque anni che è morto, è vero non lo chiamo mai neanche lui, ma c’è un perché.
“E di tuo nonno !”
Ci sto pensando e mi viene il magone e un sentimento di colpa anche per cinque milioni d’ebrei, gli armeni, i curdi, i palestinesi, e tutti gli oppressi del pianeta.
“Mi sono fatta vecchia vecchia, na vecchiarella”
A occhio e croce conosco mia nonna da quando sono nato, tolti alcuni anni di coscienza informale da bebè, sono una trentina d’anni che la conosco e che sta inesorabilmente diventando vecchia vecchia: quanto può durare l’invecchiamento? Una vita intera?
“Ho fatto solo la quinta elementare, però l’educazione la so.”
Su questo non me la prendo: lo so che ha diritto a vendicarsi su di me per aver lasciato i quaderni per la zappa a dodici anni.
“Non sono intelligente ma la so.”
Mi dispiace che mia nonna confonda istruzione con intelligenza: vorrei presentarle tutta una serie di professori e luminari perché chiarisca questo qui pro quo.
A questo punto in genere si rilassa, mi racconta i cancri delle sorelle con un piacere morboso per i dettagli, la cecità di Velia, la sua preferita che vive in Inghilterra da sempre, e che la chiama due o tre volte al giorno
“Uh quanto chiama quella, ma non ha niente da fare? Mi fa morire! ”
Ma come: anche lei? Ma si sa: gli estremi si toccano.
Poi, in apnea, continua per altri dieci minuti sulla vita, morte e miracoli degli abitanti del paese – per fortuna che è uno di quei paesi quasi fantasma di vecchi e bambini in cui quasi tutti sono emigrati da tempo – e alla fine mi fa ridere con i suoi proverbi e le sue dicerie che mi fanno capire che in fondo tutto funziona uguale da sempre.
Ho trovato una tecnica, per schivare questa sua inclinazione a incriminarmi di tutte le nefandezze del pianeta, che funziona anche quando non la chiamo da mesi.
“Nonna – dico subito- sto cucinando. Mi chiedevo… i calamari meglio chiuderli con lo spago o con uno stuzzicadenti? Sì, non li riempio troppo, certo, se no esplodono.”
Come per magia in quei casi non esiste nient’altro, nessun conflitto ci separa e anzi una sottile linea si disegna e ci ricongiunge nel tempo e nella distanza: non siamo più rivali ma diventiamo complici, gomito a gomito, davanti ai fornelli.
Se una ricetta si interpone tra di noi tutto il resto scompare.
Mi è successo vivendo a Buenos Aires, a diecimila chilometri e cinque fusi orari di distanza. Mi succede anche in Francia. È successo così per il polpo in insalata.
Purtroppo, o per fortuna non so, l’ho chiamata giusto quando Elvira, la sua vicina – amica e nemica del cuore – era passata a trovarla.
“Passa sempre quella”
“Meglio, no?”
“Meglio cosa? Viene qui per controllare.”
“Controllare cosa?”
“Quello che cucino, poi torna a casa e lo fa pure lei.”
Mia nonna da poco ha messo una telecamera di sorveglianza sopra il portone.
Anni di Raiuno riescono a convincere l’ultimo dei sottoproletari che condivide gli stessi problemi di un Rockefeller.
E la telecamera, a circuito chiuso, si affaccia su un monitor, che lei può riuscire a controllare anche mentre cucina. È così che ha scoperto chi da anni le fa lo scherzo del campanello; chi suona e poi scappa.
Si: Elvira… Ma non le darà mai il gusto di dirle che lo sa.
Penso che sia amore il loro. Amore vero.
Comunque ai tempi di questa telefonata ancora non aveva la telecamera e Elvira era lì.
E quando ha sentito mia nonna dire “polpo” le ha strappato la cornetta di mano e ha preso i comandi della conversazione.
“Per ogni chilo di polpo tu ne metti il doppio di patate. Dopo aver bollito le patate, le metti sul fondo e le copri col polpo e il suo succo, che vedi che prendono il sapore e poi tutti ti dicono che buono e mangiano le patate credendo che è polpo! ”
Ha riso: era contenta. Fiera di quell’intelligenza meridionale che trasforma un problema in una soluzione. Quella stessa intelligenza che fa si che per una stessa zucchina o melanzana esistano centinaia di pietanze diverse.
Ho ringraziato, mi ha ripassato mia nonna, che ha borbottato qualcosa, stranamente taciturna, e ho appeso.
Un paio d’ore dopo mia nonna mi ha richiamato in panico.
“Lo fa per umiliarmi.”
“Ma cosa?”
“Le patate.”
“Che patate?”
“Come che patate? Quelle del polpo. Ti ha detto così per trattarti da straccione, per umiliare me.
Tu non devi mettere così tante patate che se no sembra che sei un morto di fame.
Non avrebbe mai detto una cosa così ai suoi di nipoti ! Mai ! Ma me, mi voleva umiliare.”
“Ma nonna….”
“Niente ma. Le patate non devono mai essere più del polpo. Se no che figura ci fai?”
L’ho rassicurata che avrei immediatamente cambiato la ricetta, adattandola alla verità che mi aveva appena rivelato: non potevo deluderla e l’ho sentita contenta.
Però io le patate le avevo già messe e già le avevo ricoperte di polpo, non potevo più tornare indietro.
Non so se era vero: se Elvira l’aveva detto per umiliarla o se era solo un complesso di mia nonna. Però devo dire che era buono, e alla gente è piaciuto.
Da allora l’insalata di polpo continuo a farla così.
Le polpette, la parmigiana, le lasagne, le zucchine alla scapece, i calamari ripieni, i peperoni al forno, i cannelloni, la pasta fresca: tutto, tutto glielo devo a mia nonna e alle nostre conversazioni telefoniche.
Il polpo in insalata no, quello è di Elvira.