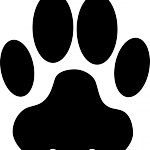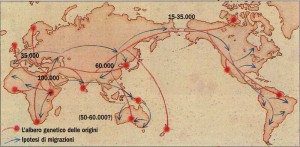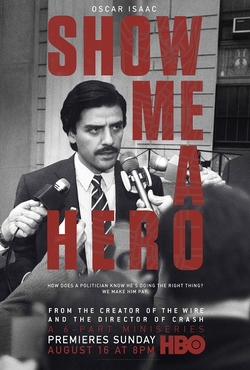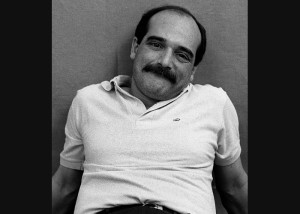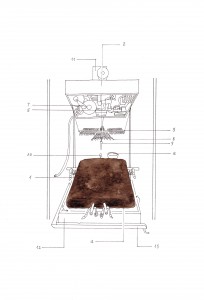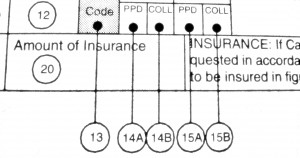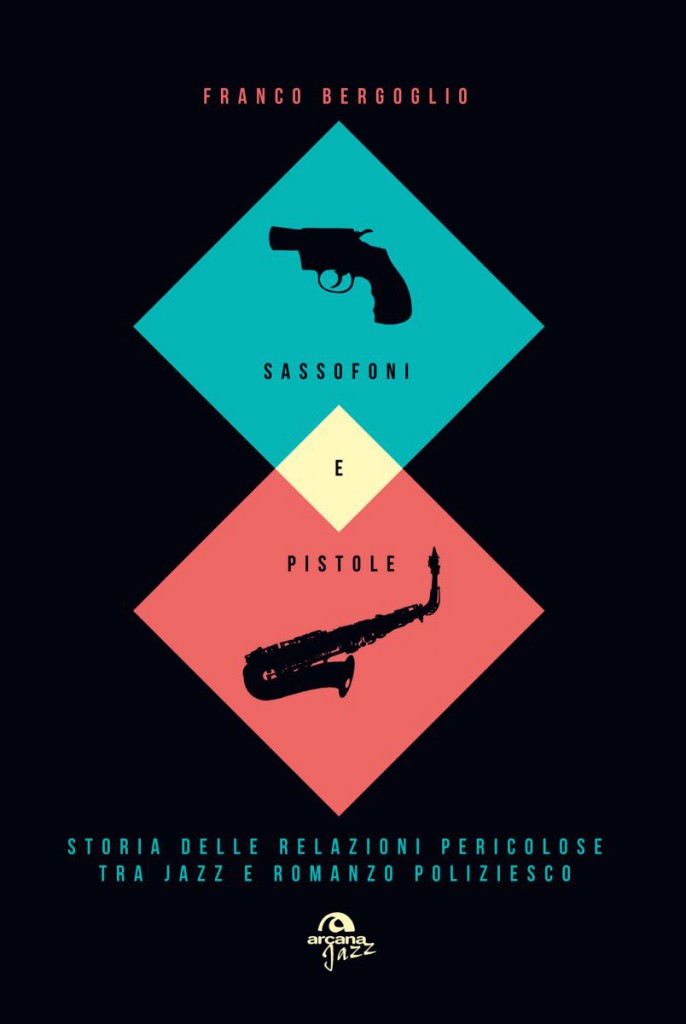I tafani della Merse
di
Simone Ghelli
Per fare quel ritratto che adesso teneva tra le mani Giovanni s’era dovuto avvicinare molto, a non più di un metro, e gli schizzi d’acqua gli erano andati sull’obiettivo e così erano rimasti impressi quei puntini, quelle microscopiche gocce che gli veniva di toglierle col dito. Nella fotografia Fabrizio aveva la bocca spalancata per il terrore e annaspava con un braccio nel tentativo di divincolarsi dalla presa di Danilo, che lo teneva da dietro per costringerlo a non uscire dall’acqua. Danilo lavorava alla cooperativa, andava al manicomio due volte alla settimana col furgoncino bianco e il disegno di un sole sulla fiancata con cui portava l’allegria. Fabrizio, che piangeva e si lamentava in continuazione coi dottori per le sue cadute e i dolori alle ossa, si metteva di buonumore non appena lo vedeva.
Quel giorno Danilo si era presentato già in costume e infradito ai piedi e aveva proposto di portarli alla Merse, come dicevano a Siena. Disse di conoscere un buon punto in mezzo al bosco dove avrebbero portato gli ospiti a fare il bagno. L’assistente sociale fu entusiasta dell’idea e ci mancò poco che non li abbracciasse, ma disse che purtroppo avrebbero potuto portarne al massimo quattro perché mancavano gli infermieri. Allora Danilo propose subito Fabrizio, che voleva tenere per qualche ora lontano dalle sue paure e dalle botte che prendeva in continuazione. Poi chiese a Giovanni chi altri volesse portare e lui propose Giulio, che stava dalla mattina alla sera accovacciato in un angolo. Si era così abituato a quella postura che ormai non riusciva più a camminare in posizione eretta e aveva bisogno di qualcuno che lo tenesse per un gomito e lo trascinasse.
«Giulio non dà fastidio a nessuno,» aveva spiegato Giovanni, «e anche la Teresa».
La Teresa parlava tutto il giorno coi suoi parenti morti, che vedeva da qualche parte sopra le nuvole, e quello le bastava. Poi Danilo fece il nome di Sabrina. Sabrina era difficile da tenere, aveva continui spasmi, non stava mai ferma e poi faceva quel rumore coi denti, quel rumore che era come uno sfregamento di giunture che si rompono e che a Giovanni faceva venire i brividi.
«Allora è deciso».
Danilo sorrise, sorrideva sempre lui.
Col furgoncino passarono per una strada sterrata, piena di buche, il sole sulla fiancata che splendeva in mezzo all’ombra dei cerri. Proseguirono fino a un punto in cui il fiume si allargava e l’acqua era bassa e un po’ stagnante per via di una diga naturale composta da sassi e pezzi di legno. Il posto era così pieno di tafani che Giovanni aveva dovuto azionare il tergicristalli per vederci qualcosa. Mentre percorrevano lentamente gli ultimi metri, Danilo aveva provato a spiegargli che la colpa era del motore, del calore che emanava, ma Giovanni non era riuscito ad ascoltarlo fino in fondo perché gli era preso il terrore di scendere ed era rimasto con le mani strette sul volante e gli occhi incollati al parabrezza che si affacciava sul corso d’acqua.
Quando furono finalmente fermi finse addirittura di cercare dei guanti in lattice sotto al sedile e rimase così, con le mani che razzolavano tra la terra e i sassolini sparsi sul tappetino, finché non fu sicuro che anche l’ultimo di loro fosse sceso. I tafani però non se n’era andati e alla fine aveva dovuto affrontare le sue paure ed era uscito di corsa con i palmi delle mani aperti davanti al viso e per poco non era inciampato sul greto del fiume. Non se n’era accorto nessuno, ma il solo pensiero di poter essere preso in giro gli aveva fatto perdere definitivamente la pazienza. Non aveva affatto voglia di dover costringere gli ospiti a fare qualcosa che non desideravano, e anche se Danilo affermava il contrario (che in loro i desideri andassero creati perché non erano stati abituati ad averne), certe volte Giovanni pensava che fosse una gran perdita di tempo perché tanto loro non avrebbero capito mai niente di niente. I primi tempi quei pensieri lo avevano fatto sentire una bestia.
Tutte le sue ore di studio e le idee romantiche sulla follia, che gli erano sembrate così forti da poter reggere l’urto contro ogni realtà, si erano sbriciolate nel giro di pochi minuti il giorno in cui un infermiere gli aveva chiesto se avesse per caso già fatto il vaccino contro l’epatite. In un attimo Giovanni aveva ripensato a tutti i malati che aveva toccato – altro che ospiti: quelli erano malati e contro la paura il linguaggio non aveva potuto niente – e improvvisamente aveva accusato un giramento e si era dovuto sedere perché gli tremavano le gambe e davanti agli occhi erano comparsi tutti quei puntini, proprio come quelli che erano rimasti impressi nella fotografia. Giovanni s’era dovuto avvicinare molto per farla. Aveva dovuto togliersi scarpe e calzini, arrotolarsi i jeans fino alle ginocchia e sopportare il contatto con il fondo limaccioso del fiume, dove sprofondava la pianta del piede. Danilo teneva Fabrizio da dietro e lo costringeva a immergersi fino al collo, che aveva tutti i tendini tirati per lo sforzo.
«Scatta adesso, scatta prima che si liberi!»
Rideva Danilo e rideva anche la Teresa, con le braccia sollevate al cielo e la gonna che faceva una nuvola sulla superficie dell’acqua. Giulio, invece, non rideva affatto. Fermo su un sasso come un granchio venuto a prendersi un po’ di sole, aveva la bocca piegata in quel modo a lui solito, che era un’espressione di disgusto.
«Scatta adesso, non riesco più a tenerlo!»
Sabrina era rimasta da sola a riva. Si rotolava per terra, raschiava il sudicio con le unghie che avrebbe poi ciucciato.
«Dai!»
Giovanni schiacciò il pulsante e bloccò il movimento di Fabrizio che si stava sbilanciando nello sforzo di divincolarsi dall’abbraccio di Danilo. In un turbinio di schizzi ritrasse il suo volto deformato dalla paura di cadere nell’acqua. A distanza di quindici anni la fotografia aveva conservato vivo ogni dettaglio e il ricordo di tutto ciò che premeva dal fuori campo – la cantilena di Teresa, lo sguardo fisso di Giulio, il ronzio dei tafani dentro a un tronco marcio, le gambe bianche e insozzate di Sabrina e tutto quello che era venuto dopo e che aveva avuto a che fare con lo smantellamento di quelle vite, che avevano sradicato e buttato altrove. In tutti quegli anni si era chiesto più volte se fosse stato anche lui una persona cattiva. Il fatto è che si era sempre nascosto dietro a qualcun altro. Non aveva mai fatto né più né meno di quello che gli veniva chiesto. Con Danilo vestiva la parte di quello che criticava l’istituzione e i suoi uomini, gli faceva credere che se fosse stato per lui chissà che rivoluzione là dentro. Danilo lo aveva sempre ascoltato con il sorriso. Sorrideva sempre, lui. Sorrideva anche il giorno che chiusero tutto.
«Vedrai che ora staranno meglio,» gli promise, «vedrai che finiranno i loro anni in pace».
«La smetteranno anche di chiamarli ospiti?»
«Cosa vuoi che gliene importi a loro di come li chiameranno».
Dopo che furono trasferiti non andò neanche più a trovarli, di loro non ebbe più notizie, eppure si ricordava tutti i loro nomi e anche la disposizione con cui prendevano posto a tavola. Li sognò soltanto una volta, ma non avrebbe saputo dire se fossero stati davvero liberi. Del sogno gli era rimasto soltanto il ricordo di questo ronzio, che era come un pungolo; la sensazione che anche lui, in fondo, non fosse poi tanto più buono degli altri.





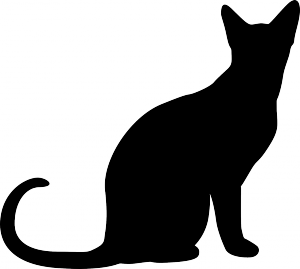 – Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.
– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.