di Erika Maderna

È uscito per Aboca La memoria nelle mani. Storie, tradizioni e rituali delle levatrici di Erika Maderna.
Ospito qui un estratto.
***
Erbe madri, pietre magiche e amuleti
Le mani della levatrice declinavano un alfabeto di gesti di antica memoria; il ritmo salmodiato di sapienti liturgie di parola orchestrava i tempi del parto. Ma un altro elemento importantissimo concorreva a completare il prezioso bagaglio delle competenze operative: una vasta e circostanziata farmacopea, appartenente a un filone sapienziale femminile che oscillava fra evidenze empiriche e magia. Le piante delle curatrici hanno una lunga storia, che le collega agli usi sacri di erbe medicamentose ritenute “materne”: quelle che la tradizione classica definiva matres herbarum, erbe madri, o per le madri, come se la natura le avesse generate al fine di salvaguardare la salute e la fertilità delle donne.
Fortunatamente, parte della trattatistica medica conserva abbondanti informazioni sull’utilizzo di queste risorse. La continuità fra il mondo classico e il Medioevo è ancora una volta sorprendente, ed è dovuta soprattutto alla fortuna di quel sorprendente catalogo di saperi che è la Storia naturale di Plinio il Vecchio, che nei capitoli dedicati alle risorse botaniche riportava un dovizioso inventario di rimedi.
Dalla summa pliniana si ricava una ricca aneddotica, che mescola evidenze empiriche, superstizioni e ritualità apotropaiche; un’eterogenea confluenza di tradizioni circoscrive la salute umana in una rete di corrispondenze fra uomo e natura, dove quest’ultima si esprime attraverso segnature, significati reconditi e conformità simboliche.
Plinio attribuiva grande utilità alle piante che definiva surdae e ignobiles, cioè silenziose e prive di fama, ovvero le erbe autoctone e spontanee che costituivano la base della tradizione farmaceutica mediterranea. Sono le piante di cui per secoli anche le donne si sono servite per curare.
Il complesso delle informazioni sulle affezioni ginecologiche comprende numerosissimi riferimenti. Una ricognizione dei rimedi più comunemente citati include erbe dalla denominazione marcatamente femminile: per esempio l’aristolochia, che come suggerisce la parola greca è “ottima per il parto”, cioè provoca il mestruo e ha potere espulsivo; il ciclamino, il cui nome suggerisce un beneficio per il “ciclo”; l’artemisia, pianta “artemidea” dalle qualità emmenagoghe; il partenio (“erba vergine” o “erba delle vergini”), che in forma di pessario procura le mestruazioni e favorisce l’espulsione della placenta. Ma ricorrono anche erbe comuni quali l’iperico, la betonica e la piantaggine, impiegate per le più diverse affezioni dell’utero e per quelle conseguenti al parto.
Di uso frequente erano poi il dittamo e la malva, che in pozione o in fumigazione provocano le mestruazioni e facilitano il parto; la calendula regolatrice del flusso mestruale e la menta che lo blocca; la verbena, il cumino e l’ortica contro i crampi uterini, il polio per espellere la placenta e i feti morti, il fieno greco per gli indurimenti, i gonfiori e le contrazioni dell’utero.
Anche l’anice godeva di un ampio utilizzo. Plinio ricorda che un certo Dalione, erborista, ne prescriveva cataplasmi da applicare sul ventre per calmare i crampi uterini, e alle gravide somministrava talora una pozione di anice e aneto, sostenendo che dopo averne odorato l’aroma riuscissero a partorire più facilmente.
All’alloro nano, ai semi pestati del fieno greco e al sonco scaldato in vino bianco o olio si ricorreva per facilitare il travaglio. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi. I tipi di preparazione erano numerosissimi e variegati, e spaziavano fra infusi, decotti, unguenti, polveri, macerati, suffumigi, impacchi, purganti.
Un approfondimento a parte merita il ricco sistema di amuleti botanici riservati alla gravidanza, al parto e alla protezione del neonato. Erano chiamati okytòkia, letteralmente “rimedi per un parto veloce”. Sebbene ad avere maggiore diffusione fossero soprattutto le pietre-amuleto, le fonti danno prova che certe piante erano ritenute efficaci non solo come ingredienti farmaceutici ordinari, ma anche come talismani, grazie alla loro carica di energie benefiche. Conservate all’interno di piccoli sacchetti, venivano posizionate a contatto con il corpo oppure appese alla cintura.
Anche in questo caso, l’enciclopedia pliniana si rivela una risorsa aneddotica fondamentale. Si dà conto, per esempio, di come i semi del cetriolo favoriscano il concepimento e giovino al parto, qualora avvolti in lana d’ariete e messi sulle reni della donna a sua insaputa, a patto che subito dopo il parto vengano immediatamente portati fuori dall’abitazione della puerpera. Similmente, il ramo di un moro, colto con la luna piena e a condizione che non abbia toccato il terreno, se legato al braccio delle donne rimedierebbe a un flusso mestruale sovrabbondante. Anche il vischio, raccolto nella prima fase della luna senza usare strumenti di ferro e senza fargli toccare terra, funzionerebbe come talismano. Approccio sperimentale e funzione magica convivevano legittimamente, senza conflitto.
Un’altra pianta utilizzata a tale scopo era la malva, erba spontanea assai comune: Risulta che le partorienti sgravano più rapidamente se sotto di loro si pongono delle foglie di malva, le quali immediatamente dopo il parto devono essere tolte per evitare che venga espulso l’utero. Alle partorienti si fa bere anche, a digiuno, del succo ottenuto facendo bollire in vino un’emina di malva.
L’impiego nella fase finale del parto era giustificato da un presunto potere espulsivo di questa erba: si tratta di una delucidazione che Plinio si premura di aggiungere, attribuendone la paternità alla scrittrice e ostetrica Olimpiade di Tebe. La necessità di sottrarre un okytòkion subito dopo il parto, e addirittura di portarlo fuori dalla stanza della puerpera o dall’abitazione, rispondeva alla necessità di evitare che la forza espulsiva dell’amuleto continuasse a operare, trascinando fuori dal corpo della donna anche l’utero e le viscere.
È lecito supporre che tutte queste informazioni, esito di un accurato spoglio della letteratura disponibile sulla medicina ginecologica, abbiano in gran parte attinto alla tradizione delle levatrici, che di quei rimedi semplici e composti sperimentavano quotidianamente sul campo successi e fallimenti. Tuttavia, la mancanza di fonti dirette non ci concede di andare oltre la congettura intuitiva. Questo almeno fino al VI secolo, quando un manuale di un’ostetrica bizantina, Metrodora, avrebbe permesso finalmente di operare un confronto con la tradizione operativa di ostetriche e medichesse. Avremo modo più avanti di descrivere nel dettaglio questo testo, prezioso per il nostro approfondimento; qui è tuttavia importante rilevare come la dotazione farmaceutica di Metrodora riveli un’evidente continuità con le informazioni di fonte pliniana.
Per le infiammazioni dell’utero troviamo prescrizioni di massaggi con olio di mirto, di maggiorana o di giglio; in caso di parto difficile rimedi a base di ruta, aneto, cumino. Per evitare gli aborti spontanei l’ostetrica bizantina ricorreva all’onnipresente artemisia, mentre per i disordini del mestruo e vari altri disturbi tipici femminili si trovano medicamenti a base di salvia, aneto, camomilla, altea, fieno greco, lentisco, e, ancora una volta, ruta e artemisia. Metrodora ricorre di frequente anche all’uso dei pessari, cioè tamponi di erbe compresse da inserire all’interno della vagina a scopo anticoncezionale o per trattare piaghe o altri disturbi, per lo più preparati con foglie di rovo o di mirto e rose secche.
Facendo un salto di alcuni secoli, queste stesse piante sarebbero state protagoniste indiscusse anche della tradizione ginecologica della Scuola medica salernitana. Nel Libro sulle malattie delle donne, attribuito a Trotula de’ Ruggiero, si cita una bevanda chiamata diathessaron, utile per i disordini del mestruo, composta da menta o mirto, genziana, aristolochia e bacche di alloro in eguale dose, assunti con miele e acqua. Per le stesse evenienze, si ritenevano salutari erbe diuretiche quali finocchio, spigonardo, sedano selvatico, cumino, cicuta velenosa, carvi, prezzemolo, cotti nel vino o bevuti con miele.68 Negli scritti salernitani l’artemisia e la ruta vengono menzionate con grande frequenza, così come la menta, la piantaggine, il mirto, il giusquiamo, il fieno greco, la verbena, l’altea, la camomilla, la salvia e l’alloro.
Tutta imbevuta di sapere farmaceutico è una prescrizione relativa alle difficoltà nel parto, presente nel libro Cause e cure della badessa tedesca Ildegarda di Bingen, nella quale si può anche osservare come si ripresenti il tema dell’apertura e della chiusura del corpo femminile, che continua ad abitare il linguaggio simbolico del parto. L’efficacia del finocchio e della renella, infatti, viene attribuita alla capacità di queste erbe di scaldare soavemente, e dunque schiudere e sciogliere, le membra.
Se una donna incinta fatica molto durante il parto, si cuocia in acqua, con precauzione e grande controllo, un poco di erbe leggere, ossia il finocchio e la renella, e tolta l’acqua, le si disponga calde intorno ai fianchi e al dorso della donna, legandole delicatamente con un panno che le tenga ferme, affinché il dolore e le chiusure si sciolgano un poco più facilmente e dolcemente. Gli umori cattivi e freddi che sono nella femmina quando è incinta, la contraggono e la chiudono, ma il soave calore del finocchio e della renella, esaltati dalla dolcezza dell’acqua messa sul fuoco e disposti intorno ai fianchi al dorso, dal momento che proprio in quei punti la donna soffre per la contrazione, stimolano le membra ad aprirsi.
Ma erano soprattutto certe pietre, dette “pietre gravide”, a corredare l’armamentario degli oggetti scaramantici. L’aetite, o pietra aquilina (così chiamata perché si diceva andasse cercata nei nidi delle aquile), ricordava nella forma un utero gravido, e per questa ragione le veniva riconosciuta una funzione benefica per il parto. Ha la caratteristica di contenere un’altra pietra più piccola, che come in un guscio si muove quando la pietra “madre” viene scossa: questo dettaglio rendeva intuitiva l’analogia con un feto nel grembo materno, e la conseguente presunta azione terapeutica per magia simpatica. Veniva posizionata a contatto col corpo, all’interno di un involucro di pelli animali, al fine di trattenere il feto nell’utero scongiurando l’aborto; come ogni altro okytòkion, andava però assolutamente rimossa nella fase conclusiva o subito dopo il parto, per evitare un prolasso uterino o conseguenze peggiori.
Tali superstizioni sono rimaste vitali molto a lungo, tanto che l’utilizzo della pietra aquilina caratterizza anche in tempi recenti alcune tradizioni popolari. Si usava legarla al braccio o al collo della donna gravida per attirare simbolicamente e fisicamente il feto verso l’alto, scongiurando così una fuoriuscita prematura; durante il parto, poi, veniva rimossa e collocata sulla coscia, in modo da esercitare, quasi fosse una calamita, una forza d’attrazione opposta.
Le pietre gravide potevano essere fornite dalla levatrice, ma spesso appartenevano al patrimonio delle donne della famiglia, oppure venivano inviate, scambiate o prestate all’interno della rete parentale o amicale. Trotula de’ Ruggiero ci ricorda che la conoscenza specifica delle proprietà di questi particolari ausili era di solito affidata all’esperienza delle ostetriche:
Ugualmente si noterà che vi sono certi rimedi fisici il cui potere ci è oscuro, i quali sono utili quando espletati dalle levatrici. Pertanto fa che la paziente tenga un magnete nella mano destra e questo le gioverà. Fa che beva raschiatura di avorio. Giova il corallo sospeso al collo. Allo stesso modo, è utile somministrata in una pozione la materia bianca che si trova negli escrementi di falco. In una maniera simile, l’acqua nella quale sia stata lavata la pietra del primogenito trovata nel ventre di una rondine o nel suo nido giovevole per lo stesso stato e per molti altri.
Anche fra le pagine del Libro delle creature di Ildegarda di Bingen troviamo testimonianza di convinzioni che assegnano alle virtù dei cristalli efficaci poteri protettivi, e in aggiunta propongono immagini e simboli estremamente suggestivi. In precedenza abbiamo menzionato l’utilizzo rituale di una pietra denominata “sarda”, che la badessa cita per una sua presunta virtù “espulsiva”; ma è altrettanto sorprendente una notizia riferita al diaspro, segnalato per essere un potente talismano scacciadiavoli, capace di proteggere contro le presenze malevole che possono insidiare la salute della madre e del bambino dopo il parto.
Quando una donna partorisce un bambino, a iniziare dal momento del parto e per tutto il puerperio tenga in mano un diaspro: gli spiriti malvagi dell’aria non potranno fare del male a lei né al suo bambino. La lingua dell’antico serpente è attratta dal sudore del bambino che esce dalla vulva della madre e in quel momento insidia tanto il bambino quanto la madre. Se dunque il serpente esala il suo alito in qualche luogo, colloca lì un diaspro: il suo fiato s’indebolirà, farà meno male e il serpente smetterà di soffiare.
Ancora più stupefacente si rivela questa bizzarra storiella: quando la femmina del topo deve partorire, fa fatica e trova difficoltà. Allora, mentre soffre, si reca sul bordo dell’acqua, cerca delle pietre piccolissime e ne ingoia tante quante ne può tenere in gola. Poi corre nella sua tana, le risputa, soffia sopra, le copre con il proprio corpo, le riscalda e subito partorisce. Dopo aver partorito, scopre di detestarle e le respinge con le proprie zampe, si sdraia sui propri piccoli e li riscalda. Se qualcuno potesse trovare quelle minuscole pietre entro un mese dal momento in cui la femmina del topo le ha respinte e le attaccasse sull’ombelico di una donna che è già in travaglio ma non riesce a partorire, costei partorirebbe rapidamente, poi dovrebbe subito allontanare le pietre.
Questo tipo di oggetti scaramantici avrebbe assunto nel tempo forme e modalità di utilizzo differenti, adattandosi di volta in volta a linguaggi e ritualità più affini al contesto religioso. Nella tradizione cristiana, la funzione protettiva accreditata agli amuleti okytòkia sarebbe stata assorbita, fino a tempi relativamente recenti, dai cosiddetti “abitini” e dai “brevi”.
I primi erano piccoli sacchetti contenenti immaginette dei santi, che le donne gravide posizionavano sotto gli abiti. Analoghi, e ugualmente operanti per magia di contatto, erano i “brevi”, fogli di carta o pergamena recanti formule propiziatorie o preghiere. Potevano essere preparati anche con la cosiddetta “carta vergine”, un materiale ricavato dalla lavorazione della membrana amniotica che talora riveste il neonato quando “nasce con la camicia”, e alla quale si attribuivano poteri magici. Questa veniva portata in chiesa di nascosto, per “assorbire” le benedizioni durante la messa, oppure fatta battezzare insieme al bambino, occultata fra le vesti. Poi, una volta fatta seccare, si poteva utilizzare come supporto su cui scrivere invocazioni e formule benauguranti. La segretezza che doveva necessariamente coprire la preparazione di questi amuleti ne identificava tuttavia anche la natura illecita in quanto superstiziosa; e non è un caso se molte delle informazioni relative a queste pratiche si ricavano dalle carte relative a processi per stregoneria.
Quest’ultima considerazione introduce un elemento rilevante, ai fini del nostro intento di tracciare l’identikit storico della levatrice, ma soprattutto di circoscriverne la rappresentazione sociale e culturale. Osservando la variegata trama, e la connotazione fortemente magica, delle procedure che abbiamo considerato, non sorprende che l’identità della levatrice abbia potuto essere soggetta a un’ambivalente rappresentazione. Oltretutto queste operatrici, che si muovevano in un territorio estremamente delicato, erano sottoposte a un giudizio collettivo assai poco incline ad accreditare fiducia alle iniziative delle donne.
La loro storia si è pericolosamente incrociata con quella di epoche ostili a ogni forma di sapere femminile, che in molti casi hanno assunto forme persecutorie.








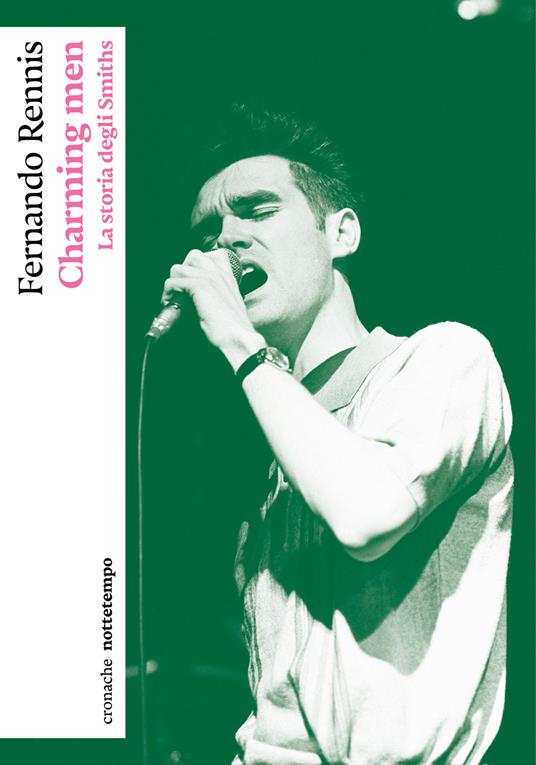

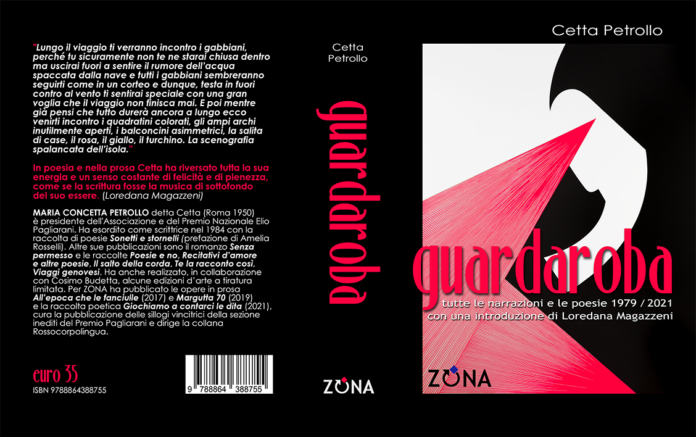
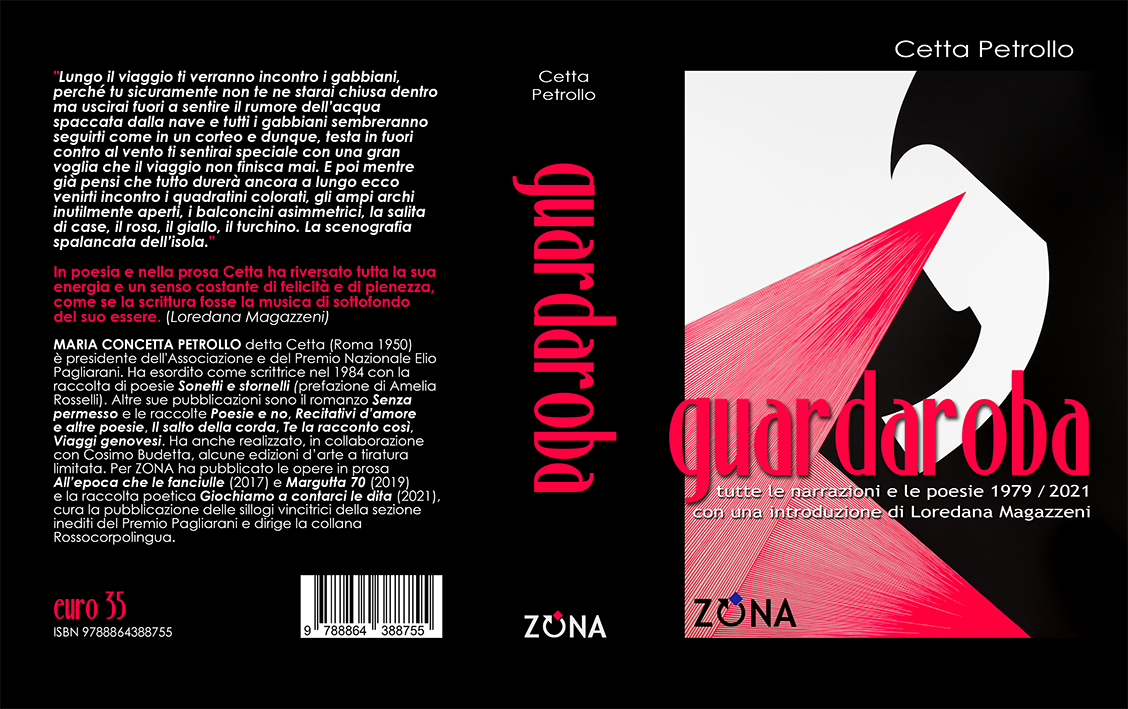


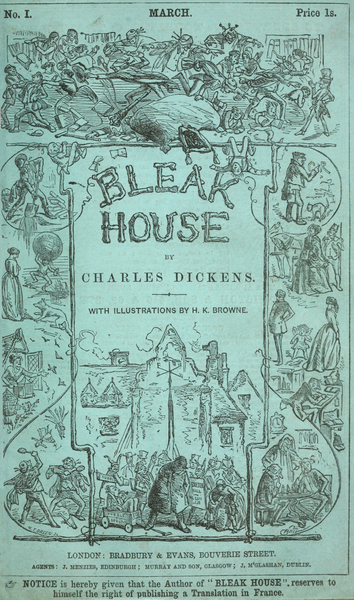
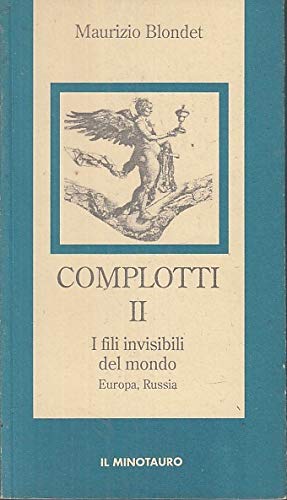
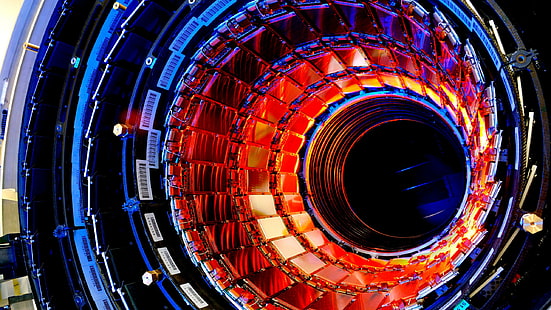













 “Che cazzo è?”
“Che cazzo è?”
