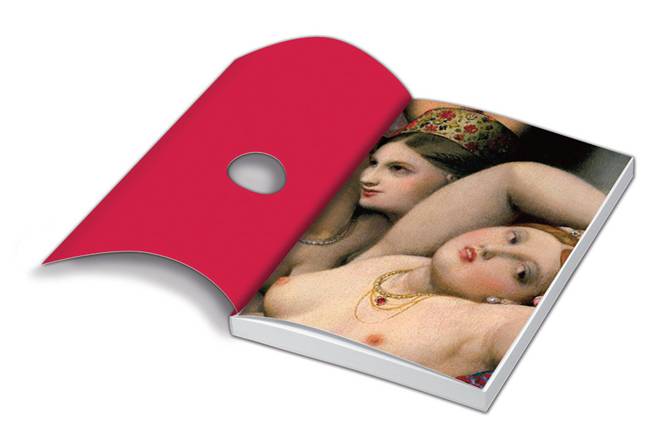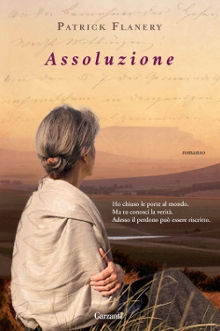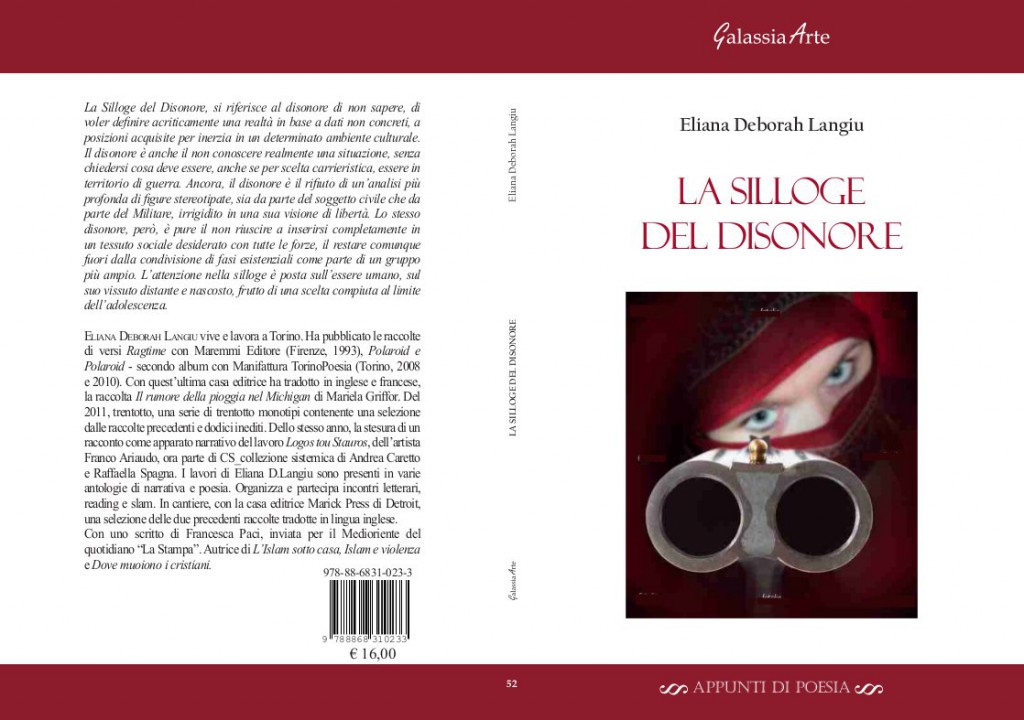Un milione d’anni fa ecco Mohamed. Fuggiva da Mogadiscio per salvarsi la vita. Lo rinchiudevano cinque mesi a Ganfuda prigione libica di Bengasi e «il direttore della prigione si chiama Ibrahim, lui ha deciso che se vuoi essere libero devi pagare denaro». Mescolava la scabbia, le zecche, i soldi, la libertà, confezionava la vela, costruiva la zattera e «c’è questa grande nave» e «noi eravamo 260» e «qualcosa del genere» e «troppa gente». Ma: Portopalo. Ma: un’ascesa. Verticale. Verso Perugia. Cammino nel sacrosanto diritto del profugo a vivere. Fabrizio Ricci raccolse la storia nel video. Mohamed raccontò, mostrò, spiegò. Era infermiere. A Mogadiscio. Disse del viaggio. Disse: «Come animali». Oggi è uomo, nel suo diritto, infermiere, lavora da noi, in una clinica, «non posso lamentarmi», spiega, «di come vanno le cose». La famiglia è venuta a trovarlo. La famiglia è tornata in Somalia. Nel video, un milione di anni fa, aveva lo sguardo scottato. Diceva: «Fate qualcosa». «Fate qualcosa di diverso». Diceva: «Non respingeteci». «Come animali». [D.O.]
Le coglionerie di Paolo Giordano, i romanzi merda, le vetrine delle belle librerie all’estero
di Giacomo Sartori
Cominciamo dai fatti. In quest’autunno ancora mite in tutte – dico tutte – le vetrine delle belle librerie della città estera dove mi trovo c’è la traduzione di una merda di Paolo Giordano. Ma no, già parto male, il prodotto di Paolo Giordano devo chiamarlo romanzo, non merda. Lo sappiamo tutti, fin dall’inizio romanzo ha voluto dire merda e nettare, borghesia ottusa e animi illuminati, baldanzosa ignoranza e monacale erudizione, bigottismi e trasgressione, logorrea e essenzialità, abissi spirituali e sgualcite banconote, accademici sovrappeso e geniali morti di fame, popolo e elite, nauseanti luoghi comuni e eterea intelligenza, inondazioni editoriali e tirature infime (o postume), piattezze letterali e strati sotterranei di senso, verità sull’uomo e prevenzioni del tempo, artifici retorici e libertà espressiva, romanticherie e rigore dell’analisi, frasi dozzinali e perle linguistiche. E anzi, proprio in questa dialettica tra opposti inconciliabili, e nell’impossibilità di tracciare precise linee di demarcazione (e ancora più di teorizzarle), sta forse l’essenza dell’inafferrabile genere. Quindi mi correggo, questa mercetta tipografica non la chiamerò più merda, ma romanzo. Romanzo a tutti gli effetti. Romanzo che io non leggo, e non leggerò mai, che non ha nulla ha a che fare con la mia idea di romanzo (e con i romanzi e non romanzi che scrivo io), ma comunque romanzo. E mi scuso anzi per aver usato quel vocabolo, per la mia volgarità: non volevo offendere nessuno. Chi mi conosce sa che a parte qualche asmatica intemperanza sono una persona mite e tollerante (e anzi sempre più con l’età). L’insignificante Giordano ha tutto il diritto di scrivere le inezie che scrive, e contento lui se ha tanti lettori. No, sbaglio: non solo ha diritto, ma deve assolutamente scrivere le coglionerie che scrive, il Romanzo, la Letteratura, ne hanno bisogno. Non potrebbero esserci i poli sublimi, senza i paoli giordani.
[È scontato che adesso sarò accusato di essere invidioso di Paolo Giordano, o insomma del suo successo, di essere il tipico scrittorucolo frustrato che sfrigola nel livore. Giuro sulla Bibbia, o sui volumi della Recherche, che non sono invidioso di Paolo Giordano o della sua notorietà. Come non potrei invidiare un signorotto che conduce una Ferrari, perché a me la sua Ferrari non dice nulla, e tanto meno la tipologia umana che ama possederla e fregiarsene. So però che sono parole inutili: già dalle prime righe sono stato bollato come un geloso fallito, quindi lascio stare.]
Riveniamo ai fatti: in tutte le vetrine delle librerie (e anche dei giornalai!) della città dove sto c’è questo lucido romanzo di Paolo Giordano, che è il contrario di quello che io reputo un buon romanzo, ma è pur sempre un romanzo (si noti che faccio dei progressi). Questo romanzo è pubblicato da un’ottima e gloriosa casa editrice del paese dove mi trovo adesso. Un editore che qualche anno fa (dico qualche, non dieci) non avrebbe nemmeno preso in considerazione uno scrivente come Paolo Giordano. A costo di andare a scovare (e magari in un periodo in cui la narrativa italiana non aveva la cote!) autori italiani poco noti, o non ancora noti, a costo di correre il rischio (succedeva) di vendere solo qualche centinaio di copie, per poi pubblicare un’altra opera dello stesso, che a sua volta vendeva qualche centinaio di copie (succedeva). Adesso invece questo solido pilastro delle lettere traduce Paolo Giordano, e a quanto intuisco non prende nemmeno più in considerazione autori italiani che non siano come Paolo Giordano. Questa è un’autentica rivoluzione, che io, che non so in fondo nulla dell’editoria (mi interessano i dettagli?), e che frequento sporadicamente persone che ci lavorano, e non vado alle fiere, e ho tutt’altro per la testa, rilevo nelle vetrine delle librerie davanti alle quali mi fermo. [Certo gli addetti al mestiere, se leggessero queste mie parole, avrebbero a questo punto un sorrisetto di condiscendenza: avrebbero perfettamente ragione.]
Devo del resto confessare che non entro spesso in libreria, nella città dove mi trovo, anzi molto di rado. Il problema è che se entro compro dei libri, perché a me i libri piacciono molto, e trovo sempre qualcosa che mi entusiasma. Se faccio l’erroraccio di entrare, acquisto tre, quattro, cinque libri (quando ne compro uno solo è perché sono di fretta, o la libreria proprio non mi garba, ma mi dispiace che il libraio mi veda uscire a mani vuote: oltre ai libri amo anche i librai), che qui sono molto costosi (in altri periodi erano meno costosi che in Italia, ora non è così). E insomma arrivo poi a casa con la mia piletta di libri nuovi fiammanti, e mia moglie vede che invece di aver fatto la spesa ho comprato solo libri, e il frigo resta vuoto. Mia moglie è molto comprensiva, e anche lei ama molto i libri, ci mancherebbe, però insomma le piace anche che nel frigo ci sia qualcosa, quando ritorna stanca dal lavoro. Questo è il motivo per cui lotto con me stesso per non entrare nelle librerie. Beninteso con la stessa difficoltà e gli stessi cedimenti che hanno i giocatori di azzardo nei confronti dei luoghi manigoldi dove si gioca. Però insomma in questo dominio posso essere fiero di me, di solito riesco a padroneggiare le mie pulsioni (per prudenza le vetrine le guardo soprattutto nelle mie passeggiate notturne, quando so che non corro alcun rischio di poter entrare a spendere i quattrini destinati al cibo).
Ma torniamo ancora ai nomi italiani nelle vetrine delle librerie della città di cui parlo. Se si trattasse solo di Paolo Giordano sarebbe niente. Il problema è che in questo momento affacciati alle belle strade ci sono molti altri romanzi italiani che nella mia testa finiscono nella stessa categoria in cui è cascato quello di Paolo Giordano. Veramente tanti. Troppi. E la maggior parte pubblicati da gloriose case editrici che fino a qualche anno fa avrebbero disdegnato mediocrità del genere. Adesso non voglio fare dei nomi (già mi sono inimicato per tutta la vita il simpatico Paolo Giordano, per un post può bastare), ma insomma ci siamo capiti, parlo di quella desolante medietà (talvolta con qualcosa di buono, e/o accattivante, ci mancherebbe) che più sopra mi sono lasciato andare a chiamare pubblicamente (in privato la mia testa fa quello che vuole) merda. [Del resto la pensano come me, è noto, l’ottanta per cento dei critici, anche se per vari motivi spesso si limitano a mugugnare in privato o a rimpiangere i bei tempi passati, il cinquanta per cento degli addetti nelle case editrici, il trenta per cento dei librai e il venti per cento dei giornalisti culturali)]. Ma intendiamoci, aguzzando bene lo sguardo qualche bel nome italiano, certo un po’ sul lato, o nell’angolino, qualche volta c’è. Siti, per esempio, confezionato da un editore molto elegante e molto prestigioso, anche se davvero di nicchia.
E allora mi accorgo, lì davanti alla vetrina notturna, che sono parecchio preoccupato. Ma i lettori di questo paese, mi chiedo, avvezzi a ben altri nutrimenti (almeno nel passato), ameranno davvero queste insulsaggini italiane? La traduzione concorre forse a mascherarne almeno in parte l’idiozia? O le leggeranno perché è quello che passa il convento, come mandano giù i pomodori senza sapore, ormai ineludibili sui banchi della verdura? [Quando chiedo a mia madre novantaduenne: ti è piaciuto Paolo Giordano? Lei risponde: sì. Guardandola negli occhi: Ma ti è piaciuto DAVVERO? Pausa, poi: No] O forse il pubblico é ormai costituito prevalentemente da zittelle con cagnolino e papille gustative atrofizzate, visto che i giovani non leggono più? Quanto pesa questo fattore sociologico? E questo supposto rincoglionimento dei lettori va forse di pari passo con il pensiero unico? Perché proprio l’Italia è all’avanguardia in questo genere di laccate mercine? Davvero i critici italiani non hanno alcuna responsabilità, con i loro scafati silenzi, con i loro inspiegabili imballamenti, la loro pigrizia a leggere, la loro lamentosa pavidità? E che dire degli addetti delle case editrici che presuppongono che mia madre e il resto della gente – che disprezzano (altro che altezzosità di chi crede ancora – candido e arcaico! – alle qualità!) – non abbia cervello? E questi politici, rei del genocidio della cultura? Ma che ne sarà allora della carica innovativa e ermeneutica del romanzo, che per qualche secolo ci ha regalato perle così belle? Se le cose vanno così in fretta, l’anno prossimo troverò ancora Siti in vetrina? La forma romanzo può sussistere, se si annienta uno dei suoi due poli? Resisterà un manipolo di catacombali buongustai, o saranno cancellati anche quelli? O tutto all’opposto per qualche motivo ci sarà un magnifico riscatto dell’intelligenza e dello spirito critico e dell’apertura mentale e del gusto, e si tornerà a un affastellamento di geni, come è successo in qualche epoca (anche recente) della storia letteraria? Tutte domande molto ingenue (e in parte anche interessate: anch’io scrivo romanzi), di un poveraccio fuori da tutto (e che certo non è stato alla fiera di Francoforte) e molto invidioso della mediatica coglioneria di Paolo Giordano.
Clandestinità
di Giovanni Giovannetti
(prelevo, con il consenso degli interessati, questo molto interessante scritto dal Primo Amore, a.s.)

«Se alle elezioni politiche avessimo proposto l’abolizione del reato di clandestinità il M5S avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefonico». Lo ha detto Beppe Grillo, con buona pace della ragione, dell’interesse nazionale e di ogni residuo di idealità, in linea col più becero-populista-opportunista leghismo sedimentato nel maroniano “pacchetto sicurezza” che, il 24 aprile 2009, introdusse l’odioso reato di immigrazione clandestina (clandestino diventava anche chi non poteva più disporre del permesso di soggiorno).
Sciascia e La Cava: Un taccuino letterario a due voci
di Domenico Talia
«Caro La Cava, … vorrei tanto leggere i suoi Caratteri: da anni seguo la Sua attività, e sempre ho letto le Sue cose con grandissimo gusto. …» Inizia così, con una lettera spedita il 3 Maggio del 1951 da Racalmuto (nell’entroterra della provincia di Agrigento) a Bovalino (sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria), il lungo e denso scambio epistolare tra Leonardo Sciascia e Mario La Cava durato quasi quarant’anni. Una corrispondenza iniziata quel giorno e conclusa nel giugno del 1988 con un’ultima lettera di La Cava all’amico siciliano in cui si parla, come in tutte le altre, di letteratura e di vita. Trentasette anni di corrispondenze che compongono un ricco taccuino letterario a due voci. Un lunghissimo incontro epistolare che diventa anche un’auto-descrizione, che i due scrittori offrono inconsapevolmente, delle loro vite e delle opere dalla loro genesi fino ad arrivare alla pubblicazione e diffusione.
un buco nella rete
Quando i gioielli sono discreti: per un’estetica della vulva
di
Marilisa Moccia
Chi avrebbe mai pensato ad una estetica della vulva? Eppure, la sempre maggiore esposizione cui sono sottoposti gli organi genitali, di qualsiasi sorta di esposizione si tratti, sembra proprio aver fatto nascere l’esigenza di una vagina che è chiamata a rispondere a rigidi dettami di bellezza come estrema pratica igienica. Via tutti i peli, per lasciar vedere più dettagli e soprattutto via le piccole labbra troppo lunghe e pendenti si ricorre infatti alla chirurgia estetica per aggiustare le imperfezioni di una vulva “in disordine”, dalle labbra troppo lunghe o irregolari. Il diktat estetico imposto dall’industria del porno a cui molte donne si rifanno, e rifanno, seguendone gli stilemi, anche il look alla propria vagina, impone che la vulva debba, insomma, somigliare sempre più a quella delle bambine, glabra e nelle cui grandi labbra tutto possa racchiudersi e nulla fuoriuscire. Le pratiche di bellezza di repressione autodisciplinante approdano all’autolesionismo. Il corpo è consacrato nella sua astrazione asettica, quasi asessuata.
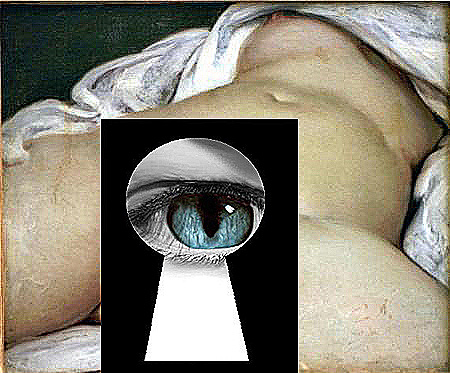
In passato, fatta eccezione per Courbet, a nessuno interessava cosa ci fosse là sotto. Nel Rinascimento non esisteva un termine anatomico per descrivere nei particolari il sesso femminile. La vagina veniva percepita come una variante rovesciata del sesso maschile, composta dagli stessi organi ma disposti in maniera differente. E se fino all’avvento massiccio dell’immagine pornografica la vagina era relegata “là sotto” come una questione poco interessante se non nella sua funzione di “buco” (nei porno degli anni 80 il pube è peloso), adesso tutti sanno come è fatta e in cosa differiscono le une dalle altre. L’invasione delle immagini ha sdoganato il processo di un’operazione di giudizio e paragone che ciascuno può operare tra ciò che si possiede e ciò che appartiene agli altri. Esibizione d’altronde rima con inibizione.
Il problema però non è il porno di per sé ma il modello di identificazione che dalle immagini scaturisce nella spettacolarizzazione della vulva, poiché come ci ha insegnato Debord «lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini». La novità di questi ultimi anni è che l’identificazione, processo rimasto per anni appannaggio maschile, ora sta cedendo lo scettro (per restare in tema di simbologia fallica) al gentil sesso. Per le donne il problema dell’identificazione è forse maggiore rispetto agli uomini. Non c’è molta possibilità di confrontare la forma della propria vulva con quella delle altre donne, data la conformazione anatomica, mentre per i maschi il rapporto di paragone è molto più naturale e quotidiano, si pensi alle docce dopo le partite di calcetto. Ciò sta a significare che l’unica occasione data alle donne per vedere altre vagine è soltanto quella dell’immagine pornografica.

In Australia è nato un blog , in cui sono state raccolte foto di vulve inviate da donne da ogni parte del mondo. La maggior parte di esse ringrazia per aver posto l’attenzione sull’argomento poiché non immaginavano che l’irregolarità delle loro labbra fosse “normale”.
Così, al ritmo crescente del 20% ogni anno, sempre più donne, nell’occidente lontano dal fantasma dell’infibulazione, ricorrono a interventi di labioplastica. A sentire i medici che pubblicizzano da youtube con una certa nonchalance e compiacenza i prodigi del bisturi corregge l’ipertrofia delle piccole labbra “fastidiose perché non consentono di indossare biancheria intima”, viene veramente da chiedersi: sì, ma chi l’ha deciso che sono troppo lunghe? I commenti ai video si dividono fra quelli di alcune donne che trovano assurda la pratica chirurgica e le “estasiate”, tra cui alcune che chiedono se è possibile farsi praticare la labioplastica pur essendo minorenni. Il target è nettamente diviso in fasce d’età: fra adolescenti disposte alle pratiche narcisistiche più estreme e le loro “sorelle maggiori”, formatesi evidentemente in un clima ancora post sessantottino secondo cui la legittima riappropriazione del corpo rispondeva a pratiche secolari di oscurantismo.
Liberati i corpi dalle censure interiori, è cominciata la loro colonizzazione. Nel 1970 Baudrillard scriveva «occorre che l’individuo si assuma lui stesso come oggetto, come il più bello degli oggetti come il più prezioso materiale di scambio, perché si possa istituire al livello del corpo distrutto, della sessualità distrutta, un processo economico di redditività»
Ciò che sembra essere accaduto negli ultimi anni è un mutamento del narcisismo che non risponde più ad una logica diretta: IO CORPO, ma è diventato indotto: DIKTAT DELL’IMMAGINARIO SOCIALE IO CORPO, in cui il soggetto non è altro che un mediatore/esecutore ed ha il compito di agire per modificare e uniformare. Il paradosso della labioplastica è che standardizza i genitali esterni rendendoli simili a quelli degli altri mammiferi, le piccole labbra sono infatti il tratto distintivo della specie umana. Viene da chiedersi se, prima di vedere il video, prima che la figura del chirurgo genitale contribuisse alla costruzione di una doxa estetizzante, qualcuna di quelle donne che richiede per sé l’intervento di labioplastica si era mai posta il problema dell’eccessiva lunghezza delle proprie labbra.
Troppo semplice chiamare in causa la violenza simbolica e il dominio maschile, le donne imitano le donne o meglio, «si dà da consumare la Donna alla donna», la questione si fa più sottile e al contempo più sfuggente. Le pratiche narcisistiche paiono rispondere ad una sola logica: quella del capitale, non un capitale economico, ma un capitale estetico che potrebbe essere così formulato: il mio corpo vale le cure che gli propino. Il taglio delle piccole labbra rientra allora in un – assurdo – processo di capitalizzazione del corpo. Le labbra vengono immolate in nome del dio dell’estetica, del capitale estetico supplementare, che a quanto pare diventa più potente addirittura del piacere. Tagliare una parte delle labbra, ricche di terminazioni nervose e vasi sanguigni, vuol dire, infatti, ridurre inevitabilmente la porzione di superficie sensibile.
In quest’ottica la presenza dell’altro da sé lungi dall’essere sminuita, si rafforza: l’altro non è più qualcuno con cui condividere il piacere erotico ma lo spettatore di un corpo monadico, sempre più individualizzato, che basta sempre più a se stesso.
Poco male, dunque, se i “gioielli” sono bruttini e discreti, li si può sempre depilare, impreziosire con Swarovski (altra pratica che sta prendendo piede), trasformare chirurgicamente. Il fine ultimo non ha nulla a che vedere col potenziamento del piacere che dovrebbe essere il solo a interessare un sano rapporto col proprio organo genitale. Cosa resta allora della libera fruizione del corpo e del proprio piacere se non appena la vulva è stata liberata subito le si è costruito intorno una gabbia di costrizioni estetiche? Sembra che il concetto di “corpo” si sia evoluto secondo una parabola che va dal narcisismo alla medicalizzazione. Il corpo è diventato un feticcio che richiede un continuo intervento di manutenzione fatto di diete, fitness e autodisciplinamento. Il medico è colui che supervisiona l’operato dell’individuo e coopera al suo miglioramento e alla sua trasformazione estetica.

L’epoca moderna, che ha avuto il grande merito di liberare l’uomo dalla superstizione e da quella che Bauman ha definito «perdurante influenza della tradizione», ha formulato una religione del corpo, una sua sacralizzazione che travalica i confini dell’amor proprio trasformandosi in un amore malato che giunge fino alla nevrosi, all’autolesionismo, alla mutilazione.
Assoluzione
Orfano di genitori terroristi che si batterono contro l’apartheid, Sam Leroux è un ricercatore che riceve l’incarico di scrivere la biografia della celebre scrittrice Clare Wald. Per lui, che vive da anni a New York, è l’occasione per tornare in Sudafrica nei luoghi natali, e per incontrare la narratrice i cui libri da ragazzo gli hanno fornito una mappa di se stesso. “Ho cercato di scordare i motivi per cui sono partito, tutta la storia della mia vita che ho lasciato alle spalle, ma continua a tornare, come una malattia cronica”.
Tra la vecchia scrittrice e il suo biografo c’è una vicenda irrisolta che rimbomba tra loro, un catalogo di rimorsi, come si scopre negli ambigui anfratti delle rispettive riflessioni. Nelle scatole narrative di cui si compone il romanzo Assoluzione di Patrick Flanery (Garzanti, 408 pag., trad. di Alba Bariffi), una si riempie del racconto di Sam, a Città del Capo (e poi a Johannesburg), i suoi incontri con la scontrosa Clare, la scrittrice che lo riceve per i colloqui utili alla biografia: lei lo misura, quasi lo mettesse alla prova. Ripercorrendo i luoghi che lo videro bambino, Sam tenta di ridare volto ai genitori uccisi nel 1988 da un ordigno che forse avrebbero dovuto utilizzare, davanti alla centrale di polizia di Città del Capo.
Un altro anfratto di questo romanzo polifonico è dato dal punto di vista in soggettiva di Clare, dalla ricostruzione dei fatti che l’hanno segnata durante il passato malato del suo Paese, e per i quali oggi chiede una “assoluzione” laica. La scrittrice è convinta di essere stata responsabile dell’assassinio della sorella Nora, sulla sponda politica opposta alla sua. Nora, con la quale i rapporti erano diffidenti, scelse l’establishment, sposò un uomo di apparato. Clare era invece su una sponda liberal che strizzava l’occhio a movimenti radicali. Nora e il marito furono assassinati.
Un segmento centrale del romanzo è poi costituito dai diari della figlia di Clare, Laura: la catena che tiene stretti in un abbraccio muto la scrittrice e il ricercatore. Laura si diede alla lotta armata, conobbe i genitori di Sam, visse in clandestinità, poi sparì senza che di lei si sapesse più nulla. I quaderni, ultimo documento della sua vita, sono giunti fino alla madre. I taccuini di una donna braccata, quasi certamente morta dopo torture atroci, risultano il terzo punto di vista delle vicende, in queste vie dei canti che si intrecciano e si contraddicono. “Ci sono segreti che rimangono sepolti nella storia di questo paese”.
Anche se il regime di segregazione razziale è terminato, anche se ha operato la “Commissione per la verità e la riconciliazione” (che non ha riabilitato Laura), la ricomposizione dei frammenti è tutt’altro che realizzata. Sia nella società, solcata da un senso di paranoica protezione e sospetto, sia nella ricostruzione delle vite singolari. Laura aveva scelto di porsi oltre le regole, perché le regole erano sbagliate. Ma anche lei stava dalla parte sbagliata. Clare sa di avere deluso la figlia, perché, pur condividendone i presupposti politici di partenza, non le ha rivelato, quando ancora la storia poteva prendere un’altra piega, quanto fossero simili. Da vent’anni sogna l’agonia della figlia. Anche per questo, chiede oggi “assoluzione”.
Sebbene sia vittima della storia, anche Sam ha la sua dose di rimozioni per cui chiedere clemenza. Il confronto tra lui e Clare è una partita verso la resa dei conti, nessuno dei due svela le parti più segrete di sé: eppure Sam ha abitato nei libri di Clare in cerca di indizi, allo scopo di trovare la chiave di un’infanzia martoriata; e Clare ha davanti quel bambino orfano e sa che anche a causa sua ha deluso la figlia scomparsa.
Senza speranza di perdono da parte dei morti, restano, in un romanzo ricco e brillante, le compensazioni della storia (ingannevole), le deformazioni e gli adattamenti della memoria, l’innocenza, le complicità.
(pubblicato su Mucchio selvaggio n. 711 – Ottobre 2013)
Lombroso senza l’apostrofo
Da “il Reportage”, n.16, ottobre-dicembre 2013
L’ultima casa del dottor Lombroso
di
Juan Terranova
traduzione di Maria Nicola

1.
Il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso dell’Università di Torino si trova in via Pietro Giuria 15. Condivide l’edificio, noto come Palazzo degli Istituti Anatomici, con il Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando e il meno prevedibile Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti. Quest’ultimo presenta una collezione di “migliaia di frutti artificiali modellati dall’eccentrico Francesco Garnier Valletti”. Il pieghevole promette “un tuffo nel passato”, oltre che “un’occasione per riflettere sul tema, attualissimo, della biodiversità”. L’ingresso ai tre musei del Palazzo degli Istituti Anatomici – quello della frutta, quello dei corpi e quello di Lombroso – costa 10 euro. Ogni mercoledì l’accesso è gratuito e l’orario è dalle 10 alle 18 tutti i giorni, tranne la domenica che è giorno di chiusura.
2.
Con i suoi soffitti alti e i colori ocra, elegante e austero, il Palazzo degli Istituti Anatomici ripete il gesto architettonico generale della città. Gli eccellenti e saldi pavimenti di legno così come l’accurata lucentezza delle vetrine accentuano l’atmosfera da gabinetto scientifico dell’Ottocento. Nell’atrio già si vedono alcuni ritratti di criminali eseguiti a matita. Poco più avanti, pagato il biglietto, si entra nella prima sala intitolata “Motori, farmaci, telefono, lampadine”, dove si assiste alla proiezione simultanea di una serie di filmati. Dagli schermi, due personaggi discutono del progresso. Il giovane è enfatico e convinto; il vecchio, scettico. Astuzia del curatore: in pochi minuti i responsabili del museo ci avvertono che per capire Lombroso, per capire quell’entusiasmo, occorre risalire a un’epoca di intensi cambiamenti. Un’epoca in cui, nel giro di pochi anni, si scoprono o si inventano l’anestesia, la genetica, il motore elettrico, il motore a scoppio, la lampadina, la radio e il telegrafo senza fili. E ciascuna di queste scoperte o invenzioni genera a sua volta o perfeziona una disciplina destinata a percorrere tutto il Novecento.
La seconda sala ci presenta qualcosa di più “anatomico”. Uno scheletro completo ritto dietro un vetro saluta il nostro ingresso. Sono le ossa dello stesso Cesare Lombroso, esibite per sua volontà. Che cosa significa essere ricevuti dai resti ossei del padrone di casa organizzati come se ancora potesse camminare? Questo fantasma ci dà il benvenuto in un luogo di scienza che è anche una tomba collettiva e un testamento pubblico. La sua presenza dimostra molte cose, alcune delle quali di così difficile interpretazione da sfuggire al visitatore e forse anche ai curatori, agli studiosi e allo stesso criminologo. Primo dato oggettivo: Lombroso era basso. Lungo di braccia, il suo scheletro ricorda quello di un primate evoluto. E, con buona approssimazione, dalle fotografie come dai ritratti, si può dedurre che fosse un piccoletto grassoccio, non certo un atleta.
Che altro? Cesare Lombroso nasce nel 1835 nel Regno Lombardo-Veneto, governato in quel momento da Vienna. Studia medicina a Pavia. Nel 1859 si arruola come medico militare e presta servizio nella seconda Guerra d’Indipendenza. Nel 1870 elabora la sua teoria dell’”atavismo criminale”, che stabilisce un nesso tra l’inclinazione al crimine all’ereditarietà. Sei anni dopo pubblica la sua opera di riferimento, L’uomo delinquente, e diventa professore all’Università di Torino. Nel 1898 inaugura il suo museo di psichiatria e criminologia. Nel 1904 abbandona il seggio di consigliere comunale della città di Torino e lascia il Partito Socialista. Lombroso, socialista? Il museo insiste parecchio su questo punto. “Progresso” e “socialismo” sono concetti suggeriti persino dalla sottile ed efficace illuminazione delle sale. La seconda stanza si intitola “Misurare, misurare” e mostra gli strumenti meccanici di cui il dottore si serviva per esaminare i suoi pazienti. Lombroso li usava con metodicità ossessiva, ma non li aveva inventati. Il “craniografo”, per esempio, è opera del francese Paul Broca. Ciò dimostra che la sua mania non era solitaria e che nel momento in cui lui intraprende le sue indagini vi era già un’attiva tradizione antica e moderna alla quale rifarsi. Una citazione del dottore accompagna gli apparecchi: “Per molti il progresso si riduce a certe macchine meravigliose come il telegrafo e il vapore. Per me, invece, il vero carattere che distingue la nostra epoca dalle epoche antiche sta nel trionfo della cifra sulle opinioni vaghe, sui pregiudizi, sulle vane teorie”.
3.
La terza sala del museo è ampia. Si intitola “Il mio museo” e occupa il centro indiscusso dell’esposizione. Vi si raccolgono tre tipi di materiali perfettamente esibiti. Da un lato ci sono “i corpi del reato”: una spaventosa collezione di pugnali, coltelli e strumenti perforanti; passepartout e grimaldelli; maschere e funi di diverse grossezze che furono usate per legare o per strangolare. Una grande stanga di legno biancastro, arma favolosa e primitiva insieme, presiede, eccezionale, la serie. Lombroso dice di voler combattere i pregiudizi e l’ignoranza. Di qui il valore dei “documenti”. Accompagnano queste prove materiali una trentina di maschere in cera che riproducono il volto di criminali morti in carcere. Donate a Lombroso da Lorenzo Tenchini, professore di anatomia all’Università di Parma, sono realistiche, volgari nel loro significato e raffinate nella fattura. Ciascuna accompagnata dalla sua etichetta – “Ladro italiano”, “Brigante”, “Stupratore”, “Assassino tedesco” –, riproducono nei particolari le fattezze di persone morte più di cent’anni fa e che pure non cessano di esistere in questa imperturbabile materia inerte. Che cosa direbbero queste copie se potessero parlare? Ma né le armi né le facce di lontani disadattati sociali possono rivaleggiare con le file di crani, un imponente monumento barocco fatto con le teste disseccate di, come minimo, trecento persone. Secondo una tradizione nella quale si inserì anche Leonardo da Vinci, che praticava autopsie alla luce delle candele e contro le leggi della Chiesa, Lombroso si spinse a depredare vecchi cimiteri abbandonati. Dall’azione delle armi alla mimesi statica della cera, per giungere, infine, alla sua biologica nudità, l’oggetto di studio del criminologo si moltiplica, soverchiante. Non sono cinque pugnali, sono trecento. Non sono dieci crani, sono seicento. Duplice brutalità, dunque, quella di questa sala centrale del Museo di Antropologia Criminale. In primo luogo, lungi dal denunciarla, essa accoglie l’evidenza di uomini e donne violenti capaci di uccidere servendosi di un lungo chiodo o di un coltello dalla lama finemente istoriata. In secondo luogo, la fredda scienza applicata a questi delinquenti li espone senza il beneficio di una santa sepoltura. Non c’è bisogno di pensare al mito, né ad Antigone. Qui è tutta un’altra cosa, ma che cosa? Qui la nostalgia per un mondo passato e saldo si mescola con la “sensibilità artistica” dell’esperto museografo addetto all’allestimento.
4.
Nella sala numero quattro si dà conto di un episodio centrale nella vita professionale di Lombroso. Intitolata “La rivelazione”, questa piccola stanza racconta la storia di una scoperta. Nell’agosto del 1864 il dottore esamina il cranio trapanato e vaporoso di Giuseppe Villella, un ladro condannato a sette anni di carcere e morto di scorbuto, solitario e maligno perfino nella sua reclusione. In quel momento, a cadavere ancora fresco, Lombroso non trova nulla. Ma sei anni dopo, “in una grigia e fredda mattina del dicembre 1870”, scopre nel suo cranio una fossetta occipitale mediana che aveva lo scopo di ospitare una parte del cervelletto. Così Villella – o per meglio dire il suo cranio – si trasforma nel paziente zero della nuova scienza che metterà fine al crimine. La microcefalia, che si riflette in quella cavità, era, secondo Lombroso, ciò che impediva ai delinquenti di sviluppare appieno le emozioni, togliendo loro la possibilità di lavorare e di vivere da onesti cittadini. Lì c’erano le prove. La scienza aveva parlato. E invece no. Un testo su un pannello si affretta a informarci che le misure e le forme del cervello sono variabili e che non esiste prova alcuna che possano determinare comportamenti delittuosi. Una frase fa da punto d’appoggio: “La scienza procede per errori”. Il senso di questa massima, la tranquillità che ci infonde, traballa un po’ quando scopriamo, subito dopo, tre modelli tridimensioni di piante carnivore. Nella sua ricerca di prove sull’atavismo, ovvero il ripresentarsi di caratteristiche evolutive superate, Lombroso giunse a collezionarle, quasi si trattasse di piante criminali, di esseri involuti, disfunzionali, sbagliati. I tre modelli aggiungono, da una teca, il giusto tocco fantascientifico al genere “giallo” cui il museo è consacrato. (…)
per continuare la visita si raccomanda vivamente la lettura su “il Reportage”
Il Nobel per la letteratura di quest’anno
un accorato appello di Gianni Biondillo
In attesa del responso dell’Accademia di Svezia voglio dirlo, ad alta voce, senza peli sulla lingua: ma quale Nobel per la letteratura a Bob Dylan! Insomma, basta con queste frescacce. Possibile che dobbiamo sistematicamente sottostare alla logica dello star system?
Mai come quest’anno s’è fatto avanti nel nostro afflitto paese un nome che ci rappresenta al meglio, che ci rende orgogliosi e convinti della oculata candidatura (vorrei tanto conoscere il misterioso proponente, l’insigne professore, l’istituzione lungimirante).
Il nome di un autore, di un compositore, che ha saputo frantumare i muri dei generi artistici. Uno scrittore riservato, discreto, artefice di versi scolpiti nella memoria di tutti, capace di fare della poesia qualcosa che interessa tutti, non solo il piccolo, miope, circolino dell’intelligecjia nostrana. Qualcuno che ha da insegnare al mondo, Dylan compreso.
L’autore di rime alte, nobili, etiche. Roberto Vecchioni. Il mio candidato per Stoccolma.
In alternativa propongo Franco Arminio.
http://www.youtube.com/watch?v=DkpaI_2VtYQ
;-)
Ricotta calda
di Margherita Carbonaro
Questa sera andiamo a mangiare la ricotta all’agriturismo. La ricotta calda che evoca memorie di masserie antiche in mezzo ai carrubi e di massari con le mani callose. Per chi è troppo giovane per ricordare le mani callose dei massari, che ormai non ci sono più, evoca pure memorie di agriturismo.
Per andare a mangiare la ricotta calda bisogna compiere innanzitutto esercitazioni complicatissime di geometria pratica. Far sgusciare cioè le macchine, l’una dopo l’altra, fuori dalla stradina di questo nostro villaggio di cemento d’annata stretto fra la provinciale e il mare.
Samir
di Riccardo Ferrazzi
Lo conobbi quando avevo i canini aguzzi e giravo per il Medio Oriente. Samir era un agente marittimo con gli uffici in due stanzette buie in fondo a un vicolo: non aveva bisogno di impressionare i clienti, preferiva disorientarli. Gli proposi di concorrere insieme a un appalto ad Alessandria d’Egitto.
Era un buon contratto, anche se sapevo che la burocrazia egiziana è intricata come il delta del Nilo e le pratiche finiscono sempre per incagliarsi in qualche meandro limaccioso. Non me ne preoccupai: in un modo o nell’altro ero sicuro di cavarmela.
Vincemmo la gara e aprii il cantiere. Ma i pagamenti non arrivarono. Ogni fine mese prendevo l’aereo e andavo a trovare Samir: tiravamo le somme del dare e dell’avere. Lui mi guardava da dietro le ciglia socchiuse, in silenzio. Io sorridevo e lo invitavo a cena.
Quando si era trattato di preparare l’offerta aveva tirato in lungo per due settimane: prima era sparito, poi aveva preteso referenze e affidavit, e infine aveva sfoderato un’infinità di obiezioni, una più capziosa dell’altra. Non sapevo più cosa pensare. Sospettavo che avesse concluso un accordo sottobanco con la concorrenza e stavo per mandarlo al diavolo. Poi, di punto in bianco, avevamo cominciato a lavorare in pieno accordo.
Capii che tutti quegli indugi gli erano serviti per studiarmi. Samir, un omone dalla pelle scura e dai lineamenti negroidi, voleva sentirsi ispirare una fiducia che andasse oltre la stima e che si arrestasse solo sulla soglia dell’amicizia: valutava l’uomo che aveva di fronte e prendeva i suoi rischi. Chissà se esiste ancora gente come lui.
Due anni prima c’era stata una guerra. Non era durata molto, ma aveva ridotto l’Egitto in pessime condizioni. E negli ultimi tempi Samir sembrava l’immagine dell’Egitto perché era ammalato e lo sapeva. Una mattina trovai un telex sulla scrivania, e fu così che lo seppi anch’io: a Samir restavano poche settimane.
***
Sbarcai al Cairo in una sera d’aprile rossa ed estenuata come gli ultimi bagliori di un incendio. A Beirut, in quei giorni, si sparava nelle strade e Zurigo era piena di libanesi. Ma erano i miei anni corsari: avevo nella pelle un mal d’Africa che non era nostalgia di un luogo in particolare, era una frenetica attrazione per gli aeroporti, per le camere d’albergo, per tutto ciò che sapeva di provvisorio.
All’aeroporto del Cairo non feci caso al sudiciume, al fetore di urina fermentata, alle attese senza spiegazioni. Ormai ci avevo fatto l’abitudine. Come sempre, ai cancelli di imbarco per Jeddah, Riyad e Dharan, bivaccavano squadroni di manovali in ghellabeia, con la testa coperta da luride sciarpe arrotolate. L’Arab Contractors li strappava alle campagne e li sparpagliava nei campi petroliferi del deserto arabico. Qualcuno faceva bollire l’acqua per il the sui fornelli a spirito, altri dormivano rannicchiati su una fila di sedie, altri ancora guardavano nel vuoto, fissi e imbambolati, con l’espressione di chi ha messo il futuro nelle mani di Allah. E tutt’attorno c’era la sinfonia del vociare arabo, che ha la monotona uniformità e gli scoppi cacofonici di un’orchestra che accorda gli strumenti aspettando l’entrata del Maestro.
Aid, l’autista, aveva poche novità. No, i pagamenti non erano arrivati. Sì, Samir stava per lasciarci: ormai non usciva più di casa.
Dai finestrini aperti entrava aria tiepida, densa come brodo. Sfilammo lungo un viale fiancheggiato da ville liberty sepolte nella polvere e nella sporcizia. In vista della Cittadella il tramonto proiettava le ombre dei minareti fino alle cupole della Città dei Morti. E quando la collina fu alle spalle ci ritrovammo in mezzo al caos e al lerciume cairota. I bar rigurgitavano sulla strada una umanità in ciabatte e ghellabeia seduta a fumare sudici narghilè; le macellerie protendevano sulla strada ganci da cui pendevano pezzi di carne sommersa dalle mosche; e centinaia di storpi si trascinavano in mezzo al traffico urlando suoni gutturali contro gli ululati dei clacson; e le vie erano ingombre di gente, di autobus stracolmi, di camion che cadevano a pezzi, di carretti, asini e dromedari; e sui marciapiedi ragazzini armati di canne sottili spingevano avanti in fila indiana bufali magrissimi, con le ossa in rilievo sotto la pelle floscia.
Poi la strada si avvitò in ampi tornanti su per un’erta bianca di calce. In cima, con un brusco passaggio, venne avanti il deserto, e con il deserto il silenzio. Aid guidava e taceva. Se fosse stato solo avrebbe preso la strada del delta, piena di villaggi dove ci si può fermare, bere un the, fumare in pace una sigaretta. Sapevo cosa gli passava per la testa. Gli arabi odiano il deserto, gli europei ne sono affascinati. Ma gli europei sono pazzi.
Il sole era caduto dietro l’orizzonte, eppure il crepuscolo non finiva mai. A poco a poco, la luna in cielo aveva preso a splendere fino a incendiarsi come il faro di Alessandria. Il deserto cambiava continuamente, con infinite sfumature di grigio che affondavano dentro a voragini buie e risalivano lungo creste metalliche come lame di falci.
Ore e ore di riflessi e fuochi fatui, sigarette, colpi di sonno. E in fondo all’ultimo risveglio Alessandria, il mare, l’aria umida e salata.
***
Avevo davanti a me due giorni di lavoro e non volevo pensare ad altro, ma non potevo lasciare l’Egitto senza render visita a Samir. A meno che nel frattempo le cose precipitassero.
Già, e i funerali? Tappeti rossi, caffè amaro, la fila delle sedie, i parenti seduti con gli occhi bassi a spiare chi si alza per primo.
No, non potevo svignarmela: dovevo affrontare la situazione. Con quella spina nel cervello giravo per uffici, sbrigavo pratiche, battevo cassa. E tra un appuntamento e l’altro, nelle ore di anticamera, pensavo: che colore avrà la mia faccia quando andrò da Samir e gli dirò: “Prima di partire ho disposto un bonifico da Zurigo, i tuoi soldi sono in viaggio, dovresti riceverli da un giorno all’altro”? Se mi vedessi in uno specchio morirei di vergogna. Lui leggerà la menzogna sul mio volto, io vedrò la mia faccia nei suoi occhi.
Meglio la verità. Gli chiederò di aver pazienza.
Ma quale pazienza? Lui non ha più tempo. Mi griderà sul muso: voglio i miei soldi, voglio vederli qui con me come se fossero i miei figli, perché sono i MIEI.
No. Non si fa così. Andrò in casa sua, dirò le mie bugie e lui sarà contento. Farà finta di credermi. Fingerà anche con se stesso, perché non ha altra scelta. E io sarò cinico, crudele e sorridente.
***
Ogni tanto mi capita di svegliarmi al buio e mi pare di essere ancora là, fra le lenzuola umide, in una notte di odori e di suoni sconosciuti, in una Alessandria semplice e complicata dove la gente ti pianta addosso sguardi che forse non vogliono dire niente ma sembra che celino un segreto tragicomico, la soluzione di tutti i paradossi.
Ricordo una notte agitata, un risveglio a bocca amara. Altri incontri d’affari, e poi il pranzo con lo staff. Farli mangiar bene. Pagare il conto. E via, lungo la strada del delta, nella pianura dove immense vele bianche appaiono e scompaiono tra gli alberi e le feluche scivolano nei canali seminascosti, tra chiuse e ponti, casupole fangose e bufali accovacciati nella mota. E di nuovo Il Cairo, la periferia sbrindellata e puzzolente, i milioni di abitanti, i vicoli senza nome. E il Nilo, gonfio, enorme, il padre dei fiumi.
***
La casa di Samir era un appartamento pulitissimo, con la cera ai pavimenti. Lui mi ricevette in camera, ma volle alzarsi dal letto. Con fatica, avvolto in una candida camicia da notte, venne a sedersi in poltrona. Sul tavolino era già apparecchiato il the, con un vassoio di dolci e pasticcini.
Guardavo Samir e gli occhi non mi sembravano più i suoi. Aveva le guance cascanti. La voce si imbrogliava alla fine delle frasi come se gli mancasse il fiato in gola. Finse la più assoluta normalità, come se ci fossimo seduti al caffè per scambiarci notizie e pettegolezzi. Discutemmo di politica internazionale e del prezzo del petrolio. Assurdamente, sperai che si fosse messo il cuore in pace.
Non era così. Finimmo il the, fu portato via il vassoio, e Samir, parlando come se non attendesse risposta, incominciò la sua perorazione: il mio debito era scaduto e il mancato incasso gli procurava un certo numero di inconvenienti. Li enumerò con il tono svogliato di chi adempie a un dovere. Non importava, concluse. Lui sapeva di avere a che fare con un galantuomo ed era sicuro che presto avrei pagato.
Tutto qui, un discorsetto pieno di decoro e signorilità. Appoggiò le mani sui braccioli e si affaccendò ad alzarsi per tornare a letto. Ma quando fu in piedi si voltò, come se avesse dimenticato qualcosa. Mi fissò, e per un attimo i suoi occhi tornarono a essere quelli che conoscevo.
“Non è per mancanza di fiducia” dichiarò. “Ma è una grossa cifra.”
Giuro: disse queste precise parole. Una bugia nitida come un mattino di primavera, detta con semplicità, così come ci si volta, si tende il braccio e si preme il grilletto.
Era la vita che non voleva smettere di scorrergli nelle vene, era il gusto di viverla, l’accumulo di troppe esperienze pagate care e il desiderio di farne altre, tante altre, perché non sono mai abbastanza, e invece il nostro è un tempo limitato, il cui confine non si sa mai dov’è, e all’improvviso è qui, è già arrivato, e non puoi farci niente.
***
Lasciai l’Egitto il giorno dopo, in un mattino di cielo limpido e aria frizzante. Dal finestrino dell’aereo vedevo una distesa gialla uniforme, terra bruciata fino in lontananza, dove cambiava tonalità e si sgranava in una nube confusa che a poco a poco diventava cielo. Laggiù, il Nilo era una striscia verde che tagliava il deserto e andava a conficcarsi dentro all’orizzonte. E si perdeva, semplice e complicata, nelle profondità dell’Africa.
(Riccardo Ferrazzi ha pubblicato recentemente “Cipango!“, Leone Editore, 2013)
Sei poesie
di Gilda Policastro
Da Non come vita, Nino Aragno/I domani, 2013.
Autunno
Nemmeno per l’inverno
restavi
E le lapidi invetriate
nel deposito
deluttuoso
della memoria
Come un film, risusciti in fermo immagine
gialla al fotoshop riproducibile
di Santi Alessia compagna
Vent’anni e bionda, e tu solo gialla
per i prodigi multipli
dell’erbitux
Non durerà, godetevi
la forza dei gravi duttili
Il peso dell’unheilbar
Krebs non ci sta
nella foto che parla
Di gialle foto in cerca su bianchi lenzuoli
obitori in feste di fiori come a macabri party
Dimettiamoci, se possiamo visitare
le intercessioni di vita nella cura della morte
Mi cerchi compagna
mi trovi nemica
nel gelo che dilava gli occhi
a mai più guardare
Chissà se ci arriva a Natale,
di malattia incurabile si muore
(forse il cuore, sì, è stato il cuore che non ha retto)
ma solo dopo,
dopo l’estate
-
Estate
Bambina ti levavo
dai seni gli occhi
Nella riproduzione delle macchie
a seguire
l’impietà di guardare
le masse colliquate intatte
dall’erbitux
Inerti
nel dolore inconvertibile
ti poso addosso le dita
per la misurazione delle masse
(coi tronchi meno grossi
si fanno i coperchi delle casse)
Filamenti d’ovatta mentre ti lavo
i capelli e ben bene sotto le braccia
(le masse denutrite non proliferano in meno
di sei /dodici mesi
nel quaranta per cento dei casi)
Godere in analettico conforto
anche di cose qui per noi indifferentissime
(sfilaccia, l’acqua, l’ovatta, prendimi per favore dell’altra acqua)
E poi mai più,
che lavorare
stanca le masse
e il contenimento è il vero successo,
in oncologia
Questa
non sei tu:
- Non il bene vecchio ma il cattivo nuovo,
una massima di B., diceva B.*:
-
Tre visioni
1. Hermann Nitsch
Dove si macella e si squarta, lì si cura
mette le bende, il bisturi
come incensi
sull’altare che immola
l’organo in cancrena
Prima che la festa si rovesci in lutto
bianco, al chirurgo o al macello,
togli da sotto la carcassa
il lenzuolo Nel camice
residuale rivive,
quando è macchia, la speranza
al congiunto che vede,
da sotto la benda verde, altro bianco,
di scampato a -
Nell’atrio che aspetta, si fissa
l’infermità tra la vita e la -
làvati, làvati bene quelle tue mani
mentre bevi, che fa bene
al cuore, che squarti
quando entri, con lame, e dove risali
lì sono gli altari
Se il pane si spezza,
il rosso lo versi a grumi:
sul sacrificio bianco,
vive, fluidifica oppure coagula
ma si saprà dopo,
dopo che sarà l’offerta
senza intenzione, senza dono
-
2. Louise Bourgeois
Chiami mamma e ti preda
l’artiglio che accoglie
nella cella che dici ‘casa’ ed è
culla crepata come ampolla
di sotto alla fiamma
La stanza di sopra tiene appesi
con i ganci gli arnesi,
al rimpasto che appare
nel banchetto di padre
Figlio lo espelli ruminato
come bava, come scolo
emesso dallo scarico
- uguale -
S’entra nello spazio
in cui svuota la forza
combatti e godi, che non sei tu
che ghermisci, non è lei: ma siamo,
siamo così,
ancora
siamo
così
-
3. Bill Viola
Avvicinati, più lento
e dimmi cosa vedi La madre, vedo lui,
non vedo nessuno,
l’acqua, il fuoco, vedo chi li riceve
e i morti e i vivi
capovolti
nel riflesso che appare
Andiamo, andiamo piano
passiamo attraverso
e guardiamo com’è
il corpo ch’è mosso,
per finta, a far fine
quando muore,
lo guardano altri
e da lontano tutti
più lenti di così,
molto di meno
ci vanno
accanto,
dondolandosi piano
Prendi quei due, sembrano vivi e sono
nell’acqua ch’è mossa non dai fiati
ma da come li vedi,
piano, andando
altrove
che è fine, e ricomincia, per tutti,
piano
-
I cari altri
Gli altri sono:
mangiare il panino a morsi,
gridare al telefono e
sputare
mentre lo fanno
I gesti che non durano,
la bambina dire ciao dalla porta,
e lui che ci hai dormito, una notte,
la mattina non ne sai il nome più
- ma non è come pensi
Gli altri sono:
il ventre che spinge
sotto le calze, e sopra i seni
le mani,
ma pensare che non resiste,
e ochéi, ci sentiamo domani
Un’unica forma, o misura, ha il fare,
il resto è represso
dal vestito di madre,
dal divieto,
e più chiedono, gli altri, più ingombrano,
meno ci stai
con gli altri sono:
i figli, morire, tu-figlia-loro-morti,
e le coperte, e il velo
e i pigiami e le giacche,
gli altri le porteranno, li butteremo,
e quel giorno non verrai
nel sogno a rimproverare
non come vita, ma più di dormire o meno,
adesso non ricordare, non dire il nome, che non sai
degli altri, che a te chiedono, loro,
di non andartene
e che hanno paura,
non vanno a letto, non si sdraiano come d’amore,
eppure non passa, non va-e-non-viene, e sono a metà
-
* Brecht; Benjamin. --
[Dalla quarta di copertina]
È questo il libro della prima stagione poetica di Gilda Policastro. E proprio Stagioni è la metonimia che intitola la sua prima sezione. Prima in ordine di composizione ma, ciò che più importa, in termini “narrativi”: col mettere in scena il primo di una sequenza di lutti, inconsutile manto funebre che, alla pelle mentale di chi dice «io», a lungo è calzato come una guaina perfetta. Si dice «stagioni» e si vuol dire dei tempi vissuti, o che piuttosto tali non sono stati: e tuttavia riposti in quello che, con immagine beckettiana e pun rosselliano, viene definito il «deposito / deluttuoso / della memoria». Nei versi più celebri di quello che resta l’ispiratore primo e indiscusso («Sono un tronco, diceva qualcuno»), si cantavano «le morte stagioni, e la presente / e viva, e il suon di lei». Ecco: mentre le morte stagioni si prendono tutto lo spazio – in quest’intirizzito catasto degli estinti – della viva, coi suoi suoni, davvero non c’è traccia. E forse una radice, di questa coazione luttuosa che intride ogni fibra del libro, andrà cercata – oltre che nell’enciclopedia dei palinsesti lirici omaggiati, da Leopardi a Montale – nell’origine remota (ma a tratti rinvenibile), di chi scrive, nelle terre in cui a suo tempo Ernesto de Martino trovò la sostanza antropologica di Morte e pianto rituale. Come in quel repertorio la materia fonda del dolore, sorda e opaca, rilutta alla realtà storica e dunque a qualsiasi elaborazione, a ogni minimo movimento (così nella sequenza più lancinante: «E chi si muove da terra», con quel che segue). Proprio come i morti, per definizione «statici» nel flash che li imprigiona in immaginette votive, chi scrive si rappresenta recluso in una cellula di fiele: rintanato, diceva quell’altro, in un «letargo di talpe, abiezione / che funghisce su sé…». Ed è allora un bene – se non altro per la vita di chi afferma, qui, d’esserne priva – che questa stagione, col suo annichilito splendore catatonico, possa dirsi conclusa.
Andrea Cortellessa
Gilda Policastro è nata a Salerno e cresciuta in Basilicata; vive a Roma. Italianista e critica letteraria, collabora con riviste, quotidiani e lit-blog. La sua prima raccolta, Stagioni e altre, è uscita nel Decimo quaderno di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2010). Nel 2010 ha pubblicato per i tipi della d’if il prosimetro La famiglia felice (vincitore del Premio Mazzacurati-Russo nel 2009) e nel 2011, per Transeuropa, Antiprodigi e passi falsi (vincitore del premio Antonio Delfini nel 2009), con un cd di interazioni poetiche e musicali. Nel 2010 Fandango ha pubblicato il suo primo romanzo, Il farmaco; cui fa ora seguito, per lo stesso editore, Sotto.
y

Con il simbolo Y si indica uno dei cromosomi sessuali;
l’altro, presente nel sesso eterozigote, si indica con X.
Nei maschi umani fertili la metà degli spermatozoi porta
un cromosoma Y e l’altra metà un cromosoma X, mentre
nelle femmine tutte le uova contengono un cromosoma X;
il cromosoma Y determina nella specie umana il sesso maschile.
Amyci
di
effeffe
Si parlano, si dicono cose
Un pugno, uno schiaffo
Un pugno o uno schiaffo?
Qualcosa di simile a un piatto che cade, un frastuono ma senza rumore diciamo nell’anima, che non si sente da fuori e che dentro fa male, fa male boia, e sanguina
Allora si vede se sanguina?
No, non si vede. Uno sbattere di finestre, anzi di porta
Si parlano, si dicono cose e le ripetono
No, non si vede. Uno sbattere di finestre, anzi di porta
Di porte o finestre?
Qualcosa che era aperto e che entravi, senza bussare, senza dire se c’era qualcuno, uno sbattere di ciglia, nessuno, e che ti ritrovi a passare e c’entri dentro come nel burro come nell’acqua
Burro o acqua?
Come l’acqua. Erano lacrime non so se di prima o di dopo
E si vedevano allora?
Si parlano, si dicono cose e le ripetono, non si capiscono più quando quasi in fondo alla strada si fermano
E si vedevano allora?
Non si scorgevano manco al microscopio manco alla lente manco. Piangevano dentro e rigavano quasi le cose che al solito sono all’interno. il cuore, il cuore, lo stomaco
Il cuore o lo stomaco?
Qualcosa che batte, dum dum, però è come un battito sordo, sordo dum dum che si sente, però, e non sai se è soltanto il raggrumo, il raggrinzo, la pelle, la pelle di dentro che suona come un tamburo, capisci no?
No non capisco
Un dolore un pizzico un morso di ciuccio, capisci?
Nemmeno
Una botta tremenda, la faccia che sembra nemmeno pensare, e si gonfia a pensare se quella cosa davvero ci stava, davvero era giusta, davvero era ben meritata
Si parlano, si dicono cose e le ripetono, non si capiscono più quando quasi in fondo alla strada si fermano, e quasi senza guardarsi il giovane prosegue prendendo una strada allora che l’altro più vecchio di poco, di poco che nemmeno si vede, continua sull’altra
Una botta tremenda, la faccia che sembra nemmeno pensare, e si gonfia a pensare se quella cosa davvero ci stava, davvero era giusta, davvero era ben meritata
La faccia, ma allora si vede da fuori?
No, non si vede, ma è dentro, ed è così dentro che non puoi neppure sapere se è una ferita profonda, se è un taglio, è già cicatrice
Un taglio o è cicatrice?
Un taglio? Una cicatrice?
Si parlano, si dicono cose e le ripetono, non si capiscono più quando quasi in fondo alla strada si fermano, e quasi senza guardarsi il giovane prosegue prendendo una strada allora che l’altro più vecchio di poco, di poco che nemmeno si vede, continua sull’altra. Erano amici da molto, da molto, da prima
I poeti appartati: Eliana Deborah Langiu
La Silloge del Disonore
Giovedì 3 ottobre, alle 21, Eliana Deborah Langiu ha presentato alla libreria Trebisonda, La Silloge del Disonore (Galassia Arte Edizioni), da Malvina, eroica libraia di San Salvario a Torino.
Di questa sua opera ha scritto Maria Grazia Calandrone sul numero 284 (Lugio Agosto) di Poesia
“Eliana D. Langiu analizza la sventura di essere creatura umana in territorio di guerra, ovvero in luoghi completamente disertati dalla grazia. E lo fa inserendo il gergo tecnico militare in una lingua dell’umanesimo.
La Silloge del Disonore – dedicata alla missione in Afghanistan come centro del vissuto bellico più prossimo – si divide in tre sezioni, anticipate da una introduzione, aspra abbastanza da farci aprire le orecchie, come avvertiti da un’iscrizione sul cancello: qui non si usano simboli o lirismo, qui si analizzano i resti, si avanza frantumati tra i frantumi di ciò che è stato umano. Le quattro parti del ragionamento di Langiu, ciascuna aperta da una citazione da L’arte della guerra di Sun Tzu, possono essere applicate a qualsiasi conflitto: la stessa autrice precisa di avete scelto l’Afghanistan a causa della quantità di notizie diffuse proprio a ridosso di noi, che le ha offerto l’occasione di mettere al lavoro la leva silenziosa della poesia. in un discorso divulgativo confezionato in anni recentissimi, nel cuore di un errore umano che è partito dalla definizione della nostra missione di pace.“
Ho chiesto a Eliana di dare la possibilità ai lettori di Nazione Indiana di leggere alcune delle poesie contenute nella silloge. Eccole. effeffe
Ouverture
Quando le forze delle stesso Stato si combattono a vicenda,
questo è territorio dispersivo. […]
Dunque, su territorio dispersivo, non combattere.
Sun Tzu, L’Arte della Guerra.
con il coltello
nel petto
apro
da far uscire esistenze
dal taglio longitudinale
perpendicolare al cesareo
si aprono vite a croce
a piste desertiche
deserto questo vivere
a pezzi
tessere dei tuoi ricordi ricucite
chiusi a chiave
bianche pagine non stampate
scritte con succo di limone
criptate
a profani
eretici del rigirare esistenze tra le righe
nell’opportunismo poetico
in questa forma scolpita in forma aperta
di porta socchiusa a spiare
una squarcio quadretto familiare acustico
fa valutare te
persona
quasi raggiungibile l’umanità
di cui ti liberi nei liquidi torbidi
di bottiglie agli sgoccioli
odio e fastidio declinano l’affetto
quel poco che basta al ribrezzo
della normalità cui ti riferisci
che quasi nella polvere
a linee orizzontali e un poco oblique
a sostenere oggetti neri longilinei
nel giallo sabbioso di una terra
rivedo la figura e il viso
che per errore ho cancellato
tanti anni trasmissioni video
per rivedere un volto ignoto e nitido
nella casuale registrazione del ricordo
PARTE I
Per sottomettere un nemico, devi valutare te stesso, valutare lui,
e ottenere il sostegno del popolo. Questo è tutto.
Sun Tzu, L’Arte della Guerra.
non ringraziarmi per le cattive parole
sono parole vere
è la verità l’evoluzione un divenire
dici non contare su di me per quelle buone
un male portatore di bugie e mezze verità
masticate nel chicco di caffè corretto
perduto nel sambuca
verde vetro del bancone
in tua presenza
tessi arazzi di cattivo gusto
con le dita
tenute appese dai capelli grigi
siete in tanti appesi ai fili
di un coiffeur a sorpresa
dalla forbice facile e distratta
che taglia rasoiate dalla strada
o da una torretta
non mendicare quindi la tua unicità
venduta a mazzi di generazioni e scelte
non sei unico nemmeno in questa strada
città fu bellica per antonomasia
dio tua patria e famiglia
nel rinnegarlo costante
nell’accusarlo negl’altri
tua allucinazione karmica
vomitata su parole secolari
che poco hanno a che fare
con esperienza ecclesiastica
lo sottolinei ad ogni pie’ sospinto
questo cristo questa chiesa
che ti stanno tanto a noia
dalla scatola stretta che ti muove
non avendo dubbi sull’essenza cristianica
dell’interlocutore
prendi le distanze capitano
distanze di pensiero
tra te e te dieci anni prima
persona persa fraintesa
in congelata adolescenza
dio patria famiglia
affondano radici in te come
radici di un ficus secolare
invadono la strada i marciapiedi le case
la necessità deflagrante
di uccidere il cristo e sue diramazioni
sublimano esplosioni di polvere e chimiche
esaltazioni di potere decisionale
occasionale incontro favorisce criptate
battaglie di urne contraddizioni
nel tuo mostrarti agile
nello schivare l’eredità pesante di un paese
immensamente chiesa
di cui rinnegandola sei parte
blocca la crescita una vita accademica
sono ore di scultura a inaridire
il punto di vista
l’equilibrio sul limite estremo
troppo presto
sul tempo di crescita
la bocca si accosta alla vita
stordita dal non oltre
l’oltre girandola a vortice
tentativi di banali trasgredire
ascolti ascolti oltre mai presente
nei giri veloci d’inchiostro nero
della penna ricercata
nei giorni di terra lasciata
a casa
PARTE II
Col termine terreno, intendo la distanza, e se il territorio da percorrere è agevolo
o arduo, se è ampio o ristretto, e le eventualità di sopravvivenza o di morte che offre.
Sun Tzu, L’Arte della Guerra.
neve o polvere senza continuità
questa terra ignara a chiazze
degli eserciti
degli amici dei nemici
di questo simbolo vivente di democrazia
acquisita ad occidente
per tutti quelli che stanno ad ovest dell’Afghanistan
karzai presidente a macchia di leopardo
karzai sindaco di Kabul
la concentrazione bassa di attentati
nei territori più calmi
della NATO
non cambia la disposizione mentale
in vista della personale esplosione
divise e mezzi blindati
sono sempre equivalenti della guerra
per una popolazione occupata
sebbene non siano mancati casi
di evidente discriminazione
delle basi
le trame che ci legano l’un l’altro
ci sfogliano per strada pezzi a pezzi
non più uomini o donne ricordi
il vivo continua la sua vita per istinto
la sopravvivenza a volte è solo
questione di scelta
al di qua di una professione
quasi morti bianche sempre omicidi
alla fin fine
commessi da mani trasparenti
nate senza impronte né segni
mani di bambole assenti di linee
tirano i fili e succede che le trame
non reggano si spezzino prima
del tempo
una morte bianca è sempre casuale
ti pesca come una roulette russa e cadi
nella polvere perdendoti in quello
che ti è accanto
come chiedere scusa e le scuse
non sono mai abbastanza davanti
al disonore dei fatti
il quotidiano preferito
restituisce la giusta indignazione
su misura per le nostre inclinazioni politiche
in tutto questo non capiamo è tutta
un’astrazione questa metrica d’articoli
questo gergo editoriale
segna vendite e titoli più che le notizie
e non sapere cosa fare è forse l’unico
senso
ci restituiscono i giornali notizie calibrate
senza sottotesto
e lo cerchiamo per morbosità della natura
forse è vero che non c’è complotto
è tutto semplice tutto naturale
una giungla di cemento armata
di segnali e mezzi
che se non li capisci sei il prossimo a cadere
poi succede nella previsione
del disgelo
il nemico sorprende d’esuberanza
il nemico senza forma
il nemico senza faccia
a scadenza annuale prevedibili
i mezzi i tempi
solo i gusti più teatrali
tirano a contrattazioni fuori sede
tirano a delegittimare
chiusi nelle basi
chiusi nelle basi finché passa
questa primavera
finché smette di saltare a zolle
questa terra
ed è ritorno
PARTE III
Quando sei inferiore in tutto, se puoi ritirati.
Sun Tzu, L’Arte della Guerra.
un tuffo
dall’argilla alla vita
nella vita d’asfalto
vortici colorati della movida
tutto distante e stinto e confuso
nella gradazione della ripresa
di coscienza civile
ritorni mai del tutto
pezzi lasciati a parte sulla pista
segnaletica enzimatica
nella mappa grigia
si allontana il malessere
della tua pelle
è un incendio lontano fa capolino
se provo a pensarci tra il giorno e la notte
è con mia nonna l’incendio della tua pelle
è con i morti
resta una traccia nella memoria
un rievocare soffocato di sensazioni
è rapido cambiare tra l’uno e l’altro viaggio
nel tempo che porta cambiamento
nella sua definizione
lascio laggiù
i quattro graffi nella memoria
corto circuito destinato a bruciare nella scatola nera
costruisco in difetto il contenitore
non esisti negli altri universi sei morto
è in questo che ti ostini a vivere
per tentare di uccidermi
snocciolo parole per esorcizzarti
per ricacciarti nella tomba
da cui vieni
assetato di sangue vitale povero
come questo mio sangue annacquato
da decenni mestruali
periodicamente la tua mano
mi lacera l’utero
periodicamente la tua mano
strappa ovuli maturi
ti ricaccio dentro all’aut aut mentale
affondo un pugnale passando
a misura
all’ingresso dell’utero
avverto l’apparato riproduttivo
del pericolo
alle spalle di Pinocchio
di Antonio Sparzani
La Volpetta e il Gattofano si conoscevano da tanti anni, erano diventati amici da quel giorno in cui in birreria avevano dato luogo a una storica sceneggiata che li aveva trovati alleati per la pelle e che aveva suggellato un’amicizia duratura.
Poi avevano scelto strade diverse, anche per non farsi la guerra l’un l’altro e non pestarsi i piedi e farsi ombra – l’unica rivalità tra loro era quella delle cravatte: la Volpetta aveva, e sempre mantenne, un gusto più sicuro e raffinato in materia che non il Gattofano – così che avevano concepito quella straordinaria strategia di militare in fazioni diverse, e spesso opposte, mantenendo però una infrangibile solidarietà di fondo. Per ricordarsela sempre si dicevano spesso “veDremo! veDremo!”
Cari signori con i piedi neri
di Giacomo Sartori
Cari signori
con i vostri piedi neri e magri
che spuntano dalle cerate
(donate da noi
teniamo a precisare)
ci accusate di questo e di quello
ma è facile biasimare
bisogna che capiate
che la colpa non è nostra
sono i nostri colleghi
Lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio…
di Franco Arminio
illustri rappresentanti del popolo italiano
vi chiedo di considerare la possibilità di indire una giornata di lutto nazionale
per i morti di Lampedusa.
Sarebbe un gesto che renderebbe agli alleati europei la misura della nostra difficoltà
ad
Frammenti dalla fuga di un fuggiasco (2)
Di Giorgio Mascitelli
Sono immerso nell’acqua melmosa fino al collo; primo o poi dovrò uscirne. Intanto essi non sono passati. Ma non posso ancora uscire perché essi potrebbero passare.
Adesso che sono nella melma fino al collo, perché qui l’acqua è melmosa, è il momento giusto per chiedersi se l’avrei fatto lo stesso, se avessi previsto che poi mi sarebbe capitato tutto quanto mi è capitato!
Ma ogni Austerlitz ha la sua Waterloo, che è vero, ma non c’entra nulla con i miei casi passati né presenti. Ho fatto solo il mio dovere. Certo quando si è fatto il proprio dovere e si è rimasti soli, ci si sente un po’ dei pirla. Ma si tratta di una visione estremamente soggettiva. Non mi sembra che essi mi considerino un pirla, non mi considerano nulla probabilmente.
E giù un altro starnuto. Intanto il giorno trascorre, essi non passano e io resto nell’acqua fino al collo con un raffreddore incipiente. Dovrei sollevarmi dall’acqua e nascondermi in altro modo perché mi sembra più saggio a questo punto camminare di notte. Comincio a non essere più molto soddisfatto del mio piano. Per la verità non sono soddisfatto di molte altre cose. Forse ho perfino la febbre. Forse è meglio che mi tiri fuori dall’acqua. Devo cercare di asciugarmi alla bell’è meglio, che poi è quello che ho sempre fatto. Tutto quello che mi è capitato ho cercato sempre di affrontarlo alla bell’è meglio. No, non è vero: ho anche cercato di fare dei piani, ma spesso i miei piani sono finiti come questo di nascondermi nello stagno. Nuova salva di starnuti. Dovrei veramente tirarmi fuori dall’acqua. Magari dovrei fare come quel tale che era uscito dalla palude tirandosi su da solo per il codino dei capelli. Ma ciò mi sembra difficilmente realizzabile in primo luogo perché non porto il codino, in secondo luogo perché questo significherebbe forzare la mano alla pur vivida fantasia della mano che mi fa parlare.
La insoddisfazione nasce da me o dagli eventi? Questa è una domanda doverosa per rispondere con piena razionalità alla quale occorrerebbero tali e tanti elementi che non basterebbe una sola vita per accumularli. Quindi è una domanda a cui si risponde sulla base di qualche indizio spesso confuso. Non è serio invece rispondere che nasce da entrambi i fattori perché questo lo sanno anche i bambini. I miei indizi andavano verso gli eventi.
Ma insomma l’inverno della nostra insoddisfazione cederà mai il passo a una primavera se non di armonia e conciliazione almeno di speranza?
No, non ci sono più le stagioni, porca miseria!
Se c’è una cosa che mi fa tanto male è l’acqua dello stagno. Ho fatto bene a uscirne semplicemente con le mie gambe perché così posso sfruttare le ultime ore del giorno per asciugarmi e riposarmi. Ho strizzato meticolosamente le mie mutande, che per fortuna non hanno perso il colore. Dovrei assumere del paracetamolo, che, anche se ingerito a stomaco vuoto, a differenza dell’acido acetilsalicilico non dà disturbi gastrici ed è pertanto il più indicato per il fuggiasco. In ogni caso non ho con me né l’uno né l’altro, perciò tremo, batto i denti e mi sento stanchissimo. Mi incamminerò dopo il tramonto e dopo aver mangiato un po’ di briciole di wafer che ho trovato sul fondo della bisaccia.
Dunque, riassumendo la mia situazione, sono fuggito sfruttando una circostanza favorevole senza aver messo a punto un piano, quando ho ideato il piano, esso si è rivelato molto più dannoso della stessa pervicacia degli inseguitori così che ora sono digiuno, febbricitante e stravolto. Ciononostante continuo a essere insoddisfatto con gli eventi e non con me. Il partito più saggio, a questo punto, sarebbe quello di arrendersi, di consegnarmi, di rimettermi alla clemenza della corte, di abbassare la testa. Perché non lo faccio? Perché non sono ancora abbastanza stanco per rinunciare a essere me stesso. Veramente l’ostinazione fa fede.
Fedele alle mie deliberazioni, pertanto, dopo il tramonto mi metto in cammino con l’unico vantaggio, non strategico, di non essere appesantito nella mia marcia da cibi poco digeribili.
Sento un rumore che viene dal cielo, proprio sopra le mia testa, tipo flap flap. No, è più forte, è piuttosto un vron vron. Ma è più ripetitivo come se fosse una sorta di cutucutucu. Sì, è proprio un cutucutucututu. Alzo gli occhi e non ti vedo un elicottero che ha pure acceso il riflettore. Stanno forse usando l’elicottero per cercarmi?
– Arrenditi!- Dice una voce all’altoparlante- Abbiamo i visori a infrarossi, ti sgamiamo in un secondo!
Starei per arrendermi, prima ancora di accorgermi che stanno parlando alla cieca perché mi hanno superato abbondantemente, quando si fiondano in picchiata un bel pezzo davanti a me gridando all’altoparlante:
– Ti abbiamo beccato! I visori a infrarossi non ingannano mai!- Dall’elicottero che riprende quota come uno sparviero scornacchiato gridano qualcosa come:
– Adoriamo l’odore del napalm alla mattina presto.
Ma è ancora notte e l’elicottero si allontana, prosegue il suo giro, ma da bordo urlano un “torneremo!”.
Adesso, nonostante i tremiti, mi sforzo di trattenere il respiro, anche se è perfettamente superfluo, visto che non mi hanno localizzato neanche prima. Starei per prendere tutta una serie di provvedimenti di dubbia utilità, visto che per sfuggire a un elicottero basta camminare sotto gli alberi di notte, ma mi distrae per fortuna la curiosità impossibile da soddisfare di sapere cosa hanno scambiato per me.
Beh, se usano perfino l’elicottero per inseguirmi vuol dire che come fuggiasco qualcosa valgo, porca miseria!
C’è una casa nel bosco: la vedo, la intravvedo, ora che il sole sorge di nuovo. Io sono sporco, stanco, affamato, ho la barba incolta. La foga con cui mi sono dato alla fuga si sta esaurendo inesorabilmente.
Mi chiedo se, conciato così, mi daranno ricetto. Certo se decidono di accogliere un fuggiasco non possono pretendere che si presenti da loro lustrato e inamidato. D’altra parte vedendomi arrivare così, non mi lasceranno certo parlare e spiegare che sono un fuggiasco, ma mi cacceranno. Non so neppure se mi convenga rivelare che sono un fuggiasco, magari sono delle spie o addirittura essi si sono nascosti nella casa per tendermi un’imboscata. Forse mi conviene girare al largo. Ma girare dove e per dove conciato così? In realtà l’unico elemento di ottimismo in questa situazione deriva dalla mia memoria cinematografica.
Magari è una casa disabitata, ma è troppo ben tenuta per esserlo. Magari sono via per il week end, ma a parte che oggi dovrebbe essere un giorno feriale, in effetti anche il week end potrebbero trascorrerlo qui all’aria sana degli Appennini.
La natura, tuttavia, interviene a togliermi da questo penso stato di incertezza perché dopo una mia poderosa salva di starnuti si accende la luce e si apre una finestra della casa. Una donna di mezz’età mi squadra con un’aria non priva di severità e mi domanda:
– Sei della comune?
– Sì.
– Peccato che qui in zona non ci sia nessuna comune, pirla.
– E va bene: sono un fuggiasco.
– Ma guarda un po’. Credevo che fossi un rappresentante di aspirapolveri.
Poi mi passa dalla finestra una canna e del sapone e mi dice di lavarmi prima di entrare in casa; quando avrò finito, uscirà suo marito che mi porgerà dei vestiti puliti e asciutti. Mi lamento che è fredda e lei replica che un fuggiasco dovrebbe già baciarsi i gomiti, se gli riesce di lavarsi. Quando ho finito, arriva il marito, un omone barbuto ma buono, che mi porge un asciugamani e dei vestiti. Mi offro di comprarglieli, invero non sapendo con quali soldi, visto che ho solo pochi spiccioli nelle tasche, ma l’uomo declina l’offerta. Dice che sono abiti ormai vecchi ed essendo loro anticlericali preferiscono darli a me piuttosto che alla Caritas.
Finalmente posso entrare in casa. Sul tavolo in cucina c’è una scodella di caffellatte fumante e due piatti pieni di biscotti, oswego nell’uno e krumiri nell’altro. La padrona di casa mi dice di mangiare quelli che voglio. Io le chiedo se posso mangiare tutti e due. Acconsente un po’ infastidita. Dopo che ho terminato la mia colazione, il marito mi dice che dietro la casa, nel capanno degli attrezzi, c’è una branda: oggi posso riposarmi lì, ma al tramonto me ne devo andare. In compenso mi faranno trovare la mia bisaccia piena di provviste e anche a mezzogiorno sua moglie mi porterà un piatto di pasta e un bicchier di vino. Io chiedo se non hanno paura ad aiutarmi.
A questo punto è la donna che risponde:
– No, non abbiamo paura e non siamo neanche delle spie. Semplicemente non importa nulla quello che facciamo noi. Gli costerebbe troppo controllare se ti aiutiamo o meno e alla fine non cambia niente: da qui, dopo qualche ora di cammino, arriverai sulla cresta di un monte dove c’è un paesello ormai abbandonato. Da lì puoi solo scendere lungo la provinciale oppure seguire il sentiero che sbocca in un posto chiamato le Bocche di fra’ Serafino. Lì ti aspettano e ti riprendono. L’importante è che tu vada in una certa direzione e per questo basta controllare due o tre snodi. Per il resto anche se gli sfuggi per un po’, poi ti ripigliano e gli costa di meno così. Anche sull’elicottero risparmiano: un tempo veniva usato una notte intera, adesso fa un giretto di un’ora e se ne torna a casina.
– Ma allora perché mi aiutate?
– Perché tu serbi un buon ricordo di noi-. Poi mi fa cenno di andare a riposare nel capanno degli attrezzi.
E io che mi sono anche preso il raffreddore per questa fuga, porca miseria!
Paese mio che stai sulla collina, ora ti vedo anche se c’è buio. Sei un po’ bruttarello, come una specie di Rio Bo, ma più del cazzo però; mi pare che si chiama Sarchiapone o qualcosa del genere. O forse dovrei dire “ si chiamava”, visto che non ci abita più nessuno. Però le case ci sono ancora e dunque il paese c’è ancora, ma gli abitanti non ci sono più, pertanto il paese non c’è più. Non è che sia poi una questione così importante.
Entro in una casa, che deve essere quella dell’ultima vecchina che hanno portato un paio d’anni fa in una casa di riposo perché c’è ancora appeso al muro un calendario di frate Indovino dell’anno 2010. Apro la bisaccia: due scatolette di tonno, una forchettina di plastica, due pagnotte fatte da loro, una mela, i pochi oswego che non ho mangiato al mattino. Non è che si sono sprecati, forse avevano paura che metta su pancia. O forse è quanto basta per arrivare alle Bocche di fra’ Serafino.
Insomma questo è il tempo che mi è dato ed è inutile che cammini carico come un mulo. Magari essi stanno scommettendo se scendo dalla provinciale o dalle Bocche di fra’ Serafino. Io però sono stanco e mi fermo qui. Temporeggio assolutamente, per così dire. Quando non si ha più tempo, l’unica cosa seria da farsi è sprecarlo. Ho deciso di far perdere del tempo a me e a loro.
Che essi vengano a prendermi! Perché fare ancora fatica? Io li aspetto qua e così se hanno scommesso, nessuno vince la scommessa.
All’alba mi rifocillo e il pallido sole rende il paese ancora più tetro, il ricordo della mia allegria è l’unica nota stonata in questo paese fantasma in cui un fuggiasco aspetta che lo vengano a prendere. Certe volte il giorno si annuncia più buio della notte perché quella alla fin fine fa soltanto il suo lavoro, come tutti o quasi.
Ci vorrebbe una mossa improvvisa, una giocata alla Roberto Baggio che cambi la situazione, ma Baggio ha smesso di giocare da molto tempo.
Un raggio di sole illumina una biro che si trova su un tavolo. Scrive ancora. Non è che abbia molto senso annotare i propri pensieri sul retro del calendario di frate Indovino per poi riappenderlo alla parete. Ma non dipende da me sapere se sia un’azione del tutto priva di senso o meno.
Sento che essi vengono. Ormai sento i rumori dei motori dei suv, sento i latrati delle cagne, sento le imprecazioni perché hanno dovuto consumare la benzina per salire fin qui e perché nessuno ha vinto la scommessa.
Essi sono arrivati, porca miseria!
( fine)
Frammenti dalla fuga di un fuggiasco (1)
Di Giorgio Mascitelli
Sento i latrati dei cani nelle mie orecchie, sulle mie spalle, lungo la spina dorsale. Ma dev’essere uno scherzo della tensione o il frutto di un’immaginazione troppo viva: chi, realmente, nel 2013 con tutti i mezzi tecnologici a disposizione e senza la necessità di localizzarlo con il fiuto inseguirebbe un fuggiasco con i cani? Credo che oggi un buon satellitare o un buon suv o meglio ancora un’accorta combinazione del loro uso possa svolgere il lavoro di cento molossoidi. Sì, non è possibile che ci siano i cani: vuol dire che sento le voci, porca miseria!
Questo è il risultato dei troppi film che ho visto: sono un fuggiasco dovrei occuparmi di suv , di satellitari, di vie di fuga, di procurarmi vestiti nuovi e invece sono qui a preoccuparmi dei cani. Veramente il mondo era più tranquillo quando Hollywood non c’era. Se anche le orecchie mi tradiscono, la mia mente sa bene che non è possibile oggi, in un 2013, che mi inseguano ancora con i cani come se fossi fuggito dalla piantagioni di cotone o dai Piombi. C’è la tecnologia, ci sono i metodi raffinati. E’ che alle volte io penso troppo; anche in un momento d’azione come questo mi fermo a pensare e la fantasia sbrigliata si mette a correre: c’è un eccesso di produzione nella mia fantasia e occorrerebbe davvero un piano d’austerità. Per fortuna c’è una mente razionale che non si lascia ingannare dagli improvvidi conati della fantasia.
Ora, però, è meglio che corra.
Non c’è il fiato. E’ vero che la disperazione fa muovere le gambe, ma non c’è il fiato. Il fiato è un parametro oggettivo. La lena con cui fai le cose può dipendere da fattori soggettivi: dovrebbe esserci sempre, invece talvolta c’è e talvolta non c’è, ma quando manca il fiato, allora non si può discutere, non c’è spazio per la psicologia. Quando ero un ragazzo, si dava grande importanza ai bioritmi; poi questi sono scomparsi. Oggi si ritiene che la verità sia nei numeri, che è una gran bella verità, peccato che non ci sia un’adeguata formula numerica per espimerla.
Allora, se non ce la faccio a correre, non resisto a voltarmi indietro per un attimo, a osservare i miei inseguitori e nella penombra le vedo. Sulla cima della collina di fronte attorniate da suv e satellitari e numerose bocche da fuoco ci sono tre cagne magre, studiose e conte.
Non posso avere anche le allucinazioni, oltre a sentire le voci, non posso tradirmi anche gli occhi, oltre alle orecchie. Statisticamente è più probabile che mi inganni un solo organo ( la mente razionale) anziché due, gli occhi e gli orecchi.
Essi hanno davvero i cani, porca miseria!
Benchè non abbiano l’imponente maestà delle vette alpine, gli Appennini sono provvisti di un loro ruvido fascino che li rivela montagna faticosa, tignosa, poco generosa, perciò degna di imprese insolite quale la mia fuga. C’è in tutto questo una nota rassicurante e sono i lontani echi dei rumori motoristici provenienti dai viadotti autostradali che con intermittenza crescente in ragione della notte che avanza giungono alle mie orecchie. Abbiamo già visto prima che non devo diffidare delle mie orecchie. La stagione è indeterminata: ha piovuto da poco e il terreno è bagnato, ma non fa propriamente freddo. Potrebbe essere una fine d’inverno tiepido o una primavera così così o un inizio d’estate molto fresco o un autunno che, pur conservando ancora il ricordo dell’estate, già si predispone all’arrivo della stagione morta. D’altronde non ci sono più le stagioni.
Non ci sono più neanche i rumori dei cani o dei suv. Ma dal pendio in cui mi trovo non riesco a vedere nulla e poi è scesa completamente la notte. Non mi sembra neanche una notte di luna piena, cosa che fa il mio gioco non perché abbia timore dei lupi mannari, ma perché così è difficile scorgermi. Non mi devo rilassare, però, non devo pensare neanche per scherzo che abbiano rinunciato a seguirmi. Essi non rinunciano mai. Può essere che essi ritengano che anch’io dorma da qualche parte e che possano raggiungermi con tutto agio al mattino presto oppure essi sanno meglio di me dove mi trovo e ogni via di fuga è bloccata. Potrebbe essere una situazione come quella in un libro di fantascienza che lessi tanto tempo fa, in cui il protagonista veniva inviato in un piccola colonia umana in un pianeta disabitato lontano dal sistema solare, ma poi quando erano stati uccisi quasi tutti gli abitanti della colonia, perlopiù dei rottemi umani, scopre di essere sulla Terra. Certo io so di essere sulla Terra e non mi trovo in una colonia umana, ma a parte questo la situazione è uguale. Nella piccola bisaccia che ho con me ci sono solo dei wafer alla nocciola, che si sono sbriciolati, e un formaggino Mio, che tiene abbastanza dignitosamente; inoltre sono due giorni che non mi cambio le mutande e mi sono pulito con una foglia quando ho espletato le mie funzioni fisiologiche. Questo tanto per chiarire che i problemi del fuggiasco non sono soltanto relativi agli inseguitori, al dove andare, al che fare, ma anche una grave assenza di tutti i comfort che in una vita moderna sono degli standard ormai.
Quando giungo a mezza costa d’un colle, vedo i bagliori di un fuoco in lontananza alle mie spalle e capisco che sono loro che si sono accampati. Se essi hanno i cani con loro, possono anche accendersi un falò, porca miseria!
C’è già buio, un buio pesto, ma sono arrivato in cima a un altro colle e la discesa è breve perché mi imbatto in uno stagno. Allora mi viene in mente un piano astutissimo, che ho già visto una volta in un film: adesso mi metto a dormire qui vicino, poi prima dell’alba mi immergo nello stagno fino alla testa, nascondendomi con le ninfee o addirittura immergendomi e respirando con una canna che spunterà dall’acqua come un giunco, quando essi passeranno e andranno oltre. L’unica cosa che devo studiare con attenzione è un nascondiglio sicuro per la bisaccia nella quale metterò anche i vestiti, salvo le mutande che così si lavano e nel deprecabile caso che mi dovessero beccare, avrei comunque un minimo di dignità.
Nel caso di cattura e, più in generale, di sconfitta non sono mica sicuro che bastino le mutande per salvare la dignità; anzi ho l’impressione che, anche se fossi vestito di tutto punto perfino con i gemelli da cresima ai polsini della camicia, non ci sarebbe alcuna dignità. Per coloro che perdono o scappano non c’è nessuna dignità ed è tornata la scelta tra essere nulla ed essere male. A tal punto il mondo è stanco di me da cacciarmi così con ignominia?
Se solo avessi un’altra via d’uscita. Invece ora che è mattina sono immerso fino al collo nell’acqua dello stagno e certo non è il luogo adatto per cercare altre vie d’uscita. Mi ricordo che, quando ero bambino, c’era una pubblicità in televisione di un signore con l’acqua fino al collo in un bagno in camicia e cravatta, che reclamizzava una nota ( allora) marca di detersivi. Anch’io sono come lui, ma sono senza camicia e cravatta e non reclamizzo nulla: come cambiano i tempi!
La rana in Spagna gracida in campagna. Però poi starnutisco e faccio scappare i girini. Il raffreddore, avevo sottovalutato il raffreddore, ma per fortuna non passa nessuno. Non si sentono i latrati dei cani, degli uomini e dei suv. Non si sente nulla di nulla.
Le grandi fughe nella storia sono riuscite certo anche per l’intraprendenza individuale, ma soprattutto per un adeguato sistema di appoggi esterni. Insomma le grandi fughe sono un po’ come le grandi imprese sportive in solitaria: sì in solitaria, ma solo da quel lato della telecamera. Devo ammettere che ho sottovalutato questo aspetto al momento della mia fuga. Devo anche aggiungere che questa cosa mi è venuta in mente solo stando nell’acqua per un certo lasso di tempo. Evidentemente l’acqua, a dispetto di un’imponente tradizione che la indica come foriera di oblio, rafforza invece la memoria o la ristabilisce. Ma forse perché questa è acqua stagnante e l’altra che scorre. Comunque nel mio piano di fuga non avevo tenuto abbastanza in considerazione o sarebbe meglio dire per nulla tale dato della storia. L’idea di corrompere il guardiano a cui scadeva tre giorni dopo il contratto a progetto con trenta euri non è stata male. Gli ho chiesto di lasciarmi pisciare contro un albero nel corso di un trasferimento e poi si è ferito da solo con un sasso di modo da simulare una mia aggressione, non senza avermi dato prima la mia bisaccia, nella quale avevo messo qualche genere di conforto. Tanto lui sapeva che non gli avrebbero fatto storie perché sarebbe stato maggiore lo scandalo che la traduzione di un prigioniero sia sorvegliata effettivamente da una sola persona, per di più non di ruolo, anziché dalle due previste dalla normativa. Sì l’inizio della mia fuga può essere definito brillante, ma poi francamente di brillante non c’è stato più nulla.
E nessuna sa nemmeno che sono fuggito, porca miseria!
( continua)