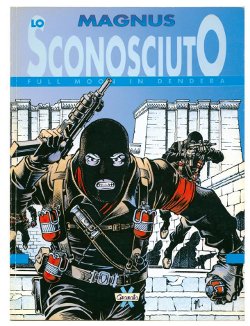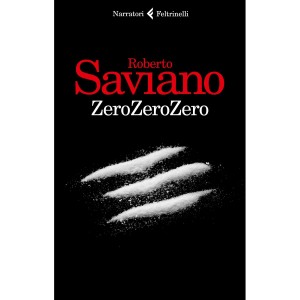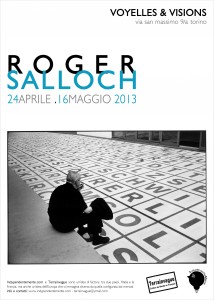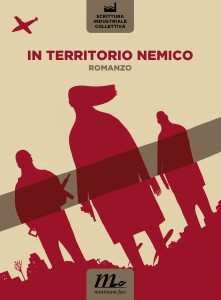(Un altro piccolo estratto da una cosa lunga che vado scrivendo da tempo)
di Giuseppe Zucco

Un grandangolo deforma leggermente ai lati l’espressione attonita di Mario e Cristina. Il fucile puntato di un microfono allinea il loro silenzio. Una giornalista molto pettinata e truccata più del dovuto, intimando all’operatore di riprenderla esclusivamente dal lato sinistro, con un sorriso di circostanza e un’aura che circonda tutta la sua figura – una materia instabile che potrebbe da un momento all’altro sciogliersi in una cascata di microscopici brillantissimi pixel – chiede ai due ragazzi cosa ne sanno loro della parola amore e in che modo i giovani oggi parlano d’amore racchiusi dentro la piccola fortezza di una coppia.
“Nomignoli?”, dice la giornalista.
“Vi date dei nomignoli?”, dice.
La giornalista ha i jeans aderenti strappati sul ginocchio. Il naso, di una simmetria soprannaturale, arte concettuale più che cartilagine, è il centro dell’attenzione.
“E il sesso orale?”.
“Quante volte a settimana?”.
L’operatore avvisa che c’è stato un problema audio, uno scroscio, sulla domanda. La giornalista lo guarda come si guardano le formiche, in fila indiana, sulle mattonelle di casa, prima di soccombere all’istinto di schiacciarle.
“E nel caso aspettaste un bambino, lo vorreste?”.
“Lo terreste con voi?”.
Mario e Cristina la guardano. La telecamera, non le domande, li mineralizza. Fossili, mica esseri umani. Echinodermi rivestiti di calcare come quelli che si studiano a scuola. Una scena muta tecnicamente perfetta. Almeno fino a quando Mario, non sopportando più lo sguardo tassonomico della giornalista – come se loro due fossero gli esemplari di una nuova inquietante specie di difficile catalogazione se non per le abitudini sessuali e la connessione wireless – butta lì con supremo distacco che hanno già un bambino, che presto ne sforneranno un secondo, che niente e nessuno impedirà loro di registrarlo all’anagrafe con il nome di Marty McFly, il protagonista del migliore film di tutti i tempi.
Poi Mario dice Ehi, guarda, indicando un punto indefinito sopra le loro teste. La giornalista si volta, l’operatore vira meccanicamente l’occhio della telecamera, Mario prende Cristina per mano e inizia a correre, infilando in volata la strada, un vicolo anonimo saturo di vetrine minimaliste, bianche perlopiù, con un solo capo in vista, sebbene non avesse la minima idea di dove andare a parare.
La giornalista e l’operatore, sciolto l’inganno, tengono il passo, veleggiando nella loro scia, la velocità di crociera smorzata dai tacchi (lei) e dal peso della telecamera (lui), urlando ai ragazzi di fermarsi, una domanda, un’altra ancora – ma se la giornalista è una cacciatrice di animali esotici, e quella corsa il completamento imprevisto di un safari, Mario e Cristina sono due felini ormai lontani, le cui macchie del manto continuano a galleggiare nell’aria solo per un effetto ottico.
Sbucano su una strada, ne infilano un’altra. Con il respiro rotto, voltandosi indietro, non trovano alcun retino televisivo a caccia del loro isterico e inutile battere di ali – si fermano. Piegati in due, Mario tiene l’equilibrio appoggiandosi a Cristina, e viceversa. Potrebbero essere appena scampati a una retata di polizia, o essere arrivati senza fiato al punto in cui si concludono gli scippi, o ancora essere inseguiti da uomini bene in carne e con la fedina penale adeguatamente annerita che starebbero per materializzarsi da dietro l’angolo, o con più disperazione i due potrebbero avventarsi e accanirsi sul primo passante disponibile per ripianare simbolicamente un torto appena subito – la gente non gli passa accanto, fa tutto un giro complicato e ridondante, attraversando dall’altra parte della carreggiata, pur di non sfiorare quelle due masse umane scosse dall’accelerazione cardiaca.
“Non ti bastava un figlio?”, dice Cristina.
“Mi piaccio le famiglie numerose”, dice Mario.
“E i nomi li decidi tu?”.
“Marty McFly non va bene?”.
“Perché non Jack lo Squartatore, allora?”.
“Potrebbe essere un’idea”.
“Oppure Marilyn Manson, no?”.
“Hai la mia approvazione”.
“Mario”.
“Sì”.
“Io chiedo il divorzio”.
“Finalmente”.
Le nubi di una crisi matrimoniale si addensano e svaniscono sopra le loro teste. Mario verifica la tenuta dei suoi undici decimi, impigliando lo sguardo dove possibile, mettendo a fuoco punti anche molto distanti, la vetrina dietro cui leccatissimi trentenni con il bicchiere in mano esauriscono la vena aurifera dei recipienti di nachos, il tronco obliquo di un albero con alcune chiazze grigie a forma di madonnina, due stencil – uno bianco e nero di Gary Coleman, il protagonista de Il mio amico Arnold, eternamente bambino, uno verde fosforescente con le guance incavate dell’ultimo identikit di un pericoloso latitante, entrambi evaporati dal mondo e comunque presenti sui muri di Milano – tutto pure di non voltarsi e avere la conferma che Cristina, al pari degli avvocati, e dei due colpi sordi martellati dal giudice in pectore, sia sparita insieme ai titoli di coda della serie televisiva appena andata in onda in un punto imprecisato dei suoi emisferi cerebrali, una serie così piatta e sentimentalmente trita da chiudersi sul primo e unico colpo di scena della stagione, quel divorzio.
Cristina dice che non divorzierà mai, perché non si sposerà mai, questo sia chiaro. Mario, con fare scocciato, dice che non è nei patti. Se ricorda, l’illuminazione era balenata la più lunga delle notti passate a scambiarsi emoticon e file musicali. Tre giorni dopo il primo incontro, senza l’ingombro di centinaia di parenti e amici di famiglia, si sarebbero sposati, nella prima chiesa, anche metodista, dove capitava. Poi avrebbero speso il resto della vita a conoscersi e avvelenarsi, mandarsi a fanculo e porgersi il termometro con il mercurio già abbassato, viaggiare tipo in Giappone e fare carriera in una qualche multinazionale, guardare i film pirata in streaming abbracciati sul divano e tradirsi ripetutamente lasciando le prove del tradimento allo scoperto, scoparsi in piedi in cucina e mettere al mondo una genia a questo punto decisamente mora ma né troppo alta né troppo corpulenta che un giorno avrebbe sospinto la loro carrozzina di vecchi catorci sconclusionati lungo un corridoio di linoleum lucido e senza quadri alle pareti.
“Nightmare finisce con più speranza”, dice Cristina.
“Anche con il catetere sarai bellissima”, dice Mario.
Cristina unisce le labbra, Mario segue lo stato-nazione del pudore estendere autorità e influenza oltre i propri confini, dalle guancie agli zigomi ai lobi delle orecchie, come se qualcosa le avvampasse dentro, di certo non l’innocenza, o ciò che ne resta, la colomba ha già spiccato il volo da quel ramo.
Del resto, né bellissima, né la più bella in assoluto: Mario, approfittando della momentanea superiorità, gira intorno a Cristina, le dita a rettangolo, facendo finta di scattare foto, impressionando la superficie del nulla della rosa allargata dell’imbarazzo, e quindi del viso di Cristina, della leggerissima asimmetria che sposta a sinistra l’equilibrio dei suoi lineamenti. Per quanto impercettibile, è l’unico difetto che Mario riconosca a Cristina, difetto in virtù del quale la realtà è reale e i palazzi si allungano al cielo e le macchine si accodano sui sanpietrini e un gruppo di universitari si dà appuntamento sui navigli e Cristina si schermisce con la mano come per evitare che fosse immortalata sul serio e il tempo rallenta in modo da riuscire a piegarlo e riporlo con estrema cura nei cassetti della memoria e i sentimenti, perfino quelli tragici, i più patetici, il sentimento del disastro della propria epoca, sono accolti e interiorizzati con una letizia scevra di rassegnazione che rintoccherà due o tre volte in tutto nella vita.
[La foto dello stencil è tratta da qui]