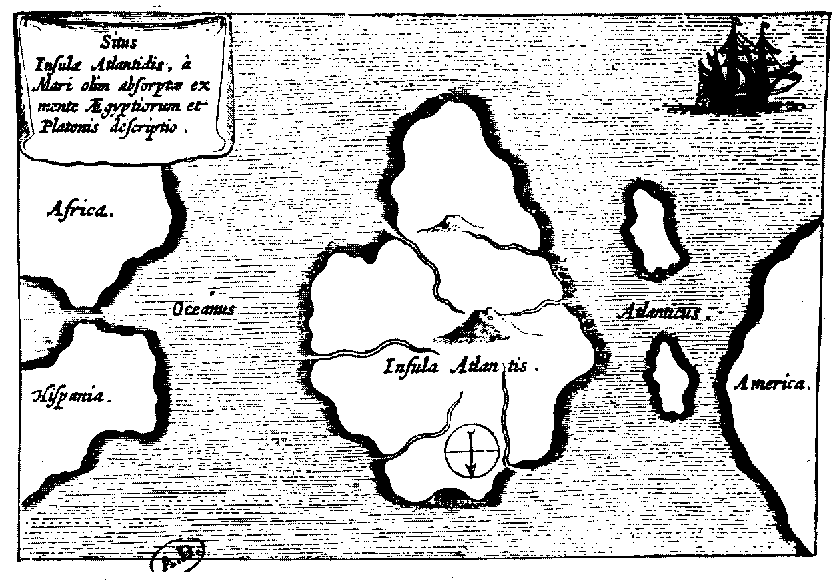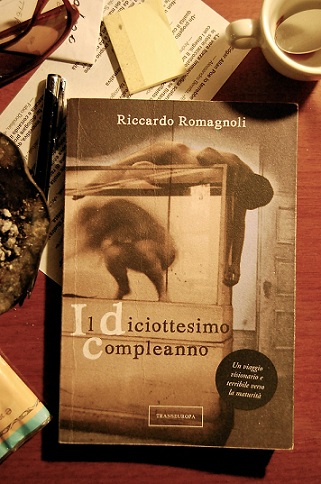(Lo scorso anno mi fu chiesto da Ranieri Polese un pezzo per il suo Almanacco che quell’anno aveva come tema l’editoria. Decisi perciò di parlare della mia esperienza sul web. Le cose che ora riporto qui non sono una novità per i lettori della rete, ma furono scritte come compendio per quelli della carta stampata. Le condivido ora in prossimità del decennale come viatico della festa. G.B.)
Il dibattito culturale nel web per me – che non sono uno storico, che racconto queste cose quasi a memoria, senza neppure andare a consultare alcunché – inizia con La Società delle menti, rubrica fissa del portale Clarence. Non ricordo neppure se era il 2001 o l’anno appresso. Ho saputo poi che di letteratura, sociologia, filosofia, arte, etc. se ne parlava già prima, prima ancora della diffusione del web, con le BBS, con il Luther Blissett Project e con tante altre esperienze e aggregazioni attorno al nuovo mezzo tecnologico, nuovo per davvero, oggi quasi non ce ne rendiamo conto: rammento, per dire, che mi sentivo quasi un iniziato quando andavo al Centro di Calcolo del Politecnico per potermi connettere nella rete universitaria (sarà stato attorno al 1990) e comunicare con un amico che studiava alla Pennsylvania State University. Roba da film di fantascienza. Ho visto nascere il World Wide Web, ho consultato Internet anche dopo essermi laureato, l’ho usata come una gigantesca edizione delle pagine gialle, da architetto come strumento di lavoro, ma mai come qualcosa di strettamente connesso al dibattito culturale. Da questo punto di vista ero ancora troppo legato all’idea romantica delle riviste cartacee che leggevo (Nuovi Argomenti, Alfabeta, Linea d’ombra) o alla “terza pagina” dei quotidiani. Terza pagina spostata sempre più in fondo, che diventava decima, ventesima, al punto che oggi aspetto solo che venga dislocata dietro le pagine sportive, in fondo, assieme all’oroscopo, per poi sparire del tutto, definitivamente.
Credo cercai su Altavista (Google ancora non aveva preso piede) qualcosa attorno alla raccolta di poesie Nelle galassie oggi come oggi. Covers di Montanari, Nove e Scarpa. Trovai un pezzo di Giuseppe Genna. Divenne il mio appuntamento quotidiano. Ogni mattina, a studio, prima di scartabellare pratiche edilizie o di mettermi a disegnare passavo dalla Società delle Menti a vedere che aria tirava. C’era nella gestione – al contempo pop e culta – dei temi trattati da Genna una passione che sembrava ormai scomparsa dalle succitate terze (ma sempre più in fondo) pagine culturali, che apparivano al confronto bolse, rigide, ingessate. Devo dire che a distanza di oltre un decennio Genna da una parte e il collettivo Wu Ming dall’altra, restano sempre un passo avanti nella scoperta e declinazione ad uso culturale delle nuove tecnologie (Facebook, Twitter, etc.). Ma quello che all’epoca non sapevo è che da lì a poco mi ci sarei ritrovato immerso fino alla cintola anch’io.
Perché ancora non sapevo che nel novembre del 2001, dopo lo shock degli attentati terroristici dell’11 settembre, un gruppo di scrittori, poeti, intellettuali, aveva deciso di organizzare un convegno per fare il punto della situazione. Scrivere sul fronte occidentale, si chiamava quel guardarsi negli occhi. Decisero di utilizzare i proventi del libro che ne nacque per mettere on line una rivista, utilizzando uno strumento ancora poco frequentato in Italia, che permetteva a chiunque di pubblicare, “postare”, senza particolari conoscenze informatiche, contenuti sul web. Un blog. Inutile dire che a gestire l’operazione fu proprio Giuseppe Genna, il quale, all’ultimo, decise di defilarsi dal progetto per portare avanti una sua pagina personale. Così nacque Nazione Indiana, nel marzo del 2003. La cosa curiosa è che in teoria doveva essere rivista on line senza commenti. Ma per un errore di gestione i commenti furono lasciati aperti, credo se ne accorse Christian Raimo che ne lasciò uno, da casa sua a Roma.
Seguii subito Nazione Indiana come qualcosa di davvero nuovo, dirompente. Autori più o meno miei coetanei, che non riuscivano a trovare spazio nelle asfittiche pagine culturali, al posto di lagnarsi dello status quo intraprendevano percorsi alternativi, scevri da autocompiacimenti, reciproci favori, “marchette” editoriali. (Per inciso: ancora oggi vige su Nazione Indiana l’imperativo di non pubblicare recensioni che parlino di opere dei redattori o vicendevoli elogi, così come non abbiamo mai optato né per l’utilizzo di piattaforme gratuite, che implicavano la perdita della proprietà dei contenuti che abbiamo sempre considerato Creative Common, né abbiamo mai voluto pubblicità di alcuna sorta, sobbarcandoci gli oneri finanziari del progetto, rendendolo così libero da ogni eventuale, involontaria o meno, pressione esterna).
Il blog nacque in marzo. Solo a settembre, non ostante la frequentazione quotidiana, pubblicai il mio primo commento. Sentivo, ormai, di far parte di questa comunità che si disinteressava a quel principio di autorità (e autorialità) che bloccava il dibattito cartaceo e che invece, orizzontalmente, metteva assieme autori e lettori, scrittori e utenti. Il mio primo pezzo, nell’aprile 2004, fu pubblicato di rapina da Tiziano Scarpa. Si innamorò di un mio lungo e ironico commento e decise di trasformarlo in un post. In seguito postai i miei pezzi ospitato da Dario Voltolini, o da un giovane giornalista campano free lance che scriveva cose inaudite e rabbiose, Roberto Saviano. Pochi mesi dopo ricevetti l’invito di far parte della redazione. La cosa interessante è che io non conoscevo di persona praticamente nessuno. Lo racconto perché trovo in qualche modo esemplare, tipico, il modo in cui sono stato arruolato. Nel corso degli anni i redattori si sono avvicendati, alcuni, nel 2006 – fra cui Scarpa stesso, Antonio Moresco, Carla Benedetti (soci fondatori e appassionate anime critiche del blog) – lasciarono Nazione Indiana per contrasti interni. Contrasti espliciti, dichiarati, pubblicati sul sito stesso, nel quale nacque una discussione calda e coinvolta. Altri se ne sono aggiunti, invitati di volta in volta dalla redazione. Dei soci fondatori, dopo nove anni, sono rimasti solo Andrea Inglese e Helena Janeczeck. Eppure, non ostante la più antica critica al blog sia sempre stata che “Nazione Indiana non è più quella di una volta” (ce lo siamo sentiti ripetere già a pochi mesi dalla nascita), credo che lo spirito del blog, la sua tonalità, le sue modalità, i suoi intenti siano sempre gli stessi. Sogno, di mio, una Nazione Indiana dove nessuno dei presenti redattori sia a firmarlo, nelle mani di 20 giovani redattori, sconosciuti, pronti a portare avanti il progetto.
Progetto che, sinceramente, agli albori era visto dalla critica ufficiale, accademica, come qualcosa di curioso e poco interessante. Poco più di un covo di letterati freak frustrati. La stessa modalità dei commenti aperti, la critica spesso ingenerosa ai pezzi pubblicati che ne nasceva, inorridiva la vecchia guardia. E tutt’ora urtica. Anche perché, ammettiamolo, una sorta di male interpretata idea di libertà che circola dalla sua nascita su Internet trasforma, spesso, il web in un far west dove tutti possono dire tutto, trivialità, insulti, aggressioni, nascosti dietro l’anonimato non tanto del nome (mai avuto problemi a relazionarmi coi nickname) ma del corpo. Discutere così, a botta calda, senza guardarsi in faccia aiuta i livorosi – i “leoni da tastiera” li ha chiamati Wu Ming 3 – a scatenarsi, trasformando, spesso, lo spazio dei commenti, in tutti i blog, in un defecatoio dove c’è chi, per fare un esempio, spiega il teorema di Pitagora e chi, come se fosse sensato, dice di non essere d’accordo col filosofo greco. Ma altrettanto spesso non è così. Per me molte discussioni con gli utenti si sono trasformate in luoghi di arricchimento, di scoperta, di condivisione. Ecco, quest’aspetto giustifica, da sempre, la ragione dei commenti aperti, anche se per noi redattori significa una continua attenzione a evitare che le discussioni deraglino nell’insulto gratuito, spesso nei confronti dei meno bellicosi (io ho una procedura standard: gli insulti a me rivolti li tengo tutti, ma se viene maltrattato un mio ospite non ho problemi a cancellare il commento ingiurioso).
Parlo di Nazione Indiana ma questo racconto andrebbe allargato all’intero sistema di blog e siti letterari e culturali che nel frattempo stavano nascendo in quegli anni. Ognuno con la propria identità. Come Vibrisse di Giulio Mozzi (precursore e grande pioniere del mezzo), Zibaldoni, Carmilla on line, nata per trasferire in rete una rivista cartacea diretta da Valerio Evangelisti, o come Lipperatura, blog di Loredana Lipperini dal taglio giornalistico, Minima et Moralia, La poesia e lo spirito, La dimora del tempo sospeso, Absoluteville, Il primo amore, fondato dagli autori che uscirono da Nazione Indiana, e tanti altri. L’elenco, il blogroll, è lungo e meriterebbe di essere fatto per intero. Anche perché l’insieme dei blog culturali ha da subito “fatto rete”: autori di un sito hanno pubblicato su un altro, oppure si sono spostati da una redazione ad un’altra, ci si è letti a vicenda, anche polemizzato, ma più spesso collaborato. Cercato, cioè, di fare massa critica.
Il “vecchio mondo” – fatto di critici, giornalisti, scrittori, editori – legato a ritualità novecentesche, iniziò, con lentezza e farragine a sentire il peso di questa avanguardia sgangherata che dibatteva animosamente in rete. Me ne resi conto un giorno, in libreria, quando vidi il libro di un giovane scrittore che nella quarta di copertina al posto di citare firme prestigiose della carta stampata metteva in bella evidenza i commenti positivi ricevuti dai lit-blog. “Ormai al mattino” mi disse un redattore di una grande casa editrice “iniziamo la nostra rassegna stampa accendendo il computer: cosa pubblica oggi Nazione indiana? Cosa Carmilla?”
Il lavoro di scouting fatto dalla rete in questi Anni Zero, dove l’editoria classica sembrava sempre più ridotta a fare cassa inseguendo gli umori del momento e chiudendo perciò tutti gli spazi possibili a scritture altre, differenti, è stato enorme. Pensiamo solo a come la più reietta, dall’editoria, delle attività di scrittura, la poesia, abbia trovato uno spazio dove esprimersi per davvero. Dalla rete sono nati autori che poi hanno trovato sbocchi editoriali. La rete ha dato attenzione ad autori che altrimenti rischiavano la smemoratezza. Anche autori internazionali, di enorme spessore (e qui, con un orgoglio un po’ beota, non ho vergogna a ricordare le traduzioni inedite di autori straordinari fatte su Nazione Indiana e poi ripubblicate, senza autorizzazione, dalla carta stampata. O i premi Nobel sconosciuti dalle pagine culturali nazionali che da noi avevano da tempo trovato spazio e recensioni).
Insomma, qualcosa era cambiato. Agli albori capitava sovente che pezzi pubblicati sui quotidiani venissero poi riproposti dalla rete. Nel tempo accadeva sempre più spesso il contrario: discussioni scaturite dalla rete diventavano argomenti della carta stampata. Esemplare il dibattito sul New Italian Epic che nacque in rete dal testo dei Wu Ming e che si propagò ben oltre il web diventando tema di convegni universitari non solo nazionali. E sempre più spesso autori, critici, accademici curiosi iniziarono a guardare alla rete con maggiore attenzione, intervenendo dapprima magari con automatismi professorali subito cassati da chi in rete ci stava da anni (e che ora un po’ si atteggiava da carbonaro detentore della netiquette) e poi sempre più vicino ai nuovi linguaggi e modalità. In questo modo sono nate altre realtà come DoppioZero, Le parole e le cose, Alfabeta2, etc. così come chi aveva battuto da subito la strada del virtuale ha nel tempo cercato altre inclusive pratiche di scambio culturale: iniziative editoriali “tradizionali” – Il Primo Amore che diventa rivista cartacea, così come lo è Alfabeta2 – “miste”, come le Murene, librettini pubblicati da Nazione Indiana ai quali abbonarsi on line (senza cioè la classica distribuzione in libreria) – ebook, performance, manifesti – penso all’attività del movimento Generazione TQ -, marce da nord a sud del paese – il “Cammina Cammina” organizzata da Il Primo amore -, ritrovi – penso alle Feste Indiane svolte al Castello di Malaspina in Lunigiana e all’Arci Bellezza di Milano -, e tanto altro ancora.
Questo per dire che ormai quelle che apparivano barriere pregiudiziali che definivano spazi incapaci di comunicare fra di loro, opposti quasi, si sono dimostrate fortunatamente fragili, creando così un modo inclusivo di concepire il campo della cultura, più ampio, variegato, ricco. Fatto di continui feedback fra i vari dispositivi di diffusione della cultura non maggioritaria, non pacificata, non arresa ai modelli omologanti imposti da un centro politico e ideologico che in questi anni difficili ha banalizzato e reso marginale l’idea di cultura in Italia.
Nazione Indiana ha nove anni. Non so se ci sarà ancora fra nove anni. Non so neppure cosa farò io fra nove anni, magari mi dedicherò alla danza classica, chi può saperlo. Nove anni di vita, sul web, sono un’era geologica. So che questi nove anni, a guardarli ora, retrospettivamente – ora che mentre scrivo queste righe do un occhio alla posta elettronica, leggo un messaggio su skype, controllo gli aggiornamenti sui vari lit-blog, rispondo ad un commento – a guardarli, tutti assieme, mi sembrano passati in un soffio. Gli oltre settemila post pubblicati e le decine di migliaia di contatti unici mensili, invece, mi ricordano il lavoro enorme di resistenza culturale che siamo riusciti, redattori, ospiti e lettori, a produrre, tutti assieme. Gratis, senza alcun tornaconto, per pura militanza, per pura, anarchica felicità. Per amore.
(pubblicato col titolo C’era una volta il blog. E poi gli indiani uscirono dalle riserve, in: Fare libri. Come cambia il mestiere dell’editore, (a cura di) Ranieri Polese, Guanda, 2012)