di Giacomo Sartori

Ieri pomeriggio ho ricevuto una mail della mia agente letteraria. Fa sempre piacere trovare una mail dalla propria agente. O almeno fa piacere a uno come me, che nel cosiddetto mondo dell’editoria ha vendemmiato suo malgrado non poche ruggini. Come dire, è segno che le cose avanzano, o che comunque qualcosa bolle in pentola. Quando è calma piatta l’agente non ti scrive, puoi stare sicuro. Scrive ai suoi pupilli, gli scrittori che vendono bene, e a te nemmeno ci pensa. O anche li chiama personalmente, i suoi preziosi pezzi da novanta, e sta tre ore al telefono con ciascuno di loro, magari anche solo sguazzando nelle indiscrezioni della cosiddetta repubblica delle lettere, quei meschini pettegolezzi, per non chiamarle maldicenze, che sono il prezzemolo delle cucine in cui si sfornano i libri. Per quanto ho avuto modo di vedere nove volte su dieci gli agenti letterari adorano i pettegolezzi, proprio come i commercialisti, che proprio nella perversa curiosità per le fragilità più umane, per non dire più basse, dei loro clienti, sembrano trovare un contrappeso all’aridità delle cifre che maneggiano tutto il santo giorno. Ma non è questo quello che volevo dire. Quello che intendevo chiarire è che quando l’agente ti cerca, ti cerca lui, dopo un sacco di tempo che non lo senti, vuol dire che una casa editrice è interessata all’ultimo tuo manoscritto, o si profila una traduzione in un qualche paese straniero. Una di quelle traduzioni che proprio non ti aspettavi, e come per miracolo si materializza sotto forma di un numero con tre zeri nella colonna dei crediti del tuo estratto conto. Questo è il ragionamento che ha fatto il mio cervello rettiliano. Un po’ alla volta anche in queste cose ci si fa un’esperienza, come in tutte le altre. Non è che le faccende letterarie siano poi così diverse dalle altre, per esempio il mio lavoro scientifico. Anche lì ci sono gli sgomitatori, i millantatori specializzati nel vendere fumo, gli stronzi fatti e finiti, le vedettes che si credono meglio di tutti gli altri, e hanno sete di reiterate conferme, e anche lì ci sono le persone per bene, quelli che hanno diamanti da mostrare e li mostrano. A modo loro, scrivendo. Pochi, pochissimi, ma ci sono. Insomma, sto di nuovo perdendomi per strada: in allegato alla mail dell’agente c’era il resoconto delle vendite del mio ultimo romanzo. Qualcosa dentro di me ha deciso di cominciare da quello. Checché se ne dica fa sempre bene imbattersi in una riprova nero su bianco di un minimo senso – qualcuno preferirebbe forse chiamarlo riconoscimento, o dose minima di gratificazione – dei propri sforzi letterari, mi sono detto. Si ha un bel ripetere che si scrive per se stessi, e che si scriverebbe anche se non si avessero lettori, in realtà l’atto di scrivere è uno struggente appello, una supplica. L’invocazione di un agonizzante, un lancinante urlo di dolore. I manzoniani venticinque lettori sono solo bassa propaganda, la maschera da fraticello indossata dalla montagna di orgoglio allignante nell’autore, lo sanno tutti. Ho aperto quindi il documento allegato al messaggio, e prima ancora che me ne rendessi conto i miei occhi si sono tuffati come avvoltoi verso la riga delle copie vendute. I miei occhi hanno vacillato, increduli della cifra che mettevano a fuoco: centosessantasette. I miei occhi hanno verificato se dopo le tre misere cifre seguisse per caso qualche zero che si leggeva male, ma anche a strizzare come limoni i muscoli degli zigomi non c’era nessun zero: centosessantasette e basta. Centosessantasette è un numero bassissimo. O meglio, ridicolo. Meglio ancora, offensivo. O anche tragico. Ho respirato a fondo, dicendomi che certo i miei occhi avevano preso un abbaglio. Come tante persone che passano la vita a leggere e a scrivere non è che ci veda poi così bene. Ho cinque paia di occhiali, ognuno adeguato a un preciso spettro di condizioni e di esigenze, tanto che ogni volta che vado dall’oculista ci metto mezz’ora a spiegargli perché ne ho appunto cinque paia. Per gli oculisti contemporanei si dovrebbe però avere un solo paio di occhiali, quelle lenti che fanno tutto, e già quando ne hai due paia cominciano a sospirare. Se ne hai tre aggrottano le sopracciglia. Con cinque ti trattano come se fossi pazzo da legare: la calibrazione empirica effettuata da un essere libero di pensare contraddice di netto tutta la loro dottrina, fa a pugni con le loro inflessibili credenze. Per questo nelle mie spiegazioni oftalmiche finisco sempre per ingarbugliarmi: quando ti fissano come se fossi pazzo finisci per sentirti un po’ pazzo tu stesso. Una volta mi sono perfino messo a litigare, con una oculistina che pensava di sapere tutto. Per farla breve, diffidando dei miei occhi ho preso in mano la situazione in prima persona, intenzionato a dipanare l’equivoco che mi aveva inculcato quel funesto spavento. Ho affrontato di nuovo il resoconto della casa editrice, questa volta sotto la vigile supervisione del mio cervello. La dizione precisa, il mio cervello abituato alle analisi approfondite e ai complessi enigmi scientifici sapeva che per fare le cose bene bisognava cominciare da lì, era Copie vendute tramite distributori e privatamene. Il mio medesimo cervello ha poi vegliato che scorrendo verso destra i miei occhi non slittassero di una riga, come può sempre capitare anche agli occhi più allenati. Contro ogni aspettativa la cifra continuava a essere centosessantasette. Ancora centosessantasette. Sempre quel maledetto centosessantasette. Abbinato, non c’era possibilità di sbagliarsi, a quel Copie vendute tramite distributori e privatamente. Più sotto, accanto alla frase un po’ criptica Giacenza nostro magazzino e distributore c’era una cifra che suonava in qualche modo come una conferma: millecentoquarantanove. Millecentoquarantanove è un numero degno di ogni rispetto, accettabilissimo: peccato che avesse pensato bene di schierarsi nel campo avverso. Se millecentoquarantanove esemplari restavano a ammuffire in magazzino, sommando le copie per la stampa e tutto il briciolame delle altre voci, le copie vendute dovevano essere davvero pochissime: i conti tornavano. Era ineluttabile, le copie vendute del mio romanzo erano effettivamente centosessantasette. Solo centosessantasette. Il grande romanzo che mi aveva preso per anni, per il quale avevo dato l’anima, e che consideravo fondamentale nel mio cosiddetto percorso letterario, s’era accasato solo centosessantasette miserissime volte. Io a dire la verità non mi ero mai domandato quante copie fossero state smerciate, ma presupponevo molte di più. Come dire, una cifra non stratosferica ma degna. Per esempio appunto millecentoquarantanove. Certo i miei romanzi precedenti non avevano mai sbaragliato, però nel loro piccolo si erano difesi bene. Ma a quanto pare questa volta le copie acquistate erano centosessantasette, e nemmeno una di più. Il mio cervello a questo punto ha avuto uno scatto di orgoglio, si è concentrato come una micidiale arma di precisione su quello sbifido Copie vendute tramite distributori e privatamente. Sicuro che avrebbe stanato l’indizio ben nascosto ma inequivocabile suscettibile di ribaltare la situazione, traendoci d’impiccio. Io sono un tipo che di fronte alle difficoltà tende a demoralizzarsi, per non dire a deprimersi, se non addirittura a imboccare i vertiginosi sentieri della paranoia, e quindi il mio cervello molto spesso si risolve a indossare i panni del crocerossino. Calcando sugli aspetti positivi mi fa capire che non c’è ragione per vedere tutto in nero, a suon di analisi inconfutabili mi convince a perseverare. Insomma, memore delle esperienze passate il mio cervello si aspettava di tirarmi per l’ennesima volta fuori dalle peste, e io stesso speravo tanto che lo facesse. Non mi restava del resto altra soluzione. E invece senza volerlo questa volta il mio cervellaccio ha aggravato ancora di più le cose, come quei soccorritori maldestri che fanno sprofondare ancora di più nel pozzo scuro e umido il derelitto bimbo gemente, allontanando ancora di più la speranza di tirarlo fuori vivo. Quel privatamente del Copie vendute tramite distributori e privatamente, ha arguito il mio petulante cervello, includeva senza ombra di dubbio anche le copie che avevo comprato io. Quindi la cifra andava rivista al ribasso. E di molto: questa volta avevo acquistato davvero tante copie. Avevo deciso di fare le cose in grande. Mi ero detto che per me questo era un libro importante, per non dire capitale, e quindi era assurdo lesinare sui mezzi che mi sarebbero serviti per promuoverlo. Naturalmente l’ufficio stampa della casa editrice avrebbe fatto il suo lavoro, ma ormai li conoscevo gli uffici stampa, presi per il collo dall’esorbitante numero di libri che devono sostenere, e animati dallo stesso entusiasmo, specie quando l’autore non è tanto noto, di un operaio che sgobba a una catena di montaggio: questa volta dovevo impegnarmi di persona. Certo non avevo tanti contatti, anzi ne avevo proprio pochini, perché ero sempre stato molto isolato, questo nessuno avrebbe potuto negarlo, ma in fondo qualcuno lo conoscevo, qualche pista potevo provare a batterla. Per il romanzo precedente avevo adottato la strategia opposta, e dalla casa editrice, che era un’altra – ogni volta mi epurano e devo ricominciare altrove – ne avevo comprati pochissimi. Nemmeno a certi amici intimi, lo avevo dato, il romanzo precedente, e qualcuno se l’era legata al dito. Questo invece lo avevo distribuito in giro come si lanciano in aria i coriandoli, senza pensare alle fatture che mi sarebbero arrivate da pagare, e che anzi puntualmente arrivavano (se c’è un’attività nella quale le case editrici si mostrano sempre molto efficienti è proprio questo). Ma soprattutto, a parte i conoscenti per così dire privati, lo avevo mandato o fatto avere a un sacco di persone che secondo me avrebbero potuto essere interessate, per non dire avrebbero potuto entusiasmarsi. Avevo passato settimane a trovare i contatti, a cercare di attivarli, a tastare il terreno, a carpire assensi, a mandare pacchetti. Il libro avevo al centro una vicenda storica, e quindi avevo stanato molti storici. Mi ero presentato, avevo riassunto in maniera sobria ma accattivante la vicenda, avevo chiesto se per caso erano interessati a dargli un’occhiata. Specificando naturalmente che non si impegnavano a nulla: se avessero visto che non era nelle loro corde avrebbero potuto buttarlo dalla finestra, o anche da un aereo in volo, o sotto il piede di un mobile traballante, dove volevano loro. Ci tenevo a non apparire insistente, e quindi calcavo sempre molto su questo punto, inventavo sempre nuovi mezzi di distruzione del mio libro. Se c’è una cosa che voglio evitare è proprio assillare gli storici. Molti non mi hanno nemmeno risposto, alcuni invece si sono mostrati disponibili. Tra gli altri uno storico molto famoso, con le quali avevo scambiato diverse cordiali mail. Fatta qualche sporadica eccezione nessuno aveva poi letto il romanzo, nonostante trattasse di un grande personaggio storico che nessuno scrittore aveva mai osato tirare in ballo, e a dispetto dei miei più o meno patetici tentativi di rilanciare la cosa: non avevo avuto quasi nessun riscontro. Nemmeno dallo storico molto famoso che si era mostrato tanto gentile e alla mano. Tutta fatica inutile. Tentativi privi di senso, macchiati da quella stessa indegnità di una madre che si prostituisce per nutrire i suoi figli. Queste cose però le penso adesso, quello che capivo mentre guardavo i conteggi della casa editrice, e che appunto aggrava ulteriormente la situazione, rendendola luttuosa, è che alle centosessantasette copie dovevo sottrarre le molte che avevo comprato io. Il che era come sottrarre il mangiare a chi non ha niente da mangiare. Lì per lì ero troppo confuso per ricordarmi esattamente quanti esemplari mi ero fatto mandare al prezzo di favore stipulato dal contratto, ma dovevano essere almeno un’ottantina, se non di più. Quindi le copie vendute in libreria scendevano, al meglio, a ottantasette. Nemmeno cento. Nemmeno novanta. Comprendendo naturalmente anche le librerie online. Tutti quegli sforzi durati anni, quelle ricerche, quelle letture, quelle cattedrali mentali, quelle abissali riflessioni, quell’accanimento sulla lingua, quelle infinite revisioni, quelle interminabili limature finali, quelle battaglie con l’ottuso editor della casa editrice, e poi appunto quelle mail, quelle telefonate, quell’attenzione a giornalisti insipienti, quelle interviste radiofoniche con conduttori che non avevano letto il testo, quel vano darsi da fare, quell’umiliarsi – perché di questo si trattava, di umiliazione – per spacciare non venticinque copie, il che nella disdetta avrebbe pur sempre rappresentato un traguardo onorevole, ma ottanta. Perfino la tenzone con il famoso critico che sosteneva che il mio libro fosse scritto malissimo, e non vedeva che proprio nel discostamento da quella che lui considerava una bella scrittura erano annidati i segreti più preziosi del testo, prendeva una luce sinistra, alla luce di quel benedetto centosessantasette. Ero proprio abbattuto, non posso negarlo. Io sono una persona che si scoraggia facilmente, l’ho già detto, ma questo non era dei soliti inghippi che la mia indole saturnina ingigantisce e ingrigisce a suo piacimento: era una vera e propria mazzata a tradimento. Una cannonata sparata nelle spalle, un colpo mortale. Il mio cervello non mi diceva più niente, non pensava più niente: era anche lui spezzato, annientato, esattamente come me. È in questo stato di spirito che mi sono ricordato del messaggio dell’agente, che non avevo ancora letto. Certo qualche frase di conforto mi tirerà su un po’ il morale, mi sono detto. Le cose sono andate come sono andare, ma il tuo romanzo è magnifico, mi aspettavo di leggere. L’importante è che tu non ti demoralizzi, perché nonostante tutto sei davvero bravo, molto più in gamba di tanti nomi che sono sulla bocca di tutti. Verrà il momento in cui i tuoi testi verranno apprezzati, puoi starne certo. O insomma qualcosa del genere. E invece l’agente mi comunicava che nel corso degli ultimi mesi aveva riflettuto sul nostro rapporto di lavoro, testuali parole, e le pareva che in fondo questo non si fosse rivelato molto soddisfacente per nessuna delle due parti, testuali parole. Pertanto le pareva più corretto che la nostra collaborazione, parole testuali, cessasse a partire da quel giorno stesso, cioè ieri. Mi ringraziava per la fiducia che le avevo accordato in quel periodo e mi faceva, testuali parole, i suoi più sinceri auguri. Quindi da oggi sono anche senza agente.
[l’immagine: Louis Soutter]
 di Alessandro Chiappanuvoli
di Alessandro Chiappanuvoli

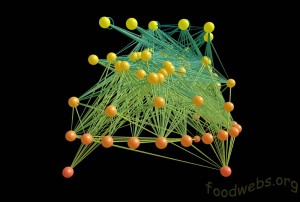



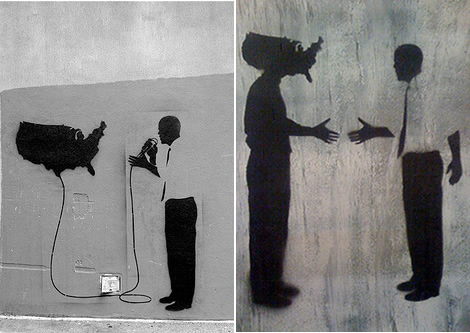
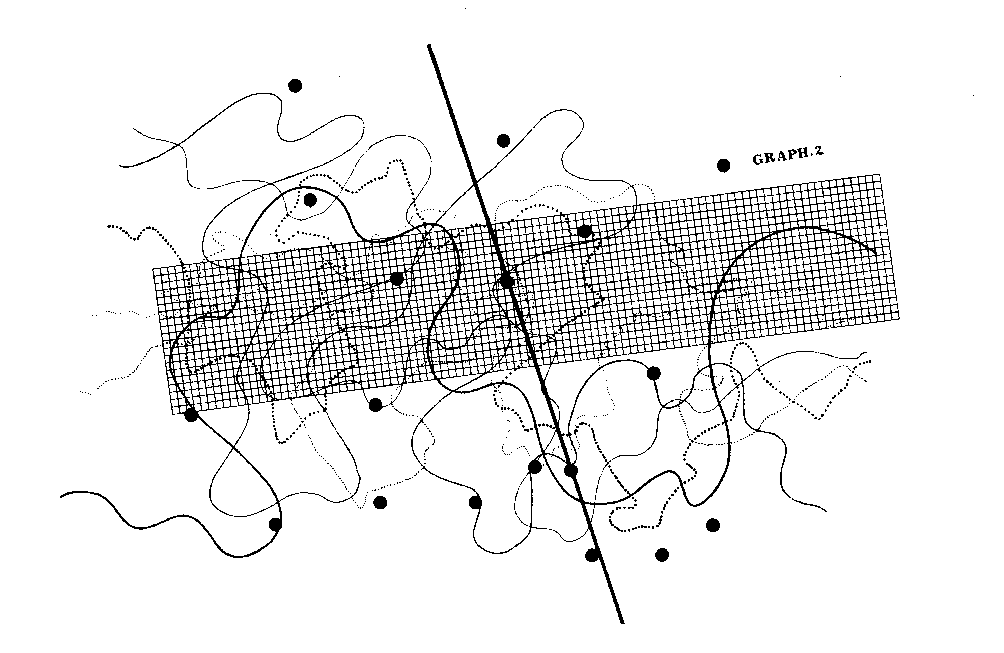

 (Giovedì prossimo è in uscita per Guanda Nel nome dello Zio, il nuovo romanzo di Stefano Piedimonte, il quale gentilmente ci regala l’anteprima, qui di seguito, del quinto capitolo. G.B.)
(Giovedì prossimo è in uscita per Guanda Nel nome dello Zio, il nuovo romanzo di Stefano Piedimonte, il quale gentilmente ci regala l’anteprima, qui di seguito, del quinto capitolo. G.B.)
