 di
di
Francesco Forlani
Europeana è un libro uscito per la prima volta nel 2005 e riproposto un anno fa in una nuova edizione dalla siciliana duepunti. Se ne parlo oggi, in questa fine estate del 2012 è perchè la sensazione che ho, avendolo acquistato a Mesagne, alla libreria del mio amico Domenico Pinto, la Lettera 22, è che il libro sia effettivamente uscito nel momento in cui, su consiglio di un amico critico con cui sono spesso in disaccordo, l’ho comprato. Sensazione, per certi versi, verificata quando parlandone in giro, certo non con addetti ai lavori , nessuno ne sapeva niente.
Nel 2007, proprio su Nazione Indiana, Giorgio Vasta pubblicava un’interessante intervista all’autore di Europeana, Patrik Ourednik, facendola seguire a una bella recensione del libro pubblicata sempre qui. Europeana è in verità un libro la cui prima edizione è del 2001: “Europeana. Stručné dějiny dvacáteho věku”, Rep. Ceca. Dunque, ricapitolando, noi oggi, domenica 26 agosto 2012, parleremo di un libro scritto presumibilmente prima del 2000, pubblicato in Repubblica Ceca nel 2001 e in Italia, una prima volta nel 2005, una seconda nel 2011 e che ha tutta l’aria di essere non solo appena stato pubblicato ma, mo mo, scritto dal suo autore. Prima di entrare nel vivo di questa mirabolante Breve storia del XX secolo proporrei a chi non avesse ancora letto il libro, la fulminante e precisa sintesi che ne ha fatto The New York Times Book Review, sottoscrivendola in pieno,.
« Toccando temi ed eventi diversi tra loro come l’invenzione del reggiseno, delle bambole Barbie, Scientology, l’eugenetica, Internet, la guerra, il genocidio e i campi di concentramento, scandisce un ritmo implacabile che diventa inaspettatamente coinvolgente, addirittura toccante. »
Regolata, se così si può dire, la mise en claire delle ragioni per cui vale la pena leggere, presumibilmente acquistare, questo libro, anche perchè è bello, attuale nella sua inattualità, sperimentale nella forma, godibile, edito da una valorosa e indipendente casa editrice siciliana, proposto da critici letterari autorevoli, posso finalmente parlarvi di un percorso di lettura un po’ particolare con la speranza che la cosa faccia conquistare altri lettori al libro, certo che altri lettori, Europeana, ne conquisterà a prescindere.
 Forse non tutti sanno che
Forse non tutti sanno che
Bene. La prima cosa a cui ho pensato, a lettura ultimata, è stata la Settimana Enigmistica. Ma non il mirabolante mondo dei rebus, o i giochi di logica a incastro, le parole crociate quanto la storica rubrica del “forse non tutti sanno che“. Leggendo infatti una dopo l’altra e in rapida successione tipografica e non affatto cronologica, le notizie allestite dall’autore, vuoi per la lunghezza dei paragrafi più o meno dello stesso numero di battute, vuoi per la mancanza di una logica compositiva tra un fatto e l’altro, è a quel fortunato cabinet des curiosités che ho pensato. Ovvero agli “studioli” del Rinascimento italiano, in cui vi si trovavano raccolte d’arte e di oggetti rari, collezioni enciclopediche di oggetti preziosi o semplicemente insoliti, noti anche come Wunderkammer.
Più particolarmente, la domanda che mi sono posto era: cosa spinge un lettore in quel buco nero dell’aneddoto storico, in quelle Wunderkammer verbali, cosa lo fa rimanere incollato a informazioni che riguardano l’invenzione della cerniera lampo o dell’uso presso i romani di un tale abito in determinate circostanze.La risposta, ancora una volta, è nella filosofia, nella sua storia. Ha senso immaginare una storia della filosofia senza gli aneddoti che l’attraversano? Per quanto il rischio sia che ci si ricordi del fatto che gli abitanti di Königsberg regolassero i loro orologi quando vedevano passare il filosofo Immanuel Kant nelle sue passeggiate, dimenticando il resto. Certo ci sono aneddoti e aneddoti, e infatti Deleuze descriveva l’ «anecdote philosophique», quello che permetteva di cogliere quel misterioso punto “segreto” in cui “la même chose est anecdote de la vie et aphorisme de la pensée”.
A parer mio in un rovesciamento continuo della frontiera di senso, in Europeana, tra storia bassa e storia alta, tra fatti minimi e grandi narrazioni nella storia, il lettore trova in ognuno dei passaggi come una “casa di risonanza”, una casa che non c’è più ma da cui, in qualche modo, si provenga, come una casa dell’origine di cui sappiamo il nome ed è novecento. Un Novecento che si ripete, esattamente come certi rimandi che ritroviamo alla fine del libro, oltre il novecento alla soglia del 2000.
Ma cosa c’entra Ferrini, mo?
Per quei lettori la cui giovane età non ha permesso di “vivere” un importante momento della televisione italiana, ovvero il programma “Quelli della notte” creato da Renzo Arbore, Ferrini era un comico che faceva la parodia del militante comunista romagnolo che presentava la propria visione del mondo spesso citando, tra le proprie fonti, gli incontrovertibili documenti “documenti eh!” della settimana enigmistica. All’epoca, ancora vivevo a Caserta, ricordo che ogni qualvolta a tavola qualcuno se ne uscisse con un aneddoto storico particolarmente strano, strano ma vero, una curiosità inedita e speciale, tutti si pensava che la fonte fosse non tanto una voce tratta dal Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri o dalle milioni di enciclopedie vendute agli italiani, a rate, negli anni settanta e ottanta ma proprio « alLa rivista che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione! » .
Un finale europeano
In epoche come la nostra, di accessibilità in rete immediata e portatile a tutti i saperi possibili, lasciandomi prendere la mano, come al solito, dalla curiosità, quando ho letto che La Settimana Enigmistica inventata dal Dottor Ingegner Giorgio Sisini, sul primo numero pubblicato il 23 gennaio 1932 al costo di 50 centesimi di lire recava in copertina l’immagine dell’attrice messicana Lupe Vélez, non so perchè, sono andato a cercarmi notizie su di lei. E allora?

Forse non tutti sanno che The Mexican Spitfire” (“La Lanciafiamme Messicana “) fu una delle prime star maledette, dalla vita tormentata, sposata una prima volta con l’attore Johnny Weissmuller, leggendario Tarzan del primo cinema, e che Il 13 dicembre 1944, dopo un’“ultima cena ” con le sue migliori amiche si suicidò. La filosofia dell’amore di Lupe Velez, si può riassumere con uno dei suoi più fulminanti aforismi “The first time you buy a house you think how pretty it is and sign the check. The second time you look to see if the basement has termites. It`s the same with men.” Un altro aneddoto riguarda il ritrovamento del cadavere. Pare che non ci fossero foto di Lupe sul letto di morte a commento dell’elogio funebre della Parsons, celebre cronista della vita hollywoodiana e voci più credibili, testimonianze più o meno dirette raccontavano “che in un impeto estremo si fosse svegliata durante la notte per vomitare e che, scivolando nel bagno fosse caduta battendo la testa nella tazza del water. Solo i grandi hanno diritto a una morte ridicola, credo abbia scritto Milan Kundera da qualche parte.
L’Insostenibile leggerezza dell’essere, che inaugurò la collana Fabula della casa editrice Adelphi fu pubblicato nell’ottobre del 1984 ma fu solo nella primavera del 1985 grazie al programma Quelli della notte, e al “tormentone” dell’inventore dell’Edonismo Reaganiano, Roberto D’Agostino che lo citava in ogni puntata che se ne decretò il grande successo di pubblico.
All’attrice messicana Andy Warhol dedicò Il cortometraggio “Lupe”(1965) interpretato da Edie Sedgwick e che ripercorre gli avvenimenti accaduti la notte del suo suicidio. Nell’agosto del 1969, nel reparto psichiatrico del Cottage Hospital, Edie Sedgwick conobbe Michael Post; si sposarono il 24 luglio 1971. Venne trovata morta dal marito a causa di un’overdose di barbiturici la mattina del 16 novembre 1971. A Edie Sedgwick, Bob Dylan che ebbe una breve e tormentata storia con la “bellissima” ragazza della Factory, dedicò la canzone, Just like a woman . “Femme fatale” dei Velvet Underground sembra cucitale addosso.
Nonostante la pubblicazione del libro “La fine della Storia” dello storico post-moderno Fukuyama, Patrik Ourednik, conclude scrivendo che « beaucoup de gens ne connaissaient pas cette théorie et continuaient à faire de l’histoire comme si de rien n’était. » (p. 151).

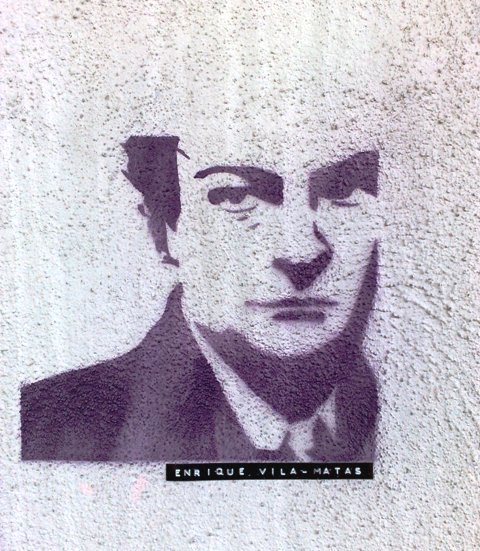

 a cura di Francesco Forlani
a cura di Francesco Forlani
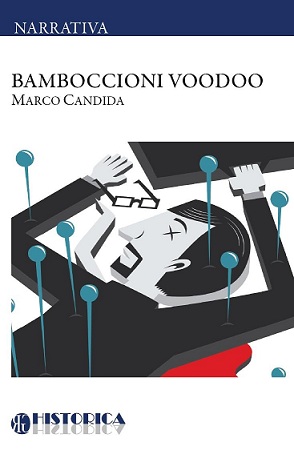 (Marco ci regala un estratto del suo nuovo libro, in questo scampolo di fine estate. G.B.)
(Marco ci regala un estratto del suo nuovo libro, in questo scampolo di fine estate. G.B.)

















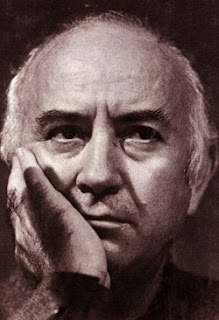

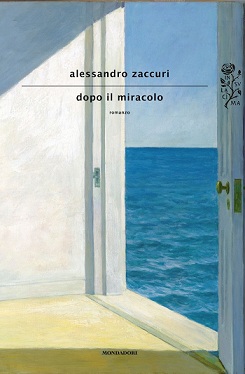 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo