ovvero “Una cosa noiosa che non ho mai fatto”
di Stefano Durì
[dopo la pubblicazione di questa recensione su The Pale King, nella casella postale di NI è nata una discussione fra l’autrice e un nostro lettore, il quale ha condensato in questo pezzo le sue considerazioni, che qui volentieri pubblico. G.B.]
Ho letto “Il re pallido” e alcune recensioni. In almeno tre di quelle italiane si afferma che ad un certo punto DFW parla della propria esperienza all’Agenzia delle Entrate, dando al romanzo anche “un valore testimoniale e autobiografico” (cit. dall’articolo di Sandro Veronesi, Repubblica, 31/10/2011). In quelle straniere (v. ad esempio qui o qui ) e anche in Wikipedia si dà invece per scontato che il DFW presente nel romanzo (e che si presenta come “il vero autore”) sia un personaggio di finzione (lo chiameremo “DFW”).
In effetti, nel periodo del presunto apprendistato all’IRS il vero DFW si laureava ad Amherst. Wikipedia a parte, troviamo una descrizione degli anni di Amherst in questo articolo (peraltro segnalato da Wikipedia): . Per documentarsi sulle questioni fiscali DFW ha invece seguito corsi di contabilità, stabilendo anche contatti con veri esperti della materia. Cito da qui:
In 1997 [..] Wallace enrolled in accounting classes at Illinois State University and began plowing through shelves of technical literature, transcribing notes on tax scams, criteria for audit and the problem of “agent terrorism” into a series of notebooks.
He also carried on lively correspondence with tax lawyers and C.P.A.’s [..] Their replies, now held in the Wallace archive at the Harry Ransom Center at the University of Texas, evoke some of the big themes of the novel, and suggest that the philosophical Jesuit accounting professor who “converts” a character to a career in “the Service” may not be a wild invention.
Un recensore della LA Review of Books afferma anche, sulla base della propria esperienza all’IRS, che la stessa Iniziativa Spackman è pura finzione (dal retrogusto curiosamente pynchoniano, tra l’altro) e così pure il cambiamento del Social Security Number, che si rivela piuttosto un utile espediente narrativo.
Se il tutto si riducesse all’invenzione di un qualche particolare autobiografico non ci sarebbe granché da dire. Ma la storia mi pare più interessante: dal 1997 DFW si è costruito una competenza specifica e l’ha proiettata all’indietro nel tempo nell’esperienza di un proprio alter ego fittizio (“DFW”), creando la memoria di un “universo fiscale anni ’80” tecnicamente plausibile ma non aderente alla realtà storica. Parliamo cioé della nascita “in vitro” di un interesse per le questioni fiscali le cui radici non affondano nelle vicende personali: la materia della narrazione è stata scelta in base ad un’elaborazione autonoma e poi è stata modellata nel corso della narrazione stessa. Siamo di fronte ad un progetto il cui senso e le cui motivazioni sono da cercare nella storia precedente di DFW in quanto autore, nella sua autobiografia intellettuale. Questa affermazione sarebbe valida anche se ci trovassimo di fronte ad un’opera portata davvero a termine da DFW in persona, con la differenza che in quel caso ci confronteremmo con un oggetto a tutto tondo, finito. Ci muoveremmo sulla terraferma (per quanto accidentata) e non in una palude.
Mi sono chiesto se, come lettore, posso sorvolare su tutto questo in nome della famosa “sospensione dell’incredulità” e lasciarmi prendere dal testo, indifferente alla realtà fattuale. La domanda può anche essere posta in questo modo: in che cosa il me-stesso-lettore che conosce i fatti differisce dal me-stesso-lettore che si beve tutte le affermazioni di “DFW”?
Tempo fa, al cinema, mi vedevo un film di James Bond. Se non ricordo male JB si stava lanciando da un aereo su una pista innevata a bordo di una specie di gommone. A quel punto un tale nella fila dietro se ne uscì con un commento del tipo “Questa è proprio incredibile!”. Fu un errore non sequestrarlo e torturarlo fino a scoprire perché avesse avuto un sussulto di “realismo” proprio di fronte a quella particolare scena di un film così strutturalmente e prevedibilmente basato su eventi iperbolici. La quantità si era trasformata in qualità: qualcosa, per quel tizio, aveva superato di colpo il limite accettabile della famosa “sospensione dell’incredulità”. Nei film di 007 questa sospensione è in realtà il motivo per cui paghiamo il biglietto, quindi sussultare in sala è pateticamente autolesionista. In “Il re pallido” il discorso è un po’ più complicato.
Nel capitolo 9 (“Author Here”) “DFW”, oltre a parlare della propria esperienza all’IRS (non di DFW-in-carne-ed-ossa, ora sappiamo), fa alcune affermazioni relative ad altre parti del testo. In particolare ci esorta a credere che contenga stralci di interviste, annotazioni e citazioni più o meno rimaneggiate, anche per motivi legali. Se cominciamo a “sospendere l’incredulità” nel capitolo 9 dovremo ritenere che i brani di cui “DFW” parla siano in qualche modo “documenti”, dovremo riconsiderare il ruolo dell’autore stesso e ridimensionarne il contributo creativo. Il tutto sforzandoci di ignorare le nostre impressioni più immediate che invece ci sussurrano “Simula!”, come il terribile dottore tedesco che subodora la truffa di Lemmon e Matthau in “Non per soldi ma per denaro”.
Il fatto è che nel cap.9 entra in gioco un dispositivo paradossale: se si crede alla voce narrante sparisce la finzione (e il romanziere), se non ci si crede, rinunciando alla famosa “sospensione”, sparisce anche il lettore, o almeno il fiducioso lettore ideale di romanzi. Ex post, il paradosso è ulteriormente e tetramente complicato per il fatto che la voce narrante parla all’interno di un’inesistente versione definitiva e pubblicata del romanzo e ad essa si riferisce.
Ma oltre a questa impasse logica c’è un motivo più di fondo per interrogarsi sul ruolo di questa parte del testo, ed è appunto la dimensione “progettuale” di cui parlavo prima. E’ in questa dimensione, penso, che va collocata l’opera e anche il modo della sua ricezione. Per quanto lo conosco, DFW non si diletta di giochetti metaletterari a buon mercato: lo afferma (uberparadossalmente) lo stesso “DFW”, che si dichiara pienamente cosciente della natura paradossale delle proprie affermazioni.
Insomma, se DFW mi mette di fronte questo dispositivo narrativo, sospetto che lo faccia con una motivazione strategica rilevante per me-stesso-lettore, non per mandare in estasi l’accademia. Quindi non mi sembra una buona contromossa aggirare il problema per non compromettere un presunto “gusto del racconto”. Forse il me-stesso-lettore che “sospende l’incredulità” si sta allontanando in un universo tanto parallelo quanto insipido: una lettura che dipende in modo cruciale dalla piatta accettazione delle affermazioni di “DFW” cade fuori dal regno delle letture e delle interpretazioni lecite e sensate (per collocarsi non so dove).
Non mi azzardo a proporre un’interpretazione originale. Non ne ho le capacità e, in questo caso più che mai, sarebbe incerta, difficilmente verificabile. Mi limito a segnalare uno spunto di riflessione offerto da Franzen in un testo bello e toccante apparso sul New Yorker, un racconto che si snoda su tre piani: varie riflessioni su “Robinson Crusoe”, la descrizione di un periodo trascorso in solitudine sull’isola in cui visse il “vero” Robinson e (centrale) una meditazione lucida, commossa e anche molto amara sulla morte dell’amico DFW. Franzen cita un paradosso messo in luce da un critico: nel XVIII secolo gli scrittori di narrativa rinunciano a sostenere che non stanno utilizzando materiale di finzione, ma allo stesso tempo si sforzano di rendere questo materiale il più possibile “not fictional”, cioé verosimile. Questo crea sia un genere letterario sia un modello di relazione tra lettore e testo. Forse è proprio di un nuovo “atteggiamento del lettore” che ci parla “DFW”/DFW.


![clip_image007_thumb[4]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2012/02/clip_image007_thumb4-213x300.jpg)

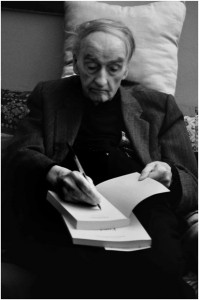 Quella volta che sono andato in gita a casa di Andrea Zanzotto
Quella volta che sono andato in gita a casa di Andrea Zanzotto








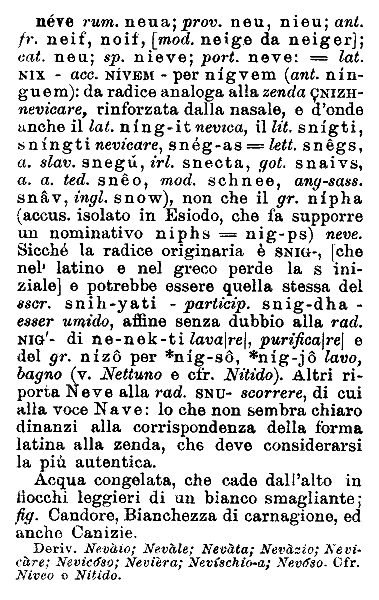
 di Khaled Khalifa
di Khaled Khalifa