
di Alessandro Tesetti
Ti rendi conto che sei fatto in un certo modo per cui io dovrò giudicare fallimento ogni cosa in cui riuscirai? Anche se a trent’anni sarai ordinario di cattedra di Lingua e letteratura inglese? Dovrò considerarti sempre e comunque un fallito, poiché sei fatto a quel certo modo. – Dunque, – aveva risposto Johnny, – dovrei morire molto giovane. –
Beppe Fenoglio
Anni di inadattamento e non-luogo. Mi è stato detto fai questa scuola, è una delle migliori per quello che vuoi fare. Io ho obbedito senza neanche chiedermi cosa volessi fare, cosa intendessero, loro, con per quello che vuoi fare. Tredicenne, balengo vuoto della terza media, cosa voglio fare? Voglio solo dare l’esame (una delle prime nevrosi da competizione), andare al lago vicino casa, compiere gesti estremi, far sì che Giulia si innamori di me, imparare a suonare la chitarra per scriverle canzoni (e non scrivere canzoni da dedicare a lei), restare sott’acqua più di un minuto e mostrare a Giulia quanto sono bravo e quanto sono innamorato di lei. Settembre è lontanissimo, macchia scura dall’altra parte del cielo. Intanto l’iscrizione all’Istituto Tecnico G. è già stata fatta, la firma è dei miei genitori, non la mia. Euforia indistinta: prendere il treno tutte le mattine e raggiungere la città. L’esame lo passo con sette, tanti bagni al lago, tanti tuffi e immersioni da un minuto e mezzo; imparo il giro di Do e scrivo qualche pezzo svenevole; Giulia non si innamora di me.
Mi trovo a un certo momento della giornata, alle 6.57 di tutte le mattine, dal lunedì al sabato, in una stazione di provincia (quando iniziai le superiori era provincia, ora è periferia). Come tutte le stazioni di provincia l’aria che si respira e ciò che si guarda iniettano una strana malinconia. Fare il pendolare a quattordici anni insegna a gestire la dose sporca dei paesaggi, dei residui, della stanchezza carnale. Pendolare è sempre stata una parola che non ho capito. Cerco l’etimologia nella ferraglia del treno, nella puzza dei freni malamente oliati quando agiscono in prossimità della banchina, nelle rughe e nelle occhiaie dei redivivi, e giustamente, nel dizionario. Sono nove anni ormai, ancora non l’ho capita; la voce nel dizionario non è esatta.
Inizio a fare il pendolare a quattordici anni per raggiungere l’Istituto Tecnico G., è bello, è emozionante; prima d’allora raggiungere la città era motivo d’occasioni importanti, o la passeggiata domenicale, o i parenti quando venivano a trovarci: ora diventa quotidianità.
Potevo scegliere una scuola vicino casa, scuola sempre molto accreditata il Liceo scientifico V., dai miei genitori come da tutti i concittadini e da quelli ancora più fuori, oltre le colline. Molti miei compagni delle medie andavano lì, anche Giulia andava lì, le professoresse delle medie consigliavano quella scuola lì. Bastava vestirmi e uscire di casa, camminare dieci minuti e sarei arrivato.
La mia decisione, sempre dove avevo la possibilità d’aprire bocca, sempre dove possedevo lucidità d’aprire bocca, è stata al negativo: basta che non sia il liceo scientifico V. E allora mio padre chiedeva ma è per il liceo scientifico o il liceo scientifico V.? Io non lo sapevo: non sapevo la differenza come non sapevo la categoria. Cos’era il liceo scientifico? Dove s’approfondiva la matematica, la scienza, la fisica; inoltre offriva una buona preparazione per l’università. Ma è tutto così generale, di conseguenza così vuoto. Io non volevo andare al liceo scientifico V., e non volevo andare al liceo scientifico: non volevo studiare generalità e svuotezze.
E mia madre diceva: ma come? Tutti i tuoi amici vanno lì, perché tu no? è vicino casa poi. Lei aveva ragione, e io, non sapendo come giustificarmi, non sapendo cosa rispondere per avere la ragione dalla mia parte dissi: perché voglio fare l’istituto tecnico G., così ho ragione, così la responsabilità me l’assumo io.
Ma si può parlare di responsabilità? Io non sapevo l’esistenza del liceo artistico, del liceo linguistico, del liceo delle scienze umane: erano tutte parole cave poste sul depliant dell’orientamento scolastico, con qualche sbavatura empirica omosociale (al linguistico vanno le ragazze, scienze umane è l’ex Magistrale è quindi per ragazze, l’artistico se non sai disegnare che ci vai a fare). Non ho mai visitato scuole di questi indirizzi, i miei genitori non me ne hanno mai parlato, le professoresse delle medie dicevano di andare al Liceo scientifico V., e quando si accennava al Liceo Classico erano perlopiù blaterazioni sulle lingue morte, la difficoltà, il mondo che cambia, la distanza da casa (raggiungere la città, far scoppiare la bolla provinciale), lo svantaggio universitario in caso di ingegneria per noi maschietti (di nuovo: educazione e formazione omosociale).
Intanto leggevo, ma non sapevo cosa fosse la letteratura. La professoressa D. in tre anni di scuole medie non ci ha dato un romanzo in mano. I miei temi erano buoni. Vicino scuola, accanto a un cassonetto, rincasando, trovai un libro di Kafka, edizione orribile con i caratteri seminvisibili. La professoressa D. non ci dava da leggere niente, io intanto provavo a leggere Kafka, i temi venivano fuori buoni, ma Kafka non lo capivo, neanche oggi lo capisco; ma intanto leggevo e mi innamoravo di altre ragazze che non erano Giulia, e non capivo Kafka, non capivo perché dovessi scegliere un percorso chiuso e immutabile e irreversibile dalla durata di cinque anni. La professoressa D. leggeva i miei temi, diceva che erano buoni, diceva di andare al liceo scientifico V. ed io non sapevo perché.
Avevo ragione: non ho studiato generalità e svuotezze, al contrario, peculiarità e maestranze. Noi che c’arrabattiamo appresso al tubo di Venturi, alle pressioni, al peso specifico dei materiali; bello tutto, ma io intanto leggevo. Interessante la meccanica aeromobile, interessante aerodinamica; ma io intanto leggevo. Leggevo nelle ore di buco, leggevo a ricreazione, ogni tanto leggevo durante le lezioni troppo numeriche e cercavo di non farmi beccare, nascondendo il libro dietro l’astuccio, guardando di continuo la lavagna, prendendo appunti freneticamente. Due volte mi hanno sgamato, e due volte non ho voluto palesare la verità: ho detto che stavo al telefono. Ma perché?, chiedeva il mio compagno di banco Alessio, meglio dire che stai leggendo piuttosto che stai al telefono. Ma io non volevo che si sapesse la verità, almeno in quei momenti lì, durante le lezioni; volevo che si sapesse a ricreazione, negli intervalli, quando il docente entrava e mi trovava leggere, ma non volevo che si sapesse mentre loro spiegavano.
Quindi, peculiarità e maestranze nelle materie scientifiche, generalità e svuotezze in Italiano. Per quattro anni abbiamo avuto la professoressa M., frustrata, aristocratica, depressa: frustrata e depressa perché insegnava in un istituto tecnico, lei che era un’aristocratica, degna del migliore liceo classico della città, invece era lì. Tutti i giorni il suo astio lo defecava su di noi con insufficienze, note, insulti. Passavamo le ore a farci insultare, non spiegava, ci dava da leggere il manuale. La sua, e anche nostra, speranza era che la richiesta di trasferimento venisse accettata, abbiamo aspettato quattro anni, noi ci siamo stancati prima di lei e abbiamo deciso di cacciarla. L’abbiamo registrata e poi siamo andati dalla preside; nell’audio volavano mamme cortigiane, padri gigolò, ignoranti e feccia che eravamo. La preside non poteva sollecitare il trasferimento, non poteva neanche trasferirla lei stessa; le cambiò classe e venne assegnata ai primini. Qualche redarguimento, una tagliuzzata di cresta aristocratica. Nei corridoi non ci salutò più, e noi la guardavamo con aria di vittoria, più che vittoria, di sfida vinta, di t’ho fregato, te l’ho messo nel culo.
In quattro anni, quattro inverni, di Letteratura non ci ha insegnato niente. Io non ricordo una sola nozione: ci dava la storia letteraria da studiare, le interessavano vitamorte&miracoli, date, e altre baggianate. Tipo la stempiatura di Ariosto, Tasso che lanciava le spade, la dieta di Petrarca, il fregno che era Foscolo. Nessuna analisi dei testi, nessun romanzo da leggere. Dalla sua borsetta kitsch fucsia non ho visto uscire un libro, e io mi chiedevo com’era possibile che una persona così insegnasse una materia così (avevo e ho una fede sacrale attorno all’insegnamento della Letteratura, un che di mistico, senza mai apparire misticheggiante; un che di religioso senza essere una religione: ecco cos’è la Letteratura, il cristianesimo senza lacrime, la religione senza peccato).
Io intanto leggevo. Leggevo in treno e nessun pendolare legge mai, in nove anni ancora mi stupisco quando trovo qualcuno a leggere. Al professore di Meccanica piacevo, piacevo perché leggevo. Non andavo bene nella sua materia, una sufficienza scarsa, sempre in bilico; però gli piacevo perché anche lui leggeva. Così mi regalò, a spese sue, Carver, Roth, Rovelli, Del Giudice. Da una parte il minimalismo, dall’altra un’opzione che non avevo mai considerato prima: posso anch’io scrivere di tecnica, di più, posso anch’io scrivere e volare senza mai staccare l’ombra da terra. L’idea era quindi quella, fare il pilota e iniziare a scrivere. Già scrivevo qualcosina: non-racconti, non-poesie, un non-romanzo. Iniziare a scrivere davvero, leggere davvero. Scrivevo e leggevo tanto, ma non davvero. Kafka l’avevo abbandonato, non lo capivo, e in fondo non m’è mai piaciuto. Io, volevo scrivere come Daniele del Giudice. La professoressa M. diceva che i miei temi non erano buoni, come se non l’avessi scritto io, talmente improbabili che non erano buoni. Non un libro da leggere, non un barlume di speranza in noi, eravamo feccia, non degni d’un libro in cui credere.
Importante svolta avvenne al quinto superiore; mandata via la professoressa M., occorreva un nuovo docente di Italiano: venne il prof. P. anti-aristocratico, anti-borghese, anti-tutto. Ci piaceva perché era come noi, uno di borgata o di provincia, cresciuto con le idee rosse e coltivate e ammaestrate con le letture. Aveva una cinquantina d’anni ma sembrava un pischello: veniva in moto, fumava con noi, parlava come noi, mangiava con un coltellino svizzero, era brutto e perciò bello, fumava e leggeva cose dai titoli assurdi (ricordo, e ricorderanno tutti, Puttane assassine). Ci disse che il manuale potevamo anche non comprarlo, che spiegava lui e avremmo preso appunti, che ci dava da leggere delle cose e noi le avremmo lette, poi commentate. Non seguiva il programma e dedicò scarsa attenzione ai grandi del primo novecento per dedicarsi ai minori, a quelli che il canone aveva escluso. D’Annunzio era da leggere insieme a Wilde e Huysmans. Due o tre poesie di Pascoli per passare subito a Corazzini e Gozzano. Baudelaire e i maledetti invece di analizzare Carducci. Poi Morante e Ginzburg e Cialente e De Cespedes per dirci che non solo gli uomini scrivono, che se non ci sono sui manuali non significa che non esistono.
Oltre a farci ragionare sul canone, su “quello che vogliono loro”, l’insegnamento della Letteratura era molto tecnico e religioso. Non c’era la storiografia, c’erano i testi. Non c’erano date e vite, busti e dipinti; c’era l’opera. Il testo era da sbrogliare, c’era l’incipit, l’intreccio, il dialogo che annoda e snoda, il narratore, l’azione. Si leggeva, si sottolineava, si dibatteva sulla verità segreta della scrittura. Religioso ma non cristiano, mai fede indiscussa: sempre compromessa, collaudata.
Mi resi conto che fino ad allora avevo letto canone, e avevo scritto canone, e Del Giudice era canone. Quindi dovevo riiniziare da capo, perlomeno proseguire con l’idea che le mie fondamenta erano canone, dal mio punto vista e dalla mia percezione, contaminanti. Chiesi al prof. P. da dove cominciare perché io ci credevo davvero, io volevo fare lo scrittore, anche se non ero bravo a scrivere e leggevo cose che non capivo, le quali mi sforzavo di capire perché era quello che dovevo leggere, era il canone che mi veniva consegnato. Il prof. P. mi diede da leggere Eluard (scelta che non capisco tutt’oggi); ma neanche Eluard capivo, allora rubai dei versi e scrissi della prosa, ma ancora canone. Forse ero io stolto, io che leggevo e leggevo e non capivo niente. I temi non mi venivano più buoni; ero triste e non sapevo che farmene di me. Mi trovavo in un luogo che non capivo: non capivo le cose che studiavo, non capivo se non ero bravo a studiare o non mi piaceva quello che studiavo. Ero triste e non vedevo la luce fuori dal tunnel, cinque anni di semibuio e disorientamento.
Poi una mattina a Porta Portese, ancora mosso dal canone, confuso da una curiosità oltreoceano, presi Salinger a cinquanta centesimi, poi a casa: io voglio scrivere così.
Senza imparare nulla a memoria, senza un disciplinamento coatto, imparammo molto più in quell’anno che in quelli precedenti. Tanti lessero un libro per la prima volta (a fare da deflorazione per molti fu Due di due di Andrea de Carlo). Nelle ore del prof. P., quando era lui a parlare vigeva un silenzio brutale; quando bisognava parlare, si interveniva, si litigava; stavamo facendo della critica militante, eravamo un’avanguardia senza dichiarare niente a nessuno: io prendevo appunti, poi a casa scrivevo. Provo gelosia se penso che il prof. P. utilizzi lo stesso metodo con altre classi, altri ragazzi. Ma è sbagliato parlare di metodo, il suo non è un fare: è un modo d’essere teso al fare.
E da quei sciatti e abborracciati che eravamo – così si rivolgeva a noi il prof. di Meccanica – stavamo maturando, ed era il tempo della diseducazione: saper prendere una decisione. Il diploma era alle porte, agli altri bussava chiassosamente, a me no. Ero più che convinto nella scelta di Lettere all’università ma ero spaventato in un modo disgustoso. Se non avessi la preparazione adeguata, se non ce la facessi con lo studio, se non fosse più immediato trovarmi un lavoro o iscrivermi ad ingegneria, se fossi mosso solo da velleità artistiche e non pragmatiche.
La verità è che non volevo più fare il pilota, non volevo più studiare materie scientifiche, non volevo più essere allevato per cinque anni dentro un recinto, non avrei mai indossato una divisa come suggerivano i miei genitori, non volevo scrivere di volo e di tecnica: io volevo fare, o meglio, volevo essere, uno scrittore. Anche se non ero bravo né a leggere né a scrivere, e di case editrici non sapevo niente, e non leggevo nuove uscite, entravo poco in libreria e compravo libri usati al mercatino, mi limitavo a sfottere il premio Strega e il premio Campiello, proclamare la morte della letteratura. Ma avevo capito delle cose: leggere bene è importante tanto quanto scrivere bene; avere un canone è una disgrazia; picchiare sui tasti un po’ pensando un po’ non pensando, un po’ sono un po’ non sono, un po’ lucido un po’ sbronzo; leggere sbranando e rubando, scrivere con l’idea di star scrivendo sempre male e sempre peggio; giurare solennemente di non avere buone intenzioni; mai nella vita e dico mai frequentare un corso di scrittura creativa.
Scelsi Lettere perché era inevitabile, perché avevo bisogno di certezze. Devo confrontarmi con qualcuno che già ne sa, io non so niente, leggo, scrivo; dico a mio padre senza guardarlo mai; voglio fare questo ma non so niente. Lui prima incredulo, poi alterato, il discorso termina con un va bene secco, tiepido. Mia madre non dice nulla. Io non sono più quello della terza media, ma loro mi giudicano più infantile adesso che allora.
Nessuno in famiglia legge o si interessa minimamente alla letteratura, solo in base ai miei esami: conta il voto e non l’argomento. La mia scelta è stata vista come uno sbandamento, un desiderio puerile, la solita non-idea attorno alle cose; sto per laurearmi e mio padre ancora mi propone dei concorsi per le forze armate, deve ancora capire perché, dove ha sbagliato con me, digerire il pasto nudo (che poi è il mio, ma lo sente il suo: lo preoccupa cosa farò dopo, non pensa sia possibile trovarmi un lavoro col mio titolo, abituato com’è a pensare che lavoro è solo quando si usano le mani, si fatica, si sputa, si bestemmia, si suda; tutte cose che faccio, scrivendo). E così il luogo astratto e intimo che m’ero creato leggendo, transumando dal recinto, si fa visibile: non più un percorso scelto a caso, distrattamente, per indecisione o inerzia, ma una scelta mia, lucida.
Uscendo quasi col massimo (seconda nevrosi da competizione: non volevo dimostrare niente, sapevo delle tasse, mi sono spolmonato apposta, uno studio insano e disinteressato per studiare senza chiacchiericci di spese ingenti) mio padre pagò quasi zero il primo anno accademico, fu un sollievo per lui, non voleva buttare soldi per un anno che avrei perso, avrei accettato il fallimento e avrei capito che quella roba non era per me. Di quei venti che eravamo in classe, quattro o cinque si dedicano esclusivamente e attivamente all’università, altri per hobby, altri ancora lavorano in nero, il residuo lavora con contratto. Di quei venti che eravamo, soltanto due lavorano in ambito aeronautico, e cioè attinente alla nostra formazione. Tutti gli altri sparsi, sparpagliati. Ma allora perché scegliere così presto? Farsi influenzare, vivere con l’angoscia, pensare di non essere bravi con lo studio e magari aver scelto solo la scuola sbagliata. Ero convinto che G. fosse portato per la filosofia, non si è mai potuto esprimere, perché noi all’istituto tecnico, non studiavamo filosofia; leggeva di nascosto, dopo il diploma non ha avuto il coraggio di iscriversi all’università. Lavora come magazziniere, ogni tanto, mi dice, va a Villa Mirafiori (dipartimento di Filosofia della Sapienza), si mette a leggere lì, immagina come sarebbe stato studiare lì.
Se avessi letto allora Works di Vitaliano Trevisan, forse, oggi, non avrei una laurea in Lettere moderne. Ogni tanto mi stuzzica l’idea di abbandonare il luogo, la bolla che è l’università (stanco delle bolle, cerco di sfuggirle, da quella provinciale a quella accademica; ma forse la vita non è altro che una serie di bolle dove si è prigionieri, c’è chi se ne accorge e chi no), non proseguire con la magistrale, trovarmi un lavoro manuale, poi scrivere, vedere quello che succede. Vivere col conforto della Letteratura, sapere e conoscere il dono del conforto, come atto di fede.
In fondo ho 23 anni, gli unici lavori che ho fatto sono stati il bagnino, il cameriere, il servizio di volantinaggio, il rider per Deliveroo, il fattorino per un ristorante giapponese. Le mie mani non hanno mai visto un callo, il mio corpo è scarno. Continuo a concentrarmi sulla letteratura e sul lavoro culturale, anche se, molto probabilmente, non sono bravo come vorrei.
Entrai a Lettere convinto di trovare gente a me affine. Trovare persone che vestono come vesto io, che pensano come penso io, che leggono spasmodicamente come spasmodicamente leggo io. Non è omologazione, né neutralizzazione; ma dopo anni di solitudine, hai bisogno dell’altro, tuo simile. Anni non qualsiasi, anni di crescita e formazione, dove inizi a farti un’idea del mondo, e il mondo non è solo quello che fino ad allora ho vissuto io: provincia-periferia, pendolarismo da bestie al macello, ragazzi delusi e incazzati che la scuola è solo un contenitore minuscolo per quello che fanno il resto della giornata; la droga come ammazzanoia, roba che si sniffa sottobanco durante lezioni, o si brucia e si tira dietro la palestra a ricreazione; l’omosocialità opprimente, l’omofobia latente; un fascismo di sinistra incomprensibile; il romanesco odierno sub-urbano come schermo, filtro e protezione; la repressione sessuale, le poche ragazze che c’erano venivano pedinate, eroticizzate, verbalmente stuprate (almeno nel gruppetto, mai direttamente, nel ristretto del giro); l’istinto manesco e coltellino se qualcosa girava storto in atrio come in certe notti a San Lorenzo. Poi l’altra metà, l’altra idea: inetti, nerd, futuri scienziati dalle mediocri competenze ma con l’idea certa del nobel, bullizzati, emo riciclati; volti che si notavano solo all’entrata e all’uscita da scuola, stavano sempre in classe e uscivano per andare al bagno durante le lezioni, mai a ricreazione, paura di chi avrebbero potuto incontrare; e con loro non sono mai riuscito a socializzare.
Oltre a non c’entrare niente, io non potevo fare niente, io volevo pure fare qualcosa, ma cosa? La Letteratura ha sempre avuto un ruolo per me quale impegno e consapevolezza e coscienza in più, ma come si traduce, poi? È solo la mia rivoluzione? Da sprovveduto che ero, sciocco e abborracciato del Tecnico, il conforto e le centinaia di vite che ho vissuto grazie ai libri, qualcosa è cambiato. Ma la rivoluzione non può essere solo individuale, non può essere solo mia. Durante le lezioni del professor. P., pensavo che la rivoluzione fosse una cosa più o meno simile: noi, in quell’aula, facevamo la rivoluzione. Poi però, usciti dall’aula, le cose tornavano uguali: per difendersi dagli altri ci mostravamo più forti degli altri: nei gesti, nei movimenti, nelle imprecazioni; la Letteratura, come ogni cosa culturale, non veniva più toccata, parevano svenevolezze da deboli. Ma io sapevo che dentro di loro, il germe c’era, e una volta che c’è, resta. E quando si prova nostalgia per una storia, la si riprende in mano.
Poi di nuovo, la delusione. Ho attorno gente senza carattere, a-patica, a-ideologica, sono qui e sanno di essere qui senza sapere perché sono qui. Andavano bene in Italiano alle superiori, avevano nove o dieci, vengono dal Liceo Classico, la scelta di Lettere è stata consequenziale. Non sono lettori, sono studenti. Non sono studenti, sono “colleghi”. Collega è la parola preferita, più volte pronunciata: dà una certa autorità, non siamo tutti uguali: in collega non c’è l’accezione di star imparando qualcosa, ma di produttività; fa sentire importanti, parte di quell’organismo, sentire quell’organismo come unico valore esistenziale, nobilitante. Al contempo, però, non socializzare l’organismo, non socializzare nell’organismo. Insomma, siamo tutti diversi, ma si sta insieme per fare qualcosa di grande, facendo finta di sostenerci, illudendoci di sostenerci l’un l’altro. Io ce la farò, voi non so, ma non mi interessa; il segreto è che se vuoi, puoi; se vuoi, ottieni.
Nessuno è appassionato davvero, leggono una decina di libri l’anno di cui la maggior parte sono a fini didattici, cioè per la preparazione degli esami. Ricordo una lezione di Critica Letteraria, una delle prime, in cui la professoressa voleva conoscerci e scoprire i nostri interessi, le nostre letture. Era il secondo anno accademico, quando ci chiese il nostro libro preferito, eravamo circa un’ottantina in classe, forse più. Uscirono fuori solo banalità, letture coercitive liceali, letture snob quali L’idiota, titoli demenziali che sfioravano l’ironia, l’unico titolo che più mi garbava era Addio alle armi, più per una certa idea che per la sostanza; il resto muffa marcia. Quando dissi il mio titolo – Detective selvaggi, nessuno lo conosceva, nessuno l’aveva mai sentito, neppure la professoressa. Eppure basta entrare in una libreria per avere minimamente presente un titolo; routine, che a quanto pare, loro non hanno. C’è da notare, poi, che parliamo del catalogo Adelphi e non Pidgin, TerraRossa, o qualche altro editore indipendente. Si conoscono i grandi, gli storici; attraverso le biblioteche. Quando vanno in libreria io lo so, io li vedo, si fiondano sul catalogo Einaudi e fanno commenti lacrimosi, prevedibili. Il libraio suggerisce, e loro con la bocca spalancata, di non star capendo. La stessa espressione quando mi trovo a parlare con loro o con i professori dell’ultima uscita, della genialità che hanno avuto quelli di Tetra edizioni, ad esempio.
Il più delle volte, comunque, i libri non li leggono, magari li stampano in pdf per non comprarli, e poi si accantonano. Si fanno sforzi quando il romanzo non supera le centocinquanta pagine (menomale dai, Una stanza tutta per sé è piccolino, mi sa che lo leggo, massì, vuoi il pdf? Io ce l’ho, così non lo compri. Che poi forse l’ho letto un sacco di tempo fa ma proprio non me lo ricordo.) Ci si accontenta delle spiegazioni del docente, che non hanno mai natura esaustiva e tecnica, ovviamente. E la cosa più indecente è che per anni e anni ti hanno affibbiato Calvino, alla fine ti scocci e lo leggi, o no? Beh, questo può anche non accadere: continui a scansarlo, ma non per leggere altro, non per avere il tempo di leggere il romanzo che vuoi, quello che hai scelto tu: no, semplicemente per… (impossibile teorizzare, impossibile trovare il termine giusto: non è pigrizia, né accidia, né inerzia. Perché uno studente di Lettere non legge romanzi?)
Mai un esame in cui il/la prof. apre il romanzo, mi fa leggere la pagina e poi commentare. Capita con la poesia, ma con la poesia ci pare legittimo; con la prosa no. Se ci fosse questo metodo, faremmo piazza pulita, il numero di promossi all’esame si ridurrebbe a uno sputo.
Scrive Flannery O’Connor Nel territorio del diavolo e c’è questa frase breve che racchiude tutto il mio paragrafo: “Penso sia senz’altro possibile completare una carriera accademica in letteratura (inglese), procurandosi fama di studioso apparentemente rispettabile, senza con ciò sapere leggere la narrativa”.
Ma infatti diventare prof. di Letteratura all’università è la cosa più facile che ci sia, non ci vuole nulla: basta chiudersi in una bella biblioteca tutti i pomeriggi, leggere i saggi assegnati fino allo sfinimento (la curiosità non è consentita, fare più del necessario è una perdita di tempo), imparare a memoria, non sollazzarsi coi romanzi; ecco fatto. Quindi si leggono sempre i soliti quattro tipi (bianchi, maschi, etero), le solite quattro sollecitudini; mai un nome nuovo, mai un titolo nuovo. Le modalità, ripeto, sono di carattere storico, psicologico, autoriale. Conta più l’autore in carne e ossa di quello che ha scritto, compiuto artisticamente in forma immortale; conta il valore differenziale storicizzato ma senza far confronti (mai sentito parlare, per esempio, di accostamenti quali Altri Libertini e Il nome della rosa, usciti entrambi nel 1980; conta solo il ruolo importante che hanno avuto i due libri nella post-produzione scrittoria ed editoriale, ma senza sapere perché). Quindi vengono date le informazioni ma senza andare a fondo: l’insegnamento della Letteratura si limita alla superficie, dell’endogeno non importa un accidente. Quindi basta sapere l’importanza senza sapere l’importante. Basta sapere cosa dice quel libro senza averlo letto.
Tutte queste cose le leggo nei volti, non solo dei colleghi ma anche dei docenti. Segno di amarezza, delusione, mentirsi, ma intanto ce l’ho fatta.
Anomalo è parlare di libri che ci piacciono, anomalo è parlare di letteratura, lì, sulla scalinata di Lettere della Sapienza, tanto famosa, tanto cinematografata. Bisogna riposare il cervello tra una lezione e l’altra, si fuma, si tracanna il caffè, le domande che si rivolgono son sempre più o meno le stesse: quanti esami ti mancano, che hai dato alla sessione, che chiede la prof. V., quando ti laurei. Il resto sono domande retoriche, le risposte già si conoscono, poiché sentite da mille persone uguali e standardizzate che la pensano tutte allo stesso modo: bisogna laurearsi in tempo per non andare fuori corso (e non è una questione di soldi e tasse, ma di principio e orgoglio e solennità), bisogna imparare senza leggere (perché leggere è una perdita gravosa e irrecuperabile di tempo), si trovano escamotage per sbrigarsi (come inserire nel piano di studio esami più semplici, esami tenuti da docenti tranquilli che non bocciano, come se bocciare non fosse l’alternativa, la possibilità, nella sua natura binaria). C’è chi la vive con insana competizione, e chi soccombe. Tutti questi discorsi portano malessere, disamore, ma sia chiaro: non è la sola università come ente ad essere malsana, il problema risiede soprattutto in chi la vive – l’università come ente. Non è solo l’università ad essere meccanismo indifferente, è l’indifferenza di chi muove il meccanismo (e quindi gli studenti e le studentesse) ad essere nocivo.
Che l’università è un luogo e un concetto borghese è risaputo: bisogna dare gli esami solo nelle sessioni dichiarate, quindi due volte e mezzo l’anno (gennaio, giugno; a settembre soli due appelli in uscita dall’estate).
Sono nove esami da dare all’anno per laurearsi in tempo, poi, si paga di più. Come se andare fuoricorso fosse un paghi pegno, un pentimento dal quale devi uscire spurgato.[1]
Resto dell’idea che la valutazione è tossica, finché ci saranno voti ci sarà competizione, finché ci sarà competizione ci sarà l’obliamento di ogni nozione, poiché lo studio è esclusivamente mnemonico, e la memoria cede quand’è superficiale. Basterebbe un idoneo, non idoneo. Ma sono gli stessi studenti a chiedere il 30 e lode, non c’è nulla da fare. Lo rincorrono, lo bramano; piangono se non ricevono la lode (votazione che viene data sempre, meramente, nel piccolo e recintato e sudicio programma del corso; la domanda non si sporge mai, la domanda non osa mai; di conseguenza, neanche la risposta. Non conta il discorso ragionato e critico, ma lo sciorinamento dei saperi mnemonici: gli appunti del professore, le citazioni del manuale).
Mentre, per alcuni, dare il massimo e prendere il massimo, diventa un fatto meccanico, euforico, dispregiativo. Per altri non è così: vedere gli altri che vanno avanti, danno gli esami, prendono il massimo; accentua l’autorità che si dà all’esame e al suo conseguimento, la difficoltà e l’impossibilità ad affrontare il docente che ti giudica, comportano nevrosi, ansia, attacchi di panico, suicidio.
Di università si muore, anzi, l’università uccide: smetti subito.
Il rapporto docente-alunno oscilla dal paternalistico-liceale al gerarchico-verticale: o trovi il professore che ti tratta come un bambino vuoto e ignorante (il che non è male all’esame, sapendo che sei stupido e sei riuscito almeno a imparare quelle due cosucce, fioccano i 30), o quello antico, vecchia solida e sordida scuola, che ti reputa un umano vuoto e ignorante. L’approccio è diverso, non bisogna fare esempi, sappiamo come ci si rivolge ai bambini. A cos’è dovuto? Alla troppa autorità che si dà a chi sta in cattedra; si sostituisce la figura del sapere e della sua trasmissione, con quella d’una guardia infida giudicante. Conta poco o nulla quanto si impari dal corso, conto solo il voto che prendo alla fine del corso. Quindi la poca umanità che si dà al prof., oltre a tagliare ogni rapporto minimamente confidenziale, non permette mai la messa in discussione della sua tesi. Ma non è solo dibattere, è anche aggiungere un’idea, un’opinione, un appunto; invece no, nessuno si azzarda a fiatare, tutti muti. Carente pure l’empatia umana: chi sta in cattedra cerca il dialogo, ma se tutti tacciono non avviene lo scambio intenzionale; e non è rassegnazione culturale, è rassegnazione umana. Quindi un rapporto asimmetrico e verticale creato dagli studenti che non parlano, non agiscono, non reagiscono; e quando parlano (è raro, sono pochi) sono mossi da ideologie che fanno vaneggiare, eppure lo fanno così accanitamente che pensano di aver ragione, che si trovano in un luogo di muffa, che l’università è ormai muffa. Il/la prof. ha ormai imparato ed è diffidente, si considera egli stesso muffa, non al ritmo coi tempi, la generazione che cambia dal linguaggio spezzato, concettual-frammentario incomprensibile.
Quindi un rapporto asimmetrico e verticale creato dagli studenti che non mettono in discussione l’università come ente, come metodo, come disciplina, come configurazione; lo sguardo dev’essere critico e sapiente, filtrato, che sappia muovere, e non balbettante ideologico-mnemonico: sarebbe combattere con le stesse armi nozionistiche, manualistiche. Lo status quo tiranneggia autarchico, le decisioni sono all’interno dell’ente, mai esposte fuori, quindi, mai contrastate (sono gli stessi a parlare, dalle stesse idee che convergono nello stesso sistema. Bisogna che gli interlocutori cambino e siano anche fuori dall’ente e dal sistema. Bisogna soprattutto che parlino con i diretti interessati: studenti e studentesse).
Vanno bene le due sessioni all’anno, vanno bene le tasse, vanno bene le banconote sganciate in più fuoricorso, vanno bene le lezioni frontali senza dialogo, vanno bene le gare come medaglie e le coppe e le lodi e premi di merito, vanno bene le inconsistenze d’un percorso lastricato, non garante, ammazzatoio, suicidario. Vanno bene i morti che sentiamo al tg per non aver passato un esame. Vanno bene i discorsi che fanno, banalizzando la morte, il percorso, gli altri motivi, la carenza, il caso unico, la famiglia alle spalle, il mancato dialogo, e tutte quelle stronzate. Vanno bene i cadaveri spiaccicati sui marciapiedi nei quartieri universitari di fuorisede volati dal settimo piano; mentre i futuri dottorandi con lo spritz in mano e la cicca in bocca che commentano Mi chiedo com’è possibile che non ce l’abbia fatta, che ci vuole, ti impari due stronzate.
Che non conferisce preparazione culturale, la laurea, è un dato di fatto. Tre anni sono solo di lusinghe preparatorie. Per chi cerca lavoro in ambito culturale, e non all’interno dello stesso contenitore – scuole e università – la laurea serve poco. Non dà prestigio in quanto ormai semi-democratica, di conseguenza neanche autorità (di fatto sbagliato), non dà curiosità. Ecco cosa manca più di tutto: curiosità. L’università è una fabbrica, la conoscenza è sul rullo, dobbiamo limitarci a non inceppare il meccanismo. Pezzo per pezzo, cfu su cfu, per anni. Vivere sul rullo, vivere del rullo. La velocità non può che passare per lo studio mnemonico, sono i tempi che lo richiedono, sono le persone che vivono di questi tempi coercitivi, inconsci. Dei suicidi non ci deve importare, sono loro a non avercela fatta, io sì. E se c’è un tempo, un merito, un traguardo, è ovvio che bisogna sbrigarsi, ovvio che la curiosità viene scartata. Bisogna leggere i libri assegnati, bisogna passare più tempo in biblioteca che in libreria, bisogna impiegare il tempo sui saggi e non sulle riviste online. Alienante tutto, allarmante la poca sensibilità che c’è.
Eliminare tutto, buttare tutto giù, riscrivere e rifondare la scuola italiana, l’educazione italiana rimasta alla riforma Gentile. Smetterla con questi incanalamenti preadolescenziali, aprirci all’imprevedibilità d’una formazione: singola e non massiccia, elaborata per ciascuno e non greggistica-omosociale. Mossa dalla curiosità dell’apprendimento, e non dalla velocità, dalla competizione e dalla nozione.
Al momento vivacchio, accontento loro: prendo il titolo ma lo reputo vuoto, dall’inchiostro slavato. Leggo tutto quello che trovo, scrivo quando posso. Parlo ai miei colleghi delle riviste online dove scrivo, della mia ricerca continua di nuovi titoli sfornati da piccoli editori. Loro mi ascoltano, si mostrano interessati e poi mi dicono che non conoscono niente di quello che ho citato e che devono rientrare in biblioteca a finire il saggio di Asor Rosa per l’esame della prof. Z.
Giorni dopo chiedo se hanno comprato quel libro di Wojtek edizioni , se hanno fatto un giro su Nazione Indiana o Super Tramps Club, se scrivono racconti, se vogliono pubblicarli. Loro mi guardano alienati, spenti, lontani; poi mi dicono non ancora, non ho avuto tempo, sono giorni così, magari domani, e tornano dentro.
Stanco del pendolarismo ho scelto un’altra città, al nord. Tra qualche mese vado, senza sapere se continuare gli studi o trovare qualcosa che mi permetta la spesa fissa di affitto e libri. Avverto la transizione, ancora una volta, unicamente mia. Percepisco la bolla, ancora una volta, asfissiante. Non ho mai scelto così lucidamente.
[1] Liberi da qualunque idea o ideologia, dati alla mano, proseguiamo oggettivamente: per laurearsi in triennale occorrono 180 CFU, considerando gli esami da 12 CFU come due esami da 6 CFU, togliendo abilità informatiche 2 cfu, altre conoscenze utili 4 cfu, lingua straniera 4 cfu, tesi 8 cfu, rimangono 162 cfu. Toglierli non significa non prepararli e non studiarli anzi, abilità informatiche è un corso da seguire con conseguimento di prova finale, spesso progettazione di un sito web, altre conoscenze utili è a discrezione dello studente: chi segue 8 seminari con relazione da 40.000 battute, chi segue un corso con esame finale, chi si rivolge ad aziende esterne per svolgere, di fatto, uno stage, solitamente non retribuito e indifferente agli orari delle lezioni in corso; lingua straniera, ripassare la grammatica di livello B2. Tesi: bibliografia da studiare, più scrivere almeno 80 pagine. Quindi, i cfu tolti sono solo per essere precisi, 162 abbiamo detto; 162÷3=54, ovvero il numero di cfu da raggiungere in un anno. Ora, sempre perché la matematica non è un opinione, arrivare a 54 cfu in un anno significa dare 9 esami. Quindi cinque alla sessione invernale e quattro a quella estiva, o viceversa; o giocarsela con la sessione di settembre. Potremmo anche riflettere perché l’università Sapienza apra solo tre sessioni all’anno, magari ci penseremo altrove. Caso strettamente individuato nel corso di Laurea in Lettere moderne, presso l’università Sapienza di Roma. Già a Bologna è diverso
Foto di Nino Souza Nino da Pixabay
 L’11 settembre più drammatico per un’intera generazione, che sognava un mondo libero e giusto, è stato nel 1973, l’anno del colpo di stato in Cile. Non quello del crollo delle Torri Gemelle nel 2001. Quanti “11 settembre” ha conosciuto l’Italia dalla bomba di Piazza Fontana nel 1969 a Milano all’esplosione nella stazione di Bologna il 2 agosto del 1980? Basta soffermarsi a pensarci un istante per cogliere l’anomalia storica del nostro paese. Paolo Morando con la sua ricostruzione della Strage di Bologna – Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito (Feltrinelli, 2023) va oltre e più a fondo. Ormai si fa fatica a ricordare, ci sollecita, che prima del 1980 le bombe esplodevano ancora numerose, anche se non facevano morti, “in giornate punteggiate dalle azioni che il terrorismo di sinistra dispiegava in tutto Italia”. Non tutti, tuttavia, furono assopiti dalle prime onde di riflusso. Un magistrato, Mario Amato, cui il libro è dedicato, si rese conto che la “guerra” non era ancora terminata. Senza di lui (ucciso dai Nar il 23 giugno 1980), oggi non conosceremmo mandanti ed esecutori dell’attentato terroristico più grave nella storia italiana.
L’11 settembre più drammatico per un’intera generazione, che sognava un mondo libero e giusto, è stato nel 1973, l’anno del colpo di stato in Cile. Non quello del crollo delle Torri Gemelle nel 2001. Quanti “11 settembre” ha conosciuto l’Italia dalla bomba di Piazza Fontana nel 1969 a Milano all’esplosione nella stazione di Bologna il 2 agosto del 1980? Basta soffermarsi a pensarci un istante per cogliere l’anomalia storica del nostro paese. Paolo Morando con la sua ricostruzione della Strage di Bologna – Bellini, i Nar, i mandanti e un perdono tradito (Feltrinelli, 2023) va oltre e più a fondo. Ormai si fa fatica a ricordare, ci sollecita, che prima del 1980 le bombe esplodevano ancora numerose, anche se non facevano morti, “in giornate punteggiate dalle azioni che il terrorismo di sinistra dispiegava in tutto Italia”. Non tutti, tuttavia, furono assopiti dalle prime onde di riflusso. Un magistrato, Mario Amato, cui il libro è dedicato, si rese conto che la “guerra” non era ancora terminata. Senza di lui (ucciso dai Nar il 23 giugno 1980), oggi non conosceremmo mandanti ed esecutori dell’attentato terroristico più grave nella storia italiana.





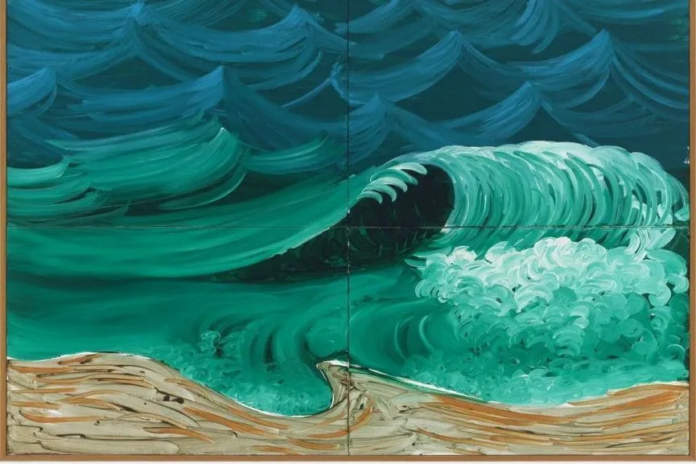


















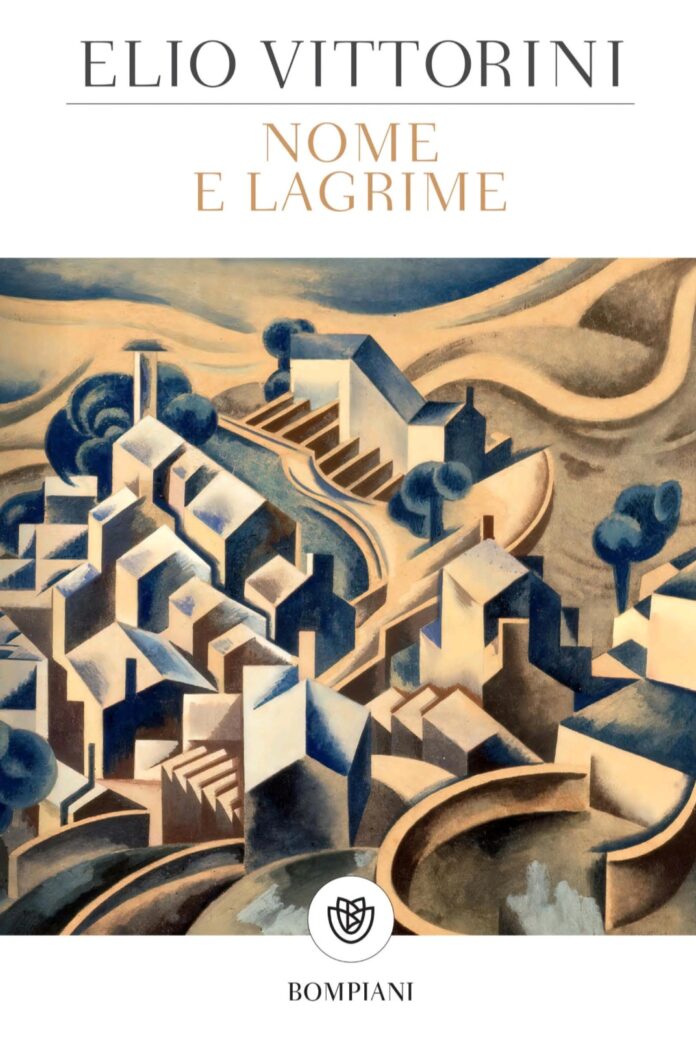




 Abituato da tempo alle terre alpine con i loro odori di resine e muschi di punto in bianco mi sono ritrovato a avere a che fare con i suoli di una valle con schiere disciplinate di meleti che occupavano ogni tassello delle ondulazioni, anche i fazzoletti più erti, a perdita d’occhio. Era evidente che i coltivatori non sopportavano la minima asperità o avvallamento: prima di irregimentare le file di piantine nanizzate piallavano i versanti con grandi macchine, rendendoli perfettamente piatti. Li volevano certo al passo con i tempi, in coerenza con i geometrici capannoni di cemento armato per la cernita e la conservazione dei frutti, e con i futuribili centri commerciali dei paesi più floridi.
Abituato da tempo alle terre alpine con i loro odori di resine e muschi di punto in bianco mi sono ritrovato a avere a che fare con i suoli di una valle con schiere disciplinate di meleti che occupavano ogni tassello delle ondulazioni, anche i fazzoletti più erti, a perdita d’occhio. Era evidente che i coltivatori non sopportavano la minima asperità o avvallamento: prima di irregimentare le file di piantine nanizzate piallavano i versanti con grandi macchine, rendendoli perfettamente piatti. Li volevano certo al passo con i tempi, in coerenza con i geometrici capannoni di cemento armato per la cernita e la conservazione dei frutti, e con i futuribili centri commerciali dei paesi più floridi.

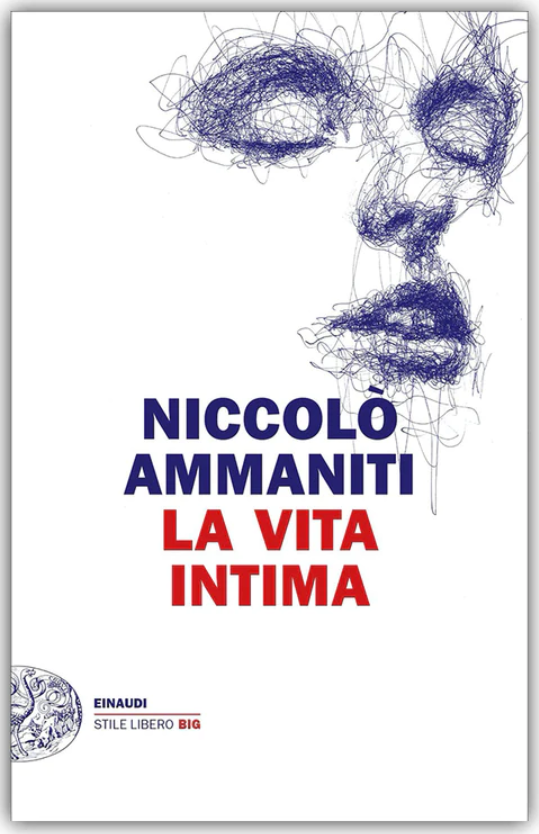
 L’inizio dell’ultimo, atteso romanzo di Niccolò Ammaniti, è faticoso. Non per la scrittura, di cui l’autore è un grande professionista e un esperto timoniere, ma per la domanda che sorge già dalle prime pagine: Perché? Un’altra, ennesima storia ambientata nel mondo dell’alta borghesia, coi suoi abissi infestati da topi e scorpioni, dove veli polverosi nascondono alla meno peggio miseria e solitudine, noia e incomunicabilità? Scriveva Silvia Plath nel romanzo La campana di vetro (1963): “Queste ragazze avevano tutte l’aria annoiata. Le vedevo nei solarium, che sbadigliavano e si laccavano le unghie mentre prendevano il sole per mantenere la tintarella delle Bermuda, e mi sembravano annoiate a morte. Scambiai due chiacchiere con una di loro: era stufa di yacht, stufa di girare il mondo in aeroplano, stufa di andare a sciare in Svizzera per Natale, stufa degli uomini del Brasile.” Sono passati sessant’anni e stiamo ancora celebrando il vuoto emozionale e la tristezza dei ricchi privilegiati? Siam sempre qui, con l’aria annoiata e anche un po’ arrabbiata?
L’inizio dell’ultimo, atteso romanzo di Niccolò Ammaniti, è faticoso. Non per la scrittura, di cui l’autore è un grande professionista e un esperto timoniere, ma per la domanda che sorge già dalle prime pagine: Perché? Un’altra, ennesima storia ambientata nel mondo dell’alta borghesia, coi suoi abissi infestati da topi e scorpioni, dove veli polverosi nascondono alla meno peggio miseria e solitudine, noia e incomunicabilità? Scriveva Silvia Plath nel romanzo La campana di vetro (1963): “Queste ragazze avevano tutte l’aria annoiata. Le vedevo nei solarium, che sbadigliavano e si laccavano le unghie mentre prendevano il sole per mantenere la tintarella delle Bermuda, e mi sembravano annoiate a morte. Scambiai due chiacchiere con una di loro: era stufa di yacht, stufa di girare il mondo in aeroplano, stufa di andare a sciare in Svizzera per Natale, stufa degli uomini del Brasile.” Sono passati sessant’anni e stiamo ancora celebrando il vuoto emozionale e la tristezza dei ricchi privilegiati? Siam sempre qui, con l’aria annoiata e anche un po’ arrabbiata?
 di
di 











