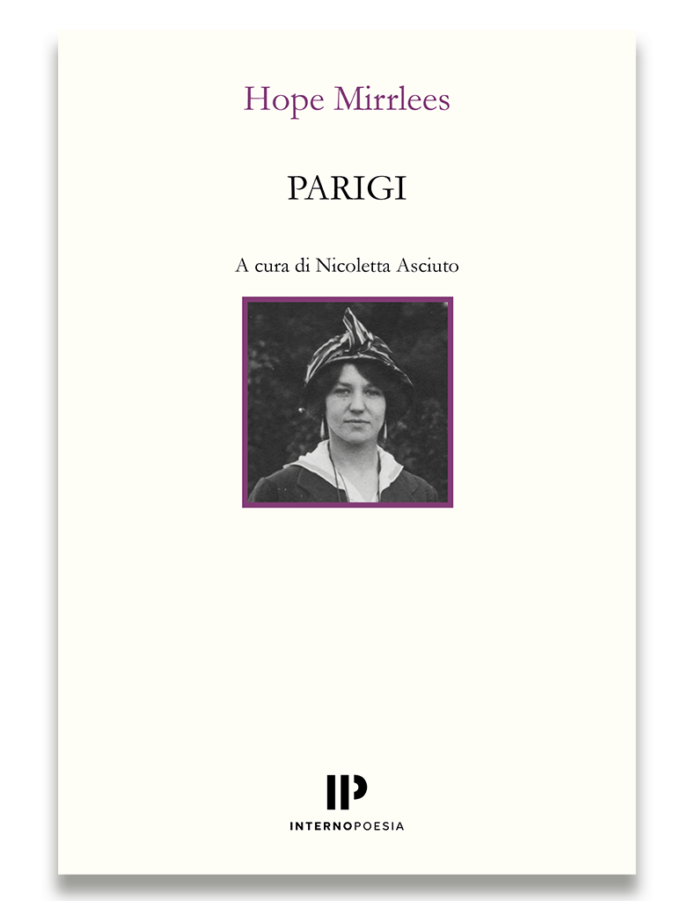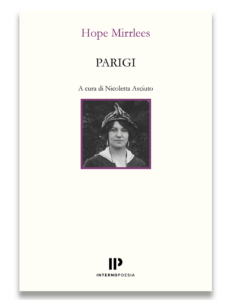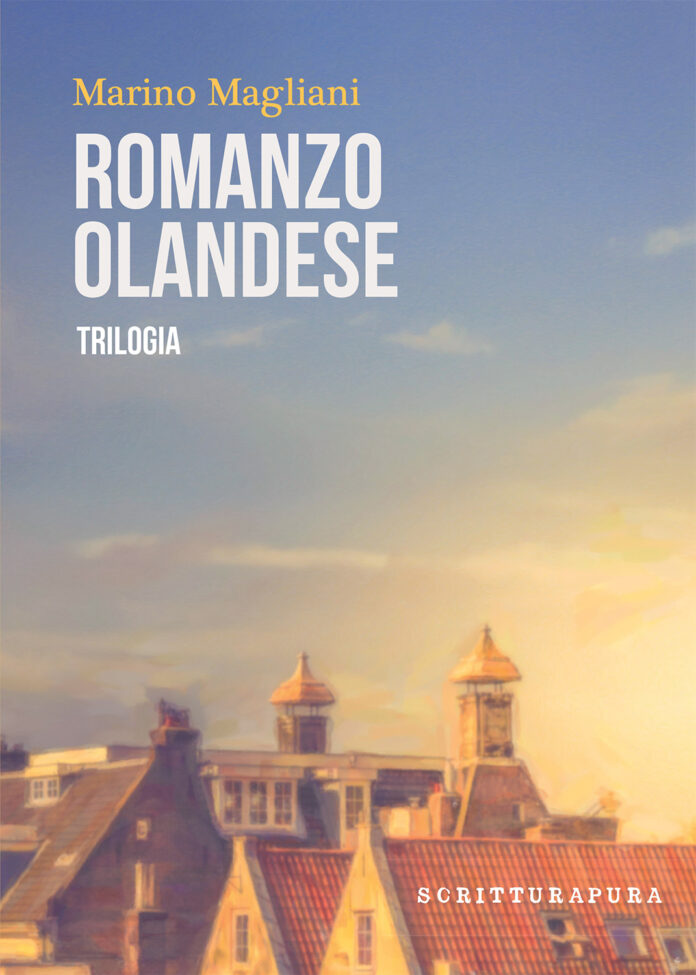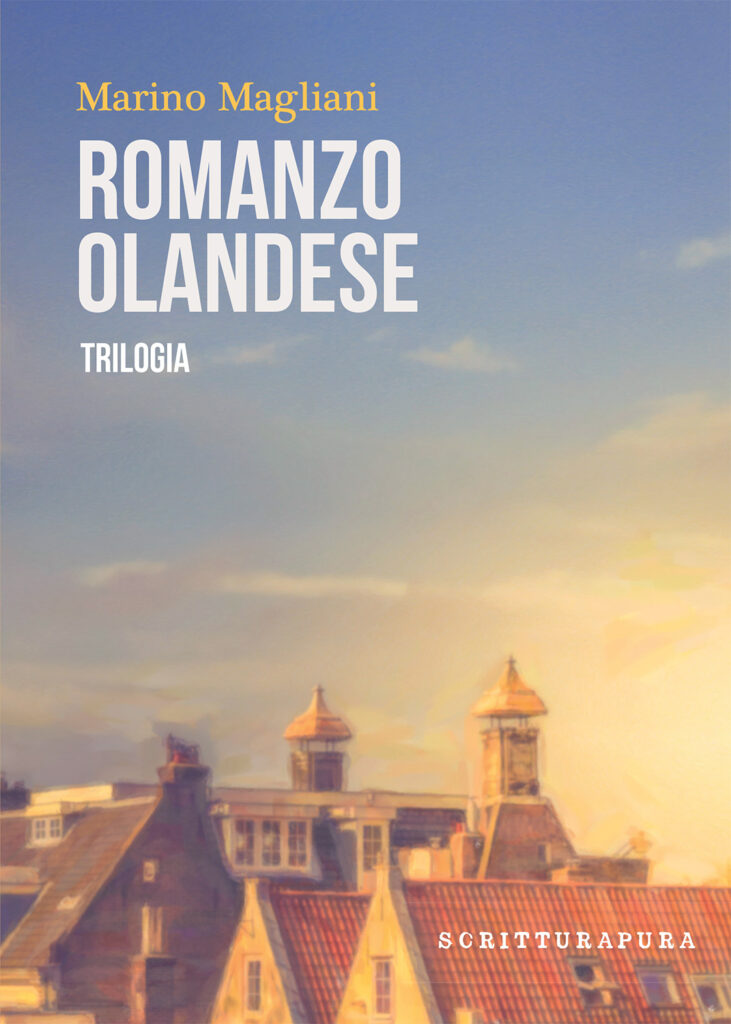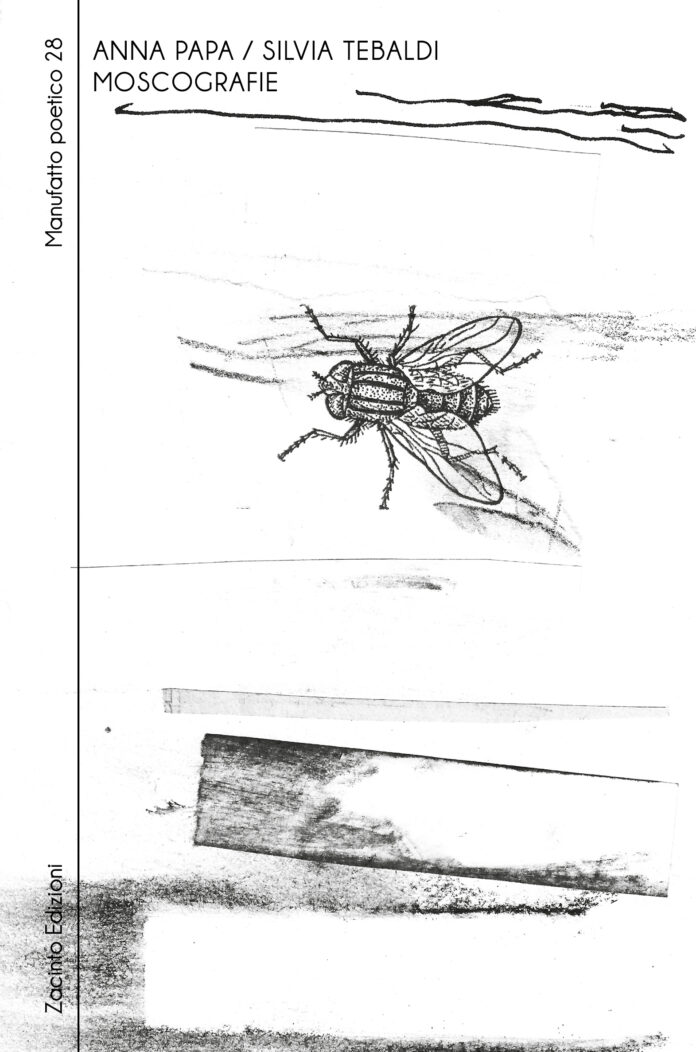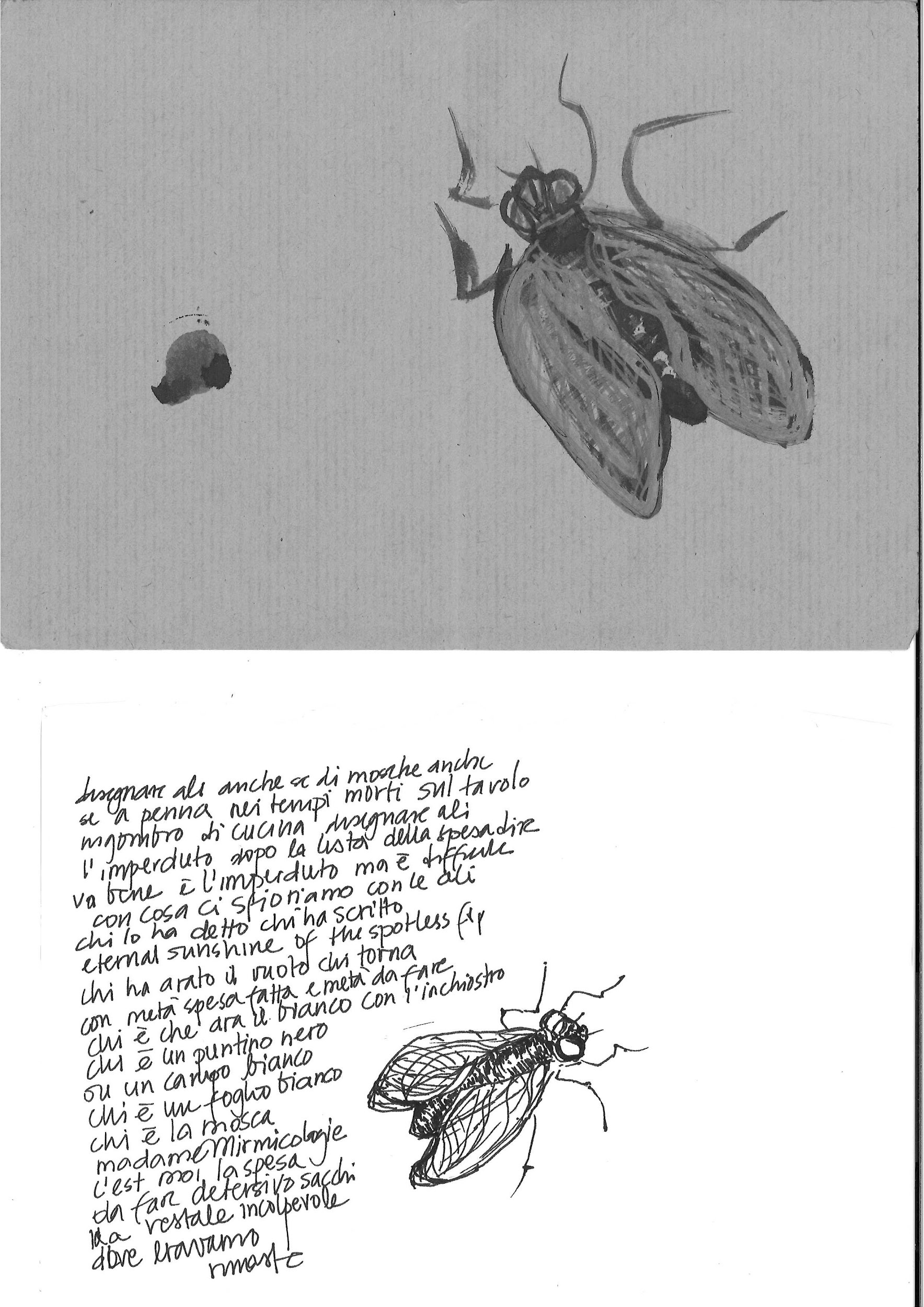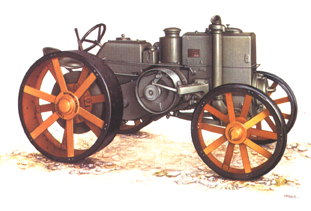di Marzia Casolari
A un mese dalla crisi Indo-Pakistana di Pahalgam, la situazione internazionale si è ulteriormente aggravata con l’attacco israeliano all’Iran, alla vigilia del terzo round di negoziati tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, per la formalizzazione di un accordo sul nucleare iraniano, dopo l’abbandono unilaterale di analoghe trattative da parte americana nel 2018. A seguito dell’attacco ingiustificato da parte israeliana, questa volta è stato l’Iran a dichiarare la fine dei negoziati. L’irrisolto conflitto tra India e Pakistan resta sempre latente, nonostante la sottoscrizione di successive tregue a accordi, tra ricorrenti crisi ed escalation. Per questo è un conflitto che non andrebbe dimenticato e che dovrebbe impegnare la comunità internazionale in uno sforzo di mediazione affinché i due contendenti trovino una soluzione definitiva e condivisa, che non sia imposta con la forza dall’uno o dall’altro. Oggi, il conflitto indo-pakistano assume una centralità ancora maggiore in quanto, con lo scontro tra Iran e Israele, che si è apparentemente risolto in dodici giorni ma rischia di tornare a deflagrare, l’arco di crisi si allarga su un’area molto vasta, che va dal Mediterraneo orientale (Gaza e Cisgiordania) all’Asia meridionale, con un’estensione alla guerra russo-ucraina. Il mondo può permettere ancora a lungo che si moltiplichino aree di guerra così distruttive, tra potenze nucleari, con tutti i rischi e le conseguenze che queste comportano?
A oltre un mese dalla crisi di Pahalgam, in una situazione internazionale ulteriormente aggravata, il conflitto permanente tra India e Pakistan, a seguito dello sforzo diplomatico di numerosi mediatori, ha trovato solo una soluzione temporanea, che ha tutte le premesse per tornare a esplodere.
I fatti di Pahalgam
Il 22 aprile 2025 cinque miliziani appartenenti a un gruppo armato del radicalismo islamico kashmiro hanno assalito a colpi di arma da fuoco una comitiva di cittadini indiani in visita alla località di Pahalgam, in Kashmir, provocando almeno 26 morti e 17 feriti.[1] L’attentato è stato rivendicato da The Resistance Front (TRF), una nuova formazione, probabilmente affiliata al Lashkar-e-Taiba (LeT, ‘esercito del bene’, ‘dei puri’ o ‘dei giusti’), storico gruppo militante, fondato all’inizio degli anni ’90 nel Kashmir indiano e attualmente stanziato in Pakistan. Il TRF è una formazione poco conosciuta, fondata nell’ottobre 2019, come reazione all’eliminazione dell’articolo 370 della Costituzione indiana, che garantiva ampie autonomie al Kashmir.[2]
Il paese di Pahalgam è il punto di partenza del pellegrinaggio verso il santuario di Amarnath, una delle mete religiose più importanti ed emblematiche dell’induismo. L’attentato del 22 aprile era quindi evidentemente motivato dalla volontà di colpire dei fedeli indù, che si trattasse di semplici turisti o pellegrini. Questo è dimostrato dal fatto che i miliziani hanno chiesto alle vittime di recitare la shahada, ovvero la formula che ogni musulmano pronuncia come atto di fede in un unico Dio e di riconoscimento di Muhammad come suo profeta. I combattenti hanno ucciso deliberatamente gli uomini non musulmani, risparmiando le donne.
La reazione immediata del governo indiano è stata di condanna al Pakistan, additato come mandante dell’attentato, prassi ormai consueta anche per i precedenti governi, in simili circostanze. Anche se, come di consueto in altre occasioni analoghe, il Pakistan ha negato ogni responsabilità, Delhi ha minacciato una risposta severa, arrivata nella notte tra il 6 e il 7 maggio, quando l’India ha lanciato l’operazione “Sindoor”: l’uso del termine riveste un preciso significato simbolico, dal momento che questa parola definisce il colore rosso della spartitura dei capelli o del segno sulla fronte delle donne indù sposate. L’operazione Sindoor aveva quindi l’obiettivo di vendicare le vedove delle vittime dell’attentato. La rappresaglia dell’India è consistita nel lancio di missili contro obiettivi in Pakistan, considerati siti terroristici. Secondo il Pakistan, invece, sarebbero stare colpite quattro moschee e una clinica, oltre a edifici civili. Immediatamente dopo l’attacco di Pahalgam, Delhi ha poi sospeso il trattato per le acque dell’Indo, che dal 1960 consente al Pakistan di utilizzare l’approvvigionamento idrico di parte del fiume principale e di due dei suoi affluenti occidentali, il Jhelam e il Chenab. Il trattato vieta all’India di costruire lungo il corso di questi fiumi infrastrutture che impediscano il flusso delle acque verso il Pakistan. La condizione posta da Delhi per il ripristino del trattato è stata che il Pakistan condannasse pubblicamente gli atti di terrorismo, cosa che il Pakistan ha effettivamente fatto. Da parte sua, Islamabad ha però definito il gesto di Delhi come un atto di guerra e ha minacciato di uscire dall’Accordo di Shimla del 1972, che rappresenta il fondamento delle relazioni bilaterali dei due paesi, dal momento che li obbliga al riconoscimento delle rispettive integrità territoriali e sovranità e all’impegno di risolvere politicamente le dispute bilaterali, compresa quella che riguarda il Kashmir.
Dopo la reazione indiana, l’escalation è stata fulminea: il Pakistan ha immediatamente risposto con un attacco missilistico a obiettivi indiani, a cui sono seguiti combattimenti aerei, scambi di fuoco e raid da ambedue le parti con missili e droni. Nella serata del 9 maggio sono state avvertite forti esplosioni all’aeroporto di Jammu, nel Kashmir indiano, dovute probabilmente all’abbattimento di droni pakistani. L’esercito di Islamabad ha colpito obiettivi non solo in Kashmir, ma anche in Rajasthan e in Punjab, persino ad Amritsar, ovvero in aree diverse da quelle contese. L’India ha effettuato attacchi a Lahore, Islamabad e altre città pakistane. La gravità dello scontro, il più serio dalla terza guerra indo-pakistana del 1971, ha suscitato preoccupazione in tutto il mondo e il timore che si aprisse un altro fronte di guerra, per giunta tra due potenze nucleari oltre a quello ucraino e a Gaza, inducendo numerosi paesi, persino l’Iran, a tentare una mediazione. Dopo avere affermato che l’attacco indiano era una “vergogna”, il presidente Trump si è speso in prima persona per evitare il conflitto e il 10 maggio le ostilità sono cessate.
Caccia cinesi, droni turchi: una sconfitta militare e politica per l’India
La crisi di Pahalgam è stata caratterizzata per l’intensità della risposta indiana all’attacco del 22 aprile: se si pensa a una circostanza molto più grave, come gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008, in cui furono colpiti diversi obiettivi in città, e in particolare il centralissimo Hotel Taj Mahal, allora la reazione da parte dell’India, che comunque non mancò di additare il Pakistan come responsabile degli attacchi, fu politica e molto più moderata di quella attuale. Nei giorni che hanno preceduto la rappresaglia del 7 maggio, il governo e la stampa indiani hanno assunto toni incendiari nei confronti del Pakistan, ripresi dall’opinione pubblica, come si è potuto evincere dai messaggi circolati sui social: l’idea era quella di ridimensionare una volta per tutte il Pakistan, evocando scenari da ‘soluzione finale’. Insolito, e ancora più preoccupante, il fatto che la posizione ufficiale del governo indiano rispetto all’attacco di Pahalgam è stata condivisa da tutto l’arco parlamentare, compresa tutta l’opposizione, incluso il Communist Party of India-Marxist, il PCI(M), che prende spesso posizioni diverse da quelle degli altri partiti in politica estera. Segno del fatto che un decennio di indottrinamento delle masse, autoritarismo e repressione violenta del dissenso hanno raggiunto l’obiettivo di inibire il senso critico delle persone. L’opposizione frontale adottata dall’India verso il Pakistan, inoltre, riflette una logica particolarmente pericolosa, considerando il fatto che entrambe le nazioni possiedono armamenti atomici. È però una visione del tutto coerente con l’atteggiamento assunto dall’India di Narendra Modi, che ambisce a imporsi come potenza egemone in Asia meridionale. La risposta ‘muscolare’ che Delhi ha deciso di adottare nei confronti del Pakistan contraddice i principi basilari del diritto internazionale, secondo i quali il ricorso alle armi dovrebbe essere l’ultima ratio, da adottare solo nel caso in cui tutte le vie politiche e diplomatiche abbiano fallito.
Dall’atteggiamento assertivo dell’India ci si sarebbe aspettati una preparazione militare impeccabile, invece l’impresa messa in atto da Delhi si è rivelata improvvisata, risultata in un bilancio di cinque velivoli, tra cui dei Rafale di fabbricazione francese in dotazione all’aeronautica militare indiana, abbattuti da caccia J-10 in uso all’aviazione pakistana, di fabbricazione cinese.[3] Quando ha cominciato a circolare sui social e sui media internazionali la notizia dell’abbattimento dei cinque jet indiani vi è stato da parte di Delhi un imbarazzato silenzio: se da un lato è normale, in simili circostanze, il riserbo sulle perdite subite e se questa è una consuetudine particolarmente in uso in India, nel caso specifico il silenzio sul bilancio dell’attacco al Pakistan è stato particolarmente eloquente. Il 9 maggio la notizia era di dominio pubblico e, al di là del numero esatto di aerei abbattuti, confermato solo diversi giorni dopo, sono stati diffusi, inizialmente soprattutto dai canali non ufficiali, i video che mostravano i caccia pakistani che inseguivano e colpivano gli aerei indiani, rendendo la notizia inconfutabile. Inoltre, i velivoli pakistani erano armati da missili a breve gittata dotati di un raggio di azione più ampio e di maggiore precisione rispetto a quelli indiani, sebbene gli armamenti cinesi in dotazione all’esercito pakistano non siano neppure quelli di più recente produzione. I fatti hanno smontato la retorica bellicista di Modi, del suo governo e della stampa indiana.
Il primo e più evidente dato emerso dall’ ‘affare Sindoor’ è che il Pakistan è riuscito a ribaltare la sua storica disparità militare verso l’India. Non avere colto il salto di qualità nella capacità militare pakistana può avere contribuito a spingere Delhi a una reazione impulsiva e mal calcolata. La conclusione paradossale (e temporanea) della crisi indo-pakistana dell’aprile-maggio 2025, che in realtà è tutt’altro che conclusa, è che la Cina ha incassato un successo di immagine, pieno di implicazioni di altra natura, in primis economiche e geopolitiche. La Cina ha mostrato una capacità tecnica militare che la mette ormai alla pari delle altre grandi potenze mondiali. Un altro effetto, non previsto e senz’altro indesiderato da parte dell’India, è stato rappresentato dal fatto che l’escalation che essa stessa ha provocato si è trasformata in una vetrina dove sfoggiare armamenti che oltretutto si pongono in concorrenza con quelli di produzione euro-americana e israeliana. Il Pakistan, che fino a pochi anni fa si riforniva di armi principalmente se non esclusivamente dagli Stati Uniti, oggi è in grado di condurre una guerra con armamenti cinesi. Allo stesso modo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, che proprio nei giorni della crisi indo-pakistana stava effettuando un’esercitazione congiunta con la Cina, si stanno accingendo ad acquistare armamenti cinesi.
Meno chiara la questione dei droni. È oramai accertato, anche per loro stessa ammissione, che entrambi, India e Pakistan, li abbiano utilizzati, e per la prima volta l’uno contro l’altro. L’India ha affermato che nella notte dell’8 maggio il Pakistan avrebbe lanciato verso l’India uno sciame di 300-400 droni e di averli abbattuti tutti, mentre il Pakistan ha affermato di avere intercettato 77 droni indiani. Quelli utilizzati dall’India sono di fabbricazione israeliana, mentre il Pakistan dispone di droni di produzione propria, cinese e turca: [4] l’efficacia dei droni turchi, altamente apprezzata nel loro primo utilizzo in combattimento nella guerra in Ucraina nel 2022, di recente è stata ridimensionata. Canali indiani e americani hanno sottolineato le carenze e la sostanziale inefficacia dei droni turchi, che probabilmente costituiscono una potenziale minaccia per la produzione americana, mentre per l’India, sminuire l’equipaggiamento tecnico del nemico fa parte di una guerra che si sta combattendo più a livello mediatico che sul campo.
Il Kashmir, la politica indiana e lo stato dei rapporti indo-pakistani
Sembra che pochi siano in grado di comprendere che, come scrive Rula Jebreal nel suo libro fresco di stampa, Genocidio, “La guerra produce vendetta: la giustizia evita la vendetta”.[5] Bisognerebbe aggiungere che i diritti e il loro riconoscimento evitano la vendetta. Che l’India tratti il Kashmir e i rapporti con il Pakistan con un metodo che si può definire ‘israeliano’,[6] ovvero con la repressione violenta all’interno dello stato himalayano e accuse, pretesti e aggressività verso la nazione confinante, arrivando ad auspicarne l’annientamento, non è la soluzione. La radicalizzazione della situazione in Kashmir viene da decenni di occupazione militare e violenza perpetrati sotto i precedenti governi nei confronti della popolazione musulmana della vallata. Il quadro è stato aggravato dalla politica adottata dal governo Modi, culminata nell’eliminazione, nel 2019, dell’articolo 370 della Costituzione indiana, che prevedeva la sostanziale autonomia del Kashmir e un sistema legislativo a sé stante. Dal 2019 sono state eliminate le protezioni che impedivano a indiani provenienti da altre zone del paese di avere proprietà o effettuare investimenti nella vallata, mentre sono state introdotte misure per garantire ai non kashmiri l’ottenimento della residenza e la possibilità di gestire attività economiche nello stato. Se si pensa che il Kashmir è una delle mete più attrattive al mondo, si può facilmente immaginare come i lucrosi affari derivanti dallo sfruttamento turistico passino ora dalle mani dei kashmiri a investitori indiani e non solo. Bisogna aggiungere che dal 2019, per anni, non è stata istituita un’assemblea legislativa in Kashmir, che di conseguenza è stato gestito direttamente da Delhi fino al 30 settembre 2024, quando sono state reintrodotte le elezioni locali, su imposizione della corte suprema indiana. Il governo di Delhi però ha introdotto dei dispositivi elettorali volti a garantire un numero più alto di seggi alla minoranza indù del Jammu, rispetto alla maggioranza musulmana del Kashmir. Nel 2019 il territorio è stato diviso in tre aree: Jammu, Kashmir e Ladakh, applicando un modello che riporta a quello coloniale della partition, secondo il principio del divide et impera. La tripartizione dello stato ha un impatto negativo sugli equilibri socio-economici preesistenti. A tutto questo si aggiungono le restrizioni, molte delle quali inasprite e giustificate da un’emergenza pandemica durata ben oltre il limite, l’imposizione del coprifuoco dall’estate 2019 fino al 2023, la repressione delle libertà civili, di opinione e di stampa, l’arresto di attivisti e giornalisti, la criminalizzazione della popolazione musulmana, che va di pari passo con la repressione dei musulmani dell’India, in una situazione che molti analisti ed esperti paragonano a quella della Palestina.[7] Il 5 giugno 2025 Narendra Modi ha celebrato l’avvio di un progetto per la costruzione di una linea ferroviaria in Kashmir, che ha lo scopo di garantire la connettività con lo stato himalayano nell’arco di tutto l’anno, con ogni condizione atmosferica. Lo scopo ufficiale della ferrovia è promuovere il turismo spirituale, facilitando l’accesso agli importanti santuari indù del Kashmir e offrire opportunità di sviluppo economico alla popolazione locale. In realtà però la nuova infrastruttura viene vista comprensibilmente come una minaccia alla specificità culturale del Kashmir e come uno strumento per rafforzare il controllo militare della vallata.[8] È abbastanza ovvio che in simili condizioni si sviluppi il radicalismo politico e c’è da sorprendersi che non dilaghi tra la popolazione musulmana di tutta l’India, vittima di analoghe repressioni. In particolare, la possibilità per i non kashmiri, indiani e stranieri, di investire e intraprendere attività economiche nello stato provoca non solo allarme e tensione, ma un danno materiale e tangibile soprattutto alle giovani generazioni: un segnale preoccupante è rappresentato dal tasso di disoccupazione giovanile, lievitato dal 2019 fino a raggiungere punte del 17.4 % nella fascia d’età 15-19, rispetto al 10.2 del dato nazionale e al 6.1% del totale della popolazione indiana.[9] A peggiorare la situazione, le misure introdotte dal governo indiano prevedono anche l’accesso alle quote riservate alle professioni nel settore pubblico ai non locali.[10]
The Resistance Front rappresenta anche il disagio delle componenti giovanili del Kashmir, che non vedono sbocchi per il futuro. Questa formazione, che non usa i simboli e il linguaggio del radicalismo islamico, ha fra i propri punti fondanti la critica all’eliminazione dell’articolo 370 della Costituzione per le sue ricadute economiche e occupazionali.[11] Certamente il Pakistan ha sostenuto e continua a sostenere le formazioni del radicalismo kashmiro, ma non si hanno certezze sulle connessioni con il TRF. Quindi non si può affermare senza ombra di dubbio, come ha fatto l’India, che l’attentato del 22 aprile sia stato organizzato direttamente da Islamabad. Puntare il dito contro il Pakistan ogni volta che si verifica un attentato in Kashmir è miope e pretestuoso, dal momento che serve a distogliere l’attenzione dalle mancanze, decennali, che i successivi governi indiani, non solo quello del BJP, hanno avuto nei confronti del Kashmir; serve a distogliere l’attenzione dall’incapacità di trovare soluzioni costruttive e non distruttive alla questione kashmira e agli stessi rapporti indo-pakistani.
Sul piano geopolitico, la mancanza di un organismo di gestione delle crisi fa sì che ogni tensione tra India e Pakistan rischi di degenerare pericolosamente in un conflitto aperto. Di conseguenza, ogni volta che entrano in collisione, India e Pakistan devono fare ricorso a mediatori esterni: nell’ultimo caso gli Stati Uniti, ma anche la Cina.[12] Non bisogna dimenticare che l’attacco di Pahalgam è avvenuto durante il secondo dei quattro giorni della visita di JD Vance in India. È probabile che l’attentato fosse un messaggio del TRF agli Stati Uniti come alleato dell’India e alla comunità internazionale. In ogni caso, la mediazione di Washington sembrerebbe essere stata fondamentale nel smorzare i toni tra i due contendenti. Se la visita del vicepresidente americano era avvenuta nella massima cordialità, con gli auspici di un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali e del coinvolgimento dell’India nei piani americani, i rapporti tra Delhi e Washington si sono raffreddati a seguito dell’attacco indiano al Pakistan. Durante la visita di Modi alla Casa Bianca, il 13 febbraio 2025, il primo ministro indiano e il presidente Trump avevano annunciato il piano denominato Tranforming the Relationship Utilizing Strategic Technology (TRUST), che prevede la realizzazione di catene di approvvigionamento sicure, soprattutto per i semiconduttori e i minerali rari e prende in considerazione la possibilità di produrre in India chip ‘maturi’, piuttosto che leading-edge, o avanzati, i quali richiederebbero la costruzione di impianti di fabbricazione troppo costosi. Il rafforzamento dei rapporti economici tra i due paesi doveva essere la cornice entro la quale sviluppare il TRUST,[13] ma l’accordo commerciale, che dovrebbe comportare, tra l’altro, il raddoppio delle transazioni entro il 2030, e la cui prima fase dovrebbe essere conclusa entro il 2030,[14] ha subito un rallentamento che ha richiesto una proroga di una settimana dei negoziati, per la definizione dei dettagli tariffari. A complicare la situazione, è arrivata la richiesta americana della liberalizzazione del mercato agricolo e caseario indiano, che suscita inquietudine in India, perché esporrebbe al rischio della povertà agricoltori e produttori.[15] Queste due componenti potrebbero mettere in atto proteste analoghe a quelle del 2020-2021, contro l’introduzione di tre norme da parte del governo indiano, tese a liberalizzare il settore agrario. Il rallentamento dei negoziati per l’accordo commerciale lascia presupporre che i rapporti tra India e Stati Uniti, nonostante l’ottimismo sbandierato soprattutto da Delhi, mantengano un certo grado di difficoltà.
Una crisi irrisolta e un futuro incerto
Ciò che resta, dopo la crisi di Pahalgam, è un conflitto irrisolto, che è tale da settant’anni. Così come quello di Pulwama del 2019 e dei molti scontri tra India e Pakistan, anche questo è un episodio di una saga apparentemente senza fine, che potrebbe sfociare in una guerra aperta, se solo intervenisse un elemento scatenante: basterebbero una reazione troppo impulsiva o un errore umano. È incredibile che né in Pakistan, né in India, a trent’anni di distanza, ci si ricordi più il tentativo di normalizzazione dei rapporti bilaterali portato avanti dal primo ministro Inder Kumar Gujral, il cui governo durò solo undici mesi, tra il 1997 e il 1998. Fu geniale, all’epoca, l’elaborazione della cosiddetta dottrina Gujral, che consisteva in un’idea visionaria e lungimirante dei rapporti tra l’India e i paesi dell’Asia meridionale, in particolare il Pakistan. Partendo dal presupposto che l’India fosse un paese di gran lunga più forte di ciascuno dei suoi vicini in Asia Meridionale,Gujral riteneva che avesse l’obbligo morale di fare concessioni più ampie di quelle che poteva aspettarsi dalle sue controparti. Su queste basi, il primo ministro aveva ideato e avviato un percorso bilaterale di pace, denominato “multi-track approach” o “composite dialogue”, dialogo composito, che consisteva nell’affrontare simultaneamente tutte le questioni irrisolte tra India e Pakistan e non solo quella riguardante il Kashmir, e nel mantenere un canale di dialogo costante.[16] I primi colloqui intrapresi tra il primo ministro indiano e il suo omologo, Pervez Musharraf, portarono alla riapertura delle frontiere, degli scambi bilaterali, alla riattivazione dei contatti tra le rispettive società civili e all’avvio di un dialogo inizialmente piuttosto serrato e propositivo, che aveva fatto credere in una definitiva distensione. Poi sopraggiunsero la guerra di Kargil, tra maggio e luglio 1999 e, appena due anni dopo, il 13 dicembre 2001, l’attacco al parlamento indiano realizzato dal Jaish-e-Mohammed (esercito di Mohammed), a rendere sempre più difficoltoso il dialogo e sempre più critici i rapporti bilaterali. Tra tentativi di riapertura dei contatti e reciproche accuse, il colpo di grazia al periodo idilliaco del governo Gujral fu dato dall’attentato all’Hotel Taj Mahal e ad altri due alberghi di lusso di Mumbai, avvenuto tra il 26 e il 29 novembre 2008 ad opera di un gruppo poco conosciuto, il Deccan Mujahedeen. Quelli erano gli anni dei governi Vajpayee, primo ministro del BJP, per poco più di un anno tra il 1998 e il 1999, poi di nuovo dal 1999 al 2004, che avevano determinato un rafforzamento senza precedenti della destra indù e dell’odio antimusulmano, non mitigati neppure dai successivi dieci anni di governo del Congresso, dal 2004 al 2014. Quello fu anche il periodo del tentativo di espandersi in Asia meridionale da parte di al-Qaeda, di cui si ritiene che il Deccan Mujahedeen fosse un’emanazione. L’affermazione politica della destra indù ha compromesso pressoché definitivamente la possibilità, da un lato, di una normalizzazione dei rapporti indo-pakistani e, dall’altro, di una soluzione definitiva della questione del Kashmir, in realtà due facce della stessa medaglia.
Anziché attuare una valutazione costruttiva degli errori commessi in Kashmir in passato e cambiare rotta, l’India continua ad additare il Pakistan come matrice dell’islam radicale e del terrorismo kashmiro, nonostante Islamabad abbia aderito alla coalizione internazionale per la lotta globale contro il terrorismo.[17] Questo tipo di retorica serve a rafforzare la politica violentemente anti-musulmana del BJP. Politica interna e politica estera si riflettono reciprocamente e l’atteggiamento duro verso i musulmani indiani e verso il Kashmir serve anche ad accreditare l’India di Modi come garante della sicurezza regionale e internazionale.
L’attacco di Pahalgam ha suscitato stupore, oltre che costernazione e indignazione, perché inaspettato: il Kashmir veniva descritto dalla retorica del BJP e dallo stesso primo ministro, come uno stato finalmente pacificato, dopo la repressione degli ultimi anni; di conseguenza lo stato indiano aveva abbassato la guardia, ipotizzando anche una futura smilitarizzazione del Kashmir. Si è trattato di una percezione e di una narrazione sbagliate e fuorvianti, puramente propagandistiche, quando si sarebbe dovuto intraprendere un progetto di sviluppo di lunga durata del Kashmir, che comprendesse tutta la sua popolazione, musulmana e indù e, al tempo stesso, la si proteggesse da interessi esterni: invece si è fatto l’esatto contrario. Soprattutto, per risolvere definitivamente la questione del Kashmir, bisogna intraprendere (o riprendere) il dialogo con il Pakistan perché, come afferma uno stimato analista indiano quale Prem Shankar Jha, qualsiasi soluzione si decida di adottare per il Kashmir, questa deve riguardare entrambe le parti dello stato, quella indiana e quella pakistana.[18] Attualmente l’atteggiamento più propositivo viene assunto dal Pakistan, il cui vice primo ministro Ishaq Dar, il 22 maggio, ha dichiarato che era necessario riprendere il dialogo composito con l’India, in un paese terzo, come l’Arabia Saudita o gli Emirati.[19]
Il recentissimo e sorprendente riavvicinamento del Pakistan all’Iran, con cui i rapporti sono stati storicamente tutt’altro che buoni, oltre a indicare l’elevato livello di pericolosità della situazione in Medio Oriente, con molta probabilità è motivato dalla paura di un Iran annientato e di un’influenza diretta in Asia Meridionale di Israele, dall’ascesa al potere di Modi alleato previlegiato dell’India. D’altra parte l’India, fin dal primo governo Modi, del 2014, non solo ha rafforzato i rapporti con Tel Aviv, con cui condivide una politica ferocemente antimusulmana, ma utilizza tecnologia per il controllo della popolazione, armamenti e assistenza tecnica e antiterrorismo forniti da Israele. Gli stessi metodi di repressione, probabilmente anche suggeriti dai consiglieri israeliani, come demolire le abitazioni di presunti terroristi al momento della cattura, anche per semplice ritorsione verso le famiglie, in Kashmir, ricordano quelli utilizzati dall’IDF in Palestina. Per quanto riguarda la politica estera, l’aggressività nei confronti degli stati confinanti, basata sulla minaccia militare più che sulla diplomazia, adottata dall’India nei confronti del Pakistan e, in parte, della Cina,[20] ricorda la politica attuata da Israele nei confronti dei vicini arabi che non hanno aderito agli Accordi di Abramo. Inoltre, anche l’utilizzo del soft power da parte dell’India ricorda quello di Israele: un’analogia rappresentata dal fatto che, una volta raggiunta la tregua dopo la crisi di Pahalgam, il governo di Delhi ha avviato un’‘offensiva diplomatica’, inviando delegazioni di parlamentari presso i ministeri degli Esteri di altri paesi, per promuovere le proprie ragioni e per influenzare positivamente i decisori politici stranieri. È una pratica che Israele adotta da decenni e che ha contribuito a generare una solidarietà internazionale spesso acritica verso Tel Aviv.[21]
[1] Il numero delle vittime varia da 26 a 28, a seconda delle fonti
[2] Y. Sharma, What is the Resistance Front, the group claiming the deadly Kashmir attack?, “Al Jazeera”, 23 aprile 2025 https://www.aljazeera.com/news/2025/4/23/what-is-the-resistance-front-the-group-behind-the-deadly-kashmir-attack
[3] Did China’s Fighter Jets Beat the West in the India-Pak War? Is U.S. Trade Power at Risk? Endgame Compass https://youtu.be/30sh7u-max0?si=ANqDJ8t1TD-lzZOK; I caccia indiani abbattuti da jet di fabbricazione cinese, “Contropiano”, 8 maggio 2025 https://contropiano.org/news/internazionale-news/2025/05/08/i-caccia-indiani-abbattuti-da-jet-di-fabbricazione-cinese-0182898
[4] Notte di scontri lungo il confine in Kashmir. India, il Pakistan ci ha attaccati con missili e droni, ANSA, 8 maggio 2025; Cosa si sa sull’uso dei droni nella crisi tra India e Pakistan, “Il Post”, 10 maggio 2025.
[5] R. Jebreal. Genocidio. Quello che rimane di noi nell’era neo-imperiale, Milano, Piemme, 2025, p. 218.
[6] La sussistenza di un’emulazione esplicita e pianificata da parte dell’India delle modalità di sopraffazione, repressione e controllo adottate da Israele verso i palestinesi è confermata da sempre più frequenti testimonianze. Nel 2019 il console generale indiano negli Stati Uniti aveva invocato l’adozione di un ‘modello israeliano’ da parte dell’India, che consistesse nella creazione di insediamenti di kashmiri indù come quelli dei coloni sionisti. Nel 2024 questa idea è stata ripresa dell’opinionista politico Anand Ranganathan, il quale ha dichiarato che in Kashmir l’India dovrebbe adottare il ‘modello israeliano’, suscitando forti polemiche nel paese: rispettivamente Anger over India’s diplomat calling for ‘Israel model’ in Kashmir, “Al Jazeera”, 28 novembre 2019; A. Bhasin, Bringing the Israeli model to Kashmir, “Al Jazeera”, 20 giugno 2020; H. Kanjwal, How India is implementing the ‘Israel model’ in Kashmir, “Middle East Eye”, 13 giugno 2024.
[7] Sulla grave situazione dei diritti umani e del diritto in genere in Kashmir dopo l’eliminazione dell’articolo 370 esiste una vastissima letteratura, sia giornalistica che accademica. Una buona sintesi, recente, si trova in India’s Modi visits Kashmir: How has the region changed since 2019?, “Al Jazeera”, 7 marzo 2024. Per uno sguardo in prospettiva storica della pubblicistica sull’analogia tra la Palestina e il Kashmir, di seguito una selezione di scritti: G. Jafar, Kashmir and Palestine: Similar ‘Solution’ to Similar Issues?, “Strategic Studies”, vol. 12, n. 2-3, inverno 1995-primavera 1996; G. Osuri, Kashmir and Palestine: The story of two occupations, “Al Jazeera”, 24 agosto 2016; U. Tramballi, Kashmir, una Palestina sull’Himalaya, ISPI, 7 agosto 2019 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kashmir-una-palestina-sullhimalaya-23779; G. Osuri, A. Zia, Kashmir and Palestine: archives of coloniality and solidarity, “Global Studies in Culture and Power”, vo.. 27, n. 3, 2020; N. Kaul, India, Israel, and Geopolitical Imagineries of Cooperation and Oppression, “Georgetown Journal of International Affairs”, 17 giugno 2022; H.K. Baloch, Drawing Parallel Between Kashmir and Palestine, “South Asia Journal”, 11 novembre 2023; H. Kanjwal, Colonizing Kashmir: State-Building Under Indian Occupation, Stanford University Press, 2023.
[8] A. Essa, India’s Kashmir railway is an engineering feat – and an occupation project, “Middle East Eye”, 21 giugno 2025.
[9] S. Zargar, Jobless and adrift, Jammu and Kashmir’s youth are struggling to keep the faith, “Scroll”, 17 marzo 2025.
[10] Y. Sharma, What is the Resistance Front, cit.
[11] Sulla situazione in genere, sulle analogie tra la politica di Modi rispetto al Kashmir e quella di Israele verso la Palestina, con particolare riferimento alle ricadute economiche e occupazionali dell’eliminazione dell’articolo 370 della Costituzione, vale la pena di ascoltare l’intervista radiofonica al Prof. Pradeep Sopory, India And Pakistan On A Knife Edge Over Kashmir Attack, “Wort 89.9 FM Madison”, 4 maggio 2025, https://soundcloud.com/wort-fm/india-and-pakistan-on-a-knife-edge-over-kashmir-attack
[12] M.W. Yusuf, Has the U.S. Prevented Another India-Pakistan War? Belfer Center for Science and International Affairs, 5 maggio 2025.
[13] K. Bandhari, The India-US Trust Initiative: Advancing Semiconductor and Supply Chain Cooperation, Carnegie Endowement for International Peace, 24 aprile 2025.
[14] A. Fox, India-US Trade Deal: A Strategic Play for Growth in Industrial and Agricultural Sectors, AInvest, 27 maggio 2025.
[15] M. Kumar, India, U.S. trade talks extended as deadline looms for interim deal, say sources, Reuters, 6 giugno 2025.
[16] F. Brunello Zanitti, La “dottrina Gujral”: un caso di studio tra aspetti biografici e storia della politica estera indiana, tesi di dottorato, Università degli Studi Firenze-Università di Siena, 2015-2018.
[17] Escalation India-Pakistan: cosa sta succedendo e come siamo arrivati fin qui, ISPI, 7 maggio 2025.
[18] P.S. Jha, Those Speaking of Kashmir as an Independent State Err in Conflating Freedom With Independence, “The Wire”, 24 novembre 2024. Prem Shankar Jha (1938) è uno dei massimi economisti indiani e giornalista. È stato consigliere personale del Primo Ministro V.P. Singh, per tutta la durata del suo mandato, tra dicembre 1989 e novembre 1990.
[19] Pakistan says open to dialogue with India, with Saudi Arabia, UAE among neutral venue options, “Arab News”, 22 maggio 2025.
[20] Soprattutto a causa dell’elevato interscambio tra i due paesi, Delhi non ha messo in secondo piano i rapporti diplomatici con Pechino: non bisogna dimenticare che entrambe fanno entrambi parte del BRICS. Tuttavia la recente adesione e crescente impegno dell’India nella Indo-Pacific Partnership a regia statunitense ha una chiara funzione di contenimento militare della Cina.
[21] Se fino all’insediamento del governo Modi, nel 2014, i rapporti di lunga data tra Israele e India erano ammantati da un certo mistero, sono diventati di dominio pubblico dopo la pubblicazione di un rapporto esteso e articolato, basato su documenti d’archivio, da parte del quotidiano israeliano Haaretz, che mette in luce i legami instaurati da diplomatici israeliani con l’opposizione al Congresso e in particolare con la destra indù, fin dagli anni ‘60 per contrastare la politica filopalestinese del governo indiano: E. Mack, The India File: Israel’s Warm TIes With the Indian Far Right Began Decades Before Modi, “Haaretz”, 8 marzo 2024.











 Gianni Biondillo intervista Leonardo Colombati
Gianni Biondillo intervista Leonardo Colombati