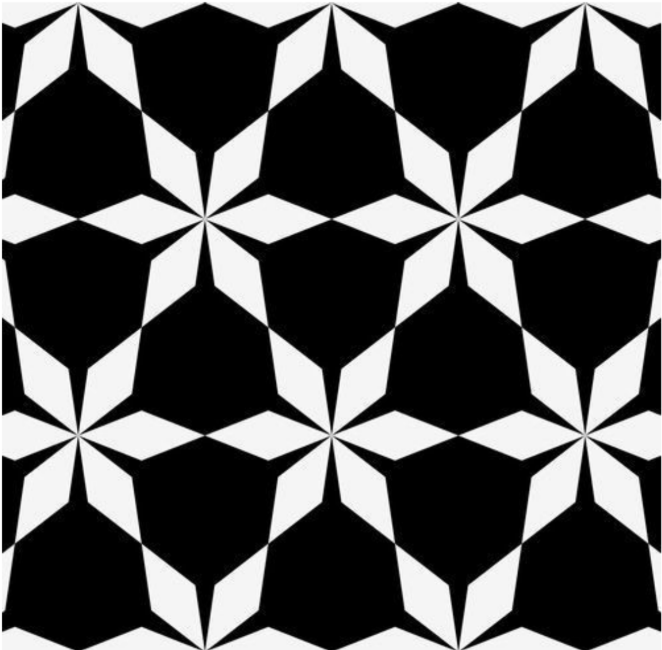di Riccardo Capoferro
- Introduzione
Quando, sia pure di sfuggita, la nostra premier ha chiamato quel che si sta consumando a Gaza “genocidio”– unendosi così ai molti italiani che lo considerano tale (secondo YouTrend il 63%)[1] – l’evidenza è parsa così flagrante da prevalere sulla Realpolitik[2].
Ma l’evidenza non è incontestata. Dal giorno in cui la parola “genocidio” è stata associata ai fatti di Gaza, si è messa in moto una specie di polizia terminologica, che molto alacremente (mentre le bombe continuavano a cadere e i palestinesi a morire) ha inchiodato gli accusatori di Israele alle loro responsabilità semantiche.
“Genocidio”, ci è stato detto, non è la parola giusta, non c’è certezza che di questo si tratti. “Genocidio” è, infatti, una parola politicizzata, polarizzata, permeata di narcisismo etico e ansia di demonizzazione, se non di un vero e proprio sentimento antisemita; spesso, infatti, esprimerebbe la volontà perversa di azzerare la memoria della Shoah accusando lo stato ebraico del crimine dei crimini; sarebbe, dunque, una parola carica di aggressività, che fa degenerare il dibattito, fomentando un muro contro muro politicamente sterile.
Ragionare su questi argomenti, le loro logiche di fondo e i loro aspetti problematici – a cominciare dalla loro inconsistenza giuridica – può essere utile: può servire a chiarire importanti sfumature dell’idea di “genocidio”, a risalire alle sue radici storiche, e a identificare con più chiarezza le situazioni in cui è indispensabile chiamarla in causa. Può offrici, in particolare, l’opportunità di evidenziare un fattore chiave dei processi genocidari: il fattore tempo (la cui importanza è tanto ovvia quanto trascurata).
Quali sono state, dunque, le logiche della negazione? Ne identificherò quattro tipi – che spesso si intrecciano – e di ciascuno mostrerò i risvolti problematici. Prima di iniziare, però, sono necessarie due note di metodo: 1) l’elenco potrebbe essere più lungo, perché idee legate a un certo argomento sono spesso sviluppate e sostenute indipendentemente, ma ho cercato di puntare all’essenziale; 2) le mie considerazioni non si addentreranno nel fondo oscuro della psiche individuale e collettiva, tra le radici profonde della negazione. Dietro al discorso sul “genocidio” a Gaza c’è stato a volte l’onesto desiderio di far ordine; ma il tono più distaccato può nascondere pulsioni viscerali: islamofobia, manie istrioniche da bastian contrario, nazionalismo di ritorno, oppure, più semplicemente, memorie familiari e legami affettivi, se non – e questo merita il più grande rispetto – traumi terribili. Ogni posizione lascia trasparire molto altro, ma va valutata di per sé.
Cominciamo dunque con la prima tipologia, quella giuridicamente più avveduta: i letteralisti.
- I letteralisti
Secondo alcuni, i fatti di Gaza costituirebbero un crimine di guerra, non, in senso stretto, un genocidio. Mancherebbe, infatti, un intento dichiarato. Non bastano le parole cariche di odio di politici, militari e civili israeliani, a cominciare dalla famosa dichiarazione in cui Netanyahu allude minacciosamente a un passo del Deuteronomio: parole con cui si annuncia una violenza sterminatrice e con cui i palestinesi vengono sviliti e deumanizzati secondo una logica di matrice razzista. Tutto questo non basta: i fatti di Gaza difetterebbero infatti di una caratteristica essenziale inclusa nella convenzione dell’ONU del 1948. A mancare sarebbe un “intento” esplicito: un “dolus specialis” affidato a documenti ufficiali, che possa essere ben accertato in sede legale. Questa posizione fa riferimento letterale alla definizione del ’48: “genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”[3].
Il problema dell’intento è stato in effetti sollevato da più parti, anche da esperti di diritto internazionale, che in vista di una sentenza hanno ribadito l’importanza di prove certe. Dato che, come ha ricordato lo storico Omer Bartov, le caratteristiche dei genocidi elencate dalla convenzione sono effettivamente riscontrabili a Gaza, l’accertamento dell’intento sembrerebbe, secondo questo punto di vista, configurarsi come una prova regina[4].
Ma è proprio sul piano giuridico che la posizione letteralista è problematica. Nell’invocare la definizione del ’48 c’è il rischio di dimenticarne la storia e di svincolarla dalle sue applicazioni, che hanno avuto cospicue ricadute sul suo significato, perché il senso di una legge deriva anche dalle interpretazioni e le sentenze che ne hanno rinegoziato i margini. Richiamando le sentenze della Corte internazionale di giustizia, B’Tselem – l’organizzazione israeliana che documenta la violazione dei diritti umani nei territori occupati – ci ha tenuto, non a caso, a evidenziare che l’intento può essere inferito dalla condotta dello stato o delle forze che commettono l’atto criminoso, e non necessariamente deve essere veicolato da un ordine scritto[5]. È poco realistico, del resto, pensare che nel XXI secolo, dopo i lager nazisti, un governo protocolli e pubblicizzi i suoi piani genocidari, riempiendo circolari e veline e distribuendo direttive agli esecutori materiali del massacro.
Se l’intento genocidario c’è si può inferire dai fatti[6]. Si può inferire, per quanto riguarda Gaza, a partire dai dati compatibili con la convenzione del ’48. Non solo dal numero esorbitante di vittime civili tra cui molti bambini; non solo dall’identificazione, permeata di odio simile a quello razziale, dei palestinesi di Gaza in quanto gruppo da annientare; non solo dall’occupazione di Gaza, che gli esponenti della destra messianica vorrebbero ricolonizzare; anche dalla “distruzione sistematica a Gaza delle abitazioni come pure di altre infrastrutture – edifici governativi, ospedali, università, scuole, moschee, siti del patrimonio culturale, impianti di trattamento delle acque, aree agricole e parchi”[7], che rende improbabile la ripresa della vita dei Gazawi sul territorio.
Il caso di Gaza non è assimilabile, certo, a contesti in cui l’intento genocidario è stato espresso più o meno chiaramente (anche se i nazisti, con le loro Endlösung der Judenfrage, Evakuierung nach Osten e Sonderbehandlung erano maestri dell’eufemismo). Richiede un modello di comprensione delle azioni e delle decisioni più flessibile; più adatto, cioè, alle apparenze giuridiche che, dopo il 1945, ogni stato che voglia dirsi “occidentale” è portato a rispettare.
Questo modello si può trovare, più che nella convenzione ONU, nel lavoro che l’ha preparata e di cui essa è in parte il precipitato; lavoro che la riflessione giuridica sul genocidio non ha mancato di elaborare. Si può trovare, cioè, negli scritti del giurista ebreo polacco Raphael Lemkin, colui che ha coniato la categoria di “genocidio”.
Lemkin dedicò molte energie alla storia dei genocidi. Riteneva infatti che ci fosse un nesso tra l’Olocausto e gli eccidi coloniali e riteneva, soprattutto, che le casistiche genocidarie fossero molteplici. Le sue riflessioni sull’intento sono molto utili. Lemkin pensava che l’intento non dovesse necessariamente essere esplicito, e che potesse anche non tradursi in un’azione diretta.
Il genocidio poteva essere messo in atto anche creando le condizioni affinché si realizzasse. Discutendo le caratteristiche del regime genocidario dei lager, Lemkin scrive che la responsabilità del comandante di un lager per la morte dei prigionieri esisteva anche qualora essa non fosse decretata, ma fosse resa altamente probabile, quindi chiaramente prevedibile, dalle condizioni di vita a cui i prigionieri erano sottoposti. In quel caso, il comandante di un lager era colpevole in quanto “[he] does not object in his mind and agrees with the eventuality of such destruction. In the criminal law of civil law countries such an intent is called ‘dolus eventualis’”[8]. Secondo Lemkin, dunque, l’intento si esplicherebbe non solo nell’eliminazione diretta di un gruppo, ma anche nel “dolus eventualis”; nella creazione di condizioni che possano portare a tale eliminazione.
Concordando con Lemkin[9], molti giuristi contemporanei hanno ripreso la nozione di “dolus eventualis”. Il giurista William A. Schabas – un’autorità in materia – non la chiama direttamente in causa, ma teorizza una casistica equivalente. Per provare le responsabilità di un genocidio, scrive Schabas, “it might be sufficient for the prosecution to demonstrate that the accused was reckless as to the consequences”[10]. Tante singole operazioni militari dalle prevedibili conseguenze genocidarie implicano, di fatto, la consapevolezza dei propri atti.
- I puristi
I puristi sono coloro che vedono nel genocidio un fine a sé stante, non inquinato da altri fini. Spesso la prospettiva purista è un corollario di quella letteralista e le due sono quasi intercambiabili. Rifacendosi alla convenzione, i puristi sostengono che, oltre a essere esplicito, l’intento debba avere come fine il genocidio stesso.
Mettiamo un caso immaginario. Un malvagio imperatore galattico non tollera più il pianeta X perché pullula di ribelli che danno all’impero filo da torcere; dà quindi ordine di spazzarne via con un gigantesco cannone di antimateria quasi tutta la popolazione e le infrastrutture – case, ospedali, università e templi inclusi. L’ordine, trasmesso oralmente al grande ammiraglio delle forze imperiali di stanza nello spazio prospiciente a X, è “spazzare via il focolaio di ribellione”: sottintende dunque che anche gli innocenti debbano essere eliminati e che occorra fare più vittime possibile dato che X potrebbe produrre nuovi ribelli. Insomma, l’intera popolazione di X, presente e futura, è chiamata in causa, perché evidentemente la “cultura della ribellione” di X dà più di un grattacapo all’impero. Ma secondo il purista l’imperatore e i suoi sottoposti non hanno commesso un genocidio. Dovevano avere come fine il genocidio in sé e dichiararlo a chiare lettere su un comunicato imperiale indirizzato agli operatori del cannone di antimateria.
Questa posizione porta in luce un elemento che spesso sfugge ai dibattiti riguardanti il genocidio: il movente. Non di rado si parla del genocidio come di un gigantesco ingranaggio pluriomicida svincolato da atti pregressi e finalità pratiche, motivato solo da una differenza etnica o razziale. La nazione o il gruppo genocida punterebbe al genocidio stesso.
Ma come la maggior parte dei crimini, il genocidio ha un movente. Anzi, i fatti ci insegnano che nel perpetrare un genocidio si persegue un vantaggio, nonostante questo dato sia spesso stato occultato dalle stesse ideologie usate a sua giustificazione, come le ideologie naziste e coloniali, incentrate sulla difesa della purezza razziale.
Per esempio, tra il 1915 e il 1917, mentre gli armeni venivano sterminati, le loro abitazioni, le loro attività agricole e commerciali, le loro chiese e gli altri loro beni venivano requisiti. Queste proprietà venivano spesso redistribuite a turchi musulmani, alleati curdi o ad altre popolazioni musulmane. Il tutto rientrava in una politica di “turchizzazione” delle province orientali, dove gli armeni avevano vissuto per secoli.
Sebbene tragga linfa da, e si ammanti di giustificazioni ideologiche che esprimono il bisogno di imporre con la violenza un’omogeneità etnica e razziale, il genocidio è stato quasi sempre funzionale all’occupazione di territorio. E nei casi in cui lo “spazio vitale” non sia stato dichiaratamente in gioco, la condotta genocidaria, con tutto il suo apparato di demarcazioni, ha comunque assolto a una funzione. È servita a eliminare o indebolire un gruppo storicamente percepito come antagonistico e in tal modo a rinforzare la coesione materiale e morale del gruppo che l’ha messa in atto e, inscindibilmente, il suo radicamento territoriale. Quest’aspetto si riscontra anche nelle persecuzioni razziali naziste, che come si sa furono in larga misura un fattore di coesione, funzionale a una mobilitazione di massa[11].
L’intento si desume, quindi, non solo dai danni biologici, culturali e infrastrutturali inflitti a una comunità; si desume anche dalla presenza di un movente[12]. Non importa quanto folle tale movente paia: nella follia può esserci del metodo. Le affermazioni deliranti di Hitler nel Mein Kampf e della propaganda nazista descrivono una necessità precisa, anche se non ancora sfociata in un piano di annientamento, e lasciano trasparire una comprensione profonda di cosa muoveva (e muove) le masse, influenzata dalla lettura attenta che Hitler fece di Gustave Le Bon[13].
Come ricorda William A. Schabas, la redazione della convenzione del ’48 fu preceduta da un’intensa riflessione sul movente. Molti stati volevano che il testo della convenzione lo menzionasse esplicitamente. E il movente figura nella definizione di uno dei crimini più vicini al genocidio, la persecuzione, le cui caratteristiche sono descritte nello Statuto di Roma (1998) nel paragrafo successivo a quello dedicato al genocidio[14]. E c’è di più. Sia nelle discussioni che condussero alla convenzione sia nelle riflessioni successive il movente è stato considerato un elemento da includere tra le prove, poiché consente di inferire l’intento genocidario. Scrive Schabas: “evidence of hateful motive will constitute an integral part of the proof of existence of a genocidal policy and therefore of a genocidal intent”[15]. La prova dell’esistenza di un movente che si accompagna a odio costituisce parte integrante della prova dell’esistenza di una politica genocidaria, quindi di un intento genocida.
Insomma, la mens rea e/o il dolus specialis, spesso non manifestati, si desumono dal contesto. Ma secondo i puristi le prove sono irrilevanti: bisogna solo cercare il documento dell’intento genocidario – un documento che ovviamente è impossibile trovare.
- I decontestualisti
L’importanza del movente ci porta a mettere a fuoco un’ulteriore categoria. Anche questa si sovrappone ai puristi e i letteralisti, ma non si produce in argomenti giuridici, limitandosi a dire che non c’è genocidio in atto, che Israele si sta solo difendendo con il fine del tutto ammissibile di disarmare Hamas, e – a volte – che l’IDF sta facendo tutto ciò che è in suo potere per contenere le vittime civili. Chiameremo i suoi rappresentanti “decontestualisti”.
Allontanando lo sguardo dal contesto in cui gli atti di Israele hanno preso forma, come pure da aspetti macroscopici dello specifico contesto di Gaza, il decontestualista ha creato a proprio uso e consumo un Israele immaginario: attento, professionale, chirurgico, protocollare, asettico, molto “occidentale”, che si limita a esercitare il suo diritto a difendersi. Ha sposato lo slogan israeliano secondo cui l’IDF è l’esercito più morale del mondo. Di fronte all’evidenza i decontestualisti hanno ammesso, in alcuni casi, che Israele ha esagerato, ma per solo colpa dei brutti ceffi al governo e in particolare di Netanyahu (le cui tendenze da autocrate faranno buon gioco quando ci sarà da trovare un capro espiatorio).
I decontestualisti possono essere divisi a loro volta in sottocategorie. C’è il decontestualista che se ne infischia della Storia e valuta gli eventi come se stesse commentando una partita di Champions League (“Hamas ha attaccato e bisogna contrattaccare!”) e quello che conosce la storia, a volte anche molto a fondo, ma ne seleziona larvatamente i dati, assecondando le sue pulsioni e i suoi preconcetti. Questo tipo di decontestualista produce una finta visione d’insieme, perché non lega un processo all’altro e così facendo oscura i pattern criminosi che hanno preparato il terreno per il massacro in atto.
Quali siano i pattern criminosi è quasi superfluo dirlo, perché chiunque si sia interessato alla faccenda ha presente la situazione abominevole dei territori occupati e la traiettoria che se ne evince.
Si tratta – repetita iuvant – di una traiettoria dal marcato carattere coloniale, benché molti decontestualisti lo neghino. In Cisgiordania, infatti, ci sono “i coloni” e gli “insediamenti”, c’è una popolazione locale ridotta a uno stato di subordinazione, e Israele è nato da una migrazione collettiva che ha portato unilateralmente alla nascita di un nuovo stato, all’inizio sponsorizzata – guarda un po’– dalla più grande potenza coloniale del tempo (la Gran Bretagna). Se poi si guarda ai lavori degli studiosi che inquadrano Israele come un’espressione tarda e peculiare di “settler colonialism” (Martin Shaw, Patrick Wolfe, Lorenzo Veracini, Ronit Lentin e altri) emergono altre analogie con il colonialismo da insediamento statunitense o australiano – al quale, va da sé, il caso israeliano non è del tutto assimilabile.
Questa traiettoria si è espressa in un processo di pulizia etnica, una categoria che non ha valore giuridico, ma che descrive efficacemente i processi di occupazione del territorio e le sue derive genocidarie. Per distinguerla bisogna guardare, oltre che alle espulsioni di massa del ’48, a quel che si verifica dal ’67 nei territori occupati.
Come si sa, in Cisgiordania, occupata ma non annessa, è stata messa in atto una distruzione graduale – e per molti versi sadica – della società palestinese, con confische di terreno, vessazioni amministrative, demolizioni, esecuzioni extragiudiziali da parte di soldati dell’IDF, sequestri di persona etichettati come “detenzioni amministrative”, crimini militari non sanzionati, tortura, assalti ai villaggi palestinesi da parte dei coloni, i cui crimini (tra cui l’omicidio) restano per la maggior parte impuniti[16], discriminazioni che negano l’accesso a risorse essenziali come quelle idriche, la costruzione di muri, strade e posti di blocco che ostacolano la vita quotidiana palestinese e strangolano le comunità e, soprattutto, l’aumento e lo sviluppo di insediamenti israeliani. Il paradosso di un’occupazione senza annessione deriva, ovviamente, dalla base etno-nazionalistica dello stato di Israele: dalla concezione dei palestinesi come di un gruppo che non può essere assimilato come tale all’interno della comunità nazionale, quindi deve essere relegato all’interno di un bantustan, rimosso, o eliminato.
Questa traiettoria ha un vettore ideologico e demografico. La destra messianica israeliana sogna da tempo un “grande Israele”, è in crescita demografica e nutre il sogno di ricolonizzare Gaza[17]. Secondo un sondaggio di luglio, il 38.9% degli elettori israeliani sarebbero a favore dell’annessione e della ricolonizzazione di Gaza[18]. Sempre a luglio (il 24) la Knesset ha votato (71 a 13) una risoluzione (non vincolante) per l’annessione della Cisgiordania e una commissione del ministero della difesa ha da poco deliberato l’attuazione del progetto E1, stanziando fondi per la costruzione di nuovi insediamenti che dovrebbero spaccare in due la Cisgiordania e congiungersi a Gerusalemme Est[19]. Nelle ultime settimane, nonostante le proteste delle alte sfere militari e di una parte della società israeliana, Netanyahu ha deciso di occupare Gaza ed è circolata la notizia che stesse cercando paesi disposti ad accoglierne la popolazione.
Inoltre, si distingue una traiettoria dal marcato potenziale genocidario nel modo in cui Israele (potenza occupante) ha gestito, dal 2005, l’assedio di Gaza (territorio occupato): un processo in cui fanno spicco atteggiamenti riconducibili all’odio etnico e razziale – cose su cui i decontestualisti sorvolano o che giustificano. Dopo l’uscita da Gaza Israele ha risposto con ferocia crescente agli attacchi di Hamas, provocati anche da azioni israeliane, rifacendosi sulla popolazione civile, sull’economia e sulle infrastrutture di Gaza.
È uno snodo cruciale di questo processo l’operazione “Piombo fuso” del 2008/2009 – preceduta da “Prime piogge”, “Piogge estive” e “Nuvole d’autunno” e seguita da “Pilastro di difesa” e varie altre. “Piombo fuso” ha reso palpabile la tendenza di Israele all’eccidio su larga scala e il disprezzo istituzionalizzato della vita dei civili, ben rappresentato dall’espressione “falciare il prato”, divenuta comune tra i militari israeliani.
Per giunta, negli stessi anni c’è chi ha cominciato a considerare i civili di Gaza, minorenni e coltivatori di fragole inclusi, come terroristi tout court: l’identificazione è stata promossa, per esempio, da rabbini ultra-nazionalisti, mentre dei civili israeliani guardavano le esplosioni dalle alture come se si trattasse di una partita di cricket[20]. Il ricorso a rappresaglie sproporzionate fece già allora parlare molti osservatori di “genocidio”. (Tra loro c’è l’allora presidente dell’assemblea generale dell’ONU)[21].
A fronte di questi presupposti, e di un bombardamento a tappeto che falcidiava la popolazione civile, non bisognava essere Auguste Dupin per capire a cosa stesse tendendo Israele alla fine del 2023[22]. Ma il decontestualista ci invita, non di rado con tono pacato, a non trarre conclusioni affrettate. “Fermi tutti!” – dice – “non si usi a sproposito il termine genocidio, perché il discorso pubblico va mantenuto a un certo livello”. Anzi, ci rimprovera per la nostra indignazione, per la nostra rabbia, per il nostro moralismo, per la nostra ostentazione di santità, invitandoci, come fa lui, a guardare i fatti – mentre i fatti, purtroppo, lo contraddicono.
5.
E poi c’è l’eccezionalista. A questa posizione sono spesso riconducibili commentatori legati in vario modo al mondo ebraico, contrari all’idea che il massacro di Gaza possa essere definito “genocidio”. Benché corredate di dati storici, le idee dell’eccezionalista implicano una visione tendenzialmente antistorica e, molto spesso, una forte preoccupazione identitaria. L’eccezionalista è in genere impermeabile alle istanze progressive del diritto internazionale. Nella speranza di un confronto produttivo può però essere utile portare alla luce le sue logiche e il contesto più ampio del quale sono espressione.
L’eccezionalista ritiene che l’Olocausto sia stato un evento irriducibilmente unico. Non di rado, rifiuta l’idea che possa essere usato come termine di comparazione e possa essere inserito in una famiglia di fenomeni accomunati da presupposti culturali e materiali comprensibili storicamente. Ritiene che solo pochissimi eccidi di massa possano essere definiti genocidi. Tra gli eccezionalisti c’è chi reagisce all’uso anche solo metaforico dell’Olocausto come a un’aggressione antisemita o a una negazione delle sofferenze che il nazismo ha inflitto al popolo ebraico.
Giova ricordare che lo stesso mondo ebraico ha espresso opinioni molto diverse: per esempio il Laboratorio Ebraico Antirazzista, Jewish Voice for Peace e vari altri collettivi stanno denunciando il genocidio a Gaza. E in ambito accademico c’è stata negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione al retroterra culturale che accomuna l’Olocausto e i massacri coloniali. L’idea di “memoria multidirezionale”, proposta nel 2009 dal teorico culturale Michael Rothberg (ebreo) mette in rilievo i momenti di memoria congiunta che abbracciano sia l’Olocausto che l’esperienza coloniale, e ha attecchito sia negli studi postcoloniali che nei memory studies[23]. Il lavoro di Rothberg ha del resto preso le mosse da quello di Arendt come da quello dei pionieri del pensiero postcoloniale, che avevano visto con chiarezza le radici coloniali dell’Olocausto[24].
L’eccezionalista tende invece a stabilire una distinzione netta tra l’Olocausto e eccidi dilazionati come quelli coloniali, tenendo ben separate le culture della memoria che li riguardano. Spesso interpreta l’uso comparativo dell’Olocausto come un atto di negazionismo. Insiste sulla scala impressionante del fenomeno, sulla sua estensione territoriale, sulla pianificazione che ha richiesto, sull’uso di un sistema industriale per la sua messa in atto, e sul fatto che il suo esito sia stato lo sterminio di massa più che lo sfruttamento.
La posizione eccezionalista presenta forti analogie con i dibattiti storiografici nordamericani degli anni ’90 relativi all’unicità dell’Olocausto, influenzati anche dalla politica delle identità nordamericana. In uno studio del 1993 sul negazionismo, la storica e attivista Deborah Lipstadt – in seguito divenuta United States Special Envoy for Monitoring and Combating Antisemitism – ha sostenuto vigorosamente l’unicità dell’Olocausto. Ci ha tenuto a precisare che il massacro degli armeni, insieme a vari altri – per esempio il genocidio perpetrato da Pol Pot in Cambogia – è stato un fenomeno diverso[25]. (In varie dichiarazioni degli anni successivi ha poi cambiato linea e lo ha senza esitazioni definito un “genocidio”)[26].
Lipstadt è stata a sua volta aspramente criticata[27]. I risvolti problematici della sua posizione emergono con forza nel momento in cui condanna i “relativisti”, cioè chi usa l’Olocausto come termine di paragone, sostenendo che ogni opera di comparazione avrebbe l’effetto di nutrire i sentimenti antisemiti. Comparare l’Olocausto andrebbe di pari passo, secondo Lipstadt, col minimizzarne l’impatto; solleverebbe – a suo dire “logicamente” – una domanda: “Why, then, do we ‘only’ hear about the Holocaust?”, domanda a cui molti, come nella Germania del’33, sarebbero portati a rispondere: “because of the power of the Jews”[28]. In sintesi, la comparazione soffierebbe sul fuoco di un mai sopito antisemitismo.
Ma l’anno in cui lo studio di Lipstadt veniva pubblicato era lo stesso in cui veniva inaugurato lo United States Holocaust Memorial Museum e si compiva il processo che Pankaj Mishra ha definito “americanizzazione” dell’Olocausto. Il quadro è ormai noto. Fino alla fine degli anni ’60, la memoria dell’Olocausto non ha avuto un grosso peso nella vita pubblica americana, anche tra gli stessi ebrei. Ma dopo il 1967 e il 1973 – dopo, cioè, la Guerra dei sei giorni e la Guerra dello Yom Kippur – le cose cambiarono: “la Shoah cominciò a essere ampiamente concepita, sia in Israele che negli Stati Uniti, come l’emblema della vulnerabilità ebraica in un mondo eternamente ostile”[29]. Molti ebrei americani fecero dell’Olocausto un pilastro della propria identità comune, e trovarono nell’etno-nazionalismo israeliano un imprescindibile punto di riferimento. Di pari passo, l’Olocausto si radicò saldamente nella cultura dell’intrattenimento di massa, e la sua memorializzazione cominciò a trovare ampio sostegno politico e istituzionale.
Il caso di Lipstadt esemplifica l’idealizzazione dell’Olocausto come fenomeno al di là della storia. Questa percezione può sfociare in un sentimento tra il difensivo, l’agonistico e il paranoico, oltre che nella tendenza a negare ad altri eccidi di massa, come quello di Gaza, lo status di genocidi. C’è insomma un punto paradossale oltre il quale la difesa strenua dell’unicità dell’Olocausto può segnare la perdita del suo valore in quanto oggetto di conoscenza, evento paradigmatico e agente di cambiamento civile: la perdita delle sue preziose potenzialità memoriali[30].
La posizione eccezionalista nasce in molti casi dall’ansia identitaria – ormai non solo statunitense – di veder riconosciuta la condizione, intergenerazionale e storicamente accertata, di vittima, e si è spesso accompagnata alla difesa a oltranza di Israele. Ma la condizione di vittima non è metastorica. Ogni fatto umano è transitorio, anche se dura da secoli. L’antisemitismo persiste – si vede da certe frasi ripugnanti sui social media – ma è meno diffuso e minaccioso di un tempo. Non c’è presidente americano che non renda conto al suo elettorato ebraico, tanto più perché i fini di buona parte di quell’elettorato sono compatibili con la politica statunitense in medio oriente, della quale Israele è una pedina fondamentale[31].
Nel corso delle piccole guerre per Gaza che hanno attraversato i media e i social media, l’atteggiamento difensivo degli eccezionalisti li ha portati a censurare i cosiddetti “pro-pal” più che lo stato di Israele. Nell’insistenza sul genocidio palestinese hanno visto un rigurgito antisemita, nella condanna di Israele una generalizzazione che polarizza il dibattito e fomenta odio. In parte, la loro risposta è stata esacerbata dalla tendenza di alcune frange pro-Palestina a replicare il lessico politico di Hamas (mossa non produttiva e di fatto inutile). Ma la tendenza degli eccezionalisti a concentrarsi sui “pro-pal” resta espressione di un vizio prospettico: nell’ultimo anno e mezzo è stata Gaza, non Israele, a subire una “minaccia esistenziale”. E se i palestinesi non morissero come mosche e Israele non usasse l’Olocausto per giustificare un eccidio la maggior parte di chi denuncia gli orrori di Gaza si dedicherebbe volentieri ad altro.
- Il fattore tempo
Nell’enfasi sulle sorti di Gaza e nel silenzio sul 7 ottobre l’eccezionalista avverte un’ostilità preconcetta a Israele, dalla larvata matrice antisemita. Ma il grido di allarme per Gaza ha nella maggior parte dei casi una spiegazione più semplice: gli orrendi fatti del 7 ottobre si sono già consumati, mentre quelli di Gaza sono tuttora in corso.
Le critiche all’uso ampio del concetto di genocidio trascurano il fattore tempo[32]. Negli anni necessari ad accertare legalmente se si sia verificato un genocidio, dei crimini di guerra possono effettivamente sfociare in genocidio, o la scala di un evento genocidario può aumentare in modo vertiginoso. Il genocidio è, infatti, un fenomeno ricorsivo e incrementale. Comporta l’emersione di schemi che tendono a ripetersi, a diffondersi e a rafforzarsi, e comporta un progressivo aumento di scala. Esige, pertanto, una risposta nel momento in cui sta iniziando. Può, in altri termini, delinearsi una fase liminale in cui la condanna e la prevenzione del fenomeno sembrano rendersi urgenti, ma che può al tempo stesso presentare incertezze.
Di fronte a un sospetto, per giunta sancito da un’indagine della corte internazionale di giustizia e dagli organi consultivi dell’ONU, alimentare il dubbio può essere controproducente. Tanto più perché per contrastare un genocidio non si chiama il 113, si chiede ascolto ai governi, non sempre inclini ad ascoltare. L’uso emergenziale della categoria di “genocidio” è inevitabilmente politico, esige una mobilitazione di massa e un innalzamento dei toni. Nei primi mesi dall’inizio della guerra a Gaza, chi ha adottato il termine lo ha usato come una metafora ad alto tasso emotivo, con l’intenzione di lanciare un allarme e denunciare un forte rischio genocidario. Aveva ragione. Mesi dopo, la dinamica genocidaria si è consolidata, diventando chiara per molti altri dei suoi spettatori.
Ma chi più di ogni altro ha avuto le idee chiare sono stati e sono i testimoni del massacro: chi vive sulla sua pelle l’assedio quotidiano di Israele e lo strangolamento dei territori occupati. In un’intervista, il poeta palestinese Mosab Abu Toha, di Gaza, ha ricordato di aver usato la parola “genocidio” già il quinto giorno dall’inizio dei bombardamenti:
I named it a genocide from the first day. I didn’t wait for Amnesty International to call it a genocide, I didn’t wait for B’Tselem […] I knew what a genocide is because I knew what Israel was capable of doing, and they are doing it. When they said we are going to cut off food, medicine, water, these are human animals, you should leave – Netanyahu said on October 12 […] “people of Gaza, you should leave”: you understand that if you don’t leave they are going to say “you see, we told them to leave. We are going to kill them. It means that they are Hamas”.[33]
Mosab Abu Toha sa di cosa parla. Ha perso molti amici e parenti stretti: famiglie intere di più generazioni spazzate via, di cui ha ricostruito gli alberi genealogici. Conosce bene l’odio di un gruppo verso un altro, è stato imprigionato e percosso senza ragione e soggetto a vessazioni amministrative di vario tipo. Sapeva chiaramente quello che sarebbe successo, e il suo allarme è rimasto inascoltato.
Il fattore tempo ha implicazioni anche sul piano della memoria. Accogliere, come fanno molti storici, l’idea che un genocidio sia un fenomeno incrementale, derivante da condizioni strutturali, dalla ricorrenza di determinati pattern in un arco di tempo che può essere protratto, e da uno o più moventi – in particolare l’occupazione di territorio – può nutrire una coscienza più viva del passato e dei suoi tanti orrori. Impone di rendere il tributo della memoria anche ai genocidi coloniali, commessi attraverso guerre a bassa intensità e, come molti storici hanno dimostrato, imparentati all’Olocausto.
Quest’idea ha il pregio di dirci da dove veniamo e dove potremmo dirigerci. Inquadra i genocidi come il grande scheletro nell’armadio dell’umanità, come un orrore pervasivo che solo dopo l’Olocausto è diventato il crimine più terribile, anche se non ancora compreso a fondo, e la cui criminalizzazione fa tutt’uno con la consapevolezza che la civiltà moderna possa lasciar riemergere le micidiali pulsioni del passato e tradurle in azioni ancora più distruttive.
Non va dimenticato, del resto, che la categoria di genocidio è stata anche il prodotto di circostanze storiche, politiche e culturali. È stata frutto di un consenso, legato a una volontà di progresso. In quanto tale, è suscettibile di revisioni, dettate da una nuova consapevolezza. Con ogni probabilità, Gaza cambierà il modo in cui guardiamo al passato. Ed è auspicabile che la sua lezione non debba applicarsi al futuro.
__
Note
[1] https://www.repubblica.it/politica/2025/07/26/news/sondaggio_antisemitismo_guerra_israele_palestina-424753192/.
[2] https://www.youtube.com/watch?v=dsWuiP7V8tc.
[3] https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.pdf.
[4] https://www.nytimes.com/2025/07/15/opinion/israel-gaza-holocaust-genocide-palestinians.html.
[5] https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202507_our_genocide_eng.pdf , p.12.
[6] Il problema dell’intento è ovviamente affrontato anche nei rapporti redatti da Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Si veda in particolare “Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967”, che oltre a fornire evidenza documentata della presenza di un genocidio definisce la cornice legale del problema. Sull’intento, si vedano in particolare i par. 39-61; https://digitallibrary.un.org/record/4064517?v=pdf#files.
[7] https://www.nytimes.com/2025/07/15/opinion/israel-gaza-holocaust-genocide-palestinians.html.
[8] Raphael Lemkin, “The Concept of Genocide in Sociology”, Raphael Lemkin papers, NYPL, box 2, folder 2. Citato in A. Dirk Moses, “Empire, Colony, Genocide: Keywords and the Philosophy of History”, in A. Dirk Moses (ed.), Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation and Subaltern Resistance in Word History, Berghan Books, New York, 2009, p. 19.
[9] Sul dibattito relativo al dolus eventualis, si veda Kai Ambos, Treatise on International Criminal Law, Volume II: The Crimes and Sentencing, Oxford University Press, Oxford, 2014, cap. 1.
[10] William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes. Third Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), p. 215.
[11] “Antisemitic slogans proved the most effective means of inspiring and organizing great masses of people”, scrive Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo.
[12] Al movente dedica ampie considerazioni Francesca Albanese in “Situation of human rights…”: par. 53(a), 68-69, 84.
[13] “La mescolanza del sangue e l’abbassamento del livello razziale che lo accompagna”, leggiamo nel Mein Kampf, “è l’unica e la sola ragione per cui le antiche civiltà scompaiono. Non sono le guerre che vengono perse a rovinare il genere umano, ma la perdita del potere di resistenza, che appartiene soltanto al sangue puro […] se rivediamo tutte le cause del collasso tedesco, quella finale e decisiva è il fallimento nel rendersi conto del problema razziale e, in particolare, la minaccia Ebraica […] La perdita della purezza razziale rovina per sempre le fortune di una razza”. Quando Hitler scrisse queste parole, la “soluzione finale” era di là da venire. Ma delineano sia la logica esplicita sia quella implicita che contribuì, agli occhi della società nazista, a caratterizzare la scomparsa di milioni di persone come un fatto desiderabile.
[14] “Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law”, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf, p. 4.
[15] William A. Schabas, Genocide in International Law, p. 277.
[16]https://www.timesofisrael.com/ngo-says-only-6-of-police-probes-of-settler-violence-it-was-party-to-ended-in-charges; https://www.icj.org/israel-palestine-authorities-must-end-impunity-for-israeli-settler-violence.
[17] https://www.lastampa.it/esteri/2025/08/07/news/smotrich_repubblica_ebraica_di_israele-15261649/amp/.
[18] https://www.timesofisrael.com/times-of-israel-poll-majority-of-israelis-oppose-annexation-of-gaza-territory.
[19] https://www.theguardian.com/world/2025/aug/14/israel-appears-set-to-approve-controversial-settlement-of-3400-homes-in-west-bank; https://www.timesofisrael.com/e1-settlement-project-widely-condemned-but-is-it-fatal-to-two-state-solution-idea/.
[20] Noam Chomsky, “‘Sterminate tutti i Bruti’: Gaza 2009”, in Noam Chomsky, Ilan Pappé, Ultima fermata Gaza: la guerra senza fine tra Israele e Palestina, Ponte alle Grazie, Milano, 2010, pp. 115-116.
[21] Ilan Pappé, “I campi di sterminio di Gaza (2004-2009)”, in Noam Chomsky, Ilan Pappé, Ultima fermata Gaza, pp. 217-220.
[22] Nell’aprile del 2025 lo storico Paul Rogers ha rilevato che le bombe sganciate su Gaza fino a quel punto equivalevano, in kilotoni, a sei Hiroshima. https://www.bradford.ac.uk/news/archive/2025/gaza-bombing-equivalent-to-six-hiroshimas-says-bradford-world-affairs-expert.php
[23] Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford University Press, Stanford, 2009.
[24] Può essere utile ricordare che la parola Konzentrationslager entrò in uso in Germania già intorno al 1900 per descrivere i modi di attuazione del genocidio degli Herero e Nama in Africa Tedesca del Sud-Ovest (oggi Namibia).
[25] Nel suo studio infatti lo chiama “massacro”, non genocidio. Le parole di Lipstadt, che hanno suscitato più di una critica, assomigliano a frasi che abbiamo sentito negli ultimi mesi: “The brutal Armenian tragedy, which the perpetrators still refuse to acknowledge adequately, was conducted within the context of a ruthless Turkish policy of expulsion and resettlement. It was terrible and caused horrendous suffering but it was not part of a process of total annihilation of an entire people”, Deborah Lipstadt, Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, Free Press, New York, 1993, p. 212.
[26] https://www.historynewsnetwork.org/article/holocaust-scholar-deborah-lipstadt-opposes-genocid; https://x.com/deborahlipstadt/status/1386323965434646528
[27] Si veda per esempio Ward Churchill, A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the Present, City Light Books, San Francisco, 1997, pp. 29-36.
[28] Deborah Lipstadt, Denying the Holocaust, p. 215.
[29] Pankaj Mishra, Il mondo dopo Gaza, Guanda, Milano, 2024, p. 176. Sull’americanizzazione dell’Olocausto vedi, oltre a Mishra, Norman Finkelstein, L’industria dell’Olocausto. Lo sfruttamento della sofferenza degli ebrei, Meltemi, Roma, 2024.
[30] A questo si unisce l’uso perverso della memoria dell’Olocausto come strumento per la giustificazione delle violenze israeliane. Si veda, in proposito, l’intervento recente di Amos Goldberg: https://zeteo.com/p/holocaust-memory-in-a-time-of-genocide.
[31] La situazione italiana degli ultimi anni ha molti aspetti in comune con quella statunitense: si veda https://www.internazionale.it/notizie/leonardo-bianchi/2025/07/28/alleanza-comunita-ebraiche-estrema-destra.
[32] Evidenziato anche da Francesca Albanese in “Situation of Human Rights”, par. 49 (“Early identification of genocide is crucial to prevent genocide, ensuring that a central tenet of the post-Second World War international legal system is not a dead letter”), 75, 86.



 di Linda Farata
di Linda Farata

 Con la testa sott’acqua
Con la testa sott’acqua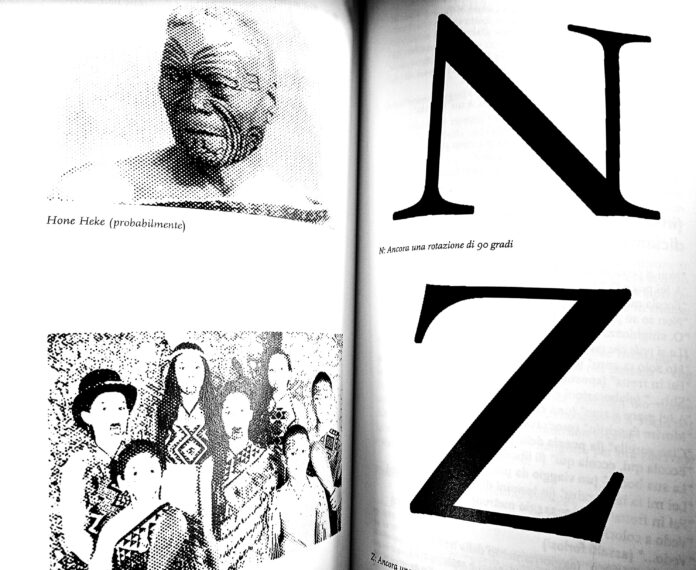







 Siamo pronti finalmente a “scendere in campo”.
Siamo pronti finalmente a “scendere in campo”.