di Francesca Matteoni
(ringrazio per molte delle fotografie lo scrittore Boris Ponomarev).

Puntando a nord-est su una cartina geografica dell’Europa, troviamo il mar Baltico e alcuni ricordi scolastici sulla lega anseatica nata nel tardo medioevo per favorire il commercio fra le varie città portuali del settentrione. Quasi al centro, fra le sponde del continente e quelle scandinave, c’è l’isola svedese di Gotland, con la sua capitale Visby, nota per le mura medievali interamente conservate e le molte rovine di chiese, abbandonate e lasciate a decadere nei venti della Riforma. A Visby si svolge nell’estate una nota festa medievale; mentre chi ha conosciuto la storia di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, potrebbe riconoscere proprio nelle variopinte stradine della città, l’ambientazione del noto sceneggiato del 1969. Per me il primo avvicinamento è avvenuto grazie alle parole della grande scrittrice svedese Selma Lagerlöf nel suo capolavoro, Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson, pubblicato nel 1906. Nils, mutato in folletto per la sua arroganza e in viaggio per tutta la Svezia con uno stormo di oche, sorvola Visby dopo aver appena ammirato i fasti della città fantasma di Vineta, sprofondata nel mare a causa dell’avidità dei suoi abitanti. Vedendo le rovine della città reale, Nils prova amarezza:
Se la città che aveva visto non fosse risprofondata in fondo al mare, forse un giorno sarebbe andata ugualmente in rovina. Forse non sarebbe riuscita a resistere al tempo e alla decadenza e si sarebbe presto ritrovata con chiese scoperchiate e palazzi scrostati e vie deserte e solitarie come quella. Era meglio che restasse in tutto il suo splendore in fondo al mare. (…) Ed è probabile che siano molti i giovani che la pensano così. Ma quando si diventa vecchi e ci si abitua ad accontentarsi di poco, ci si rallegra di più della Visby che c’è ancora che di una sfarzosa Vineta in fondo al mare.
Caro Nils, che ho portato con me in questa esperienza isolana, sono molte le meraviglie di questa città e delle sue rovine, non solo perché è patrimonio dell’UNESCO da oltre vent’anni. Forse perché divento vecchia, forse perché sono i luoghi che sanno custodire la traccia di un passato decaduto insieme a un quieto vivere presente a serbare una speciale magia, una sospensione dagli affanni del nostro contemporaneo. Visby, secondo il norreno antico: luogo di sacrifici, di riti. Chissà quale rito mi aspetta.
Con queste premesse mi ci dirigo per una residenza per scrittori e traduttori, presso il Baltic Centre for Writers and Translators, di circa tre settimane. Trascorro il primo giorno di dicembre a Stoccolma, camminando per l’isoletta di Gamla Stan, centro storico della città, e facendo visita al Nordiska Museet, il museo delle tradizioni del nord, che ho conosciuto nel gennaio 2013 mentre mi trovavo nella capitale per ricerca storica. Allora ci andai con la testa piena di folklore, culture sami, vecchi miti; questa volta mi accolgono da una parte la festa coi bambini per l’allestimento del grande albero nell’androne centrale, dall’altra una mostra didattica e accurata sull’Artico nell’era del collasso climatico: The Artic: While the Ice is Melting. Ne esco amareggiata per come in poco tempo cambia la nostra consapevolezza, per come ciò che amo anche senza averne avuta esperienza diretta (i mondi di ghiaccio, gli orsi, le culture artiche), rischia di scivolare via con conseguenze drammatiche. Trovarsi impotenti davanti al disastro è insostenibile, ancora di più nell’ultimo mese dell’anno, in cui si celebra ciò che è stato, si prepara ciò che viene, si fa posto nell’anima.

La mattina del 2 dicembre parto, infine, con questa cupezza sorda, ma anche con il desiderio di scrivere e lavorare, di confrontarmi. Nel porto di Nynashamn mi imbarco per raggiungere l’isola: tre ore di viaggio sul mare calmo. Arrivo a destinazione, verso le 15, per il tramonto. Il Baltic Centre si trova in uno dei punti più alti della cittadina, da cui si ammirano i tetti appuntiti, le pietre delle antiche chiese, la cattedrale di Santa Maria e ci si perde fino alla riva, oltre le mura. Patrick, uno dei responsabili, mi accoglie: sono due case quelle in cui abitano gli undici ospiti. Una è adibita a dormitorio, mentre nell’altra si trovano biblioteca, ampia cucina, sala per le conferenze e gli incontri. Questo luogo ha una storia importante, quasi fiabesca, che vale la pena di essere brevemente narrata. È nato nel 1993, come conseguenza di una crociera di scrittori e traduttori “Baltic Waves”, Onde Baltiche, fra le varie città dell’area, all’indomani del doppio crollo: muro di Berlino nel 1989 e URSS nel 1991. La crociera aveva lo scopo di unire nel nome della cultura e del libero scambio coloro che fino ad allora erano stati divisi. Il centro è il punto fermo, il luogo dove questo incontro continua ad avvenire, dove si gettano ponti non solo fra le varie culture affacciate sul mare, ma perfino oltre, verso tutti i paesi del mondo. Già detto così sembra un sogno di tregua, pace, conversazione aperta, dialogo che viaggia dai libri agli individui e alle loro sensibilità. Nei giorni della mia permanenza questa tregua stimolante è divenuta l’aria quotidiana. Scrittura, pensiero, solitudine proficua, camminate per la città e fuori dalle sue mura, verso la costa calcarea e sulle rive, cene e giorni condivise con gli altri ospiti e le loro storie.

Per deformazione professionale la prima cosa che vado a vedere è Galgberget la riserva naturale dove sorge la forca, alta sulla scogliera, così che tutti potessero vedere, nei secoli scorsi, i condannati spenzolare dai cappi, quale monito della giustizia degli umani. È un luogo suggestivo e potente. La forca, costruita nel tredicesimo secolo, è perfettamente conservata: l’ultima esecuzione risale al 1845, una decapitazione credo, quindi qualcuno di alto lignaggio, poiché l’impiccagione era riservata per lo più ai disgraziati del popolo. Gli archeologi hanno rinvenuto nel tempo le ossa di alcuni dei giustiziati, qui direttamente sepolti, ma non c’è nulla da temere: per quanto sia un luogo carico di terrore, di domande e di violenza trascorsa, non può ospitare spettri tormentati. Coloro che morivano per esecuzione capitale avevano almeno questa fortuna: conoscevano il momento della fine, avevano quindi il tempo di rimettere l’anima a Dio, essere perdonati, ricevere questa grazia ultraterrena che placa la sete dello spirito e gli impedisce di vagare in terra, privo del corpo. Forca: luogo di criminali e boia, di pubblico complice o partecipe, di morte e redenzione, di sangue che sgorga o corpo che si irrigidisce, di streghe notturne in cerca di reliquie, perché nulla è magico come il corpo umano… o ciò che ne rimane. Accanto alle colonne della costruzione medievale, piante di sorbo dell’uccellatore, ligustro, rose canine, due meli selvatici e alcune cinciallegre a banchettare con le bacche. La vegetazione cresce come una storia sulla morte, non va sempre così?
Nel museo di Gotland, nel cuore della vecchia Visby, si viaggia ancora più indietro attraverso la storia dell’isola, dalle pietre con iscrizioni runiche e disegni, fra cui un albero cosmico, l’Yggdrasill, e la nave dei morti, agli scheletri conservati di uomini e donne preistorici, fino alle vicende e ai tesori medievali. Mi restano impresse due donne dell’Età del Ferro: la Ragazza Riccio, così chiamata perché sepolta con un copricapo decorato con aculei dell’animale; e la Donna dei Flauti, sepolta insieme a una miriade di piccoli strumenti a fiato. Sciamane? Donne sacre? L’immaginazione corre dove non ci sono storie scritte, viaggia in questi oggetti così forti e misteriosi.
Ma la città è anche le sue mura e le sue porte da cui passare verso l’interno o verso le onde, verso gli stormi che prendono il volo al tramonto e il colore metallico del mare, uno dei mari più inquinati del mondo, purtroppo, eppure così evocativo per chi arriva qua da un altro mare chiuso, a sud. Le rovine si uniscono senza dramma alle abitazioni, alle luci di dicembre accese in tutte le case per scacciare il buio con l’avvicinarsi del solstizio. Nella piazza centrale, Stora Torget, il piccolo supermercato è anch’esso una casetta, di fronte ai resti imponenti di Santa Caterina e accanto ai pub o ristoranti aperti per le feste. Non ci si può perdere dentro le mura: basta fissare lo sguardo verso le torri della sua cattedrale, che si trova a due passi dal centro baltico, appena scese alcune rampe di scale. È lì che torno a fine di ogni passeggiata, sedendomi in fondo per raccogliere i pensieri.

Un altro luogo buono per pensare è la biblioteca cittadina, un edificio dalle ampie vetrate che danno sulla fontana e su un piccolo giardino. Qui si può sedere al bar o girare fra gli scaffali in libertà. Ho l’abitudine di prendere molti appunti su un apposito quaderno quando lavoro a un progetto di scrittura: faccio schemi, disegni brutti ma funzionali. Accade sempre fuori, dopo una passeggiata, da qualche parte a un tavolo con una tazza di tè o di cioccolata, se è inverno. Per i miei appunti i luoghi preferiti a Visby sono tre: la biblioteca; una caffetteria fuori le mura, accanto al supermercato Coop, e Karamell Buden, variopinta caffetteria e negozio di caramelle, dove abbonda l’oggettistica legata a Pippi e ai Mumin di Tove Jansson. Non si può evitare, girando per le strade: la sua vetrina è un paesaggio giocattolo, un inno a un’infanzia non tanto lontana. Penso all’episodio festoso dello sceneggiato di Pippi in cui la ragazzina compra caramelle per tutti e non posso che associarlo a questa singolare bottega. Penso anche alla scrittrice Viola Di Grado, che è stata qui prima di me e con cui abbiamo parlato di tutto, Pippi e caffetterie comprese.
Poche persone girano per le strade, ma non è freddo: pioviggina, soffia un forte vento, che può essere di grande aiuto se per esempio ci si ritrova sulla riva del mare a urlare preghiere o desideri. Almeno non si passa per pazze totali, rischio che corro ogni volta che mi trovo in una simile condizione di solitario e ventoso avvicinamento all’acqua marina. Chissà cosa si porta via il mare delle nostre parole. Non lo conosco il mare. È straordinario e commovente nella sua alterità, non mi ha mai dato quel senso di ricordo e presenza che mi danno le montagne, ma sento sempre che fa bene affidarmi a lui, quando lo incontro. Mi disperde.
Le mura della città proteggono ed espongono. Ho queste due immagini simboliche: la forca, subito fuori e il giardino botanico, dove siamo andati in un piccolo gruppo, una mattina, con i suoi alberi, diversi olmi, come ripari, l’acqua limpida e scura del laghetto, una vecchia torre, chiusa ai visitatori fino alla prossima estate, qualche gatto curioso, le scale di legno che portano sopra la cinta muraria.
Nel susseguirsi dei giorni cammino, scrivo, rileggo, do forma ai miei personaggi, ho tempo per loro, parlo e cucino insieme agli altri. Perché questo è un altro aspetto fondamentale della residenza – lo scambio umano. Una sera, per la partenza di una traduttrice danese, prepariamo una cena, la mia vera cena di Natale 2019. Cibo italiano, siriano, frutta, glögg ovvero vin brulé scandinavo, una tavola imbandita e condivisa, una lingua di compromesso, l’inglese, per comprenderci attraverso le nostre diverse provenienze: Scandinavia, Lituania, Russia, Siria, Italia, Finlandia. Stringiamo amicizie. Ci confessiamo, come succede con più facilità a volte fra estranei, ma con una differenza importante –ci accomuna radicalmente l’amore per la parola scritta, per l’eredità culturale da cui con fatica e gratitudine cerchiamo di affrancarci, da cui proviamo a respirare. Ci rispettiamo. In tutti questi giorni mi è salito il desiderio di conoscere le lingue che non ho, di rimettermi a studiare, anche solo per leggere coloro che ho incontrato; di riprendere lo svedese, di imparare il russo. Un proposito per il 2020.

Le sere di condivisione passano per il cibo, che sia popcorn o tè o dei bliny russi o bulgur o zuppa di lenticchie; attraversano i libri, la politica degli stati, le nostre vicende personali che non temono di essere respinte, mentre diventa sempre più difficile dirsi là fuori, nelle nostre vite quotidiane. Chissà quando ci rivedremo.
Dentro di me inizio a intessere quella vecchia promessa, come faccio fin da quando sono bambina, un filo invisibile che lego dove nessuno vede e sa tranne me: ricorda, ricorda, ricorda. Sono persone, capisci? Non devi perderle. E attraverso loro cerco i luoghi. Visby diventa una piccola città aperta sul mondo – si affaccia ora sui monti della Siria da dove qualcuno fugge perché la poesia resti e possa parlare a tutti; si affaccia sulla penisola di Kola e giù fino a Mosca, dove qualcuno cresce con determinazione, pronta a non tacere l’ingiustizia; si affaccia su una piccola serra per piante a Helsinki, dove qualcuno che mi rammenta tanto il mio compagno là, alle pendici del nostro Appennino, vive in modo parco, pensa forte al crimine dell’umano contro l’animale, questa ferita insanabile e morale. O in Svezia dove con mitezza qualcuno pone domande e ascolta o su un’isola norvegese di poesia e alti picchi; o dentro la Lituania, prima repubblica baltica a staccarsi dall’URSS; o sulla Moldava, nello sguardo gentile di una traduttrice per ragazzi; o in un pezzetto di Russia sulla costa del Baltico da cui un giovane scrittore ci tiene insieme, condividendo le sue fotografie. Riecheggiano nella storia che vengo componendo.

Passeggio per la via dei negozi, Adelsgatan, mi fermo dentro quello di articoli esoterici a osservare i tamburi, la collezione di tarocchi, alcuni libri sulle rune. Acquisto il mio regalo personale: un libro illustrato sulle creature soprannaturali scandinave dell’artista contemporaneo Johan Egerkrans. Per tradurre ho bisogno di tutti i miei vocabolari online, ma per le immagini riconosco il debito con i libri di Brian Froud e ancora di più con l’arte di John Bauer, creatore di troll ed elfi memorabili. Bauer mi accompagna in quanto vengo scrivendo e rubando. In questo ultimo mese, avvicinandosi al giorno più corto dell’anno, è la sua Santa Lucia che vedo mentalmente. Aspetto questo giorno, il 13 dicembre, dal mio arrivo. Perché è un giorno che ho cullato nella mia immaginazione, leggendo i libri della Lagerlöf, fiabe svedesi, articoli di folklore sulle donne fatate dell’inverno europeo. Santa Lucia nasce a Siracusa, è vero, diviene martire cristiana nel quarto secolo sotto la furia di Diocleziano, ma è in Svezia, alla fine del diciannovesimo secolo, che il suo culto si fonde con l’altro pagano, celebrativo della luce che lei porta nel nome, la luce tanto bramata nei lunghi inverni nordici. Qui, Santa Lucia è un giorno speciale. Ci sono i dolci, lussekatter (gatti di Lucia), i canti, le ragazze vestite in abito bianco e cintura rossa di stoffa e in testa una corona di candele. Al centro baltico Lena ha preparato per noi lussekatter e glögg, le candele sono accese in cucina. Abbiamo la nostra merenda insieme, mentre fuori imbrunisce. Alle sette vado nella cattedrale per assistere alla celebrazione: non ci sono più posti a sedere, mi trovo un angolo sui gradini vicino all’altare. Sette ragazze avanzano lungo la navata, hanno le coroncine di candele, quelle sul capo della prima sono vere e lei cammina dritta e sicura. Cantano inni, vengono lette leggende e aneddoti di cui capisco pochissimo, solo qualche parola che è rimasta nel mio vocabolario dai testi di folklore. Due bambine, una piccola Lucia e un folletto rosso, ballano e applaudono davanti al coro, sono lo spettacolo nello spettacolo. A me basta poco, sarà che resto una romantica e non me ne vergogno: ripenso al Bontempi su cui a fatica strimpellavo Santa Lucia, penso al buio, così bello, perché ogni luce si fa custode preziosa dentro di lui. Quando rientro nella mia stanza, mi metto le cuffie e faccio partire Sibelius, il mio compositore preferito, prima di addormentarmi. Ecco qualcosa da sigillare dentro di me, come ho fatto con le mie antiche decorazioni natalizie, portate attraverso le stagioni e raccontate sull’albero, ogni anno. Ecco l’importanza dei riti, compresi quelli di cui si è spettatori. Che cos’è un rito, mi chiedo ancora. Qualcosa per scacciare una paura, per propiziarsi un essere invisibile come la memoria. Qualcosa per trasportare di là il tempo che dura più dello scandirsi delle lancette. Qualcosa perché lo spazio nelle sue molte lingue diventi casa. Ho preso, dagli alberi di Visby, delle bacche di sorbo, delle mele selvatiche. Le chiudo in una scatolina metallica, le porto con me nella mia casa sulle colline. Marciranno, seccheranno, le disporrò nell’orto. Per sapere che io vivo in molti luoghi. A molti luoghi rubo parole. Per dire grazie quando le parole si decompongono.
Caro Nils che viaggi con le oche, torna ora a volare su questa Visby con il tuo sguardo di ragazzo. Guarda queste rovine, come parole decomposte. Vedi, crescono gli alberi dove c’era il pavimento. Muschio che ricopre cardini, finestre, porte scomparse. Mancano i tetti. E per questo sono più vicine al cielo, al mare, agli elementi. E lontano, lontano tra i venti, a me, nel centro vecchio e montuoso di una terra a forma di stivale.











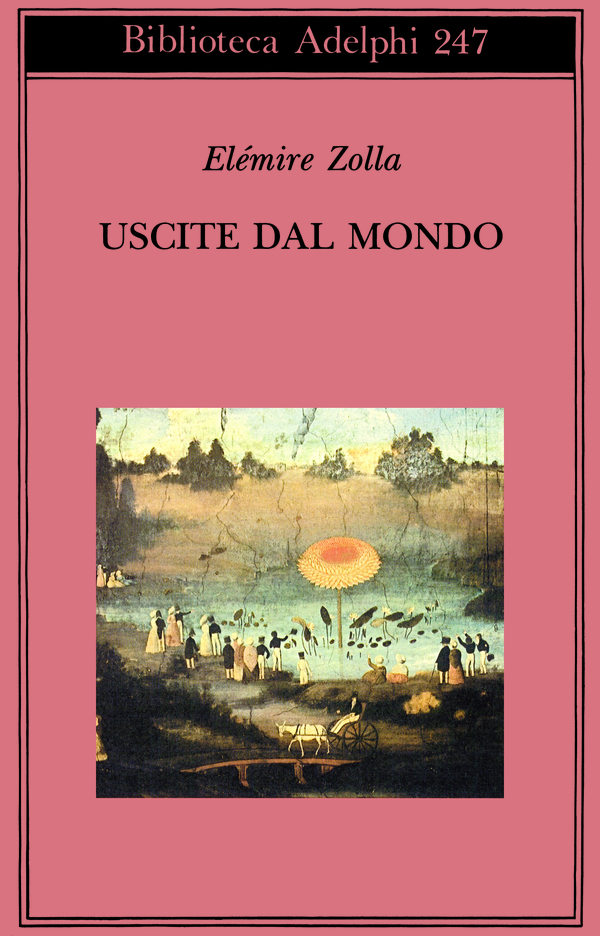
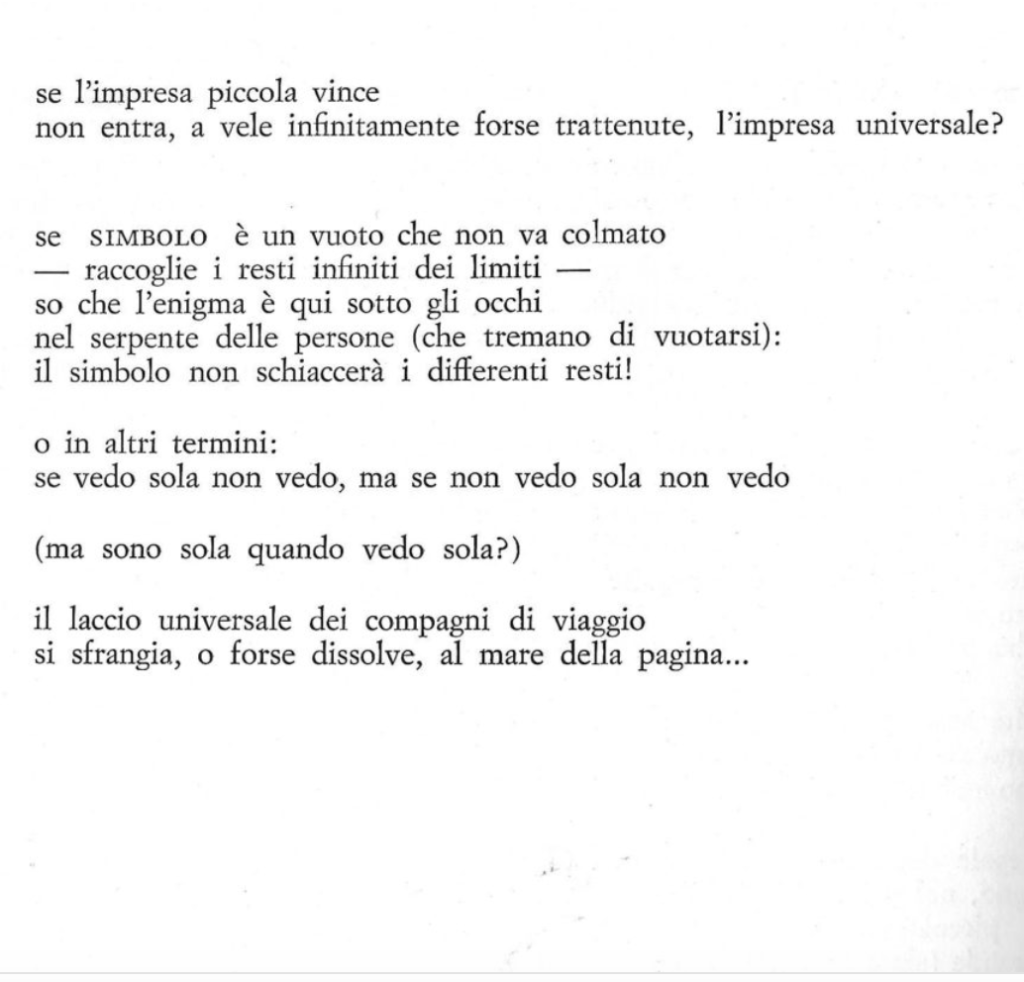

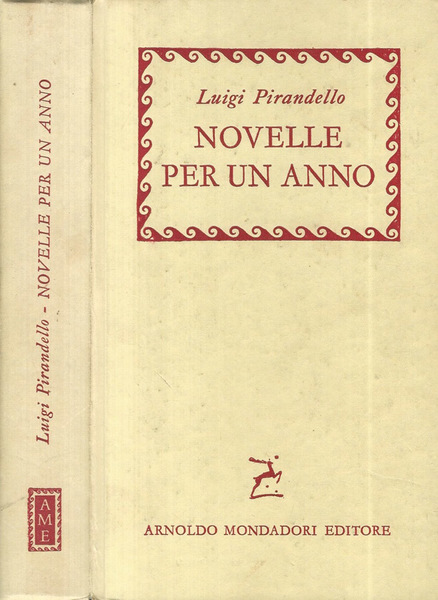

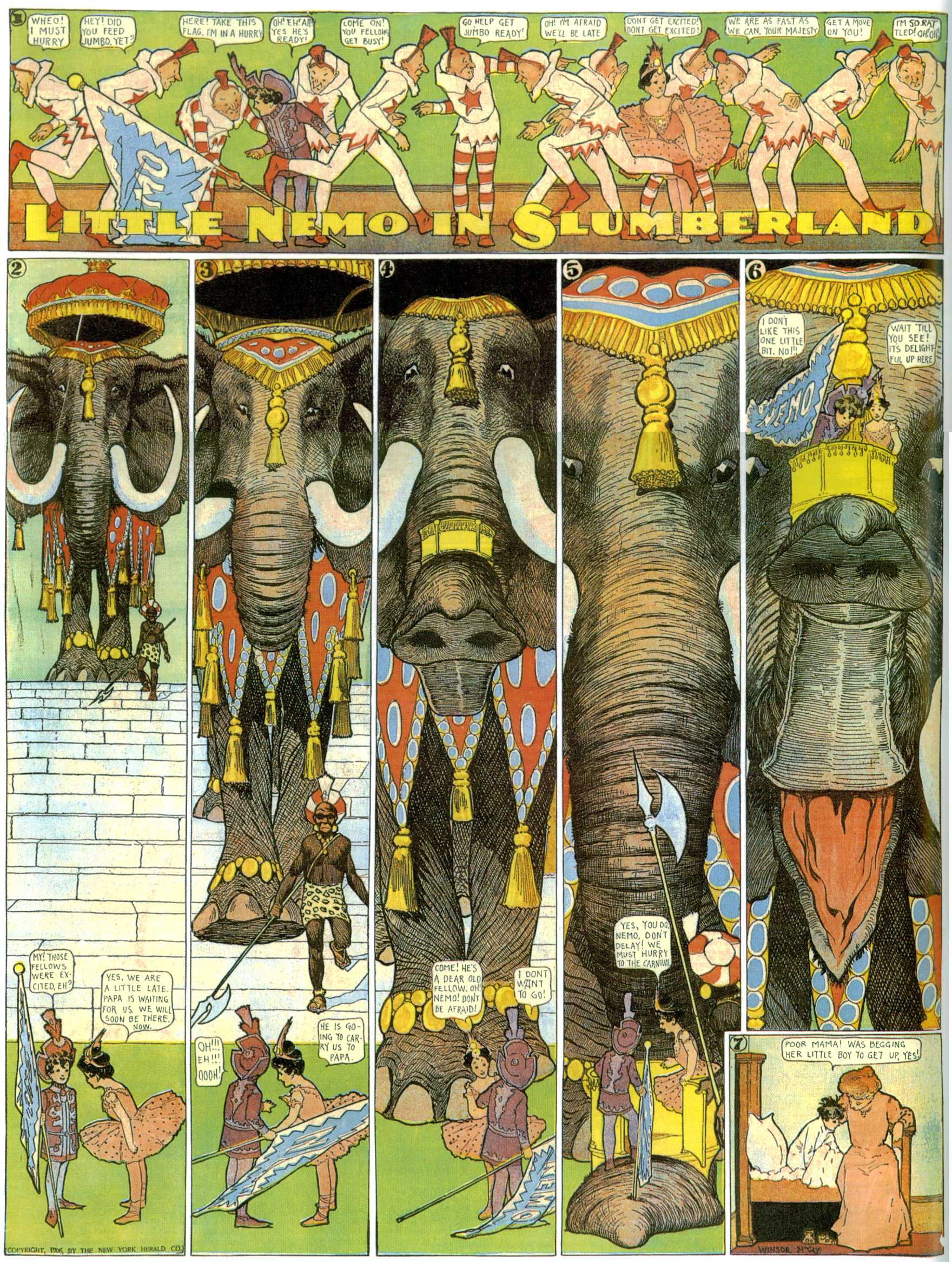

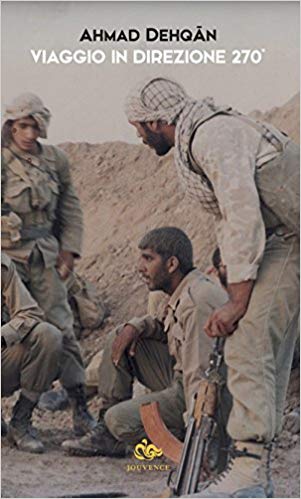



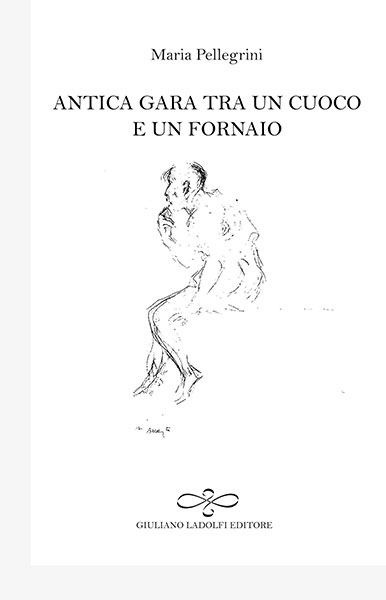































 Avresti perso perché amavi la casa? Non si combatte il fascismo con la domesticità. Ma non sapevi fermare il tuo diventare borghese, che avanzava ogni anno come una malattia, come il tempo. Quindi anche questo era accaduto a te e al tuo partito, che col tempo non vi proletarizzavate, la profezia era smentita, siete andati nella direzione contraria, verso la proprietà delle cose. Ma gli operai di occidente cosa desiderano? Restare proletari oppure la proprietà delle cose? Te lo chiedevi nell’appartamento di Monte Mario, acquistato col prestito dell’ente giornalisti italiani. Nel quartiere della Balduina. Un piccolo regno di vecchi e nuovi fascisti. Qui i laterizi erano cresciuti sul monte come l’acne sul volto di un adolescente. Avevano colori sbiaditi dall’ocra all’avorio, e forme quadrate di geometria povera (di spirito). Ma ti adattavi alla vita e restavi comodo in questo cemento. All’ultimo piano della palazzina di edilizia cooperativa. Con l’ascensore. Col televisore Brionvega in soggiorno. Con lavatrice e lavastoviglie prese a rate dal fornitore compagno. Con lo studio e il terrazzo. Col bagno e il bagnetto.
Avresti perso perché amavi la casa? Non si combatte il fascismo con la domesticità. Ma non sapevi fermare il tuo diventare borghese, che avanzava ogni anno come una malattia, come il tempo. Quindi anche questo era accaduto a te e al tuo partito, che col tempo non vi proletarizzavate, la profezia era smentita, siete andati nella direzione contraria, verso la proprietà delle cose. Ma gli operai di occidente cosa desiderano? Restare proletari oppure la proprietà delle cose? Te lo chiedevi nell’appartamento di Monte Mario, acquistato col prestito dell’ente giornalisti italiani. Nel quartiere della Balduina. Un piccolo regno di vecchi e nuovi fascisti. Qui i laterizi erano cresciuti sul monte come l’acne sul volto di un adolescente. Avevano colori sbiaditi dall’ocra all’avorio, e forme quadrate di geometria povera (di spirito). Ma ti adattavi alla vita e restavi comodo in questo cemento. All’ultimo piano della palazzina di edilizia cooperativa. Con l’ascensore. Col televisore Brionvega in soggiorno. Con lavatrice e lavastoviglie prese a rate dal fornitore compagno. Con lo studio e il terrazzo. Col bagno e il bagnetto.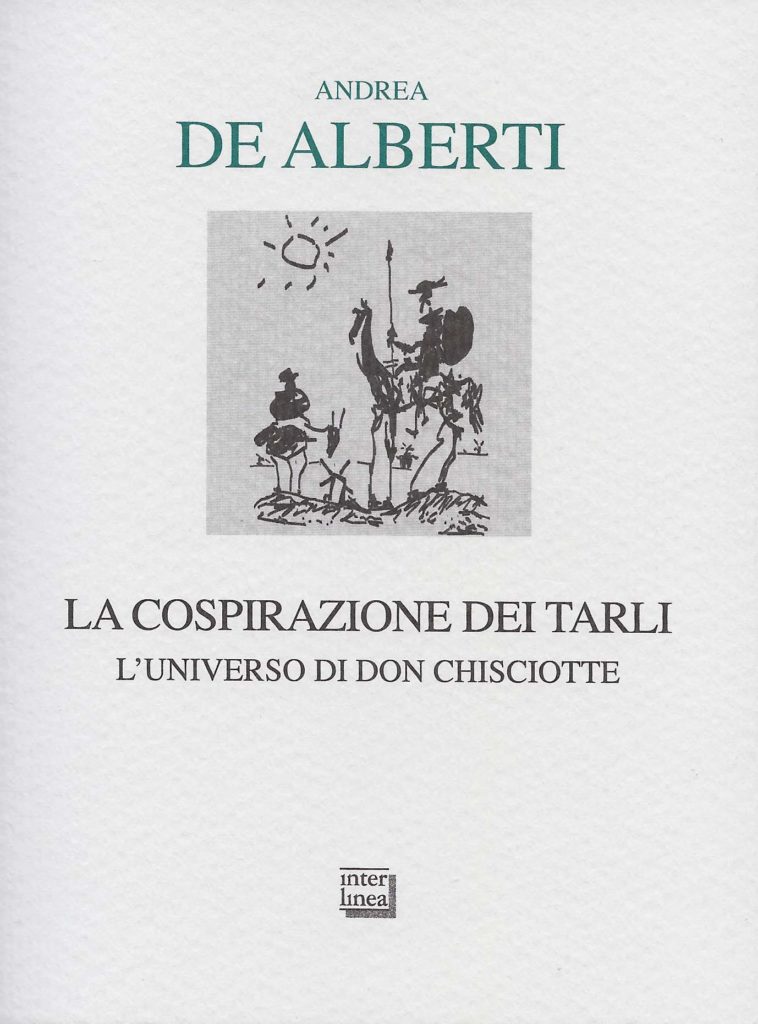 Nota di lettura
Nota di lettura



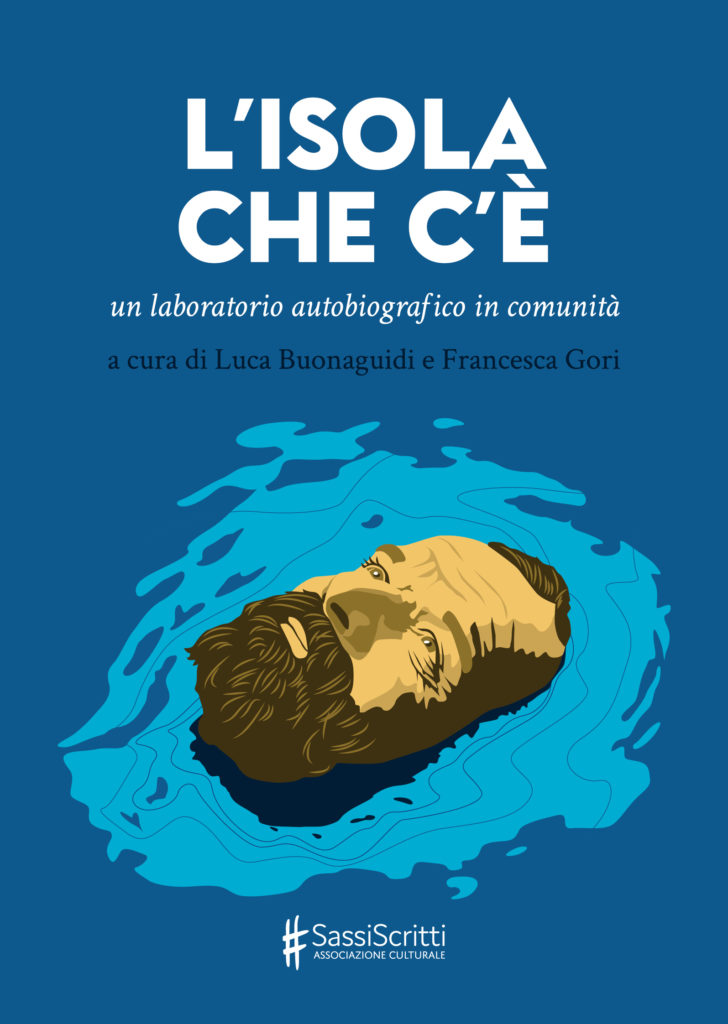 Disintossicarsi dai pregiudizi sulle tossicodipendenze
Disintossicarsi dai pregiudizi sulle tossicodipendenze