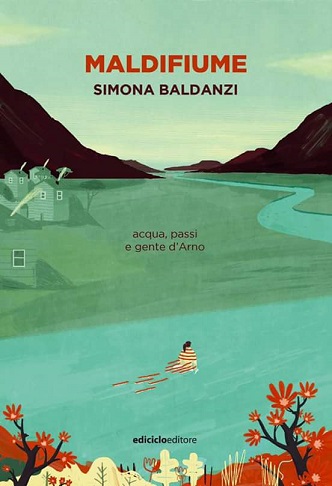di Nicola Fanizza

Era quasi sera e avevamo appena trovato posto su una delle tante panchine, che sono situate sulla rotonda a due passi dal mare. Ricordo che i miei amici mi parlavano, ma io non rispondevo, poiché il mio sguardo, improvvisamente, era stato catturato da una vela che passava, era bianca ed era gonfia di vento. Fu proprio quella vela a riportarmi alla mente il fantasma di Guglielmo. Infatti, quando ero ragazzo, lo avevo visto veleggiare con la stessa barca e sul medesimo specchio d’acqua.
Guglielmo era giunto a Mola verso la metà degli anni Cinquanta. Asseriva di essere nato a Spezzano Albanese in Calabria e che, non essendoci in quella regione alcun Liceo artistico, si era trasferito in Puglia per poter frequentare l’Istituto d’Arte di Bari. Per di più, diceva di aver scelto di abitare a Mola – a venti km dal capoluogo pugliese –, poiché era attratto dalla bellezza del suo mare.
Di certo, Guglielmo era un ragazzo che non passava inosservato. Si imponeva per sua altezza e, insieme, per la sua bellezza. Era alto quasi due metri, aveva la barba nera e, soprattutto, aveva gli occhi azzurri come il cielo. Da qui l’interesse delle ragazze nei suoi confronti. Infatti, ogni qual volta lo vedevano sfrecciare per le strade del paese alla guida della sua spider rossa decapottabile – una MG con cerchi a raggi –, si abbandonavano dolcemente ai loro sogni d’amore.
La mia curiosità nei confronti di Guglielmo e del suo mistero era mediata dal racconto dei miei fratelli più grandi. Questi ultimi mi parlavano spesso di lui, degli accidenti che avevano costellato la sua vita e spesso congetturavano in merito alla sua improvvisa scomparsa.
Stando a ciò che essi mi raccontavano, Guglielmo si faceva apprezzare per la sua cortesia, era gentile con tutti e non alzava mai la voce. La sua gentilezza, congiunta alla sua disponibilità nel promuovere relazioni degne e sovrane, gli consentì in breve tempo di guadagnarsi la simpatia e la compagnia di numerosi amici, che appartenevano alle diverse classi sociali: marinai, contadini, studenti, professionisti, armatori, ecc. Nondimeno non tutti i suoi amici possedevano la sua stessa sensibilità. Pochissimi amavano la dépense. E quando qualcuno fra i suoi amici più devoti lo invitava a moderare la sua eccessiva generosità, lui rispondeva con un motto caro a Gabriele d’Annunzio: «Io ho quel che ho donato!»*.
Fra le sue passioni vi erano il mare e la fotografia. Il suo amore per il mare lo aveva indotto a comprare la barca a vela. Era attento ai mutamenti del tempo e appena si accorgeva che stava per alzarsi il vento, salpava l’ancora e si allontanava dalla costa fino scomparire all’orizzonte. Quando arrivava l’estate, si recava sulla spiaggia – unico fra i bagnanti – con le pinne, il fucile e gli occhiali. Si immergeva e dopo alcune ore tornava a riva con una rete piena di ricci, di polpi e di pesci di scoglio, che di solito regalava ai suoi amici.
Per quel che riguarda l’altra sua passione, Guglielmo riconosceva la valenza artistica della fotografia. Andava spesso in giro, armato con una macchina fotografica giapponese, per cogliere la bellezza che affiorava dai monumenti e dai volti che raccontavano una storia. E tuttavia si rifiutava di riprendere i palazzi che erano disseminati sul perimetro della piazza del Paese. Guglielmo giustificava tale rifiuto col fatto che aveva notato la mancanza di fiori su tutti i balconi di quei palazzi, che erano abitati dalle famiglie borghesi. Ebbene, Guglielmo riteneva che la borghesia molese, proprio perché non amava i fiori, non amava nemmeno la bellezza, era priva di cultura e di sensibilità.
Il rapporto di Guglielmo con la sua città di elezione cominciò a incrinarsi, allorquando cominciò a frequentare Lilly, la quale apparteneva a una famiglia del patriziato cittadino. Lilly era stata vista salire più volte sulla spider di Guglielmo, era salita anche sulla sua barca a vela, li avevano visti passeggiare nelle strade di campagna e qualcuno aveva detto che li aveva visti mentre si baciavano. Le voci inerenti al loro legame sentimentale si fecero insistenti e arrivarono alla famiglia di Lilly. Da qui la reazione dei suoi fratelli, che, non ritenendo Guglielmo all’altezza della loro famiglia, decisero di attivarsi per salvaguardare l’integrità del loro casato. Questi ultimi, coadiuvati da alcuni delinquenti, aggredirono con pugni e schiaffi Guglielmo e lo invitarono a mettere fine alla sua relazione con la loro sorella.
Dopo questo evento, lo stile di vita di Guglielmo divenne oggetto di attenzione da parte dei benpensanti e dei delatori. Stigmatizzavano il fatto che Guglielmo non andasse mai a messa; rilevavano che in più occasioni aveva assunto atteggiamenti anticonformistici e anarchicheggianti; sostenevano che aveva espresso giudizi negativi nei confronti dei partiti di governo; asserivano di non riuscire a capire il senso delle sue azioni, la sua generosità; affermavano che i soldi di cui disponeva erano di provenienza illecita; denunciavano le sue origini albanesi; e, infine, ritenevano che la sua iscrizione all’Istituto d’Arte di Bari fosse uno schermo per coprire la sua attività di agente segreto al servizio del Cominform.
Tutte queste considerazioni diventarono il fuoco da cui si originò una delazione nei suoi confronti, il cui contenuto fu inviato al capo della polizia. Nel documento il delatore sosteneva che Guglielmo si incontrava a Bari con «individui misteriosi», ossia con agenti sovietici del N.K.V.D., e che in detta città frequentava con molta circospezione la sede del P.C.I. In più, diceva che Guglielmo era di origine albanese ed era in continui rapporti con i proprietari dei motopescherecci. Ciò faceva supporre che i motovelieri svolgessero attività per il Cominform e che Guglielmo fosse quello che dava le direttive e procedesse al pagamento del lavoro compiuto.
Il capo della polizia prese atto del fatto che il documento era pervenuto attraverso una «fonte non controllata» e, pertanto, invitò la Questura di Bari ad assumere le opportune informazioni sulle attività di Guglielmo.
Appena giunse la direttiva, i delatori e i confidenti si scatenarono. Veniva seguito ovunque egli andasse. I confidenti lo seguivano: ogni volta che si recava a Bari per frequentare le lezioni; in mare, quando usciva dal porto con la sua barca a vela; quando si spostava con la macchina; persino quando era in casa nei suoi momenti intimi e inconfessabili. A tale proposito, un confidente si era posizionato di fronte alla finestra su cui dava la cucina della casa in cui abitava Guglielmo e si trovò, casualmente, ad assistere a una sua performance erotica: mentre la sua compagna era intenta a scolare la pasta, Guglielmo approfittò della sua momentanea fragilità e la prese da dietro.
Dopo mesi di attenta sorveglianza, gli inquirenti comunicarono al capo della polizia che dalla vigilanza esercitata nei confronti di Guglielmo non erano emersi elementi degni di segnalazione.
Intanto, dopo aver conseguito il diploma, Guglielmo ritornò al suo Paese. E non rimise più piede a Mola. Nessuno ha mai saputo dire alcunché della sua vita.
*Inciso sul frontone all’ingresso del Vittoriale, è questo il più celebre dei motti dannunziani. Il poeta affermò di aver trovato la frase incisa su una pietra di focolare appartenente a un camino del Quattrocento. In realtà è la traduzione di un emistichio del poeta latino Rabirio, contemporaneo di Augusto, citato da Seneca nel VI libro del De beneficiis:«Hoc habeo quadcumque dedi».





 43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza.
43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza. di Martina Germani Riccardi
di Martina Germani Riccardi








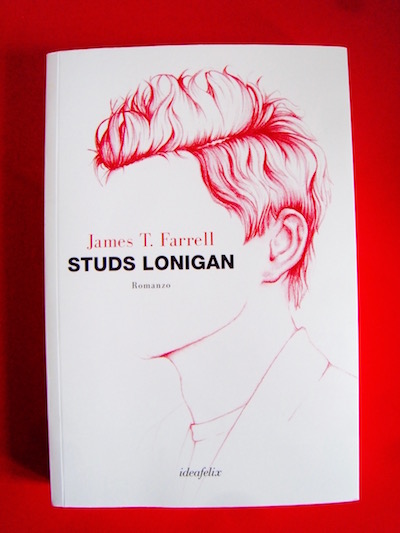
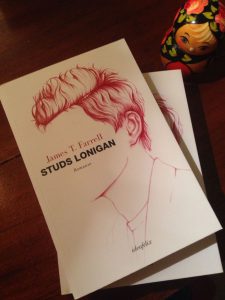 Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.
Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.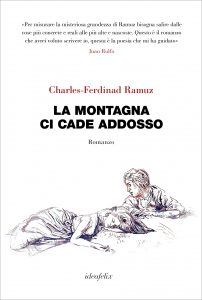
 (La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da
(La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da