di Daud al-Ahmar*
Si sbaglia a credere che le nazioni vittime della storia (e sono la maggioranza) vivano col pensiero fisso della rivoluzione, vedendovi la soluzione più semplice. Una rivoluzione è sempre un dramma (…). La rivoluzione è l’ultima risorsa e se un popolo ha deciso di ricorrervi è perché ha imparato per lunga esperienza, che non gli resta altra via d’uscita. (Ryszard Kapuściński – Shah in Shah)
Mi dice che non sapeva cosa fare dopo la prima esplosione, non c’era ancora abituato. Era corso a radunare i pezzi dei corpi per cercare di rimetterli insieme. C’erano altri ragazzini come lui, piccole prede del panico, e tutti si affannavano a dare a quei pezzi un ordine. Era un istinto nuovo (o antichissimo) e bisognava fare in fretta, ma era allo stesso tempo un dovere ineludibile costruito sul paradigma per cui non ci si può prender cura dei vivi se non è possibile farlo coi morti.
Ali mi guarda diritto, con quei suoi occhi color nocciola la cui forma allungata ha qualcosa di turcomanno e di azero e che graffiano sempre con ironia e cinismo. Ma ora che lo conosco bene ho capito che hanno anche qualcosa che appartiene all’angoscia dei testimoni, dei sopravvissuti. Qualcosa che ha radici in una solitudine profonda, sempre oscillante tra due imperi, la memoria e la dimenticanza, e sospesa sul vuoto dell’incomunicabilità. Un sentimento nato in un ragazzino iracheno di Mosul, cresciuto con lui e in lui, negli anni e guerra dopo guerra. I suoi occhi sono anche pieni d’amore per la vita, però. Anche se talvolta mi pare un amore strano, eccessivo, costruito su una vaga e inestinguibile fascinazione per la morte.
Sediamo in un minuscolo bar di Amman, un posto dai vetri opachi e dal molto fumo nell’aria. Stringiamo birra e sigarette. Tavolini angusti e consumati costringono al faccia a faccia. Sotto il mento piattini di formaggio salato, noccioline, cetrioli; sopra le teste un piccolo televisore anni ‘80 montato su un braccio meccanico simile a quello di certi alberghi economici. La voce lontana e melodiosa di Umm Kulthum fa da sottofondo ad annunci pubblicitari a dir poco grotteschi, uomini in tanga gonfi di anabolizzanti, modelle sexy al volante di macchine sportive, resort di lusso sul mar morto o ad Aqaba. Sulla parte bassa dello schermo scorrono ininterrottamente le ultime notizie: bombardamenti sulla Siria, attentati a Baghdad e a Beirut, la spianata delle moschee a Gerusalemme chiusa dagli Israeliani.
Ali dice che vorrebbe vedere tutto raso al suolo, distrutto, ogni statua, ogni colonna, ogni argilla, ogni tempio. La devono far finita con questa parola ridicola: civiltà. Che se ne vada tutto in polvere Ninive, Ur, Babilonia, nomi che non significano più nulla per gli iracheni. “Civiltà” ripete, lanciandomi un’occhiata sarcastica mentre rimuove un pezzo di nocciolina dai denti e lo inghiotte.
Ci soffermiamo a guardare lo schermo, pensando che forse quell’amalgama di immagini musica e notizie non è poi così assurdo. Non più di quanto lo siano i caccia siriani, russi, francesi, statunitensi, turchi, israeliani e via dicendo, che si sfiorano, sfrecciando a pochissimi metri di distanza sul cielo devastato della Siria.
Poi Ali, rapito da qualche pensiero, assume quell’atteggiamento paternalista che odio e mi dice che no, non posso capire. Anche se ho qualche “referenza”, sensibilità e tanta buona volontà. Sorride perché mi incazzo. Torna sereno, raccoglie due noccioline tostate dal piattino, manda giù una gran sorsata di birra e lancia una breve occhiata allo schermo esclamando: questi giordani sono proprio stronzi! E poi: ma tu, civilizzato, sei nato in ospedale, vero? E perché? Eri malato?
Paolo dall’Oglio ha scritto di aver subito durante la guerra una potente accelerazione esistenziale. Mi pare un’ottima definizione per descrivere quel tipo di dis-orientamento che hanno i profughi quando riescono a scappare o sopravvivere. E in questo caso parola non potrebbe calzare meglio, dato che non possono più volgere verso oriente, la loro terra [non è un po’ orientalista come cosa? State ad Aqaba lui va a Izmir! Cmq “dato che Ali forse non potrà più volgersi verso oriente, dov’è la sua terra].
Che ne pensi? mi guarda, la guardo. è pericoloso, dico. E poi, cosa farai? Non lo so, non importa c’è mio fratello ad Amsterdam. Qualcosa farò. Meglio che stare qui. Quando parti? La prossima settimana vado a Izmir, poi di lì non so dove mi porteranno. Non te lo dicono mai prima. Sono dei bugiardi quelli. Mi raccomando, appena sai la destinazione contattami, ho degli amici a Lesbos e in altre isole, a Kos per esempio. Certo, ti faccio sapere. Mi raccomando, così se c’è qualche problema ti possono aiutare. Certo, ti ringrazio veramente tanto. Ma figurati. Ma si, tu mi capisci. Non so se ti capisco, so solo che io farei lo stesso.
Provo a capirti (penso). Damasco posso solo immaginarla, figurati perderla. O Aleppo. A volte penso: se distruggessero Venezia che farei, che penserei, come reagirei? Mi rivolgo spesso a Venezia quando cado in queste crisi d’identità, quando provo a immedesimarmi. Non so perché proprio Venezia, io non sono di Venezia. Forse perché come il Marco Polo di Calvino ho bisogno di una città, di una bellezza originaria che mi permetta di comparare con tutto il resto (quindi di capire). E Venezia, nel suo sprofondare, mi mette faccia a faccia con la morte: una morte lenta è più accettabile, mi dico, più umana, a patto che non sia per malattia (anche nel modo di morire o di soffrire emergono i privilegi). Penso a Venezia, forse, perché dopo anni che viaggio in Medio Oriente ho capito che il suo fascino sta nel suo orientalismo (di un occidentalismo) e in un immaginario tutto arabo; tantissime persone che ho incontrato, all’udire la mia provenienza, mi hanno subito chiesto con aria curiosa e sognante come fosse Bunduqiyya (in arabo Venezia ha un nome suo proprio, c’è chi sostiene provenga dal nome di un fucile che si mercanteggiava in epoche lontane).
L’altro giorno è passato a trovarmi Abdelqader, si è avvicinato ad una delle piante che ho sul balcone e mi ha detto: ehi ma questa è una gardenia! Ho annuito, ero sorpreso che conoscesse la pianta. Poi ha aggiunto con quell’aria spensierata che si ritrova: Damasco è piena di alberi di gardenia. Sento la vostra nostalgia soprattutto quando cambiate argomento. Mi chiedo spesso se cercare di immedesimarsi non sia un esercizio inutile o patetico o paternalista.
Comunque ascolta, appena sei a Izmir fammi sapere, questo è il numero che mi hanno dato i miei amici, se ti trovi in mezzo al mare e succede qualcosa, chiamalo. è un s.o.s. che ti mette in contatto con la guardia costiera greca. Qualsiasi cosa succede chiamalo, capito? mi raccomando. Anche se qualcosa non ti quadra con quello che vi porta, non solo se il mare è grosso. Ma si non preoccuparti. Vedrai che andrà tutto bene, è vicinissimo, al massimo un paio d’ore di barca mi hanno detto. Si si, lo so, però ricordati: appena sai il nome dell’isola chiamami. Se è Lesbos – si chiama anche Mitilini – o Kos, fammelo sapere. E in ogni caso dimmi quale sarà l’isola: ci sono sempre amici di amici da contattare. Ma si, ma si, tranquillo, avrò il telefono ti scrivo. Dai che qui non è come tra la Libia e l’Italia, mi hanno detto che è facile. Si ma poi quando arrivi avrai bisogno di qualcosa, di soldi di cibo, di farti una doccia… Dai basta cosi. Vieni qui e dammi un abbraccio. Sembra che ti devo consolare io! E io: è che mi vergogno. Dai. Basta cosi. A presto. Yalla, ciao! Ciao! Ci vediamo in Europa!
Ehi, a proposito, sai nuotare? Non ricordo più se gliel’ho chiesto o l’ho immaginato.
A Beirut trovo un libro di Pasolini in francese con testo italiano a fronte. “Poesia in forma di rosa”. Lo sfoglio con affetto, un vecchio amico. Dopo gli scritti, a mo’ di postfazione, l’edizione francese ha aggiunto un’intervista a Moravia, vi leggo che Pasolini e Genet non si sono mai incontrati; dopo la morte del poeta pare che Moravia e Genet invece si siano frequentati, lo scrittore italiano catturato dalla fascinazione del poeta per la causa palestinese. La cosa mi riempie di interesse (era una cosa che mi chiedevo da molto tempo senza mai accondiscendere alla veloce risposta della rete) ma, come a rimandare un piacere, mi affretto a chiudere il libro, soddisfatto, pensando che tornerò presto sull’argomento.
Ora ho fretta. Salgo le scale e mi ributto su Hamra. Strana Beirut, una città che non conosco e che mi pare di conoscere. Chissà perché. Forse per questa maledetta abitudine al Medio Oriente. Eppure lo stesso Medio Oriente mi ha insegnato che di “medio” c’è davvero poco, che ogni posto ha il suo bel caratterino o identità e modo di lottare per questo e quella. Eppure. Un’aria familiare.
Camminando vedo un sacco di gente seduta a terra o sui marciapiedi. Siriani. Penso: eccoli qua. Negli occhi qualcosa che non è disperazione né dolore. Stanchezza. Siedono sul grembo grigio e arido della strada, su piccole lingue di asfalto, ruvide come quelle dei gatti. Tra le braccia delle donne neonati, tra le dita degli uomini sigarette, ultimo appiglio di virilità. Derubati di tutto. Uomini-bambini dal sesso fragile. Le donne invece mi sorprendono sempre, coi loro avambracci forti cullerebbero una stiva.
Vedere il mare a Beirut è un’impresa con tutti questi palazzoni grigi. E guardando in alto penso: e se fosse il mare invece a dare colore al cielo? Un cielo grigio. Sono pochi gli sguardi verso l’alto. Io me lo posso permettere mentre i profughi per strada guardano dritto, come a invocare l’orizzonte che tagli le costruzioni infami e faccia passare un po’ di brezza. Beirut è un caldo umido difficile da sopportare, con i vapori del traffico asfissiante, i peli che ti pizzicano la pelle come se fossero quelli di qualcun altro, la sporcizia accumulata ai lati delle strade, i liquami, le mosche, i clacson, i mozziconi, le rose. Le rose sulle braccia di questo bambino che me ne offre una. Ma sono al tavolo da solo, gli dico con un arabo zoppicante. E lui mi guarda, sorride, come per dire: embé? Fairuz coccola in sottofondo cantando di rose damascene: tutto torna. Faccio cenno al bambino di andare verso le coppie. Mi guarda senza muoversi, con un sorriso dai denti bianchissimi che gli illumina la pelle oliva. Gli occhi vivaci mi fanno agguato di bellezza. Ma non cedo: fisso lo scugnizzo con aria seria, che vuol essere quasi di rimprovero, mentre sento il senso del ridicolo che mi si dibatte dentro. Fingo di distrarmi per un momento e poi torno a guardarlo ma quello è già guizzato via, lasciandomi lí da solo, con un irreprensibile e sorpresa aria da coglione a chiedermi da dove venga quella rosa rossa poggiata sul mio tavolino che giace come un’apparizione. Mi torna alla mente un racconto de l’Isle d’Adam in cui i bambini andavano a rubare fiori freschi nei cimiteri per rivenderli agli stessi borghesi che li avevano lasciati qualche ora prima sopra i sepolcri dei loro parenti. Le strade del ‘900, penso, Parigi. Beirut trattiene ancora molto del novecento, e di una certa borghesissima e sprezzante aria parigina. Di un certo modo intellettuale di fare, di guardarsi intorno, di studiare, la Palestina, la Giordania, la Siria, i maroniti, gli sciiti, i sunniti, i druzi e via dicendo. Beirut è l’unica che è rimasta penso, se salta Beirut è finita. Baghdad, Damasco, Cairo, Gerusalemme, ormai inaccessibili in un modo o in un altro, più che agli stranieri, agli arabi stessi. E quanto sono importanti le rappresentazioni simboliche e culturali di queste capitali, per gli arabi. La loro identità conta più degli Stati stessi, mi pare di poter dire. Di fatti, Faiuruz canta le città, non gli Stati, penso. Guardo la rosa, sorrido, sicuramente prima di arrivare sul mio tavolo avrà fatto un giro ingegnoso e irriverente
Un rivolo di sudore mi scivola dall’ascella al gomito, solleticandomi la coscienza. Il calore mi rimbambisce. Guardo i vestiti che indossano. Non posso stare nel limbo, preferisco l’inferno, diceva Kamal, amico palestinese mentre camminava su e giù per la stanza. Te la smetti di fare “i fora?!” (cosi chiamava l’andirivieni durante l’ora d’aria nelle prigioni israeliane), ma no, sai che favoriscono la digestione e il pensiero! Ora capita anche a me di camminare avanti e indietro per la stanza quando penso. Che pensavo? Ah, già l’Inferno. Che si tratti sempre di quel vecchio inferno che formiamo stando assieme? O invece si tratta di qualcos’altro? Quanta gente c’è a Beirut e in Libano? Qui si rischia di morire soffocati dalla folla. Vivere laddove l’uomo si è ritirato a istinto. I rifugiati siriani a Beirut non sono accolti bene. Eppure sono un milione in una popolazione di tre (che conta anche un buon numero di rifugiati palestinesi) e tutto si tiene in piedi in un equilibrio stupefacente.
Penso ai vestiti, al loro logorarsi naturale, guardo gli abiti come fossero staccati dai corpi. Strumenti umani. Penso al loro logorarsi sociale. Troppo facile riconoscere nel gomito, nella manica o nella cerniera, un contadino o un operaio. E quelli di un rifugiato? Eppure non ho mai visto abiti abiti così puliti e stirati come quelli dei miei vecchi colleghi di Gaza. O quelli dei contadini che incontravo nei campi e che quando mi venivano a trovare in ufficio avevano camice impeccabili, gilet e giacca di un eleganza scintillante. E le jalabyye bianchissime dei beduini una volta lasciati gli animali nelle stalle? Quante mani di donna ci sono dietro a tutto ciò? Eccola che infatti mi torna alla mente, la vecchia contadina umbra che durante la vendemmia mi diceva: poro marito mio, me ricordo che non se riusciva a toje de dosso quella puzza de merda! Stava sempre a accudì li porchi! Io ce provavo ma mice je se la faceva! E me lo immaginavo così il marito, con lo scrimo perfetto e le mani gonfie infilate l’una nell’altra, a sentire la messa con quel raccoglimento umile e delicato. Poi c’è mio nonno: il suo affannarsi nel farsi bello, nel rigovernarsi (una volta si diceva cosi in italiano, rigovernare) ogni mattino, nonostante la morte già lo placcasse, a letto da mesi. Una delle immagini più nobili che porto con me.
Ana, I am sick, marida, malata. L’uomo ritiratosi a istinto, ad alienazione? Everybody is getting sick because of the A.C., l’aria condizionata. L’alienazione ha già in sé il germe del privilegio (di farsi alienare)? What did you buy today? Shoes. Fi discount bi shara3 el-hamra, ci sono I saldi su via Hamra? Rinunciare ai privilegi? Profittarne per estenderli? Don’t do it habibi, you will ruin your make up, ti stai rovinando il trucco, non fare cosi tesoro. Estendere o eliminare. La trasvalutazione. Guardo le dita trasvalutate di smalto di queste giovani donne libanesi che bevono birra parlandosi tra di loro senza staccare l’occhio dal telefonino intelligente: don’t do it, habibti! Queste ragazze che parlano un arabo inglesizzato, due razze non incrociabili. Già il francese beirutino ha impregnato la lingua. Ora l’inglese. Beirut sembra realizzare l’inicrociabile. è questo l’inferno, mi dico a volte, il non saper più districare, strangolati da troppi lacci in cui tutto sembra avere lo stesso valore. Strano che Pasolini e Genet non si siano mai incontrati.
Turchia.
Ma che cosa gli dovrei dire io a uno che mi chiede cosa ne penso del Mediterraneo? È così caro, per me. Già la parola suscita un riverbero ameno in me. Ma tutto sta cambiando da un po’ di anni, da quando lo vedo dalla sponda sud, sud-est. Ho cominciato a metterci sabbia sporca dentro questo bel sentimento: il presente. Vedo scendere sabbia sporca, una clessidra che si inceppa. Un tempo sporco, una puzza di passato che ritorna. Sará la puzza della Storia? E più vado avanti più insisto nel metterci sabbia: mi faccio del male? Ma potrei fare altrimenti ormai? Tutte le evocazioni solari, sognanti, romantiche con cui mi sono forgiato da giovane pensando alla Grecia, al mare tra le terre, alla lira. In arabo lo chiamano il mare bianco, tra le terre. Ecco un’altra cosa che dimentico sempre di andare a guardare, questo legame tra colori e i mari, mar rosso, mar nero, mar bianco. Chissà se anche dalle nostre parti lo si chiamava bianco, tempo fa, il mediterraneo. Deve averlo scritto Metvajevic nel suo splendido breviario ma anche qui la memoria non mi viene in soccorso. E poi anche quel breviario è poesia, e la poesia la stavo giusto giusto riempiendo di sabbia sporca. Certo Predrag se lo può pure permettere, capirai è di Mostar, un’altra dolorosa-amorosa sponda. Ma io no, non posso. Penso ancora a Pasolini, all’apertura scenica della sua Medea: tutto è santo, tutto è santo! Esclama Chirone mostrando un mare splendido al piccolo Giasone. Per poi aggiungere: ma la santità può anche essere una maledizione.
Solo chi è umile può gridare viva la libertà. Vedo le immagini della polizia di frontiera che cerca di contenere centinaia di umani, vestiti come umani. La polizia è grottesca, invece, uomini vestiti come dei non uomini. La gente non scappa, scarta di lato, poi ci ripensa, torna indietro, scavalca i muri, si infila tra i fili spinati, si graffia, si sbuccia, prende due manganellate in testa. Sanguina, urla. Ma questi scappano dalle bombe, dalla clorina, dagli stupri della guerra, dall’inaudito. Avranno mica paura di due cyborg grotteschi? E infatti passano. Si fanno pure i selfie a un certo punto. Decine di volte mi è capitato di andare a manifestazioni contro il governo: la polizia, le cariche, il fuggi fuggi. Scorrimento pacifico, zone rosse, teste rosse. Un tipo di gioco che ha delle regole. Tutti o quasi le conoscono, perché sono le regole del proprio momento storico nel proprio paese, e il rapporto dialettico che ha una data popolazione con il proprio Stato (potere) e l’uso che questi fa della forza. Sappiamo bene come la forza diventi violenza e poi come, sempre Genet ci ha insegnato, come la violenza si faccia brutalità. Si sa che lo Stato si può permettere di rompere le regole del gioco. Ma il popolo no, a meno che, appunto, non si tratti di una rivoluzione.
Ma quello che vedo ora è una specie di dipinto del Quarto Stato che avanza tra polizie di frontiera, bambini che camminano in rime sparse, ragazzi coi backpack che sembrano farsi una gita in montagna, e invece si portano dietro la casa e la vita, facce stanche ma decise ad andare avanti con dentro gli occhi la voglia di una vita migliore, anche se hanno già capito meglio di tanti giovani europei che in quest’Europa c’è qualcosa che non torna, che c’è poco da fidarsi. Ci sono pur sempre dei diritti (a pagamento), ma sono pronti (a pagare) per i campi in detenzione, le impronte digitali, il rispetto delle regole, che non si rimetta in discussione lo statu quo, simbolico e legale. Eppure avanzano e con il loro andare sbaragliano le regole del gioco. La polizia carica, respinge, lacrimogeni botte. E allora? Dove volete che vadano dopo la manifestazione? A casa? Questo è un viaggio sola andata per il momento, poi staremo a vedere. Avanzano e cambiano le leggi, stati di emergenza, detenzioni amministrative, regolamenti temporanei, quote. Schengen, Dublino I Dublino II, Dublino III. Basta, non c’è più. Finito. Tutto finito. Le hanno cambiate con una camminata lunga un mese o due: Siria-Svezia.
Decine di manifestazioni (sorrido tra me e me) da adolescente ventenne, lotte in strada all’università. Mai riusciti a cambiare una virgola in una legge negli ultimi vent’anni. Nemmeno un capoverso, maledettissima Italia. E loro invece? Arrivano e le cambiano! Facile facile, come sedersi sull’arena, osservare il mare e l’orizzonte, il moto dei gabbiani, infilare il proprio odorato nella brezza: tutto è santo. è meraviglia.
(Ma nel momento in cui guarderemo la natura come naturale tutto sarà finito. Addio mare, addio cielo).
Chiamo Ali, il mio amico iracheno, e gli annuncio: i bambini si stanno riprendendo l’acqua dell’Eufrate! Abbiamo già scherzato un sacco di volte sui due fiumi, ride, mi chiede, e come? Gli dico che mi trovo al parco e ci sono i piccoletti siriani che giocano a pallone a piedi nudi su quell’erbetta turca di un verde tanto sgargiante: si riprendono il fiume. In piena estate con 45 gradi questi turchi annaffiano tutti i giorni parchi, automobili, negozi: persino gli spartitraffico delle autostrade sono prati inglesi. Mostruose dighe hanno permesso a questo paese di diventare il granaio del Medio Oriente. Agricoltura intensiva e via a mercanteggiare. Senza preoccuparsi se si sommergono città antichissime e interi siti archeologici o se si inaridiscono altri paesi. Ma gli uni sono kurdi, gli altri siriani o iracheni. Ali recita le parole di un vecchio poeta di Baghdad, Abd al-Wahhab al-Bayyati, è un epoca in cui nemmeno più le anime si prendono cura delle altre o osano ribellarsi. Si intenerisce anche lui ogni tanto, forse rapito da qualche ricordo della sua Mosul quando ci si poteva lavare via la polvere della strada con un bel tuffo nel Tigri o quando si poteva pisciare in santa pace sui ruderi di Ninive, tra sterpaglie e fiori di ortica. Mi dice che non devo rimproverare troppo la Turchia perché si sta prendendo più di un milione di persone mentre voi (europei) prima li bombardate e poi li lasciate morire come cani, in mezzo al mare. Gli dico che lo sta facendo per convenienza politica e strategica e anche perché in fondo non potrebbe fare altrimenti. E che la smettesse di darmi dell’europeo. Mi prende in giro e dice che sono solo un turista. Gli dico che fanno bene a rubargli l’acqua allora, e ci mettiamo a ridere.
Incontro una ragazza, amica di amici, mi dice di essere siriana, le chiedo di dove, in arabo, mi chiede dove hai imparato l’arabo le dico in Palestina mi dice di essere palestinese le chiedo di dove mi dice di Haifa. Dopo una breve pausa aggiunge: mia nonna ha le chiavi di casa. Poi: ci sei stato? è bella Haifa? Mi torna alla mente un lungo poema di Mahmoud Darwish che parla di quest’uomo di Haifa rifugiato nel sud del Libano, che un giorno parte con la sua barchetta e si dirige verso sud e vuole tornare in Palestina, nella sua cittrà, Haifa. Rema finché non lo fermano i soldati israeliani. Le dico che Haifa è bella, anche se in realtà non mi è piaciuta molto, le preferisco Acca. Mi dice che suo nonno invece era un posto vicino a Tiberiade e che ogni tanto ritira fuori la storia del cane che aveva da bambino e che aveva abbandonato a casa nella fuga. Poi mi dice che è nata a Yarmouk ma cresciuta ad Aleppo. Le dico: non finite mai di muovervi voi palestinesi, eh? Sorride e mi dice si però sono stanca! Dopo l’inizio della guerra è andata a Beirut dove ha vissuto dal 2012 fino a qualche mese fa e poi è venuta in Turchia; quest’estate ha provato di arrivare in Grecia ma non ci è riuscita, mi fa capire che si è trovata in una situazione poco piacevole e non indago oltre. Si è messa a lavorare con un organizzazione umanitaria qui. Parla un ottimo inglese, e arabo madre lingua. Un po’ di curdo. Il turco non le piace anzi non le piacciono i turchi, non si sa mica quello che stanno combinando e chi pagano. Le dico di non dirlo troppo forte, sorride. La sera fumiamo un narghilè e mi racconta la storia di sua zia, la moglie del fratello del padre. È scappata da un Aleppo in fiamme un paio di settimane fa. Doveva passare i check-point governativi per andare nella zona controllata dai gruppi ribelli e poi arrivare qui in Turchia. Era con il figlio, ricercato perché doveva fare il servizio militare. Al check-point ha dato al soldato (del governo) la carta d’identità dell’altro figlio che si chiama Ibrahim ed è in Germania. Il soldato l’ha consegnata a un ufficiale e questi le ha detto: signora ci dica la verità ed io la aiuto. Come si chiama suo figlio? Ibrahim. Allora sono andati dal figlio e gli hanno detto: come ti chiami? Ibrahim. Li hanno tenuti un’ora. Dopo di che l’ufficiale è tornato dalla donna con la carta d’identità in mano e le ha detto signora, ora è disposta a dirci la verità? Come si chiama suo figlio? Ibrahim. Hanno preso il ragazzo e gli hanno detto: come ti chiami ragazzo? Ibrahim. Li hanno trattenuti per un’altra ora. Poi l’ufficiale si è avvicinato alla donna di nuovo e lei lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: è Mohammad, ha un cancro e dobbiamo andare di là. Dopo un cenno i soldati hanno portato via il ragazzo che è riapparso poco dopo zoppicante e col viso tumefatto. Dopo essere stati respinti la donna ha fatto il giro di mezza Siria passando per altri check-point da sud verso ovest e poi risalire. Stringendo tra i pugni quelle prescrizioni mediche che erano la sua unica risorsa e salvezza. Il suo lasciapassare e quello del figlio malato. E’ riuscita ad arrivare nella zona dei ribelli, e infine in Turchia. Ieri, mi ha detto Yasmin guardandomi negli occhi, si è presentata a casa mia ed era stravolta, coi vestiti logori. Le ho offerto di fare una doccia, le ho passato dei soldi, ha rifiutato. Mi ha detto che suo figlio era già arrivato a Izmir e lei doveva raggiungerlo perché non aveva con sé i documenti medici e dovevano andare in Grecia e poi in Germania al più presto. I medici ad Aleppo le hanno detto che non potevano farci niente. Ma in questo caso, aggiunge Yasmin, anche se non ci fosse stata la guerra non sarebbe stato diverso.
Guardo Yasmin che soffia fumo dal becco legnoso del narghilè e sorseggiando la sua birra dice – come si trattasse di un romanzo – che storia, eh? Io fuori dalla portata della parola, la osservo, annuisco a tutto quello che dice, provo grande imbarazzo. Le chiedo se riproverà a imbarcarsi, mi dice distrattamente: sì, forse. È stato come chiederle se domani viene a piovere.
“La separazione è sempre dolorosa!” ripete la voce meccanica di google translator mentre due visini mi sorridono di là dello schermo. Rania e Lana giocano divertite, sono venuto a trovarle perché stasera è la vigilia della loro partenza per la Germania. Sono eccitatissime, non saprei dire se tristi o felici, forse entrambe le cose. Hanno finalmente ottenuto il visto tramite il ricongiungimento familiare, perché la loro mamma, un anno esatto fa, ha traversato in qualche stiva. Dopodiché si è regolarizzata, ha pazientato dodici mesi senza marito e figli, con l’ausilio dei servizi sociali tedeschi ha studiato la lingua, trovato casa, lavoro e ora ha potuto finalmente chiamare tutti a sé. Ahmad, il marito, ha un bel sorriso da adolescente nonostante gli ultimi due anni gli abbiano scolpito rughe che la sua discreta posizione sociale ad Aleppo non aveva previsto punto. È un padre premuroso e ha fatto di tutto perché Rania e Lana continuassero a suonare (hanno deciso di non mandarle a scuola e aspettare la Germania), e Khafif (mentre scrivo è fresco fresco di diciott’anni) invece finisse la scuola in Turchia. Non dev’essere stato facile per nessuno, né per la mamma sola, lontana ed estirpata dei figli, né per lui a far collare la famiglia e tutti gli attriti adolescenziali pervertiti dall’orrore cui sono stati sottoposti. Ha responsabilizzato Khafif il più grande, e tentato di imbrigliare quel diavoletto che è Lana. Ma forse, la cosa più difficile è stata di rassicurare Rania, la più piccola, timida e introversa, ma ricca di un’intelligenza profondissima.
Ed eccoci qui alla vigilia della partenza: Khafif ha appena finito la scuola e Rania e Lana mi fanno l’ultimo concertino personale. Sono molto felice, queste due piccolette mi sembrano in grado di levare ogni pietra dal cuore del padre che le guarda sottecchi col sorriso di soddisfazione tipico del genitore. Sono mesi che mi hanno portato Fairuz con la loro voce e i loro strumenti: Lana suona il violino, Rania la chitarra. Guardo Salime mi viene da ridere pensando al momento in cui la prematura vivace bellezza delle figlie sboccerà come un melograno folgorando la povera razza germanica: quanti grattacapi che avrà il mio amico! Suonano, ma Rania è costretta a fermarsi di tanto in tanto perché le si congelano le dita e non può continuare a pizzicare le corde: perde sensibilità. Salimmi ha già spiegato in un’altra occasione che da quando la madre è partita, Rania ha cominciato ad avere questi disturbi agli arti. Rania guarda imbarazzata il padre, come a dire, eccoci di nuovo, e si strofina con violenza le mani tra loro. Le dita sono violacee. La separazione è sempre dolorosa. Penso a Rania cosi timida e silenziosa, quanta guerra c’è in lei e quanto dev’essere stato difficile dire addio alla madre che partiva in nave. Chissà se ne conosceva i rischi. Credo di sì, possiede quell’arguzia dei timidi cui non sfugge nessun dettaglio. Lo vedo da come si muove, dalle domande che mi pone (la timidezza ora che mi conosce meglio si è fatta furba discrezione) in cui echeggiano sempre pezzi di conversazione che ho avuto col padre (seppur queste avvengano in un inglese che lei capisce pochissimo) o dalle parole in italiano che ripete alla perfezione a settimane di distanza, e mi sussurra come un segreto tra me e lei.
Lana invece è una bottiglietta d’aranciata frizzante, non si ferma un attimo, trova sempre un pretesto per dire la sua. Gioca, ride, prende e si fa prendere in giro. Un giorno, mentre mi spiegava quanto fosse brava a suonare il violino l’ho interrotta e facendo finta di sgridarla le ho detto in inglese: ah! come siamo modesti! Ha guardato il padre con quel naso da scoiattolo curioso e gli ha chiesto in arabo: cosa significa humble? Da quel giorno è peggio di prima e non fa altro che lodarsi e compiacersi e concludere con un: ai eem veery veeery humble!! E giù a ridere… Lana e Rania hanno due piccoli nei sulla parte destra del mento, seminati nella stessa posizione obliqua, come una costellazione che finisce sull’arco delle labbra. Penso che se riuscirò a conoscere la loro mamma, per prima cosa andrò a cercarle l’orsa maggiore sul volto. Le rivedrò in Germania probabilmente.
È la vigilia della partenza e Salim si affaccia più del solito sulla memoria: mi parla della loro fuga da Aleppo. La peculiare intimità che comportano gli addii lo spinge a dire più cose, a indugiare sui particolari, a metterci anche l’emozione. Non tutti quelli che hanno fuggito le porte dell’inferno sono disposti a parlarne, al contrario. La memoria è “legittima difesa” e poi ci si snerva nel rispondere sempre alle stesse domande. C’è un doppio binario. Il primo è la consapevolezza più o meno intimamente dichiarata che la memoria è fallace. Prendo in prestito il termine che ha usato Primo Levi con raffinata lucidità per arrivare al secondo, analizzato anch’esso dal grande chimico-scrittore italiano: la vergogna. Quella sorta di vergogna che si prova nel raccontare, superstiti del vuoto, davanti agli occhi vergini di chi non sa cos’è l’orrore.
Salim mi racconta di come l’appartamento in cui vivevano si sia trovato, a un certo punto, sulla linea di divisione tra ribelli e forze governative. Il palazzo, appena fuori della città vecchia di Aleppo, sorge esattamente in un incrocio che era divenuto di cruciale importanza militare. Accende il portatile, mette google map e zoomma fino a mostrarmi il palazzo. Mi spiega le forze in campo, le vie, i punti strategici. Il posizionamento dei cecchini. Era così due anni fa, ora è tutto cambiato. Mi mostra come i governativi avevano occupato l’ultimo piano del palazzo dove viveva mentre i ribelli tenevano sotto controllo il territorio che comincia dall’altro lato della strada. Si erano ritrovato in mezzo a due fuochi. I governativi sparavano dal tetto e i ribelli rispondevano sull’intero palazzo, probabilmente credendo che lì vi fossero soltanto soldati e cecchini fedeli al presidente. E invece gli altri piani erano ancora abitati da famiglie.
Poi mi mostra il terrazzo del salotto, comincia a spiegarmi qualcosa ma siamo interrotti da Khafif che entra all’improvviso nella conversazione. Indica il terrazzo della sua camera, più esposto ai colpi dei ribelli, e corregge il padre su alcuni dettagli. Salim lo guarda stupito e pensieroso. Poi il figlio aggiunge: ti ricordi papà quando siamo andati a prendere i vestiti in camera mia? Abbiamo strisciato fino all’armadio per evitare le pallottole e poi, usando il vecchio bastone, abbiamo agganciato la mia roba? Salim sorride imbarazzato, come se non ricordasse. Mi dice che durante quel mese in cui erano rimasti in trappola non sapeva come comportarsi, era stordito. Aveva passato notti insonni, non solo a causa degli spari, ma perché attanagliato dalla responsabilità. Sapeva che doveva prendere una decisione, prima o poi. Aggiunge: l’unica cosa che mi rendeva “relativamente” tranquillo era che i ribelli non avevano armi che potevano colpire in modo grave, o distruggere il palazzo. All’epoca avevano solo piccoli calibri e miravano ai corpi. Bastava stare fuori dal loro tiro. Mi ricordo che al tramonto il sole creava una traiettoria di luce che entrava in salotto illuminandolo perfettamente: in quei momenti dovevamo stare particolarmente al riparo. Io dormivo in quella stanza perché c’era la televisione e cercavo di capire cosa cavolo stava succedendo nel paese: la guerra era scoppiata cosi, da un giorno all’altro. Ricordo che una volta una pallottola mi ha sfiorato la nuca e si è infilata sul muro a un palmo sopra la mia testa.
Il palazzo era costantemente sotto tiro e la cosa incredibile è che due vie più in là la vita scorreva tranquillamente, negozi aperti, gente in giro, il solito traffico aleppino. Quella era la parte governativa. L’altra era l’inferno delle bombe sganciate dai jet governativi e tutto il resto. Io oltretutto ero stato rilasciato da poco, dopo aver passato tre mesi in cella (qui non si dilunga ma avverto una lieve esitazione) perché i governativi mi avevano arrestato: avevo preso parte alle manifestazioni all’inizio della rivoluzione, dimostrazioni pacifiche e piene di speranza. Ma poi avevo lasciato perdere, quando le cose avevano cominciato a cambiare piega.
Quando mi hanno rilasciato sono corso a casa ma qualche giorno dopo i militari del governo hanno occupato il tetto del palazzo. Ora, coi soldati al piano di sopra ero sicuro che mi avrebbero riconosciuto e ammazzato. Ero considerato uno dei ribelli! Ma dopo qualche scambio di battute con gli ufficiali che perlustravano le case avevo capito che la comunicazione tra i soldati e i servizi segreti non era poi così lineare (spesso gli uni disprezzano gli altri), quindi non si sono troppo curati di me.
Mi dice come la guerra sia arrivata in città, da un giorno all’altro, senza preavviso, come la pioggia… ma a questo punto Khafif rientra violento nella conversazione (è la prima volta da quando lo conosco che lo vedo sgusciar fuori dalla sua giovane età e cambiare voce e atteggiamento) e dice ti ricordi papà quella macchina schiacciata dai carri armati? Era una giornata come le altre e dal terrazzo avevano visto un’automobile che a un certo punto si era trovata davanti un carro armato, sbucato dall’angolo. Il guidatore è uscito dalla macchina e gli hanno sparato, dice Salim ma Khafif aggiunge: sì ma non lo hanno preso, è scappato in mezzo ai cespugli di quel palazzo, aggiunge indicando lo schermo. Salim lo guarda di nuovo con stupore. Ma hanno schiacciato la macchina coi cingoli! esclama il figlio ancora incredulo.
Allora Khafif entra al centro della discussione e si mette a raccontare una storia pure lui ma questa volta si rivolge al pavimento, non a me. Sono sceso giù per comprare qualcosa da mangiare al negozio all’angolo. Eravamo affamati, stipati dentro casa coi soldati sul tetto. Quando sono uscito dal portone del palazzo c’erano tutti soldati intorno. Uno di loro, giovanissimo, mi ha chiesto se potevo comprargli un panino. Ho risposto che certamente lo avrei fatto. Il tempo di correre al negozio, prendere qualcosa al volo… dopo due minuti l’ho trovato in una pozza di sangue. Ero immobilizzato dal panico. Sono rimasto come uno scemo davanti a quel corpo col panino in mano finché non ho realizzato che tutti mi stavano gridando di scappare. Ero terrorizzato dal rumore dei colpi che venivano dall’altra parte ma anche dai soldati stessi. Non sapevo cosa fare col panino, dice sorridendo imbarazzato. Ricordo solo che poi sono tornato in me, mi sono allontanato. Un altro soldato mi ha preso il panino dalle mani, mentre a un altro fu ordinato di andare a rimpiazzare il morto. Khafif stacca gli occhi dal pavimento e torna al presente come dopo una lunga trance: mi guarda con occhi acquosi come a sincerarsi che abbia anche io partecipato al suo monologo interiore.
All’epoca Khafif aveva quindici anni, mentre lo vedo con quel panino in mano penso all’accelerazione esistenziale narrata da Paolo Dall’Oglio, prima che lo rapissero.
Infine Salim mi racconta il giorno in cui ha deciso che era ora di andarsene dal palazzo. Una mattina lui e sua moglie avevano notato due fori perfetti nelle colonne di cemento armato della casa. Ho capito che erano armi nuove. Non c’era da fare altro che radunare in fretta le cose e andare via. Quello era il segnale: la guerra stava evolvendo. Torna a mostrarmi il palazzo su google map, e indica, vedi? Siamo passati di qui e poi abbiamo preso la macchina che era parcheggiata proprio vicino a quel palo e infine siamo scappati. No, papà, dice Rafif. Siamo scappati tutti a piedi verso la parte sicura della città e tu sei tornato da solo a recuperare la macchina. Me lo ricordo, benissimo.
Vedo Salim che guarda Khafif e li lascio al loro stupore di padre e figlio, alle loro memorie complementari e sovrapposte che fondono l’insonnia, gli incubi, le opzioni, le strategie e i ripensamenti per sfuggire alla morte. Ora stanno parlando di quando scapparono da casa, ma parlano tra di loro, non più a me; io osservo lo schermo del computer e penso che se il portone del palazzo avesse dato sulla strada principale invece che sul retro un cecchino li avrebbe sterminati uno ad uno, quando scapparono. Penso a Sarajevo, che è stata la mia prima guerra e il mio primo assedio. Penso che nella guerra conta tutto, ci vuole abilità, arguzia e tanta fortuna. Ci vuole coraggio. Ma nessuno di questi ingredienti è in grado di garantirti la vita.
Rania e Lana si annoiano, scalpitano come si scalpita prima di una partenza come questa: è giunto il momento dei regali. Le porgo i braccialetti che ho portato mentre con la coda dell’occhio vedo Salim che dice a Khafif di portarmi qualcosa. Arriva con un backgammon di legno e mi dice, ci tengo a questo, portatelo in Italia. Le separazioni sono sempre dolorose, dico a Rania e Lana prima di abbracciarle. Poi dico loro che quando ci vedremo le porterò a Venezia, sono tutte contente.
La mia amica mi ha mandato un messaggio, la Grecia è bella, le piace un sacco, quando sarà finita tutta questa storia ci ritornerà in vacanza. I greci mi piacciono scrive. Sono come noi: strillano per ogni cosa. Il mare è bello anche se non so nuotare, lo guardo. Non l’avevo mai guardato così, in Siria. Ora è un valore. Le faccio un’infinità di domande, sono curiosissimo. Ma non risponde più. Riappare dopo qualche giorno, mi racconta parte del viaggio, ancora via sms: è arrivata a Bodrum e da lì si è imbarcata per Kalimnos. L’hanno portata al campo ma era pieno, ora sta in un hotel. È contenta. Poi scompare di nuovo. Ancora qualche giorno e un numero olandese mi dice che è arrivata dal fratello. Sono felicissimo. Mi dice ti posso chiamare, le dico certo. Ha la voce che brilla. Adesso si riposerà per qualche giorno e poi andrà dalle autorità. La metteranno in un campo, mi dice. Mi ci terranno spero non più di una quindicina di giorni e poi mi sposteranno in un altro. È un passaggio obbligato, se voglio la residenza. Fanno tutti cosi. Dovranno intervistarmi per l’asilo. Dopo qualche giorno mi scrive dal campo: è affollato di gente che viene da ogni dove, si sente fuori posto, è molto sola, ma si è fatta un amico. Mi invia una foto di lei che sorride con un bimbo nigeriano. Gli occhi tristi, ma hanno la bellezza di chi sta vivendo la propria storia.
Siedo in un piccolo caffè in Libano, in Turchia, in Giordania, non ne sono più cosi sicuro.
Il giardino interno è in stile aleppino, pavimentato di pietre fresche, alberi di agrumi, un pozzo, tavolini bassi dove non so mai come infilarmi. Fumo profumato di narghilè e il rumore delle pedine del backgammon. Il caffè è frequentato da molti ragazzi siriani. Discutono vivaci e aspettano. Scrivono e aspettano. Si guardano, sorridono e aspettano. Molti di loro hanno partecipato ai primi fermenti della rivoluzione, quando si andava per le strade e la polizia cominciava a torturare e a sparare. Hanno visto il sangue dei primi caduti e hanno strillato in faccia agli aguzzini in divisa. Sono tornati in strada più arrabbiati e più numerosi. Finché la rivoluzione è cambiata. Finché abbiamo cominciato a odiare la parola “rivoluzione”, mi ha detto una giovane archeologa siriana, un giorno, come a marcare “il punto di non ritorno”.
Kapuściński mi ricorda che quel momento è uno dei massimi enigmi della storia. E dell’umanità mi verrebbe da aggiungere. Questi ragazzi sono “quell’uomo della folla che ha smesso di avere paura” di cui narra il reporter polacco. Il poliziotto incontra il dimostrante in mezzo alla strada, lo minaccia, ma lui rimane impassibile. Non c’è più quella terza persona tra poliziotto e ribelle: la paura. L’uomo rimane, la folla rimane. Il poliziotto torna indietro e dà ordine di sparare. Il potere, tronfio e pieno di sé esagera in arroganza e perisce. Il despota è convinto che l’uomo sia una creatura vile perché è circondato da persone vili. Ma morire per un dittatore o morire per la libertà non è la stessa cosa.
Forse è dentro questa frase che cerco di districare quei fili che prima mi strangolavano. Si dice spesso (in Europa) che la rivoluzione siriana – e quelle arabe in generale – siano primavere tradite, fallite, trasformatesi in qualcos’altro. La violenza, la brutalità, le bombe barile, l’estremismo islamico e via dicendo. E lo si dice con quel fatalismo che non si cura nemmeno di nascondere la spocchia (tutta occidentale) da cui è generato.
Quello di cui non si parla mai invece è il tradimento della democrazia, di questa Europa tronfia e piena di sé, che ha dimenticato le sponde natie di Tiro, e che guarda il mediterraneo – non da nord verso sud – ma dall’alto verso il basso. Stati di emergenza che vengono prolungati da governi di transizione: è un Unione che si stringe intorno al proprio deficit di libertà e di identità, che non sa più a quale paese vicino riempire le tasche, a chi fare capacity building sulla sicurezza. E di nuovo quella sinistra tolleranza verso i fascismi che aumentano le proprie leve, masturbandosi nella paura sociale..
Forse per alcuni moralisti delicati, cinici dell’intelletto, anche questo è fisiologico. Ché in fondo la Storia umana non è che guerra, interrotta da brevi periodi di pace. Ma io dico, con Primo Levi, che nessuno storico o epistemologo ha ancora dimostrato che la storia umana sia un processo deterministico. Se ne discuterà tra pochi anni, quando i giovani rifugiati parleranno la nostra lingua. Sarà una bella prova, allora, trovare l’ordine del discorso. E non sarebbe male cominciare adesso.
- l’autore scrive sotto pseudonimo




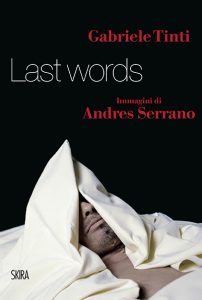


 Sono dentro.
Sono dentro.






 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo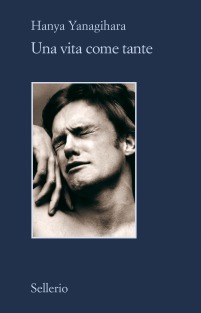
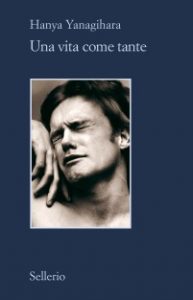 di Alessandro Garigliano
di Alessandro Garigliano

