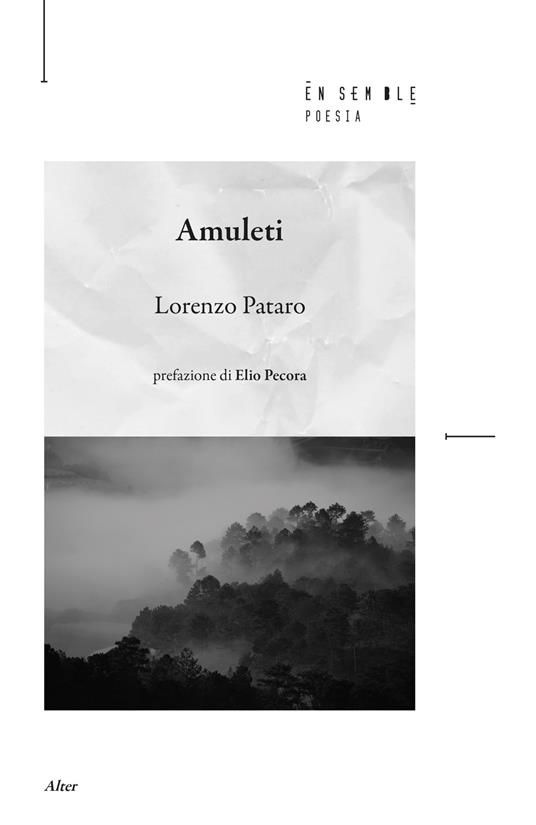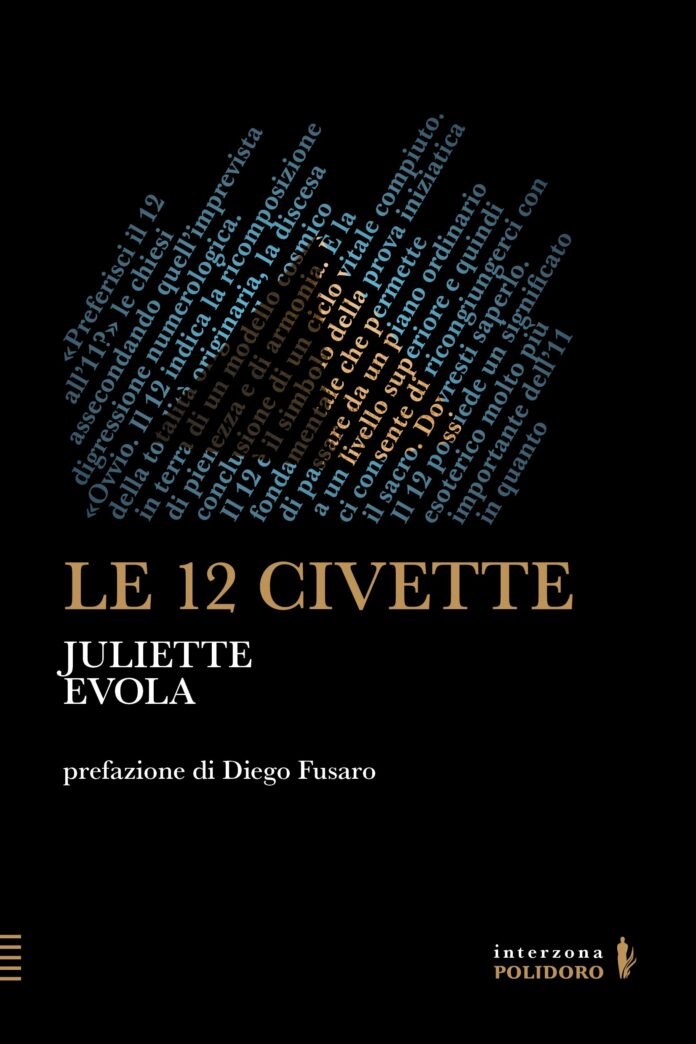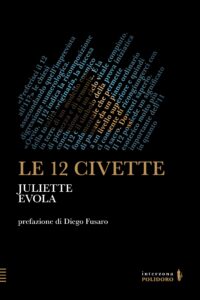di Sergio Oricci
Mio padre tra la seconda metà degli anni ’80 e i primi anni 2000 ha riempito decine, se non centinaia, di quaderni. Nel 2002, ma potrebbe essere stato il 1999 come il 2005, me ne ha donati alcuni, circa una ventina. Nel 2024 ho deciso di realizzare un’opera intitolata “Esercizio di copiatura (da un quaderno di mio padre)”. Con questo testo proverò a spiegare per quale motivo non verrà pubblicata.
Le poche righe di cui sopra sono l’unica premessa che sento il bisogno di condividere, e nel testo che segue non entrerò nello specifico del contenuto dei quaderni di mio padre, contenuto che in ogni caso è assimilabile all’idea che chiunque potrebbe avere di ciò che è possibile o meglio probabile trovare sfogliando dei quaderni: testi e immagini, i primi scritti e le seconde disegnate interamente a mano. E, oltre a non parlare di quello che è stato scritto e disegnato su quelle pagine, non parlerò neanche di diagnosi.
Ricordo il giorno in cui mio padre mi ha donato i quaderni; mi ha detto magari riuscirai a tirarne fuori qualcosa, un giorno; lo ricordo nello stesso modo in cui Vitaliano Trevisan ricorda il luccio che afferra al volo la rondine al parco Querini[1] a Vicenza; Trevisan ne parla, attraverso il personaggio di Thomas, in Un mondo meraviglioso[2] e ne parla dichiarando di non essere sicuro, o meglio di non poter essere sicuro, che si tratti di un ricordo e non di qualcosa che è avvenuto solo nella sua testa, anche per via di un’illustrazione praticamente identica alla scena in questione – un luccio che afferra una rondine – che ricorda, in questo caso con certezza, di aver visto un certo numero di volte in un libro illustrato sugli animali[3]. Dunque ecco, anche io in effetti sono abbastanza sicuro di ricordare mio padre pronunciare proprio quelle parole mentre mi porge il faldone con i quaderni, quindici o venti: magari riuscirai a tirarne fuori qualcosa, un giorno; eppure anche io – pure in assenza di illustrazioni relative a un padre che passa un faldone per documenti a un figlio in un ipotetico ma in questo caso inesistente libro illustrato sugli esseri umani – mi trovo costretto a dubitare del mio essere abbastanza sicuro e quindi a dover rivalutare non tanto la mia sicurezza in quanto tale ma il fatto che sia una sicurezza sufficiente per farci affidamento. C’è un certo margine di dubbio soprattutto relativo alla possibilità che, a distanza di almeno vent’anni, abbia costruito questo ricordo – non il ricordo di mio padre che mi dona i quaderni, che non è in discussione, ma quello delle parole da lui pronunciate – per trovare una giustificazione al fatto che oggi voglia appropriarmi dei quaderni di mio padre e intervenire su di essi, e soprattutto per convincere prima me stesso e poi gli altri che questa opera, questa idea di opera, questa volontà di intervento che in parte si è già concretizzata in un intervento che a questo punto non credo vedrà mai la luce se non nell’oscurità della mia sporca coscienza e delle mie stanze, non abbia bisogno della firma di mio padre, non abbia bisogno della sua autorizzazione, non abbia bisogno del suo nome.
Come accennavo, non ho alcun interesse a parlare qui del contenuto dei quaderni, perché il mio intervento resterebbe esattamente lo stesso qualsiasi fossero le parole messe in fila e le immagini e i grafici e gli elenchi puntati eccetera eccetera; ma ho interesse a parlare invece della mia opera, quella che avrei voluto realizzare ma che non realizzerò per questioni che riguardano il muro su cui mi sono scontrato quando ho provato a mostrare il mio lavoro, o meglio parte di esso, a chi pensavo potesse capirlo, perfino per accoglierlo; e non mi sbagliavo, o meglio non mi sbagliavo al 50%: erano le persone giuste per capirlo, e infatti l’hanno capito, ma non le persone giuste per accoglierlo, e infatti non l’hanno accolto. Le questioni etiche che l’appropriazione del lavoro altrui apre sono diverse e sono complesse, e ho compreso le obiezioni che in fondo neanche ci sono state, le perplessità che in fondo neanche ho dato il tempo di esprimere fino in fondo, perché sono stato io il primo a fermarmi quando ho capito che il mio intervento era stato frainteso, e che era stato frainteso per colpa mia.
L’opera avrebbe dovuto o almeno potuto essere realizzata e fruita da due diverse prospettive: performativa e testuale. La dimensione performativa doveva consistere in una situazione in cui un soggetto (il figlio) chiuso per un certo numero di ore in uno spazio espositivo insieme all’oggetto (i quaderni del padre) si produceva in un esercizio di copiatura. Riga dopo riga, pagina dopo pagina, quaderno dopo quaderno, avrebbe dovuto copiare interamente tutto quello che era contenuto nei quaderni su altri, differenti, simili, perfino identici, supporti. Il soggetto e l’oggetto avrebbero dovuto essere in qualche modo isolati da un pubblico, qualora ce ne fosse stato uno, per esempio chiusi in un cubo di plexiglas all’interno di una delle stanze dello spazio espositivo, in modo da permettere a chiunque fosse entrato di avere una visione completa del gesto, dell’atto performativo in sé, ma una visione solo parziale degli oggetti (i quaderni del padre e le copie dei quaderni del padre realizzate dal figlio) e del loro contenuto. Gli oggetti quindi sarebbero rimasti a margine dell’azione, perché quello che al soggetto interessava mettere in movimento era la relazione tra soggetto e oggetti e magari la distanza tra soggetto-figlio e soggetto-padre, cioè il modo in cui l’assenza reciproca dell’uno per l’altro agiva sull’azione stessa. Questo per quanto riguarda la dimensione performativa, che di fatto è stato il punto di partenza da cui è scaturita l’idea dell’intervento, ma che comunque si sarebbe, se mai fosse stato possibile, concretizzata solo in un secondo momento, perché l’azione performativa si scontrava con una serie di difficoltà esterne al soggetto che sarebbe stato necessario prima affrontare e poi provare a risolvere ma che avrebbero potuto perfino mandare a monte l’intero progetto se il soggetto, cioè io, avesse deciso di andare prima in quella direzione e solo in un secondo momento in quella della realizzazione di un secondo oggetto testuale o meglio documentale. C’era questo rischio perché avrei dovuto trovare un luogo, uno spazio espositivo a cui interessasse ospitare l’azione di uno sconosciuto, senza nessuna esperienza pregressa nel campo della performance art; questo avrebbe richiesto del tempo, e mentre il tempo passava avrei potuto perdere contatto con l’idea, demoralizzarmi, cosa che avrebbe messo fine alla questione prima ancora di aver compiuto anche solo un piccolo passo. È per questo motivo dunque che ho scelto un approccio credo controintuitivo e, invece di documentare la performance con il risultato dell’esercizio di copiatura o con un lavoro di sintesi successivo all’esercizio di copiatura, ho scelto di realizzare prima la sintesi, prima il documento, o almeno una parte del o dei documenti, una parte necessaria intanto ad avere qualcosa tra le mani, che è sempre d’aiuto quando non si riesce a liberarsi di un’idea. Era importante spostarmi il prima possibile in un laboratorio, sperimentare, mettermi e mettere l’idea in movimento per poi in qualche modo fermarne almeno un segmento, una parte, in un determinato momento e in un’unità di spazio concettuale ma anche fisico, anzi direi più fisico che concettuale in quanto è lo spazio fisico (un foglio di carta, un file) che aiuta a mettere ordine al caos mentre lo spazio concettuale è tanto caotico quanto il numero di volte in cui è possibile immaginare qualcosa dandogli forma e sviluppi che sono certamente possibilità del linguaggio, della messa in scena, dell’espressione di una certa manualità che l’autore o chi per lui può avere o non avere quando si troverà a uscire dal pensiero e a entrare nell’azione. Il laboratorio e l’esperimento sono i luoghi in cui le cose accadono prima di accadere o perfino i luoghi in cui alla fine le cose accadono e basta. E quindi è proprio uscendo dal pensiero, dall’unità di spazio concettuale, ed entrando nell’agire e nell’unità di spazio fisico, che è possibile capire se un’idea sia o non sia realizzabile e se sia o non sia possibile metterla in atto come la si era pensata, e quali sono le reali possibilità e i limiti, propri e dell’idea stessa.
Ho allora iniziato con uno dei quaderni, il mio preferito se così si può dire, e ho scelto di copiarne il contenuto mettendo tra me e l’oggetto degli strumenti formali e tecnologici, dove per strumenti formali intendo le mie decisioni in merito a cosa trascrivere e cosa non trascrivere, a quali immagini copiare e quali non copiare; li chiamo strumenti formali perché le scelte dovevano riguardare l’oggetto di partenza e quello di arrivo in termini di struttura e di quanto la sintesi fosse formalmente aderente alla fonte da cui veniva estratta, e fare una sintesi era un passaggio assolutamente necessario in questa fase perché per capire se il progetto potesse essere portato avanti avevo bisogno, ripeto, di avere qualcosa tra le mani, qualcosa che però fosse significativo e non una selezione casuale di testi e immagini: una sintesi appunto che avesse una forte corrispondenza formale e strutturale con ciò che alla sintesi aveva dato origine; mentre per strumenti tecnologici intendo il computer che ho utilizzato per l’esercizio di copiatura, lo scanner che ho utilizzato per digitalizzare alcune delle immagini, la connessione Internet e lo spazio di archiviazione in cloud che ho utilizzato per assicurarmi che il lavoro non andasse perso, i software di ritocco fotografico che ho utilizzato per capire se fosse il caso di lavorare sulle immagini acquisite per fare in modo che anche quelle scansioni non fossero solo digitalizzazioni delle immagini originali ma miei interventi sulle digitalizzazioni delle immagini originali eccetera eccetera. La necessità di avere qualcosa tra le mani non era, in ogni caso, l’unico motivo per cui ho deciso di fare una sintesi, una selezione: a differenza del momento performativo, durante il quale il pubblico non avrebbe avuto accesso, se non in maniera parziale, al contenuto dei quaderni di mio padre e al contenuto del mio esercizio di copiatura, nel momento in cui avessi terminato la realizzazione del mio oggetto, del mio testo, del mio esercizio di copiatura, e lo avessi fatto non durante la dimensione performativa in cui la distanza tra me e il pubblico, tra il pubblico e l’oggetto, consisteva nella gabbia di plexiglas o in tutto ciò che avrebbe impedito al pubblico di leggere nel dettaglio i quaderni, ma nella solitudine del dialogo tra me e mio padre o meglio tra la mia assenza per lui e la sua assenza per me, ecco in quel caso era indispensabile mettere una distanza tra me e i suoi quaderni e in un certo senso tradurre i suoi quaderni nella mia lingua, che non significava dover modificare la lingua di mio padre ma fare in modo che la lingua di mio padre, nella quale comunque trovavo e trovo una corrispondenza con la mia lingua adulta (la lingua dei miei anni più recenti, in altre parole) in termini di sintassi, di costruzioni ipotattiche e anche per alcuni tic linguistici che sembrano essere passati da lui a me attraverso il materiale ereditario, attraverso la genetica, cosa che peraltro appare del tutto probabile, ecco volevo fare in modo che questa lingua fosse filtrata in qualche modo da me, da me che leggevo e da me che copiavo non copiando tutto ma scegliendo cosa copiare (sì, sì, no, ancora sì eccetera) e come farlo (testo barrato, apice, pedice, corrispondenza nei colori, nei grassetti, e poi ancora copiare a mano, con uno scanner, ridisegnare i suoi disegni, digitalizzarli eccetera). C’era poi un’altra questione, rimasta in effetti irrisolta fino al confronto con, per così dire, il mondo esterno, che riguardava il modo in cui mio padre si avvicinava ai suoi quaderni quando non erano ancora stati riempiti, durante la sua azione di scrittura insomma, e allo spazio fisico e concettuale da loro delimitato. Sì, perché mio padre sovente iniziava a scrivere dalla prima pagina di un quaderno e continuava fino ad arrivare a metà, per poi girare il quaderno e riprendere a scrivere da quella che in teoria sarebbe dovuta essere l’ultima pagina, quindi ruotando l’orientamento del testo di 180 gradi; non riesco a essere certo della sequenza delle sue azioni perché a lavoro finito, a quaderno riempito, il testo dell’ultima pagina orientata in modo X (dall’alto verso il basso) andava a toccarsi con il testo dell’ultima pagina orientata in modo Y (dal basso verso l’alto) e – contrariamente a quanto si potrebbe immaginare – l’ultimo frammento di testo iniziava nelle ultime righe dell’ultima pagina Y e terminava, a testa in giù per così dire, a testa in giù rispetto al suo inizio, nell’ultima pagina X; quindi il modo in cui mio padre metteva in sequenza il ribaltamento doveva essere insomma un modo tutto suo che forse riuscirò a risolvere leggendo e rileggendo tutti i quindici o venti quaderni in mio possesso. Questo testo però si concentra sulla sintesi del primo quaderno e si limita a raccontare del perché l’esercizio di copiatura dei quaderni di mio padre, se pure potrà essere realizzato in modo clandestino e per uso privato, non vedrà mai la luce fuori da me, almeno fino a quando la situazione sarà questa e non cambierà in modo tanto drastico da non rendere neanche più necessario ragionare intorno alla o continuare a lavorare sulla opera in questione, e a quel punto, il peso di questo intervento, la gravità di questa azione, si alleggerirà così tanto da mettere questa idea, questa possibilità del linguaggio, sullo sfondo di qualcos’altro che allora apparirà urgente come adesso appare urgente l’esercizio di copiatura che non potrò realizzare, almeno non come l’avevo pensato, ma che dovrò limitarmi a rinchiudere in questo blocco di testo in cui la mia sintassi e quella di mio padre forse si sfiorano, ma in cui poi tutto si riduce all’impossibilità di toccarsi davvero. La questione dell’orientamento del testo, dicevo, non si è risolta perché dopo alcuni tentativi e alcune prove ho deciso di creare due file differenti: da una parte un file Word in cui il testo, per questioni di leggibilità, sarebbe stato organizzato in modo normale, tutto orientato dall’alto verso il basso e messo in una sequenza che più o meno mi sembrava fosse quella voluta da chi aveva scritto e disegnato, quindi da mio padre; dall’altra un PDF con lo stesso orientamento del quaderno originale, quindi con la necessità, per chi lo avesse letto – se mai qualcuno lo avesse fatto –, di ruotare di 180 gradi il file una volta arrivato a metà, a meno che non si fosse trattato di qualcuno in grado di leggere anche un testo capovolto; in quel caso avrebbe tranquillamente potuto continuare senza ruotare ma sarebbe comunque dovuto andare all’ultima pagina e tornare indietro di pagina in pagina fino a raggiungere di nuovo il centro; il modo più naturale per avvicinarsi a un testo del genere comunque è di farlo così come ci si è avvicinato chi lo ha scritto, dunque ruotando il PDF così come mio padre si era girato il quaderno tra le mani per riprendere a scrivere, presumibilmente, dal fondo.
Una volta terminata la sintesi del quaderno, di cui ero piuttosto anche se non del tutto soddisfatto, ho iniziato a pensare a chi potessi inviarlo per un parere, per un confronto, anche con, magari, l’idea di pubblicarla. Le prime persone a cui ho mandato i due file, capovolto e non capovolto, sono state Nicoletta De Rosa e Roberto Cuoghi, artisti visuali con cui da qualche tempo intrattenevo una sporadica ma intensa corrispondenza e con cui avevo avuto occasione di pranzare, tempo addietro, nel loro studio di Milano un volta, o forse ancora, chiamato Retrobalera, occasione che mi aveva permesso di incontrare anche Alessandra Sofia, altra artista visuale con cui Cuoghi e De Rosa lavorano. Nicoletta De Rosa ha definito la lettura delle pagine faticosissima, cosa che mi è sembrata molto positiva, anche perché secondo lei era proprio la fatica richiesta, anzi imposta, dal testo a essere il suo principale motivo di interesse. Ho poi inviato gli stessi file, Word e PDF alla redazione di GAMMM[4], la rivista di letteratura, critica, installazioni, post-poesia, scrittura asemica e di ricerca, fondata nel 2006 da Gherardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Massimo Sannelli e Michele Zaffarano, tutti autori – ad eccezione di Massimo Sannelli – che al momento dell’invio già conoscevo piuttosto bene, non personalmente ma attraverso i loro testi e i libri da loro scritti e pubblicati. L’invio a GAMMM mi sembrava in effetti l’unica possibilità sensata per il mio intervento, che a quel punto aveva un titolo, Esercizio di copiatura (da un quaderno di mio padre) – a cura di Sergio Oricci, e una sua forma più o meno definitiva seppur duplice, almeno per quello che riguardava la sintesi del primo tra i quaderni. Inviare a GAMMM mi sembrava l’unica soluzione sensata per tre motivi: il primo era che avevo già pubblicato, con l’eteronimo Emanuela Gatti, su GAMMM, una installazione testuale, che di fatto poteva considerarsi un altro esercizio di copiatura, intitolata Una nota su Autoritratto automatico di Umberto Fiori (Garzanti, 2023)[5], che non era solo una nota su Autoritratto automatico di Umberto Fiori[6] pur potendo in effetti essere letta anche come tale: si trattava di un testo installativo in cui avevo usato il pretesto del titolo di un’opera di Umberto Fiori e che consisteva nell’esercizio di copiatura di una serie di indicazioni apposte su una macchina automatica per fotografie in cui mi ero imbattuto a Roma; avevo copiato i testi e sostituito alle immagini dei falsi tag <IMG> </IMG>, e l’idea era quella di far parlare tra loro le macchine automatiche per ritratti che ancora si trovano in giro con una certa frequenza con gli autoritratti automatici di Fiori, facendo forse perfino intuire al lettore quanto poco avessi apprezzato l’opera di Fiori; quindi insomma in qualche modo GAMMM mi aveva già capito e già accolto. Il secondo motivo era che i fondatori di GAMMM erano e sono persone con cui mi faceva e mi fa piacere confrontarmi e dialogare, perché apprezzo le cose che scrivono e perché riconosco quello che fanno e hanno fatto per tutto il grande insieme di scritture definite di ricerca, che è secondo me la zona in cui la scrittura è riuscita a frammentarsi e a espandere sé stessa quanto l’arte visuale. C’è infine un terzo possibile motivo per cui poteva avere senso pubblicare quel testo su GAMMM: Arthur Danto, critico d’arte statunitense, parlando delle Brillo Box di Andy Warhol (a loro volta un esercizio di copiatura), sosteneva che la differenza tra una Brillo Box che chiunque poteva trovare al supermercato e una di Andy Warhol era una certa teoria dell’arte che definiva il significato delle Brillo Box di Warhol al di là del loro aspetto, e che fosse proprio la teoria dell’arte a impedire che l’opera collassasse nell’oggetto che sembrava essere[7]. C’è però un modo per riconoscere un’opera d’arte senza conoscere la teoria dell’arte su cui l’oggetto si poggia? Una risposta, ma non la risposta, si può trovare in una frase attribuita a Marcel Duchamp (ma secondo qualcuno di André Breton), presente alla voce Ready-Made del Dictionnaire abrégé du Surréalisme, curato da André Breton e Paul Éluard[8], secondo la quale un oggetto di uso comune può diventare un’opera d’arte anche soltanto grazie alla scelta dell’artista, cosa che può portare alla possibilità, per il pubblico, di demandare la conoscenza della teoria dell’arte a chi gestisce gli spazi in cui l’arte avviene. E dunque se una Brillo Box si trova in un supermercato, tra asciugamani e casse di birra, probabilmente sarà soltanto un bene di consumo, mentre se si trova alla Stable Gallery di New York, dove l’opera di Warhol è stata esposta per la prima volta nel 1964, allora è probabile che, oltre a quello che è possibile vedere a un primo sguardo, possa esserci qualcos’altro. Non è importante capire cosa ci sia al di là di quel primo sguardo, non è importante sapere quale sia la teoria dell’arte che impedisce all’opera di collassare nell’oggetto che sembra essere, questi dettagli in fondo non ci interessano; la cosa importante è sapere che qualcosa c’è, che una teoria dell’arte può o almeno potrebbe esserci. Non sono completamente d’accordo né con l’affermazione di Danto – le Brillo Box di Warhol differivano da quelle che si trovavano al supermercato anche per materiale e peso, per esempio – né con quella attribuibile a Duchamp – credo che un’opera abbia un valore estetico e una capacità di mettere l’osservatore in relazione con l’oggetto che vanno al di là del contesto in cui viene posizionata e al di là della persona che l’ha realizzata – e sono comunque questioni su cui varrebbe la pena riflettere ancora un po’, ma prendendole per un attimo per vere e lasciando da parte le sfumature, un esercizio di copiatura che resta in un cassetto ha quindi un certo significato, mentre lo stesso esercizio di copiatura pubblicato su GAMMM ne ha un altro, o quantomeno insinua il dubbio in chi lo guarda o in chi lo legge che un altro significato possa esserci, cosa già più che sufficiente per decretare la riuscita, o perfino il successo, di un intervento di questo tipo.
Nel mandare il testo alla redazione di GAMMM però commetto quasi subito il primo errore. Non nella prima mail, in cui spiego brevemente che l’opera è un esercizio di copiatura dei quaderni di mio padre e che è un lavoro che apre per me una serie di riflessioni sia personali sia sulla questione dell’appropriazione dell’altrui frammentazione del pensiero, ma nella seconda in cui, dopo una risposta positiva della redazione in cui mi viene detto che il testo è stato ritenuto molto interessante e dunque meritevole di pubblicazione, in coda al mio messaggio dico che questa volta – a differenza di quando ho usato l’eteronimo Emanuela Gatti per pubblicare Una nota ad Autoritratto automatico di Umberto Fiori (Garzanti, 2023) – se si dovesse pubblicare l’esercizio di copiatura dovrei usare il mio vero nome, per una questione di correttezza nei confronti di mio padre. Con questa mia richiesta, anche se non me ne rendo ancora conto, sto già alimentando il o perfino dando vita al fraintendimento che da questo momento in avanti avrà luogo: il mio esercizio di copiatura (da un quaderno di mio padre) da adesso in avanti inizierà a essere l’opera di qualcun altro o un’opera realizzata in collaborazione con qualcun altro. Un qualcun altro che però è assente. Assente e vivente? Mi viene chiesto. Assente e vivente, rispondo. E che l’errore abbia generato un fraintendimento o meglio il fraintendimento, quel fraintendimento definitivo che non è e non sarà possibile risolvere e da cui non è e non sarà possibile tornare indietro, non a uno stato precedente al fraintendimento se non altro, perché il fraintendimento ormai c’è stato ed è irrimediabile, qualunque cosa io dica o faccia o provi a spiegare, insomma che il fraintendimento ci sia e sia gigantesco e finale è chiaro quando Marco Giovenale di GAMMM mi chiede il nome di battesimo di mio padre e io rispondo scrivendo il suo nome di battesimo e dando quindi a mio padre, assente e vivente o perfino assente ma vivente, una sorta di diritto di firma su un’opera che non è sua ma che adesso non è più neanche mia o che, se anche fosse ancora mia almeno in parte, è altrettanto almeno in parte anche sua e questo significa, così mi dice Marco Giovenale, che avremo bisogno di una sua autorizzazione per pubblicare la mia opera, di un suo consenso per pubblicare queste pagine, che davvero meritano di uscire, mi dice. Io a questo punto non posso fare altro che prendere atto degli errori madornali che ho commesso: avrei dovuto presentare l’opera sì come un esercizio di copiatura, sì come un esercizio di copiatura dai quaderni del padre, ma non come un esercizio di copiatura dai quaderni di mio padre in cui fosse il contenuto dei quaderni a fare l’opera; avrei dovuto presentare il mio lavoro spiegando come l’opera fosse la copiatura in sé e nient’altro, e avrei dovuto subito mettere in chiaro che qualunque cosa avessi copiato, che fossero i quaderni di mio padre, le istruzioni di una macchina fotografica automatica, gli ingredienti di qualche merendina industriale, erano l’esercizio di copiatura e il modo in cui avevo deciso di realizzarlo a contare, molto più dell’oggetto della copiatura. Nel caso specifico, certo, non direi però che si possa completamente ignorare l’oggetto dell’esercizio, perché qualcosa racconta, ma questo semmai è un altro motivo per il quale non c’era, secondo me, bisogno di nessun consenso, di nessuna autorizzazione; provo a spiegarlo così come l’ho spiegato nella mia ultima mail a GAMMM, mail inviata non per convincere Marco Giovenale e il resto della redazione che il testo si dovesse o si potesse pubblicare – quella ormai per me era già una questione chiusa per via degli errori di cui sopra da cui non avrei potuto in nessun modo, ma se è per questo neanche avrei voluto, tornare indietro – ma solo per iniziare a ragionare attorno a un’altra possibile opera, non all’esercizio di copiatura ma all’opera che sto scrivendo adesso, a questo testo: nel momento in cui avessi chiesto il consenso, l’autorizzazione, a mio padre, al massimo lo avrei fatto per aiutarlo a pubblicare i suoi testi magari lavorando con lui, una cosa che certamente potrebbe anche essere interessante e potrei anche voler fare, ma che al momento non posso, o non voglio, ancora fare e che comunque non potrebbe essere fatta in relazione a questo esercizio di copiatura che alla fine non si farà, che non farò. Perché nel momento in cui dovessi chiedere un’autorizzazione e lavorare con lui alla pubblicazione dei suoi testi, si tratterebbe appunto dei suoi testi e non del mio esercizio di copiatura; non esisterebbe più nessun esercizio di copiatura, nessuna necessità di un esercizio di copiatura, perché ci sarebbero già i testi e potremmo pubblicare direttamente quelli, e perché quindi copiare dei testi e pubblicare un esercizio di copiatura di testi e immagini quando si hanno a disposizione già i testi e le immagini originali e c’è perfino il consenso dell’autore a pubblicare quelli? Inoltre non esisterebbe neanche più il tentativo da parte mia di parlare della reciproca assenza di me per mio padre e di mio padre per me, in quanto nel momento in cui dovessi riuscire a parlare con mio padre per chiedergli il consenso alla pubblicazione, perfino ottenendolo, non ci sarebbe più nessuna assenza reciproca ma invece ci sarebbe una presenza, per quanto breve, per quanto più o meno significativa, ma certamente non sarebbe più un’assenza reciproca, ecco, ma ci sarebbero invece due persone che collaborano per rendere dei testi e delle immagini un’opera, che è forse l’opposto di un’assenza reciproca, o se non è l’opposto è comunque qualcosa di lontanissimo da un’assenza reciproca e non credo ci siano dubbi in proposito. Sarebbe come aver preteso che Richard Prince, fotografo statunitense nato a Panama nel 1949, chiedesse l’autorizzazione agli autori delle fotografie che lui ha fotografato nel suo personale esercizio di copiatura; non l’ha fatto, non ha chiesto nessun consenso, perché, proprio come nel caso del mio esercizio di copiatura, se lo avesse fatto, il suo esercizio di copiatura non avrebbe avuto più nessun significato. E, ma è solo una nota a margine, nel 2008 qualcuno (il fotografo francese Patrick Cariou) ha provato a denunciare Prince per violazione del copyright, ma il processo si è concluso con l’assoluzione di Prince perché la corte d’appello ha riconosciuto il rispetto da parte di Prince del fair use[9]. Al di là dei precedenti e delle questioni legali, in ogni caso, Esercizio di copiatura (da un quaderno di mio padre) – a cura di Sergio Oricci, che sarei io, consisteva nell’appropriazione da parte mia dei quaderni che mio padre mi ha donato venti anni fa e che sono oggi, almeno per quella che è la mia percezione, diventati dei documenti di archivio che testimoniano la nostra reciproca assenza, e che io avevo deciso di copiare mettendo tra me e loro, tra me e mio padre, degli strumenti formali e tecnologici. Ci ho provato ma non è stato possibile, un po’ per gli errori di cui ho già detto, un po’ per la natura stessa dell’intervento, che è forse irrealizzabile almeno così come l’avevo concepito, e penso a questo punto di aver detto tutto, che non ci sia altro da aggiungere, e adesso dovrò soltanto fare pace con questa impossibilità e farmene prima o poi una ragione.
[1] “il luccio uscì dall’acqua improvvisamente, senza alcun preavviso, nessuna increspatura, nessun rumore, niente, uscì semplicemente dall’acqua e si contorse nell’aria per poi distendersi in tutta la sua spaventosa e luccicante lunghezza, le fauci spalancate, a ghermire una rondine che, incautamente, si era abbassata un po’ troppo sul pelo dell’acqua.” Un mondo meraviglioso, Vitaliano Trevisan (da Trilogia di Thomas, Einaudi, 2024; pag. 36)
[2] Theoria, 1997; Einaudi, 2003; infine inserito in Trilogia di Thomas, Einaudi, 2024
[3] “Una delle mie illustrazioni preferite era appunto l’illustrazione riguardante il luccio, e tante volte l’avevo guardata e ci avevo fantasticato sopra, che ora non sono affatto sicuro di questo ricordo, non sono affatto certo che questo ricordo, che è comunque un ricordo, sia il ricordo di qualcosa di reale, di un fatto successo, o piuttosto il ricordo di una fantasticheria.” Un mondo meraviglioso, Vitaliano Trevisan (da Trilogia di Thomas, Einaudi, 2024; pp. 36-37)
[4] https://gammm.org/
[5] https://gammm.org/2024/02/22/una-nota-su-autoritratto-automatico-di-umberto-fiori-garzanti-2023-emanuela-gatti-2024/
[6] Garzanti, 2023
[7] “Quello che alla fine fa la differenza tra una Brillo Box e un’opera d’arte costituita da una Brillo Box è una certa teoria dell’arte. È la teoria che la porta nel mondo dell’arte e le impedisce di collassare nell’oggetto reale che è.” The Artworld, Arthur C. Danto, 1964
[8] Domaine français, 1938
[9] “Il fair use (in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto) è una disposizione legislativa dell’ordinamento giuridico degli Stati Uniti d’America che regolamenta, sotto alcune condizioni, la facoltà di utilizzare materiale protetto da copyright per scopi d’informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l’autorizzazione scritta a chi detiene i diritti.” Wikipedia



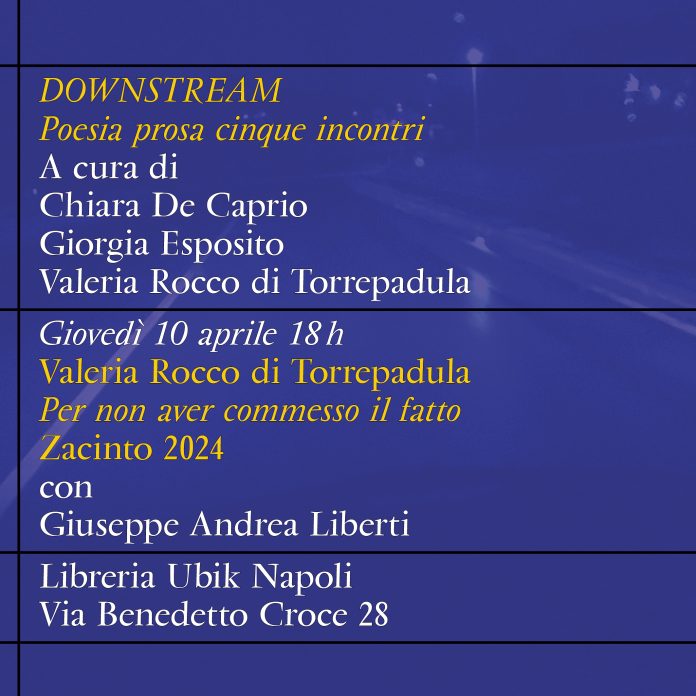
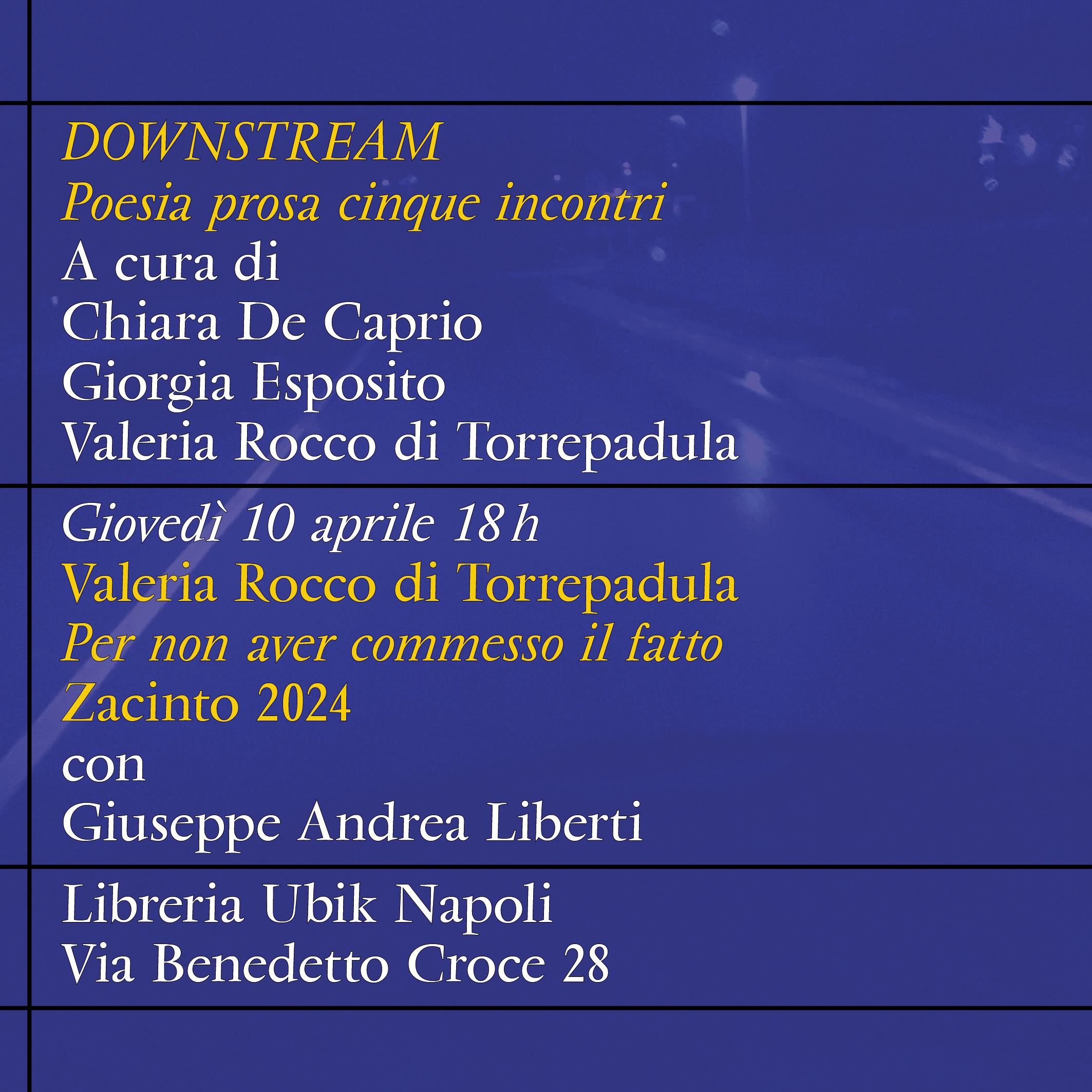



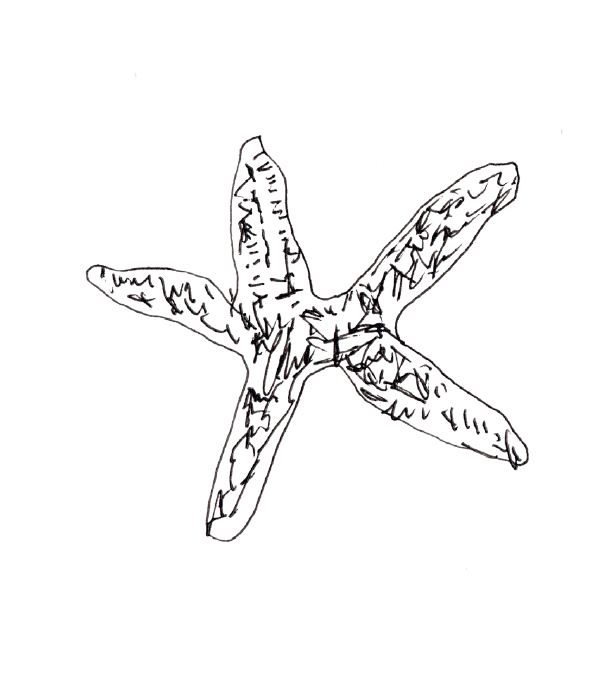





 ph. Luigi Ghirri, Viva il 25 aprile ! (Modena, 1978)
ph. Luigi Ghirri, Viva il 25 aprile ! (Modena, 1978)


 di
di  La parola, le parole, al centro dell’idea di scrittura di Lumelli ci sono loro. La parola non è uno strumento di comunicazione ma è un oggetto, solido, musicale. Un concetto da poeta che entra nel narratore. Proprio come Diodato
La parola, le parole, al centro dell’idea di scrittura di Lumelli ci sono loro. La parola non è uno strumento di comunicazione ma è un oggetto, solido, musicale. Un concetto da poeta che entra nel narratore. Proprio come Diodato 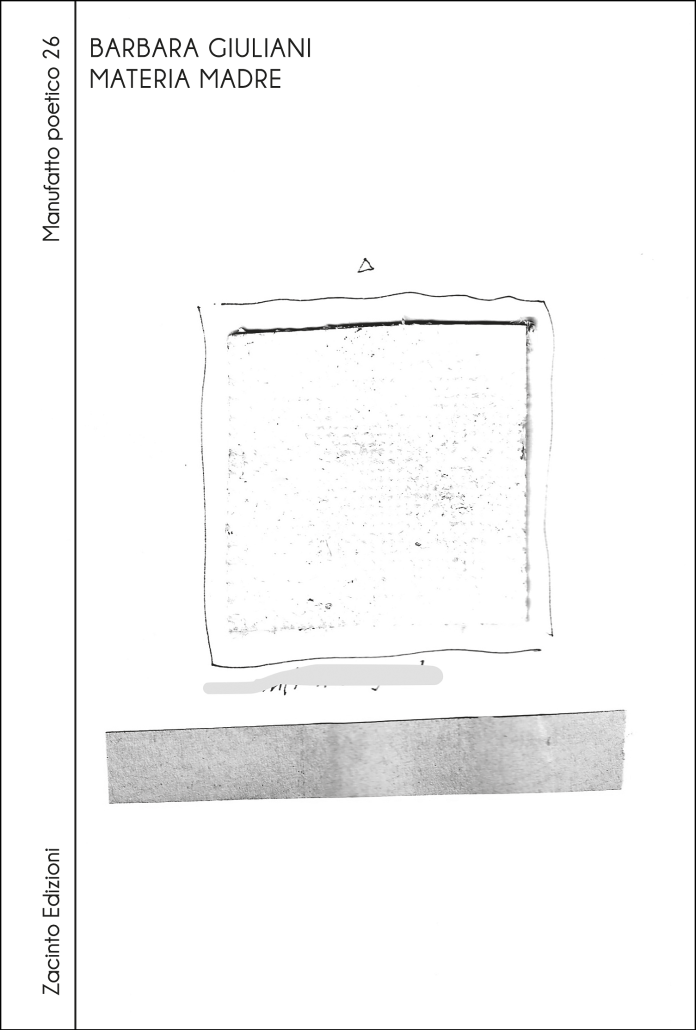
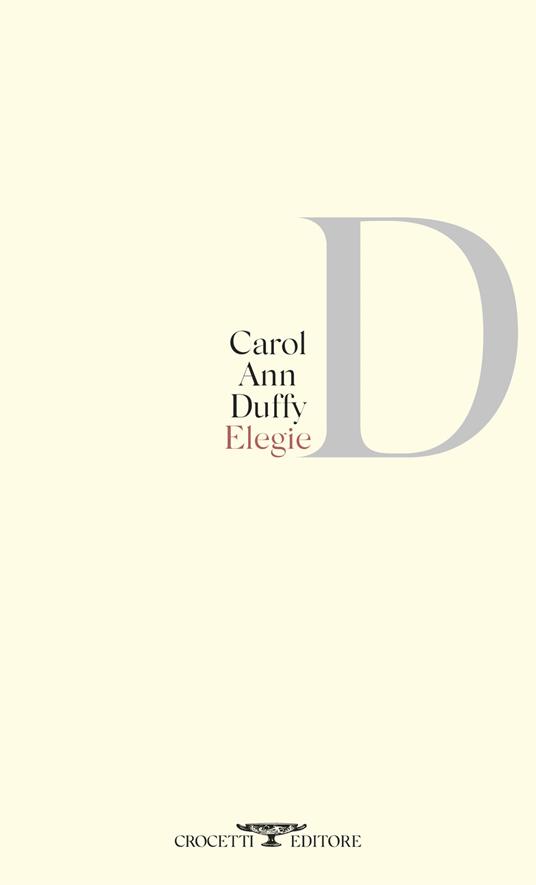

 di
di