di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas
Anatole. Giusto il tempo di far emergere i dettagli circa l’identità dell’attentatore e saltano naturalmente fuori i famosi amici del jihadista, secondo il copione che avevamo tracciato nella puntata precedente. Subito si dimostra che il Califfone è ramificato dappertutto (mi perdonerai l’omaggio al coattissimo cinquantino da motocross della nostra giovinezza) e tutti gli amici degli attentatori sono il brodo di coltura nel quale il radicalismo sguazza, eccetera (ma poi non vale se la stessa cosa accade in North Carolina, chissà perché, chissà percome). E naturalmente come potrebbe mancare il complottismo dei passaporti, che mette in fila una serie di fatti relativi alla dinamica dell’attentato di Berlino, concludendo a proposito del rifugiato pakistano arrestato che: «qualcuno potrebbe avanzare il sospetto che magari si sia cercato un capro espiatorio per chiudere la vicenda e per evitare che dilagasse il panico. O altro e più oscuro. A pensar male, purtroppo, ci si azzecca». A fare scopa, troviamo parecchio rilanciata ll’imbecillata di Fusaro del 26 luglio (controllare la data di pubblicazione non va più di moda), che suggeriva al terrorista islamico di pigliarsela con la finanza internazionale, non con laggente, perché devi fare la lotta di classe contro la finanza internazionale, non il jihad, come ti suggeriscono le fonti di informazione egemonizzate dalla finanza internazionale. Se te la pigli con laggente vuol forse dire che sei disperatissimo o, peggio, pagato da Soros, che ti fa entrare in Italia con l’aiuto del nostro amico Andrea Costa, il quale viene intervistato dal New York Times, a dimostrazione del fatto che, appunto, egli è a tutti gli effetti élite liberal radicale al servizio della finanza internazionale. Anche perché con l’elezione di Trump abbiamo capito che quando si dice finanza internazionale si intende Soros.
Lorenzo. Sul fatto che la permeabilità europea al terrorismo radicale islamico del Califfone sia una cosa che ha l’Italia al centro, immediatamente comincia ad agitarsi la politica di casa nostra, col neo-insediato Governo che s’inventa lo Schema Minniti, una roba che a me ricorda molto la bizona 5-5-5 di Oronzo Canà. E proprio a questo proposito, siccome avevamo finito la puntata scorsa parlando di soluzioni sbajate a problemi mal inquadrati (circa il qual tema anche molto interessante è questa riflessione di Domenico Talia sui “Neosemplificatori”), vorrei suggerirti una riflessione che metta a confronto il profilo di questo , ventiquattrenne tunisino sospettato di aver sequestrato camion e camionista a Berlino al fine di procurare la strage del mercatino di Natale, con lo Schema Minniti.
Anatole. Nel senso di “buttiamola in tribuna” o “viva il parroco”?
Lorenzo. Certo, ovviamente.
Anatole. Ma anche nel senso di mettere in luce l’abissale distanza tra la dimensione reale del fenomeno e le opzioni che si mettono in campo per rispondere. Voglio dire, abbiamo un personaggio uscito da Mission Impossible Gone Astray: delinquente comune, galeotto, dotato di qualità elusive che Ethan Hunt je spiccia casa. Addirittura, dice il Guardian, «had researched bomb-making online and been in contact with Isis at least once». Se c’è una fine a questa spirale di infantilismo giornalistico, sapresti indicarmi dov’è? E quanto trova riscontro nelle misure grazie alle quali vorremmo catturare questi elusivi e subdoli jihadisti?
Lorenzo. Iniziamo dalla schema Minniti, premettendo però che come dicono all’AISI (intervistati da Gad Lerner, vedi alla fine di questa puntata), questi jihadisti in Italia sono molto, molto pochi e non hanno contatti con le organizzazioni di musulmani italiane, se non labilissimi, che l’Italia ha in ruolo un progetto di deradicalizzazione nelle carceri che pare stia funzionando, che ci abbiamo tutto un sistema di siti civetta per intercettari gli appassionati dell’ISIS, che forse qualcosa in Italia succederà, speriamo di no, ma che di certo da tutti i punti di vista attaccare l’Italia non è nelle priorità dell’ISIS (e non per merito della mafia che li tiene lontani, come una mia fb-friend ha sentito dire sull’autobus), a meno ché non continuiamo a seminare il panico ogni volta che un qualsiasi scalzacani con un fucile in mano viene a dirci che “conquisteremo Roma”. Non lo è stato nemmeno per al-Qaida, in tutti questi anni. L’unico a provare a fare un attacco fu un libico molto strano, Mohamed Game. Un lupo solitario ante-litteram se vogliamo. Come scrivevo nel lontano 2009:
Il nostro wannabe-kamikaze, che viveva ai margini della nostra società, andava in biblioteca, in particolare frequentava la biblioteca comunale vicino a casa sua. E questa è una notizia perché, secondo i dati Istat, Mohammed Game faceva parte di quell’esiguo 6,7% della popolazione italiana fra i 35 e i 44 che va in biblioteca almeno una volta l’anno.
Un vero disadattato.
L’articolo ci informa anche sulle letture di Game. Ma questa non mi sembra una notizia perché leggeva cose:
- su Gheddafi
- di politica mediorientale
- sul colonialismo italiano in Libia
Ovvero proprio esattamente quello che ci si aspetta da un immigrato libico.
L’articolo del Corriere, invece, alle letture terroriste di Game da un certo rilievo:
anche la lista dei libri che ha letto potrebbe essere interessante, per cercare di ricostruire quale sia stato il percorso psicologico che lo ha portato da un tiepido attaccamento all’islam, all’esaltazione di martire della jihad
Quando si dice “affabulazione”… Segue l’elenco dei libri posseduti dalla biblioteca Harar, cioè quella frequentata da Game, sui tre argomenti succitati:
- Gheddafi : una sfida dal deserto / Angelo Del Boca. – Roma (etc.) : Laterza, 1998. – XIX, 372 p. ; 21 cm.
- Gli italiani in Libia / Angelo Del Boca. – Roma (ecc.) : Laterza. – v. ; 21 cm.
- A Babilonia con Hammurabi / Fiona MacDonald, Gerald Wood. – Firenze : Giunti Marzocco, [1991]. – 35 p. : ill. ; 27 cm. ((Trad. di Elena Mendes.
- La costruzione del Medio Oriente / Bernard Lewis. – Roma (etc.) : GLF editori Laterza, 1998. – XI, 229 p. ; 21 cm. ((Trad. di Pier Giovanni Donini.
- Cronache mediorientali : il grande inviato di guerra inglese racconta cent’anni di invasioni, tragedie e tradimenti / Robert Fisk ; traduzionedi Enrico Basaglia … [et. al.]. – Milano : il Saggiatore, [2006]. – 1180 p. : c. geogr. ; 23 cm.
- Cucine mediorientali / a cura di Carla Coco. – Torino : Sonda, 2000. – 143 p. : ill. ; 17 cm.
- No : la seconda guerra irachena e i dubbi dell’Occidente / Lucia Annunziata ; in appendice: La strategia della sicurezza nazionale: i nuovi indirizzi di politica internazionale della Amministrazione Bush. – Roma : Donzelli, [2002]. – XI, 154 p. ; 19 cm.
- L’Africa nella coscienza degli italiani : miti, memorie, errori, sconfitte / Angelo Del Boca. – Roma (etc.) : Laterza, 1992. – XV, 486 p.; 21 cm.
- Conquistadores, pirati, mercatanti : la saga dell’argento spagnuolo / Carlo M. Cipolla. – Bologna : Il mulino, 1996]. – 83 p., 7] c. di tav., : ill. ; 22 cm.
Che insomma Minniti può fare pure questo schema per poi forse tra un po’ vantarsene, ma tanto lo sa anche lui che il lupo solitario è solitario e che l’Italia è un posto relativamente tranquillo dal punto di vista del jihadismo (tocchiamo sempre ferro eh).
Anatole. Minniti ha battezzato la nuova dottrina come “prevenzione collaborativa”, immaginando un coinvolgimento pieno degli amministratori locali, i sindaci in primis, e dei corpi di polizia municipale delle città, affiancati da questori e prefetti. I soli in grado di rendere efficaci e capillari quelle forme di vigilanza attiva e di difesa passiva delle aree urbane di fronte alla minaccia del lupo solitario.
Lorenzo. E subito mi viene in mente il racconto di uno di quegli eroi del Baobab che mi disse: “un giorno, dopo un attentato, arrivarono quelli della polizia e mi chiesero: come stiamo a jihadisti, qui?”.
Anatole. “Benino e voi? A Lupi Solitari forse boh…”, che roba…
Lorenzo. C’è gente in questo paese che vieta di indossare il burkini per le strade della città senza nemmeno immaginare che, al di là del fatto che “burkini” è un marchio, stiamo parlando di un costume da bagno. C’è una baracca di disinformazione secondo la quale chiunque sia contro Asad è dell’ISIS (compreso il sottoscritto). Abbiamo uno storico in cui una percentuale altissima di “presunti terroristi” catturati in retate propagandatissime (ricordo da giovane una giornata a Il Manifesto per scrivere un pezzo sulla cosiddetta “Operazione Sfinge”, risoltasi poi in nulla) sono stati poi riconosciuti come cittadini qualunque. Abbiamo talmente poco da dire, che la prima condanna per terrorismo di qualche giorno fa ha preso le prime pagine dei giornali.
Anatole. C’è un’opinione pubblica che preme perché si faccia qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, qualunque cosa, purché dia la sensazione che la stiamo facendo, specialmente tra il momento in cui l’attentato si produce e quello in cui, ammazzato il terrorista, non gliene frega più un cazzo a nessuno perché c’è il derby Juve-Crotone. È evidente che, come abbiamo sottolineato spesso, la soluzione ce l’hai dentro di te, epperò è sbajata. A testimoniarlo è il fatto che il luposolitarismo bersaglia di anno in anno un Mercatino di Natale diverso, anzi ogni due anni, a cadenza biennale. Potremmo definirla la Biennale del Mercatino di Natale, tie’, tanto per fare pendant con la performance art del terrorista turco che ha ammazzato l’Ambasciatore russo ad Ankara. Due anni fa’ era Nantes, quest’anno Berlino. Cosa cazzo gli significhi, poi, questo mercatino di Natale al luposolitarismo radicale islamico potremmo forse anche chiedercelo. Un’assembramento casuale? Colpire il conzumismo occidentale? Il simbolo religgioso crociato? Niente di tutto questo? Secondo me il lupo solitario radicale islamico “non sa, non risponde”.
Lorenzo. Di sicuro dietro lo schema della schedatura di massa dei potenziali lupi solitari c’è un rischio, cioè l’esplosione incontrollata di “falsi positivi” all’analisi “lupo solitario”. Praticamente tu metti delle “sentinelle” su un fronte ma le sentinelle dicono “aiuto” praticamente ogni volta che si muove paglia. È un rischio grosso. C’è il rischio di fabbricare cose più che evitarle. Non sarebbe meglio mettere 1000 persone a studiare seriamente questa roba qua per poi metterle a lavorare a soluzioni più meditate? Magari fuori dallo schema dell’ordine pubblico, provando a staccare le etichette dalle persone, provando ad immaginare una società in cui puoi provare ad essere quello che ti pare, indipendentemente dalla tua origine o identità culturale, sociale, poiché, magari, ti percepisci come qualcosa di diverso dal modo in cui vieni etichettato, ma non hai spazio per proporti in quel modo. Più dispendioso, di certo, ma anche immensamente più sensato.
Anatole. Ma ci mancherebbe. Piuttosto che rinunciare alle nostre premesse culturaliste, siamo pronti a farci mettere sotto dal primo camion che passa. E comunque, se avevamo ragione la volta scorsa a parlare di Sindrome di Lee Oswald, va da sé che alla fine tra quelli che schedi non c’è mai quello che poi si schianta contro il buzzichetto del vin brulé al mercatino di natale.
Lorenzo. Oppure c’è, come nel caso di questo tunisino, ma sta in mezzo a mille, quindi che te ne fai, poi, di questa schedatura?
Anatole. Da capo, il problema non è riducibile alla povera testa di cazzo che alla fine commette il gesto, perché esso problema si prende, in realtà, tutto lo spazio che separa te da quelli che non lo commetteranno.
Lorenzo. Intendi il problema di tutti noi proprio, di noi come società democratica ecc. Sono d’accordo, c’è anche questo. Siamo in un anello più grande. Per dire: quando fai pauristica sugli immigrati o sui profughi, generi virtualmente l’immigrato o il profugo solitario, che può essere pure che fa una strage.
Anatole. Di sicuro faciliti il processo di deriva che lo condurrà ad essere quello che vuoi che sia, in assenza di altre opzioni. Poi ti possono dire che se circoscrivi il novero dei potenziali lupi solitari, allora gli altri campano tranquilli, cioè, tuteli, per dire, i rifugiati, ma, come dicevamo, questo Anis Amiri era schedatissimo. S’era fatto quattro anni di gabbio, per dire, era segnalato ovunque, non poteva volare negli USA. Allora una volta che l’hai schedato, segnalato, dipinto intorno con l’evidenziatore, ci hai attaccato sopra un cartello, quello che ti pare, ma cosa succede? Per citare il poeta “so boni tutti / a mettece un cartello”.
Lorenzo. Senonché, anche se poi riuscissi a limitare la cosa con questi criteri, cioè hai fatto questo anello sanitario attorno a stereotipi, ti scappa er Pizza Connection o simili.
Anatole. Perché quello ti cade fuori dai tag che mecciano “lupo solitario”, in quanto non sei capace di riconoscere il senso di esclusione che scatena gesti violenti individuali fuori dal quadro di referenza col quale li hai identificati. E invece, come abbiamo detto ormai centinaia di volte, il problema è che una volta acceso il riflettore, l’attore che se lo prende prima o poi arriva. La Sindrome di Lee Oswald, appunto. E non è detto che costui sia nelle tue liste di prescrizione, che guarda caso, si applicano agli ‘slamici a rischio di radicalizzazione, non, ad esempio, allo svalvolatone bianco della middle class nel North Carolina. Anche perché altrimenti dovresti schedare 1:1 mezzo pianeta terra.
Lorenzo. Sì, il riflettone paga pegno. Ti ricordi il matto di Monaco che urlava Allah akbar ma proprio non sapeva di che stesse parlando? Ma anche quel pilota che ha deciso di suicidarsi con l’aeroplano pieno di passeggeri, per non parlare di Brevik, il nazi di Utoya. È proprio roba di riflettori e non si accetta che sia così, che cioè tutte queste cose siano parte dello stesso problema, perché si preferisce, per ragioni credo ormai di idiozia conclamata più che di interesse, propagandare stupidagini identitarie basate su stereotipi culturalisti capiti male.
Anatole. Ti faccio un esempio che aiuta a capire al volo: pensa a fare la stessa cosa per il femminicida in Italia. Chi schedi? Dieci milioni di mariti frustrati? Ma non siamo alla bizona pura? Ma non sarebbe più semplice riconoscere che “Houston, abbiamo un problema”? Cioè che in Italia c’è un serissimo problema legato al fatto che abbiamo un’educazione patriarcale ai rapporti tra i sessi, tale che il maschio a una certa sbrocca e ammazza la compagna, perché non è banalmente all’altezza delle sue stesse aspettative circa la sua propria vita e/o il suo proprio rapporto sentimentale?
Lorenzo. Yes, ci siamo capiti.
Anatole. Allo stesso modo, non sarà che c’è anche un serissimo problema legato al modo in cui una vastissima maggioranza della cosiddetta opinione pubblica, che sia islamica, non islamica, laziale, feticista dell’addobbo natalizio, quello che ti pare, si confronta con i temi all’ordine del giorno, ad esempio quelli sollevati dalla situazione di Aleppo, in maniera rabbiosa e livorosa, poiché li sente straordinariamente vicini alla propria miseria anche se non lo sono manco un po’? Ne parlavamo già a proposito del Tronismo di Massa e della Sestessità Scatologica, come vedi i fili si intrecciano di nuovo.
Lorenzo. Esatto. Che poi è su questa cosa che ragioniamo quando ragioniamo di complottismo, postverità varie e – nei momenti in cui ancora non si sa niente su cosa è avvenuto a Berlino, ad esempio – anche delle transverità (il camionista fantasma pakistano ecc.) – mi si passi il termine – cioè delle “verità di transito” che presto dimenticheremo, che poggiano su un corredo discorsivo già pronto (dai fatti di Colonia in poi), che vanno bene almeno per qualche ora e su cui ci si può un po’ accapigliare rendendo la vita di un utente medio di telefonone meno angosciante anche se molto più livorosa.
Anatole. Mi piace molto la Verità di Transito. Quella cosa che succede da Mentana mentre aspettano il primo exit poll. Ero allucinato dalla diretta del TG2 la serata dopo l’attentato di Berlino: se andavi a cercare il riferimento ad un fatto, una notizia, qualcosa nel susseguirsi anche fluido del discorso, non trovavi niente che non significasse “vabbe’, c’è stato questo attentato e ancora non sappiamo un cazzo”. Ma, ribadiamolo ogni volta, l’opinione su qualunque fatto di cronaca si struttura nel corso delle prime 24 ore susseguenti, quando, appunto, non se ne sa veramente un cazzo.
Lorenzo. E infatti la Bizona Minniti salta fuori nell’intervallo che separa l’attentato dal momento in cui l’attentatore viene ammazzato per strada a Sesto San Giovanni.
Anatole. Esatto, in quell’intervallo mediatico in cui devi dire qualcosa per riempire il vuoto ansiogeno, rispondendo in maniera tecnocratica ai populismi che te se magnano vivo.
Lorenzo. Poi una volta che hai preso e ammazzato l’attentatore è tutto un trionfante strombazzare la grande efficacia dell’azione delle forze di polizia italiana, che i tedeschi e i francesi ce spicciano casa. Al netto del dramma del povero Alfano, costretto a dare la notizia della morte della ragazza italiana a Berlino da Ministro degli Esteri nel giorno in cui Minniti, nuovo Ministro dell’Interno, si prende tutti i meriti dell’azione che ha portato alla morte del terrorista, naturalmente.
Anatole. Ecco, sul copione, adesso che questo pericolosissimo terrorista è stato abbattuto, penso che potremmo riflettere un istante, prima di congedare anche quest’altra patetica puntata del Lupo Solitario. Ricostruendo la parabola di vita di questo Anis Amri, come fa ad esempio piuttosto bene questo articolo di Libération, salta agli occhi la questione che stiamo cercando di mettere a fuoco da un anno ormai, che cioè se sei musulmano e criminale, talmente prevale la prima caratteristica, che alla fine, inevitabilmente, le due cose devono coincidere, cioè devi diventare criminale poiché musulmano, in quanto musulmano. Cioè, se sei musulmano non puoi essere altro che musulmano. Non dico trovare lavoro, fare la vita che ti pare, magari anche piuttosto contraddittoria rispetto all’opinione che dovremmo farci di te in quanto musulmano, ma manco puoi vivere la tua disonesta vita di comune criminale in santa pace. Se ad esempio sei Rom, o etichettato in quanto tale anche se non lo sei, il criminale comune te lo facciamo fare. Perché? Perché ci sta che se sei zingaro fai il criminale comune, anzi, sei proprio antonomastico di criminale comune.
Lorenzo. Certo, zingaro e criminale sono la stessa cosa, mentre se sei musulmano non ce la conti giusta, non puoi essere soltanto un comune criminale. Devi essere un terrorista e insisteremo a trattarti da terrorista finché non ci diventi. Se volevi fare il criminale comune, dovevi nascere zingaro. Ce dispiace.
Anatole. Pefforza, sei tunisino e musulmano, quindi fai il terrorista e non rompere il cazzo.
Lorenzo. L’antonomasia si nutre dello stereotipo culturale e ricodifica tutti i segni a senso unico. Gli amici diventano la rete terroristica, i crimini che commettevo un sintomo di incompatibilità culturale, eccetera. Se vieni dal North Carolina e sei middle class bianca, come nel caso del Pistolero del Comet di cui parlavamo nella puntata precedente, le stesse cose valgono altro: sei una persona per bene esasperata dalla crisi e i tuoi amici non sono terminali dormienti di un reticolo terroristico, ma brava gente che ti ha lasciato andare a fare il matto perché, in fondo, che cosa ci potevano fare?
Anatole. Eppure, leggendo il profilo del pericoloso terrorista, i collegamenti con l’Imam senza Volto (altro personaggione da film di spionaggio, più da James Bond, forse, che da Mission Impossible), con i salafiti di Duisburg, coi “reclutatori jihadisti” di Dortmund, paiono più che altro labili indizi a corredo di un tentativo di narrazione, che altro. Cioè, non emerge con chiarezza che Amri fosse “uno di loro”, qualcosa che denoti una vera e propria appartenenza.
Lorenzo. Effettivamente. Sta con un piede di qua e uno di là, come se provasse a combattere la sua battaglia identitaria solitaria, finendo per soccombere. E quando in conclusione l’autore del profilo su Libération si interroga se «L’investigation a-t-elle été trop superficielle? Amri a-t-il trompé la vigilance des autorités? Trois mois plus tard, il est devenu l’homme le plus recherché d’Europe», la risposta è che l’errore non è investigativo, ma proprio concettuale, e finché non cambiamo modo di ragionare, non capiremo nulla di quello che sta succedendo.
Anatole. E la parabola di questo qua è paradigmatica del modo in cui stiamo sbagliando ad affrontare la questione, perché non vogliamo capirla. Non vogliamo vedere, in sostanza, che il senso di “esclusione percepita” dall’attualità, dalle dinamiche ansiogene del contemporaneo, è lo stesso se sei un tunisino musulmano approdato col barcone a Lampedusa o appartieni alla middle class bianca del North Carolina. Non vogliamo vedere che la partecipazione alle dinamiche del reale si basa su una ricerca identitaria perennemente in bilico tra Qualcunismo e Sestessità. Non vogliamo vedere che l’unico modo per essere Testesso e Qualcuno allo stesso tempo è accettare l’etichetta che ti viene offerta. Non vogliamo capire che, in taluni casi, l’etichetta che ti appiccichiamo in fronte può portarti a sequestrare un camionista polacco, costringerlo a lanciare il camion su una folla sconosciuta, per finire sparato dai poliziotti a Sesto San Giovanni.
Lorenzo. Bel film. Che finirebbe bene secondo la narrazione che ci stiamo dando a bere, se davvero l’attentatore avesse urlato Allah Akbar prima di morire, invece che ACAB o una cosa del genere, come invece è accaduto.
Anatole. Peccato che è vero.
Lorenzo. Parecchio vero. Ci si è provato stamattina a chiudere il cerchio, a inserire Amri nel ciclo. Nell’ennesimo varco spaziotemporale trans-vero il terrorista urlava “Allah akbar” prima di morire. Repubblica nel titolo poi cancellato scriveva “prima di morire l’islamista ha urlato Allah akbar”. Laddove il tag “islamista” sussume in sé tutto il discorso delle etichette che abbiamo appena fatto (tralasciamo le 15 pagine di introduzione a “Islam 20 parole”, Laterza, 2016, nelle quali ho spiegato perché la parola “islamista” è pesantemente biased oltre che ambigua).
Anatole. E tutti dietro a dir minchiate.
Lorenzo. Era proprio una cazzata, una sonora immensa cazzata, un fantasma che prendeva corpo chissà come, smentita dal questore. Però le minchiate le hanno dette lo stesso, nel frattempo, la storia delle etichette ha funzionato perfettamente. E’ l’ultima puntata del capitolo che avevo iniziato a scrivere su Vice nel luglio di quest’anno. Il titolo era “Come la frase Allah akbar è diventata uno spauracchio”. Attualmente su Repubblica il titolo fa: “L’attentatore di Berlino Anis Amri ha urlato poliziotti bastardi”.
Anatole. *facepalm*.
Lorenzo. Mi sa che ci abbiamo preso anche stavolta, ma non abbiamo vinto niente.
Anatole. Malgrado gli sforzi di tinteggiare in maniera comica, si rimane comunque con una brutta sensazione addosso.
Lorenzo. E se non fosse che si è fatta una certa proverei a tirar su il morale instillando d’embée il sospetto del complottone ordito da Minniti per convincere gl’italiani che il suo “schema” funziona. Cioè: ha funzionato praticamente in maniera istantanea. Il questore, di certo non volendolo fare, l’ha confermato. Anche perché Minniti, occorre dirlo, è il destinatario ultimo dell’insulto generico lanciato da Amri alle nostre forze dell’ordine nel suo ultimo minuto di esistenza.
Anatole. E l’aereo libico, allora? E chiaro che Loro…
Lorenzo. Esatto, l’aereo libico. Però ci ho una vita, e pure tu.
Anatole. Vabbene, chiudiamola così, che col complottismo abbiamo dato.









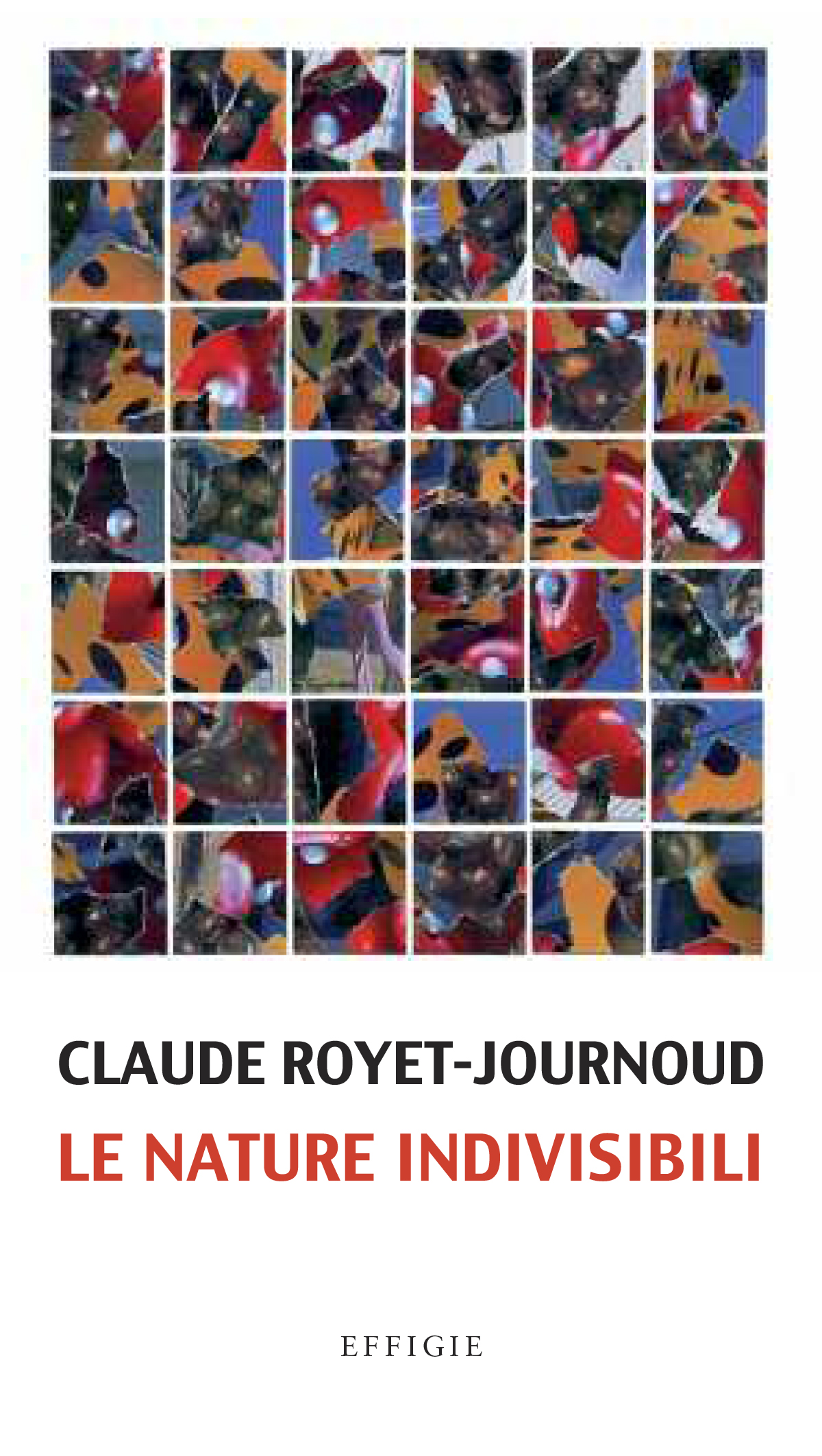



 43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza.
43 poeti per scacciare la morte, per dar sfogo a una indignazione vitale. La poesia come una affermazione, sono qui, sono con te, sono per tutti. Dove tutti significa molte persone, tutte le vive, tutte le sparite, tutte le torturate, tutte le assassinate di questo Messico contemporaneo, immerso in una guerra contro i poveri, contro chi si sente sicuro di fare il proprio dovere, contro chi vuole essere libero. Molte di più dei 43 studenti desaparecidos dall’esercito, la polizia e i narcotrafficanti ad Iguala la notte tra il 26 e il 27 settembre 2014. Però quei 43 ragazzi risvegliano la poesia: sono stati trasformati dal desiderio popolare di mettere fine alla violenza di stato e della delinquenza (nessuno sa dove finisce una e comincia l’altra) in semi di speranza.




 di Martina Germani Riccardi
di Martina Germani Riccardi

