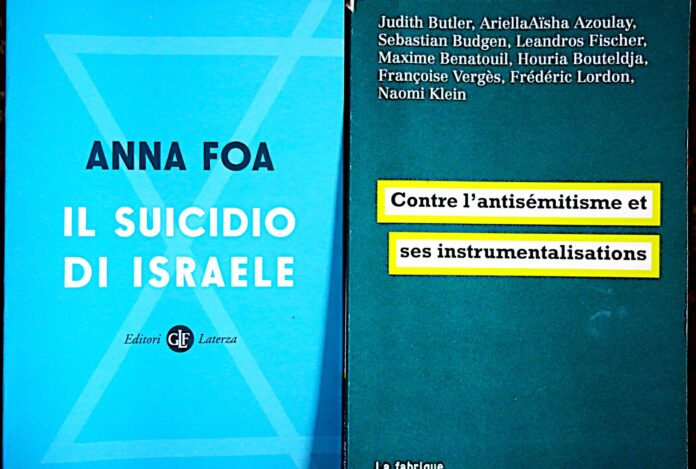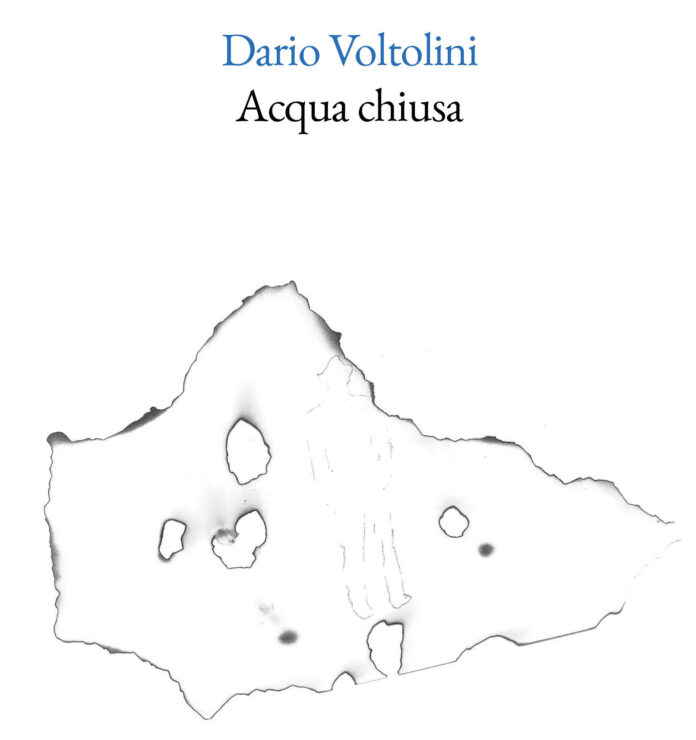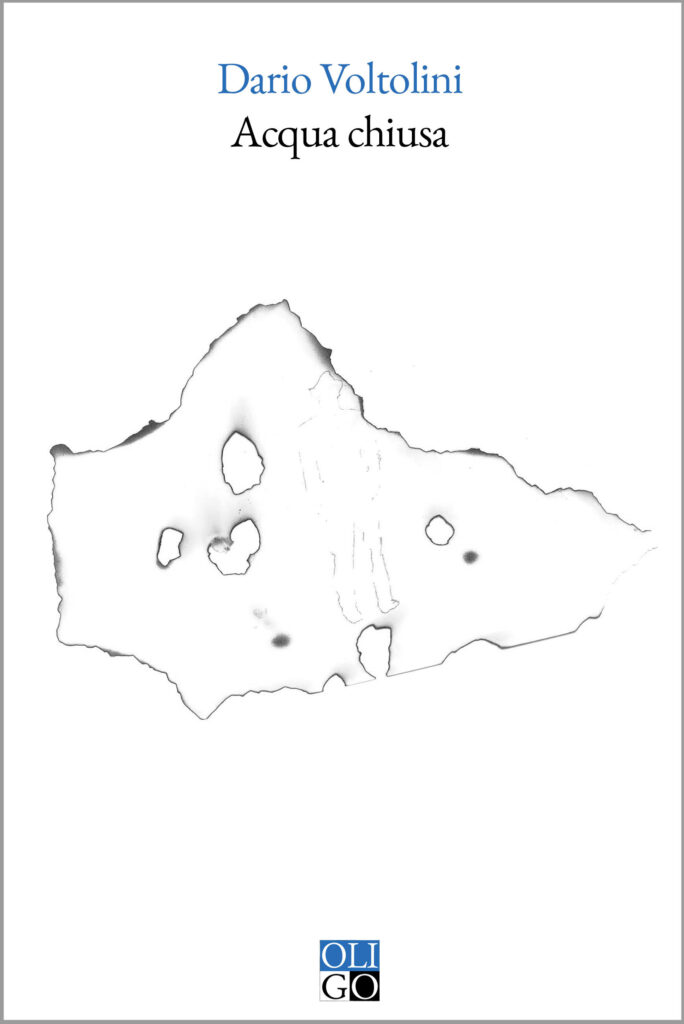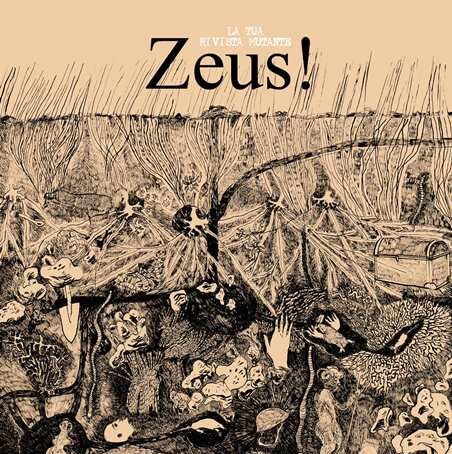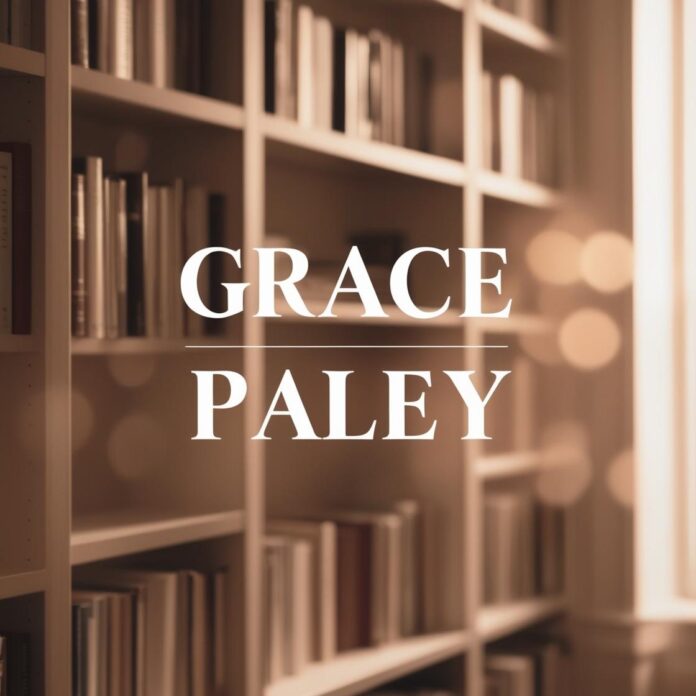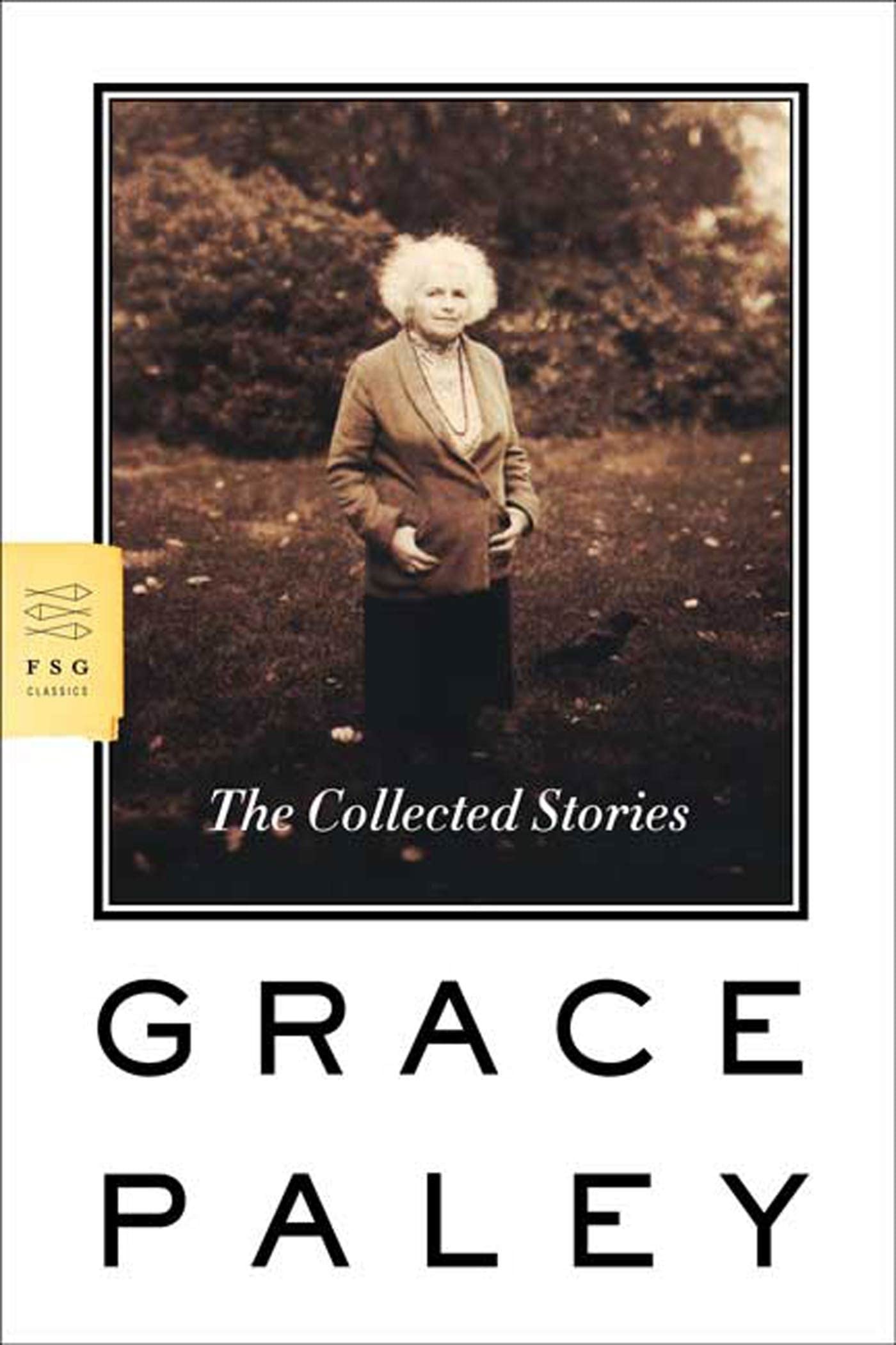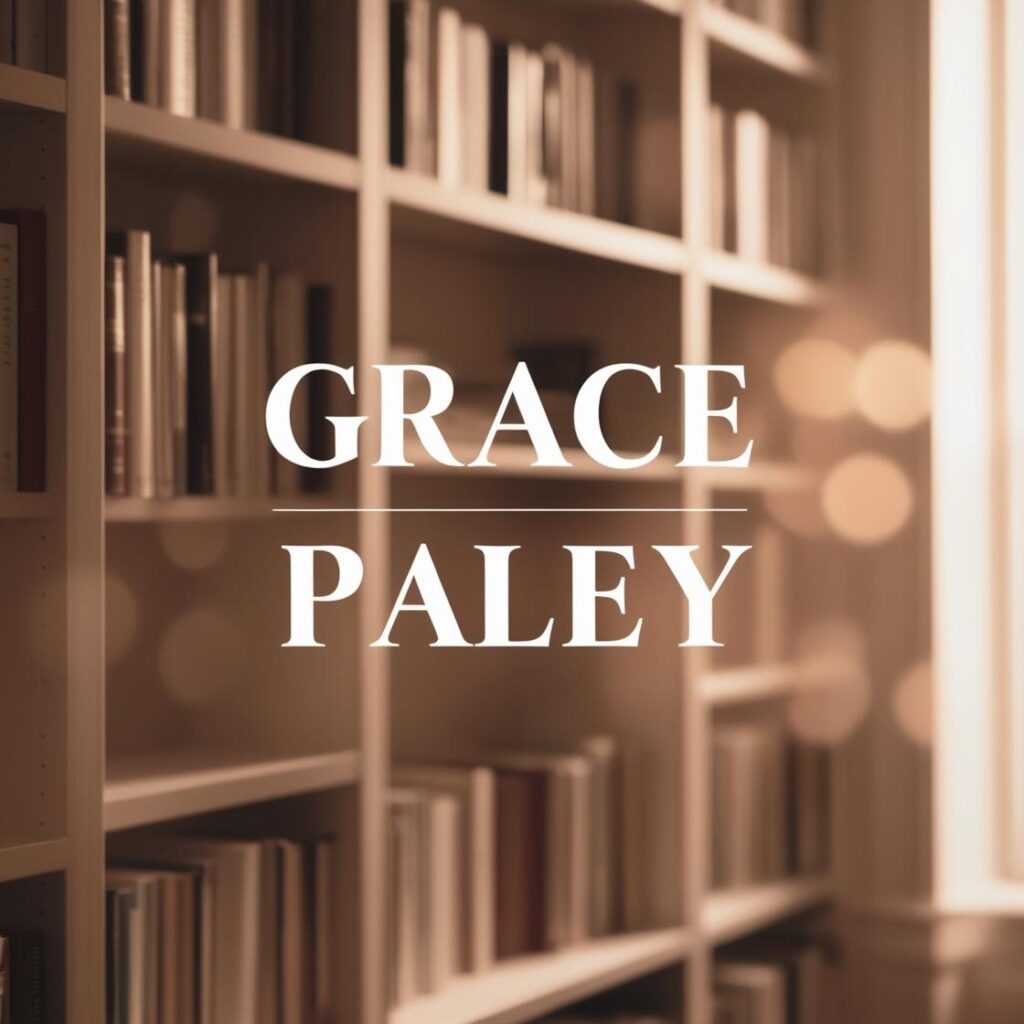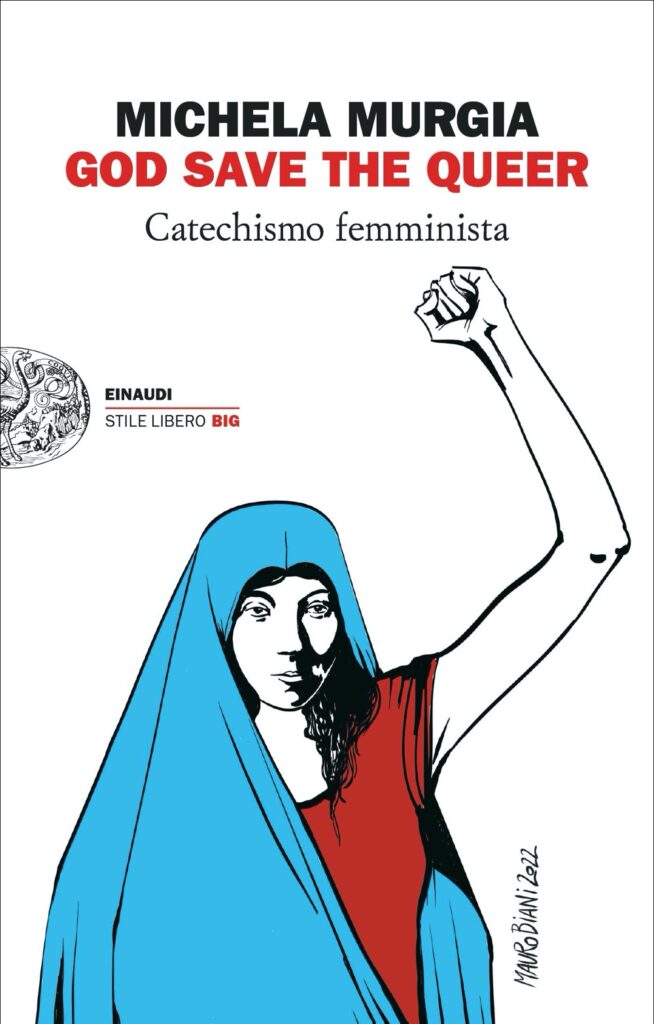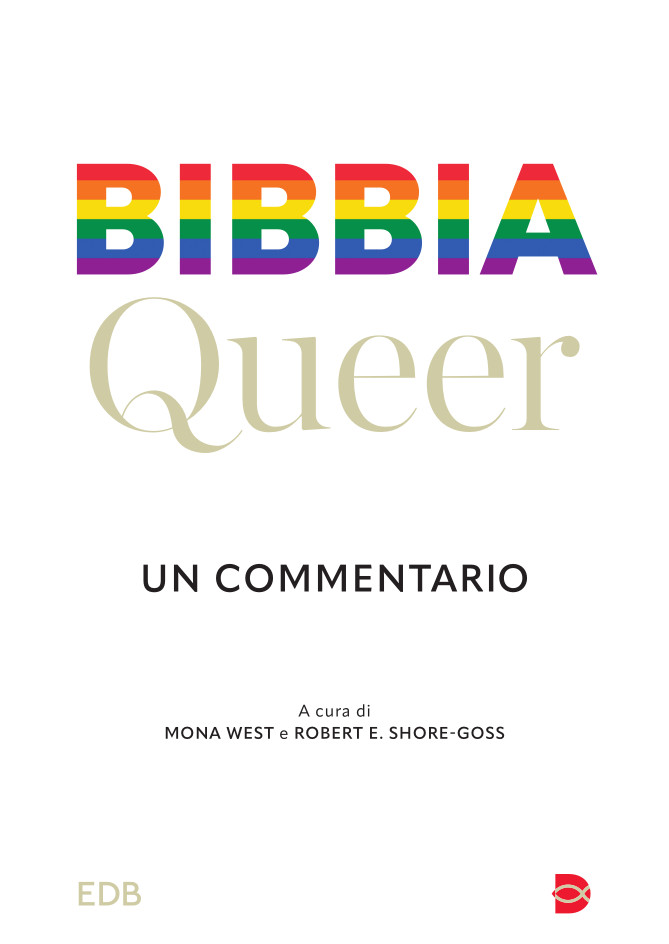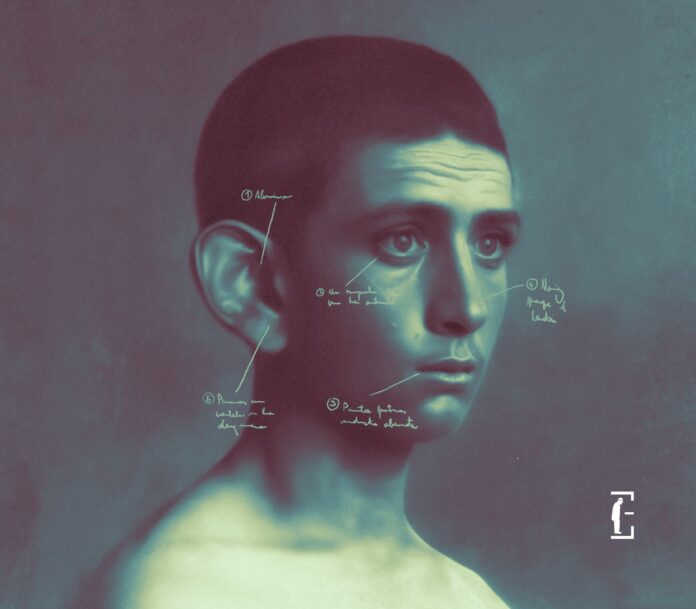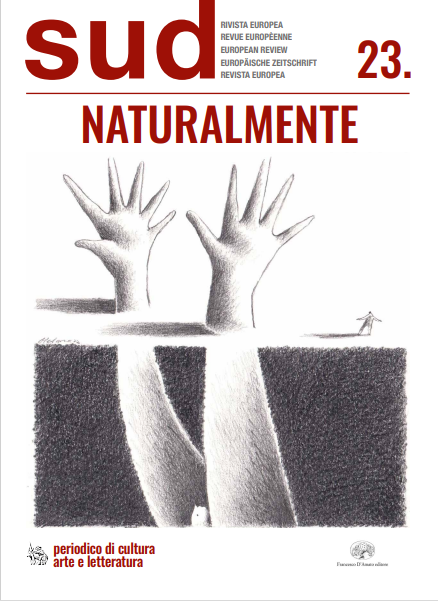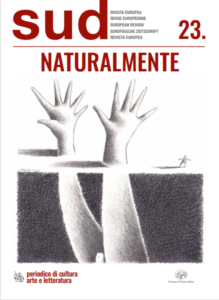È questo il quarto intervento che dedico a ciò che si è scatenato in Medio-Oriente dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Questi interventi sono la testimonianza di uno studio su diverse fonti, di dialoghi con amiche o amici e di riflessioni che hanno evoluto nel tempo. Ognuno di essi si è focalizzato su un tema. Il primo ha difeso l’idea che senza contesto e narrazione non vi può essere alcuna comprensione dell’accaduto; nel secondo, ho avanzato un quadro interpretativo di quello che, oggi, la storica Anna Foa definisce il “suicidio di Israele”; nel terzo, ho inserito l’attitudine del governo Netanyahu in un’atmosfera politica e ideologica che riguarda non solo Israele, ma anche l’Occidente capitalista nordamericano e europeo. Quest’ultimo intervento è dedicato a due voci critiche non solo della politica israeliana, ma anche della diaspora ebraica.
di Andrea Inglese
Da dove parlo
Chiunque parli della questione palestinese deve cominciare per dire innanzitutto chi è, come questa questione lo riguarda…
Ariella Aïsha Azoulay
Nonostante fosse difficile farlo, ho pensato fin dalle prime settimane dopo il 7 ottobre, vedendo quanto era successo e quel che si stava preparando, che fosse indispensabile parlare, scrivere, insomma rompere il silenzio. Parlare e scrivere per capire di più, assieme a quelli che vivono qui, in Italia, in Europa, lontano da Gaza e Israele, quello che stava accadendo laggiù tra palestinesi e israeliani. La gravità sia dell’attacco terroristico palestinese contro i civili israeliani sia della rappresaglia distruttrice contro la striscia di Gaza dell’esercito israeliano, non lasciavano adito a dubbi: questa volta il mondo non avrebbe potuto rimanere indifferente, come era invece accaduto nel corso degli ultimi anni, quando la sorte dei palestinesi non sembrava interessare più nessuno. In un modo o nell’altro, l’occidente tutto come anche il cosiddetto sud globale, oltreché i principali attori in gioco in questa guerra, sarebbero stati coinvolti. Così è accaduto. E il silenzio è stato eloquente e significativo quanto la propaganda più faziosa, e lo è stato anche se le sue motivazioni potevano o possono essere le più diverse: blocco emotivo, prudenza o semplice vigliaccheria. La guerra tra Hamas e Israele è stata scatenata da un’azione terroristica delle più crudeli (uccisione di civili, bambini inclusi) e ha prodotto una rappresaglia militare da parte israeliana, che non solo si è dispiegata attraverso modalità altrettanto terroristiche (bombardamenti indiscriminati su case e edifici pubblici come scuole, università, ospedali, ecc.), ma ha acquisito la violenza sistematica e terrificante del “genocidio”. Questo almeno agli occhi di una parte importante dell’opinione pubblica mondiale, ma anche di istituzioni internazionali e ONG indipendenti. Tornerò in seguito su questo termine. E dirò, perché è un termine che personalmente non amo utilizzare. Ma poco importano le mie ragioni o i dubbi sulla piena pertinenza dell’uso: esso si è imposto contro ogni tentativo di censura mediatica anche in una parte dell’opinione pubblica occidentale, e questo in reazione all’entità inedita della distruzione scatenata contro la striscia di Gaza, che nei fatti rende inabitabile quel territorio così densamente popolato. Possiamo utilizzare vecchie o nuove categorie, parlare di pulizia etnica o di urbicidio, quel che risulta chiaro è l’intenzione del governo israeliano di rendere Gaza un territorio dove non sia più possibile abitare, trasformando i Palestinesi in una massa di profughi sulla loro stessa terra.
Ho già esplicitato, sempre su Nazione Indiana, la ragioni del mio coinvolgimento personale, in quanto cittadino italiano ed europeo[1] in quello che è accaduto e accade laggiù, anche se non sono né palestinese né israeliano, né ebreo né arabo. Nonostante ci siano altre guerre sanguinosissime nel mondo, come la guerra civile in Sudan o quella che viene definita la seconda guerra civile nella Repubblica Centrafricana (in corso dal 2012), la guerra tra israeliani e palestinesi mi riguarda storicamente. Vorrei però aggiungere oggi che mi riguarda anche culturalmente. Nella mia formazione intellettuale e morale, la diaspora ebraica, europea e statunitense soprattutto, ha avuto un ruolo enorme. Il mio modo di vedere il mondo, di concepire la storia e la letteratura, l’emancipazione individuale e collettiva, è debitrice di tutta una serie di voci che vengono da quel mondo: da Proust a Kafka, da Primo Levi a Arendt, da Marx a Adorno, da Günther Anders al regista ebreo-russo Alexeï Guerman. E’ questa una ragione in più, che mi rende attento, oggi, alle reazioni degli ebrei europei o nordamericani. Ed è proprio di alcune voci della diaspora che voglio parlare, in particolar modo di quella di Anna Foa, storica italiana, e di Judith Butler, filosofa statunitense.
Prima di considerare il loro punto di vista, vorrei aggiungere un’ultima cosa. Gli errori che l’Occidente ha fatto, l’errore che gli Stati Uniti, ma poi l’Europa, e i governi di Francia e Italia in particolare hanno fatto, rifiutandosi di lottare con tutti i mezzi diplomatici disponibili per imporre un cessate il fuoco a Israele, lo pagheremo tutti. Lo pagano ora in modo straziante i palestinesi, ma lo pagheranno comunque anche gli israeliani, poi i cittadini statunitensi ed europei, così come tutte le nostre istituzioni nazionali e internazionali. Facts have consequences, come dicono gli anglosassoni, anche se le conseguenze non si “vedono” subito.
Sto rileggendo un libro di Jean-Pierre Filiu, storico francese del Medio-Oriente contemporaneo (Gli Arabi, il loro destino e il nostro, La Découverte, 2015). Il mondo intero sta ancora pagando per una somma precisa di decisioni e azioni realizzate in seno all’amministrazione statunitense, al momento del lancio nell’autunno del 2001 della “guerra globale contro il terrore” da parte di George W. Bush e, in particolar modo, per l’invasione dell’Iraq del 2003, fuori dal mandato dell’Onu. Da allora in poi, sia ogni tipo di terrorismo islamico sia la repressione autoritaria di ogni forma di contestazione politica, hanno avuto il vento in poppa nei paesi arabi come in alcuni paesi dell’Africa subsahariana. Caso esemplare l’Algeria che, tra il 1991 e il 2001, conosce il “decennio nero”, ossia una guerra civile tra islamisti e il governo autoritario del Fronte di Liberazione Nazionale. Con l’arrivo al potere di Bouteflika nel 1999, presidente che ha governato fino al 2019, nel paese viene imposta la politica della “concordia civile”. Ciò significa l’amnistia rapida di 5000 insorti (legati al Gruppo Armato Islamico), mentre in carcere rimangono gli oppositori che non hanno mai praticato la lotta armata. Dopo la guerra al terrore di Bush, buona parte dell’Occidente (francesi in testa) difenderanno l’opzione: meglio la “stabilità” dei regimi autoritari che la rischiosa democrazia; nel frattempo però regimi e forme d’islamismo armato non faranno che consolidarsi a vicenda, a scapito di ogni autentico progresso democratico. Le recentissime vicende siriane non fanno che confermare questa tendenza.
“Il suicidio di Israele” di Anna Foa
Il libro è uscito per Garzanti nell’ottobre del 2024. Per certi versi dialoga con il libro di un altro storico, Enzo Traverso, uscito per lo stesso editore alcuni mesi prima. Mi riferisco a Gaza davanti alla storia. Foa guarda, però, la vicenda della guerra e delle stragi di civili dal punto di vista dei tempi lunghi della storia della diaspora ebraica e soprattutto della nascita di Israele. Il suo è il punto di vista di una storica, ma è anche una voce della diaspora che vuole innanzitutto distinguersi dalla voce del governo israeliano e dalla maggioranza di israeliani che lo sostiene. È questo un punto per me fondamentale, perché per mesi sono rimasto allibito da un doppio movimento evidente in una parte importante della comunità ebraica francese: l’adesione quasi completa al punto di vista del governo Netanyahu, da un lato, e la sintonia ideologica con le posizioni del Rassemblement National (estrema destra francese), dall’altro. (Di un movimento simile, in Italia, parlano Bruno Montesano e David Calef in un articolo apparso su “il Manifesto” del 29 novembre dal titolo Ebraismo oltre la linea nera).Ora questa attitudine si è fatta sentire in modo particolare nel trattamento dell’informazione su ogni tipo di canale pubblico o privato. In altri termini, l’orientamento della diaspora, assieme ad altri fattori, ha senz’altro contribuito in Europa – più ancora, per altro, che negli Stati Uniti – a “blindare” la narrazione filoisraeliana. Il risultato di questi sforzi congiunti per legittimare l’annientamento delle vite dei civili palestinesi o per oscurarlo almeno parzialmente, ha avuto come conseguenza l’uso sempre più aperto e sistematico del termine “genocidio” di una parte dell’opinione pubblica, quali che siano le considerazioni avanzate sull’opportunità di un tale uso. È una delle tante lezioni sulla democrazia, che gli opinionisti occidentali amano elargire agli altri, senza mai apprenderle loro stessi per davvero. La polizia del pensiero funziona per “loro”, nelle sedi dei giornali o delle radiotelevisioni, ma non per la gente che non è pagata per dire o meno quello che pensa.
Per quel che mi riguarda, è un termine che preferisco non utilizzare. In questione non è tanto la pertinenza o meno di questo “termine” sul piano strettamente giuridico, per molti versi plausibile, e in ogni caso legittimo in una campagna politica di denuncia dell’azione militare israeliana e di richiesta di un cessate il fuoco. Preferisco non usarlo per gli effetti, inconsapevoli o meno, che la sua formulazione può indurre in me, cittadino italiano, appartenente a quel popolo che ha avuto un ruolo nello sterminio degli ebrei in Europa. Non trovo del tutto convincente l’articolo scritto da Liliana Segre per il ”Corriere della Sera” su questo tema (il 29 novembre 2024). Considero che, ad esempio, definire il governo Netanyahu “pessimo”, riveli oggi una forma d’indulgenza non condivisibile. Un governo da più parti (e non solo dai palestinesi) accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, su cui pende un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale, che sta promuovendo l’annessione quasi integrale della Cisgiordania, è criminale; così d’altra parte, durante i mesi delle contestazioni di piazza, l’avevano definito gli oppositori israeliani prima del 7 ottobre, anche se per ragioni di politica interna. Nonostante questo, c’è un punto importante che accolgo della riflessione di Segre. Lo cito: ”In primo luogo, solo coprendosi occhi e orecchie si può evitare di percepire il compiacimento, la libidine con cui troppi sembrano cogliere un’opportunità per sbattere in faccia agli ebrei l’accusa di fare agli altri quello che è stato fatto loro”. Io a questo ci credo, e credo che valga soprattutto per alcuni europei. E la voluttà nell’uso di tale parola, anche se è riferita alla condotta degli israeliani di oggi, risiede nel pensiero implicito che può suggerire ad alcuni di noi: “adesso, cari ebrei, siamo pari, possiamo liquidare questo vecchio fardello”. Ho sentito parlare di “genocidio” da scrittrici e scrittori arabi, ad esempio, ma in loro non era percepibile questa “libidine” né questo sollievo nel “pareggiare” i conti.
Il titolo di Foa è senza ambiguità: dal punto di vista di chi, come gli ebrei della diaspora, è amico di Israele, quello che sta accadendo è un suicidio collettivo, un suicidio sia politico che morale e culturale. L’indossare il ruolo di carnefici non è incompatibile con una condotta suicidaria. Il capitolo importante che l’autrice dedica al sionismo, alle sue varie facce e soprattutto alla sua evoluzione, prima e dopo la nascita dello stato di Israele, diventa una tappa indispensabile per comprendere i motivi e le cause degli sviluppi attuali. Diversi storici israeliani così come ebrei statunitensi hanno studiato, decostruito e criticato il mito nazionalista del sionismo. Era importante che, in questo contesto, si aggiungesse anche una voce autorevole della diaspora italiana. Anche perché Foa stessa sottolinea come “La diaspora europea [taccia] clamorosamente, tranne voci davvero isolate” (p. 10). E aggiunge: “In questi tre anni, i tre mondi ebraici del dopo 1948 sono diventati essenzialmente due: quello israeliano e quello americano. La diaspora europea perde progettualità e importanza. Oggi l’ebraismo europeo è privo di ogni progetto culturale e politico, di ogni autonomia rispetto a Israele” (p. 57).
Prospettive post-sionistiche
La ricostruzione storica dell’autrice mi sembra indispensabile per considerare in modo adeguato non solo le componenti divergenti del sionismo, ma anche il carattere ambiguo della nascita di Israele. Mi sembra anacronistico ridurre quella vicenda a un’ispirazione e a un progetto puramente coloniale, progetto che si è invece imposto progressivamente attraverso tappe e svolte specifiche, anche in rapporto all’azione dei paesi arabi circostanti o degli stessi dirigenti palestinesi. Non si tratta, qui, solamente di discettare su diversi quadri interpretativi di storici di professione, ma di comprendere la dimensione tragica di quell’evento storico, che ha costituito una prospettiva di salvezza per un popolo perseguitato fino allo rischio di sterminio totale, producendo, nello stesso tempo, una catastrofe per un altro popolo, quello palestinese. Fornire una lettura riduttiva di quell’evento, mi sembra non possa che ritardare ulteriormente il riconoscimento delle rispettive memorie traumatiche e identità storico-culturali. Oltre il conteggio delle responsabilità storiche, oltre la denuncia e la cessazione dei crimini, oltre la persecuzione dei criminali, si dovrà, per inverosimile che possa oggi apparire, giungere al riconoscimento reciproco di due popoli e del loro diritto di vivere in piena autonomia e pace.
In un’ottica non più storica, ma progettuale, il discorso di Foa mi sembra fondamentale. Scrive:
“Non è ormai giunto il momento di guardare e costruire una società civile e democratica, di cittadini liberi e uguali nelle loro diversità? E come può uno Stato ebraico, necessariamente fondato sulla supremazia degli ebrei sugli altri cittadini, garantirla? È questa una contraddizione di fondo tra Stato ebraico e Stato democratico, che si perpetua dall’inizio e che è ora necessario sciogliere se si vuole uscire da questa situazione di guerra, ma anche dallo stallo che ha preceduto la guerra.” (p. 75)
Richiamare questa contraddizione, dopo averla studiata in quanto storica, non è un punto secondario. Chi, in una prospettiva filopalestinese, nega questa contraddizione, schiacciando tutta la storia israeliana su di un progetto unicamente coloniale, non fa che rafforzare quell’identità che il sionismo religioso e l’estrema destra israeliana hanno contribuito, per primi, a consolidare in un’unica dimensione. Il futuro di uno Stato israeliano non-coloniale e davvero democratico dipenderà anche dalla capacità degli israeliani di trovare dentro di sé e dentro la loro storia una leva per trasformare la propria mentalità e i propri comportamenti. In altre parole, “per il post-sionismo è necessario voltare pagina, passando da ‘uno Stato ebraico e democratico’ come Israele è ufficialmente definito dal 1992, a ‘uno Stato democratico per tutti i suoi cittadini’, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica, nazionale e religiosa” (p. 77). Qui è Foa che cita Arturo Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi, Carocci, 2017.
“Rendere impossibile una parola ebrea contro la violenza di Stato” di Judith Butler
Affinché simili prospettive possano rendersi praticabili almeno in futuro, è indispensabile che non solo la distruzione di Gaza e l’annessione della Cisgiordania siano denunciati, ma anche gli stessi presupposti ideologici che giustificano questa politica agli occhi del governo di estrema destra e di una maggioranza della popolazione israeliana. Per fare questo, però, bisogna difendersi dalle accuse di antisemitismo che la propaganda di Netanyahu promuove, amplificata da associazioni ebraiche e da opinionisti politici in Occidente e in Europa. Anche qui i “poliziotti del pensiero”, quali che siano le loro più o meno ciniche motivazioni, non hanno impedito che, ad un certo punto, la manipolazione della memoria della Shoah sia diventato tema di molteplici critiche. Questa manipolazione è per altro in atto da anni, ma nel corso di questa guerra essa è stata definitivamente smascherata. Anche Foa evoca questo tema, ma è Judith Butler che lo affronta con più severità. L’articolo di Butler è stato raccolto in un volume francese dal titolo Contre l’antisemitisme et ses instrumentalisation edito per La fabrique nel settembre 2024.
Butler evoca una serie di episodi che hanno riguardato università e istituzioni culturali, soprattutto negli Stati Uniti e in Francia. In tutti questi casi si è considerato che iniziative o conferenze a sostegno della Palestina fossero da impedire, in quanto di per sé minacciavano la sicurezza di studenti ebrei o più in generale della comunità ebraica. Ma Butler ricorda come questa censura non sia stata esercitata in casi di appelli all’odio nei confronti degli ebrei, dove sarebbe stata comprensibile, bensì in occasione di denunce del genocidio a Gaza e di richieste di “cessate il fuoco”. E scrive:
“Questa manipolazione è profondamente nefasta, perché reclamare il cessate il fuoco esprime precisamente il desiderio che si arresti di fare del male ad altri. Oggi, sono le palestinesi e i palestinesi che hanno bisogno di essere protetti. E la comunità internazionale ha fallito nel fornire loro questa sicurezza. Hanno bisogno di essere al riparo dal pericolo, dal pericolo fisico reale – di essere ammazzati, feriti gravemente o di vedere la propria famiglia massacrata.” (p. 13)
Butler mostra come, alla fine, l’estensione indebita dell’accusa di “antisemitismo” finisca per riguardare “il fatto stesso di chiedere giustizia in Palestina”. A questa considerazione ne va aggiunta un’altra di Anna Foa, che scrive: “E gli ebrei del mondo, di quella diaspora che si riempie la bocca e la mente di etica ebraica e di pensiero ebraico, come possono accettarlo senza reagire. Come possono parlare solo dell’antisemitismo senza guardare ciò che in questo momento lo fa divampare, la guerra di Gaza?” (p. 87). Foa non nega che ci sia anche un “divampare” dell’antisemitismo, ma una tale preoccupazione, pur legittima, non può oscurare le ragioni di un tale fenomeno. E, d’altra parte – aggiungo con Butler –, non possono porsi sullo stesso piano di gravità e urgenza il massacro in atto delle vite palestinesi, vite isolate dal mondo, e azioni vandaliche su oggetti e minacce razziste, indirizzate a comunità che vivono in uno stato di diritto.
Narrazione contro cifre (e immagini)
L’ultimo tema, che Butler affronta nell’articolo citato, riguarda la “potenza del racconto” e fa riferimento all’inestimabile, insostituibile, potenza conoscitiva dei “racconti” rispetto al dato astratto fornito dalle cifre dei morti e dei feriti. L’autrice ne parla, qui, in due succinte pagine, ma si tratta di una questione capitale, che riguarda non solo l’attualità e i conflitti politici, ma il ruolo che, dal punto di vista antropologico, le narrazioni svolgono nelle nostre vite. Non pensate per favore a tutta quella letteratura insipida sulle virtù che la forma narrativa può fornire a qualsiasi tipo di evento o esperienza, come se si trattasse di una tecnica specifica, in cui specializzarsi per ottenere una sorta di “marketing esistenziale”. La comprensione delle nostre azioni è da sempre connessa ai quadri di riferimento storico-sociali e alle forme di narrazione che si accompagnano a essi. Quello che è importante capire dell’osservazione di Butler è che l’impatto che le cifre hanno su di noi è limitato: che differenza fare tra mille o diecimila bambini morti? In quale modo, se non vago, estremamente parziale, possiamo cogliere una differenza tra mille e diecimila morti? La sola idea della morte violenta di mia figlia quattordicenne, non ancora del tutto uscita dal mondo dell’infanzia, mi sembra inconcepibile e straziante. Come posso familiarizzarmi con dieci, cento, mille, diecimila volte quello stesso già inimmaginabile dolore? No, le cifre non ci aiutano ad avvicinarci alla realtà di massacri di tali entità, come quello subìto da più di un anno dalla popolazione palestinese. Ma questo vale già per il massacro del kibbutz di Kfar Aza, dove i miliziani di Hamas hanno ucciso più di 200 civili andando casa per casa. Posso misurare certamente la diversa gravità del fatto, se pongo a confronto l’uccisione di 1200 persone o quella di più di 40.000, ma la distruzione di ogni vita innocente è da considerare una perdita assoluta, incommensurabile, non perché sia sacra per un Dio o per la ragione universale, ma perché è sacra per una parte dell’umanità: un genitore, un amante, degli amici, una comunità, un popolo. E siccome ognuno di noi ha qualche vita intorno a sé che considera intimamente, visceralmente, sacra, ciò significa che ognuno di noi sa come e perché una vita è sacra.
Ma ritorniamo all’entità del “terrorismo di stato” israeliano e alla possibilità di tradurlo in qualche forma di comunicazione. Butler si riferisce a Gaza Writes Back, una raccolta di racconti di scrittrici e scrittori palestinesi dedicata all’operazione Piombo Fuso (2008-2009) dell’esercito israeliano. Commentando le parole del curatore Rafat Alareer, l’autrice scrive:
“Queste storie, queste poesie non sono appunto delle cifre: emergono da individui che lavorano in seminari di scrittura collaborativa e che traducono i testi in inglese per assicurarsi che “il mondo” sappia cosa è successo e per dare un senso vivo e dettagliato a quel che significa continuare a vivere dopo la perdita di una vita, in uno spirito di perseveranza e di resistenza collettiva.” (p. 23)
Che cosa cambia, allora, tra l’evocazione della perdita di una vita umana in cifre e quella attraverso un racconto? In realtà, non si tratta neppure di “dettagli” in quanto tali, anche se il dettaglio è sempre importante in una narrazione. Il racconto ci parla più delle cifre, perché ci permette di vedere la morte di un essere umano dalla prospettiva della vita di un altro essere umano o, al limite, dalla sua stessa prospettiva, prima che giunga l’annientamento. Non c’è argomento più persuasivo contro la pena di morte, che la narrazione, reale o fittizia, della vita di un individuo che si è meritato una tale condanna. È una delle cose che insegna la lettura, ad esempio, di un romanzo come A sangue freddo di Truman Capote.
Ho insistito sulla “debolezza” delle cifre per trasmettere l’orrore del massacro, ma un discorso analogo dovrebbe essere fatto per le foto e più generalmente le immagini. Quante foto o quante sequenze di bambini estratti a pezzi dalle macerie, dopo un bombardamento, devono convincermi che quel bombardamento è ingiusto, sbagliato, criminale? Le foto sono importanti, come è importante la loro circolazione. Ma le foto, che siano disponibili o meno, non producono di per sé indignazione. O meglio, non è la moltiplicazione di foto di massacri che possono commuovere qualcuno che non si è commosso alla documentazione di un primo massacro. È necessario vedere i corpi scheletrici degli internati dei Lager, così come le cataste dei cadaveri prodotti dallo sterminio nazista. Ma quante di queste immagini dobbiamo vedere, per convincerci dell’entità e dell’orrore della Shoa? Quelle immagini sono importanti, ma non sarebbero sufficienti, ad esempio, senza la lettura di Se questo è un uomo.
Ho trovato interessante e acuto l’articolo Davanti allo sterminio degli altri di Massimo Palma, apparso su “Antinomie” (20/11/2024). L’intervento di Palma ruota interamente intorno a questo paradosso: tante sono le circostanze e le ragioni che rendono “inefficaci” dal punto di vista “politico” le immagini dei massacri, come quello in corso a Gaza. Vi sono voci che si levano anche contro l’opportunità che tali immagini “circolino”. Palma le considera attentamente, ma lui stesso devo poi giungere a questa constatazione: “La realtà della guerra sempre online, mai disconnessa – questa è il fatto nuovo che ci sta offrendo un anno di ripresa in diretta della guerra, ora per giunta guerra diffusa”.
Come non mi piace ripetere a ogni piè sospinto che Israele sta compiendo un “genocidio” così non voglio riempirmi la mente di immagini di bambini palestinesi fatti a pezzi. Il risultato non sarebbe una maggiore comprensione o coscienza della gravità dell’accaduto, ma un semplice odio e schifo negli esseri umani in quanto tali – me incluso alla fine -, che sarebbe difficile poi togliersi di dosso. Non ho capito né accolto tutto l’orrore della distruzione di Gaza – chi è in grado di farlo? Non basterà una generazione di palestinesi e israeliani ad assimilare tutto quello scempio di vite fatto e subito. Ma condanno l’uso del terrore dei miliziani di Hamas come quello dello Stato israeliano, senza produrre un’equivalenza tra torti palestinesi (che vivono su un territorio controllato e occupato) e torti israeliani (che controllano e occupano terre altrui), né un’equivalenza riguardo all’entità del male procurato; disprezzo i dirigenti politici occidentali cinici e vigliacchi che esibiscono ancora una volta i “due pesi e due misure”, disprezzo l’opportunismo di tanti opinionisti che svolgono con entusiasmo il ruolo di “poliziotti del pensiero”, perché avrei voluto che gli uni e gli altri si impegnassero per limitare la distruzione delle vite palestinesi.
Coda
Molto di più di tante immagini o di tante cifre sull’invasione Russia dell’Ucraina, mi ha toccato Intercepted, un documentario realizzato quest’anno dalla regista ucraina Oksana Karpovych. Nel film, ascoltiamo brani di conversazione di soldati russi, attivi sul fronte ucraino, con la propria famiglia (moglie, genitori, ecc.). Queste conversazioni realmente accadute sono state intercettate dall’esercito ucraino e poi montate dalla regista, sullo sfondo di immagini di paesaggi urbani o naturali, che hanno ricevuto l’impronta della guerra. Non si vede, insomma, una sola azione violenta. La violenza è tutta nei racconti che i soldati russi fanno della loro vita al fronte, delle condizioni miserabili in cui vivono, e delle cose atroci che alcuni di loro hanno fatto (come torture o uccisioni di civili ucraini).
*
[1] Scrivevo in La trappola e il diniego. Riflessioni a margine della guerra: “Sono un italiano, nato in un paese che ha prodotto il fascismo e ospitato i nazi-fascisti. Ho letto Primo Levi, un italiano ebreo, che dai nazi-fascisti è stato spedito nei campi di sterminio. Vivo attualmente in un paese dove è esistito il regime di Vichy, che ha collaborato alla deportazione nei Lager di decine di migliaia di uomini, donne e bambini ebrei. Più in generale, sono la storia lunga dell’antisemitismo europeo, oltre a quella breve e devastante della Shoa, e infine la storia del colonialismo europeo (inglese, in particolare) a determinare la nascita dello Stato di Israele nella Palestina mandataria”.

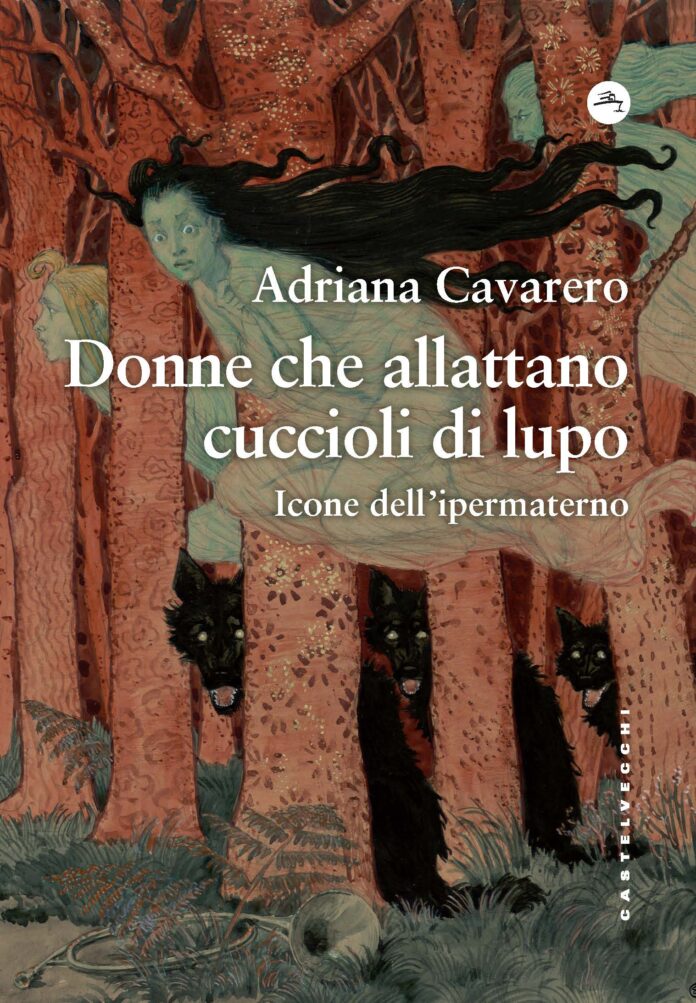




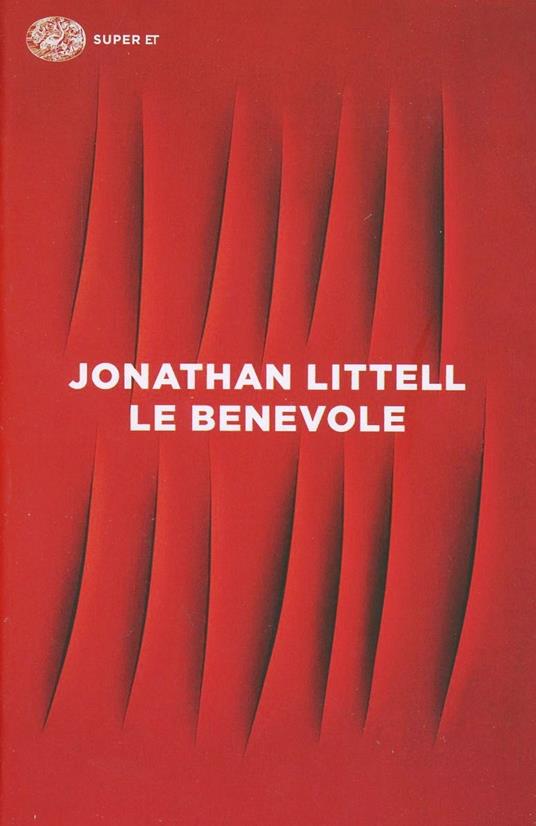







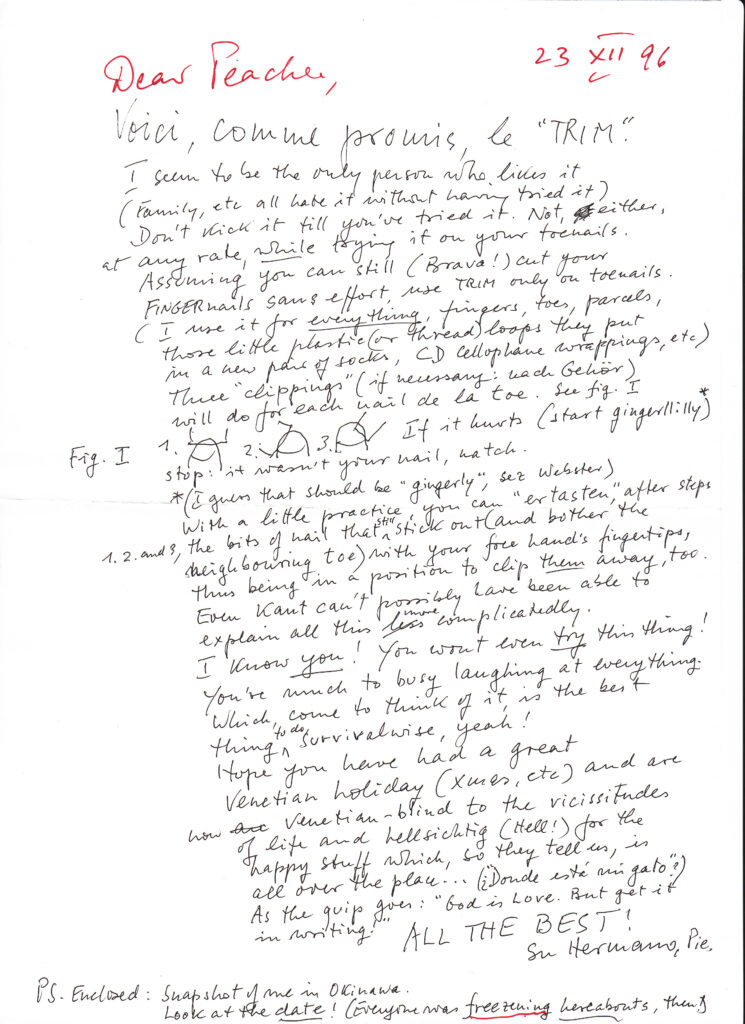
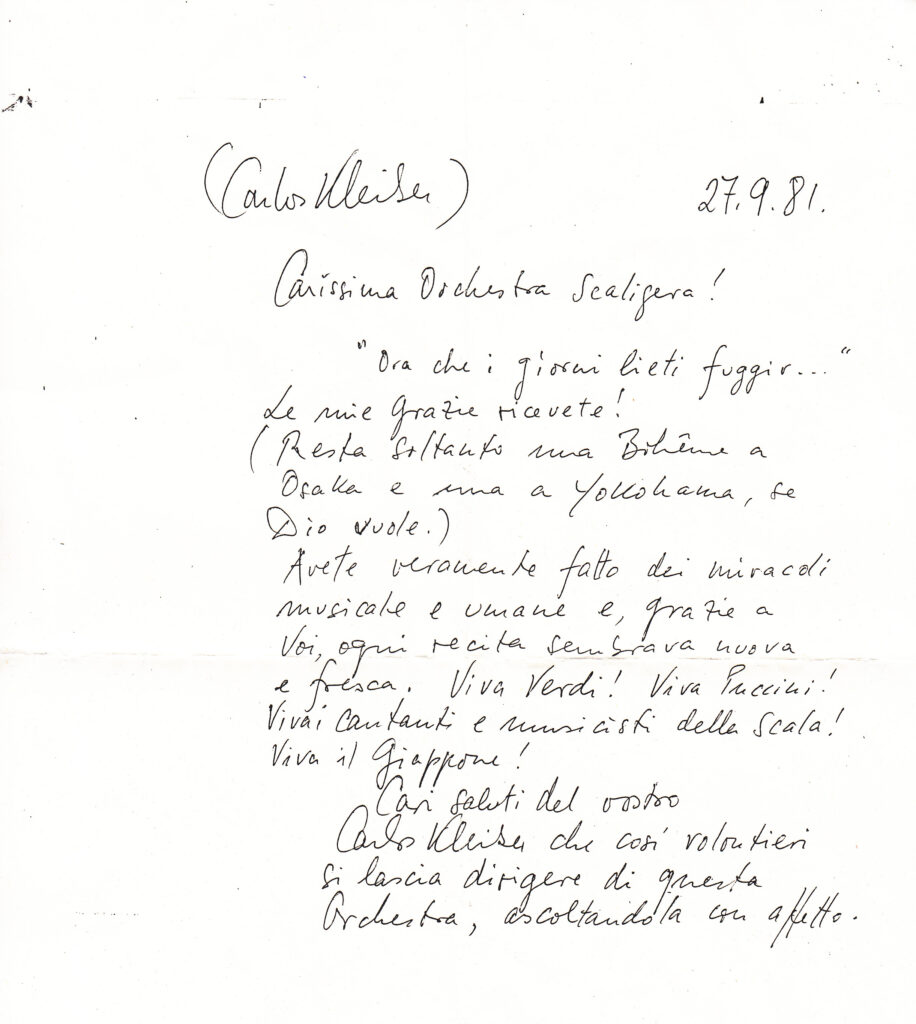
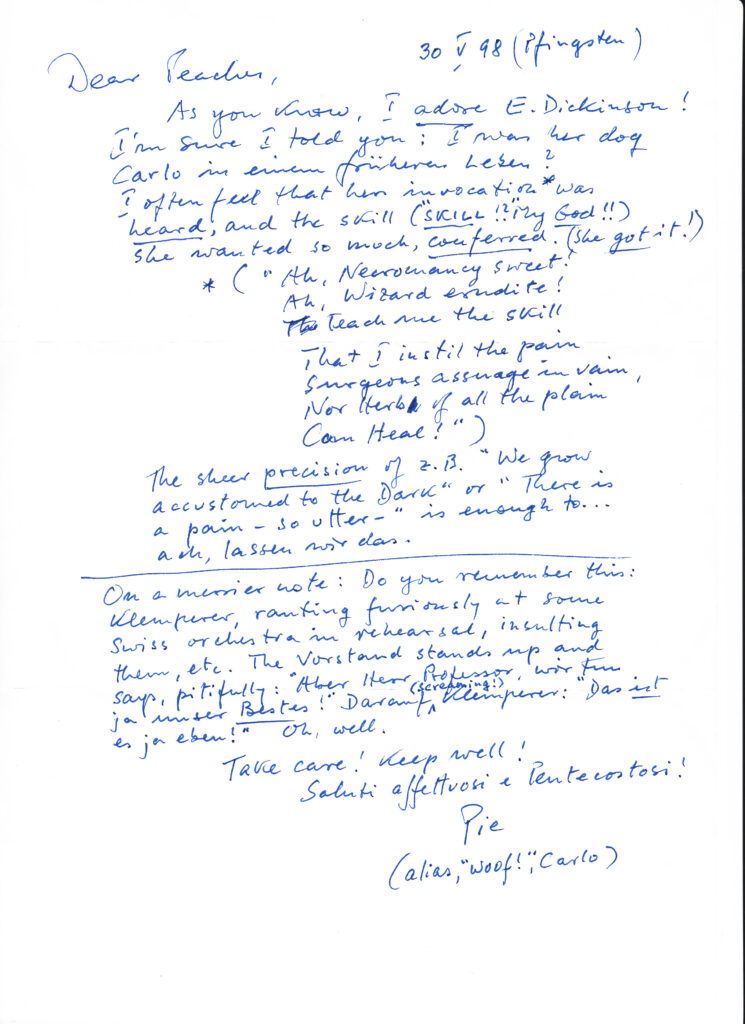
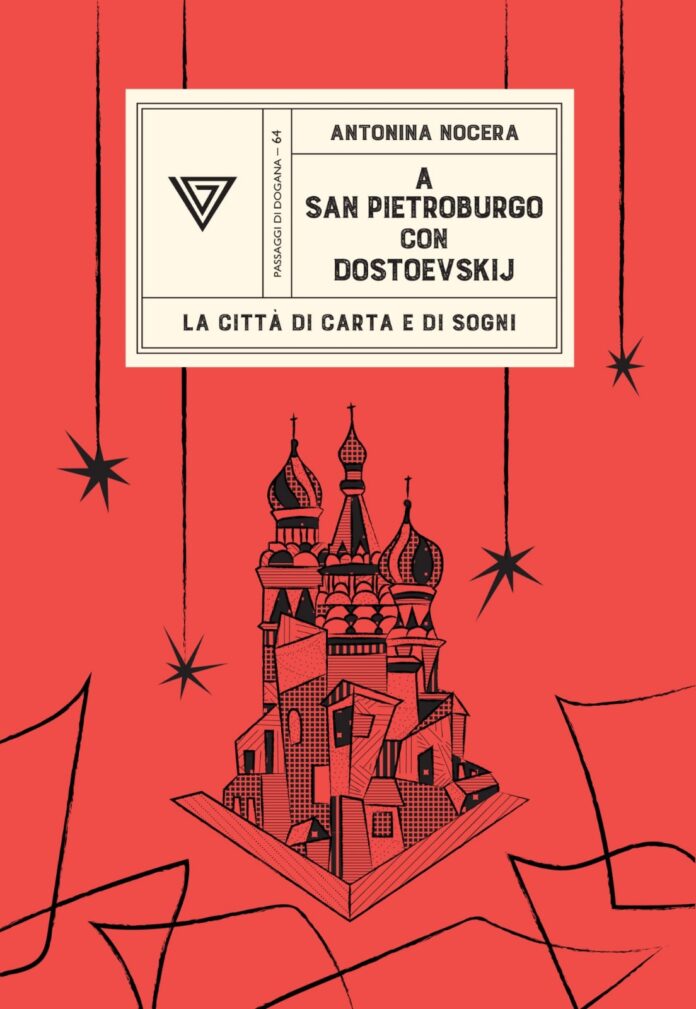


 di Simonetta Gallucci
di Simonetta Gallucci