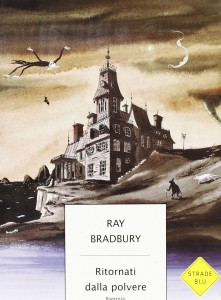di Gianluca Veltri
“Qualcosa era andato storto […], ma per quanto ci pensassi
e ci ripensassi, non riuscivo a trovare l’errore, l’abisso che
se mi guardavo alle spalle si apriva dietro di me, […]
privo di mostri sebbene non di oscurità, di silenzio e di vuoto”.
Roberto Bolaño, “I detective selvaggi”
Correva il lungo decennio dell’oblio. Dieci anni che David Crosby confesserà di aver sprecato. Wasted. L’ex guru della generazione hippie si trascinava come uno spettro. Gonfio di eroina, in cerca di un pusher nel Tenderloin, o di un poliziotto con cui attaccare briga sulla Market. Entrava e usciva di carcere. La musica meravigliosa che aveva regalato al Flower Power tornava a ronzargli ogni tanto confusamente nella testa, come un tarlo o un rimpianto, o un sogno andato a male. Come un’ipotesi ch’era stata vera un tempo e ormai non riusciva più a farsi realtà. Le armonie si trasformavano in polvere prima di uscire dalla sua mente. Qualche amico cercava di tirarlo fuori dal suo cono d’abisso: Neil Young gli dedicava una canzone, Jackson Browne andava a casa sua a Mill Valley, al di là del Golden Gate, per tentare di scuoterlo e convincerlo a disintossicarsi. Senza fortuna.
Nel 1988 esce un disco a firma CSN&Y: non è memorabile, a partire dal titolo, fuori tempo massimo: “American Dream”. Passerebbe inosservato, se verso la fine non fosse attraversato da una lama di luce accecante: un pezzo finalmente, di nuovo, a firma David Crosby. Si intitola Compass. È lui. La chitarra riprende a tintinnare armonie colme di sospensione, la voce è vissuta e dolente. È lì che Crosby parla dei suoi anni gettati via. Sembra un fantasma che sia tornato da un luogo inaccessibile agli altri.
Com’era finito in quel buco nero il principe del raga-rock?
Nel 1965, 24enne, Crosby era nel quintetto-base storico dei Byrds, in quel dream team che avrebbe sfornato lucentezze in serie, dalle rivisitazioni elettriche dylaniane alle visioni spaziali a occhi spalancati. In questo manipolo di pionieri, Crosby era quello più all’avanguardia: le sue composizioni sono quelle più scorbutiche e pensose; oniriche, introverse, acide. “Why”, “Mind Garden”, “Triad” (non pubblicata se non qualche anno dopo) , “Everybody’s Been Burned”. Sebbene il suo spazio aumenti dopo la fuoruscita dell’altro sublime songwriter della band Gene Clark, Crosby sente sacrificata la propria visibilità a causa dell’ego di Roger McGuinn. Lascia i Byrds. Comincia qui la sua personale geografia dell’irrequietezza. Comincia un triennio che lo consacrerà, neanche trentenne, come il leader non di una semplice band, bensì di un intero movimento generazionale. L’incontro con Stephen Stills e Graham Nash, velato di leggenda, consacra il trio come portabandiera di un’epoca nuova. We Can Change The World. Issati nulle navi di legno, le wooden ships, i nostri, paladini a Woodstock con l’aggiunta di Neil Young, agitano la bandiera del sol dell’avvenire.
Dov’era svanita, un decennio più tardi, tutta questa luce? Che dispersione pazzesca doveva essersi verificata per permettere tanto sciupìo? Che fine aveva fatto l’energia di quell’enorme comunità che doveva cambiare il mondo? Woodstock e i bassifondi di San Francisco erano distanti anni luce. Eppure li separavano soltanto una manciata di anni. Anni in cui Crosby, coi suoi baffoni e le giacche sfrangiate, aveva composto capolavori come “Guennevere”, “Deja Vu”, “Almost Cut My Hair”, “Long Time Gone”. Anni in cui aveva sperimentato la vetta e poi il dolore più attonito, perdendo in un incidente stradale la sua compagna Christine: l’onda lunga di questa perdita avrebbe proiettato la sua ombra negli anni successivi. Crosby aveva poi pubblicato uno dei dischi-chiave della generazione dei figli dei fiori, il paradiso dei freak: “If I Could Only Remember My Name”. Una koiné californiana – Jerry Garcia, Grace Slick, Jorma Kaukonen, Phil Lesh, Joni Mitchell, Stills, Nash, Young – a suggellare l’epitaffio. Si appone la ceralacca sul ’68, o forse una pietra tombale, sebbene dorata. Con canzoni celestiali come “Laughing”, “Music Is Love”, “Song With No Words”. È l’atto conclusivo, il punto più alto celebrato su disco di qualcosa che è finito per sempre (proprio mentre sta finendo). Dopo quel disco, è come se si sganciasse dal cielo un pezzo di montagna, precipitando in migliaia di schegge.
Crosby continua con Nash. Ma ascoltare il loro (ottimo) album che ha i loro nomi per titolo, uscito appena un anno dopo “If I Could…”, provoca uno shock straniante. La diga è crollata: loro, sentinelle del futuro, sono come usciti da una sbornia. Lui, David, è il Tiresia che capta gli anni che verranno. Quelli di Crosby & Nash sono dischi belli e desolanti, di reduci, ripiegati si se stessi, canzoni tristi cantate da ex-qualcosa. L’ultimo lampo, una specie di sequel ben simulato, è il disco della barca, nel 1977. In quei solchi ci sono tre meraviglie di Crosby destinate a rimanere le ultime per un bel po’: “In My Dreams”, “Shadow Captain”, “Anything It All”. Qui si chiude uno spesso sipario. Il capitano dell’oscurità prende il timone. David Crosby è un tossico, vive esclusivamente di droga. Non c’è più spazio per i sogni, quelli degli anni ’60 si sono deformati in vaghe ombre spettrali.
A metà degli anni ’80 il mondo si è ormai scordato di Crosby. Qualche giornalista più sensibile (si) chiede dove si sia cacciato. È la figura di un passato prossimo divenuto già remoto, un eroe guastato. Il frutto sbagliato di un’epoca giusta; il frutto giusto di un’epoca sbagliata. Quel che si sa di lui è solo che si è perso, che si è perduto. Il carcere è la sua seconda casa. Non canta più. La sua chitarra non suona più, è coperta da uno strato appiccicoso e opaco di brutte giornate e notti angosciose. Le corde diventano ruggine. Quelle meravigliose accordature aperte traboccanti di suoni e mondi non risuonano più.
Poi arriva “Compass”. I have wasted ten years in a blind-fold. Il processo è stato lentissimo, pieno di tentativi falliti, lusinghe e trabocchetti, rinunce e ricadute. Ma David infine si è aggrappato a una barchetta di legno, non è una nave, ma insomma. Lo aiuta a vivere l’amore per la sua famiglia, la moglie, la figlia. Recupera con vigoroso candore il tempo perduto. Torna a fare dischi: a diciotto anni dall’esordio-epitaffio “If I Could Only Remember My Name”, una vita fa, licenzia un disco il cui titolo è la risposta a quell’altro titolo: “O Yes I Can” (prima di Obama). Dopo solo quattro anni esce un altro disco ancora, “Thousand Roads”. David ha fame di vita come può succede solo a un sopravvissuto. Gli accadono varie cose, come a compensare lo spreco perpetrato. È richiesto come artefice maschile in alcuni casi di inseminazione artificiale, tanto da essere ribattezzato “inseminator”; scopre di essere padre di un giovane musicista di nome James Raymond, avuto da una relazione negli anni ’60; recita nel film “Hook” di Spielberg; entra per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, una volta con i Byrds, l’altra qualche anno dopo con Stills e Nash; si sottopone a un trapianto di fegato rischioso e complesso, poi infine risolutivo. Suona e incide nuovi album con il figlio ritrovato, nel nuovo trio CPR (il terzo, la P, è Jeff Pevar, giovane chitarrista crosbiano). È in tour coi vecchi sodali del pleistocene hippy. Ed eccolo a New York accanto ai contestatori globali del nuovo millennio, a Occupy.
Nel 2014 esce, a venti anni dal precedente, il quarto album a suo nome, “Croz”. Insomma David Crosby è più che mai intenzionato a riprendersi indietro un poco del tempo che ha sprecato. Come un naufrago che ha ritrovato la costa. Può succedere che te lo trovi su un palco, da solo, nella versione più sincera e priva di mediazioni possibile: voce & chitarra. Te lo puoi permettere, se hai qualcosa di importante da raccontare.







 Piazza Dante.
Piazza Dante.

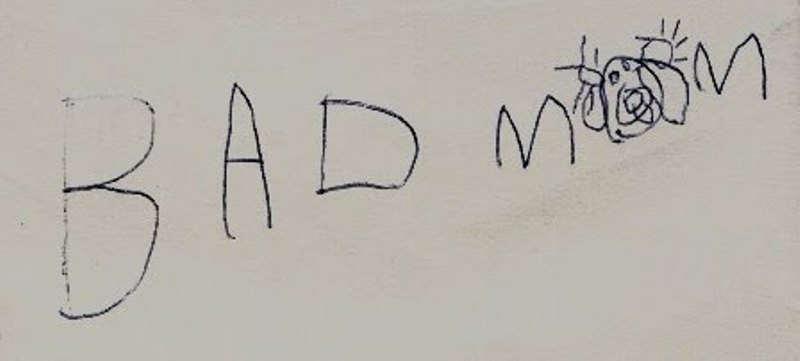


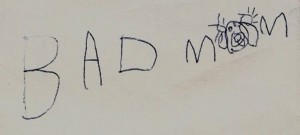
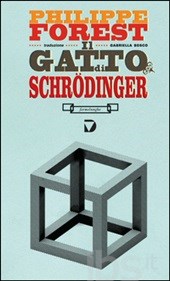


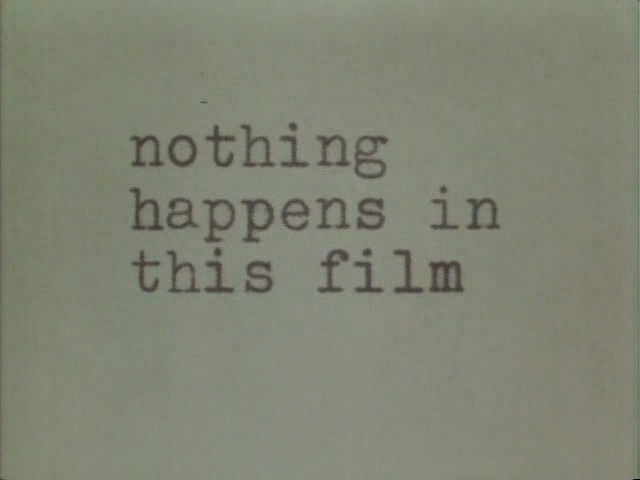



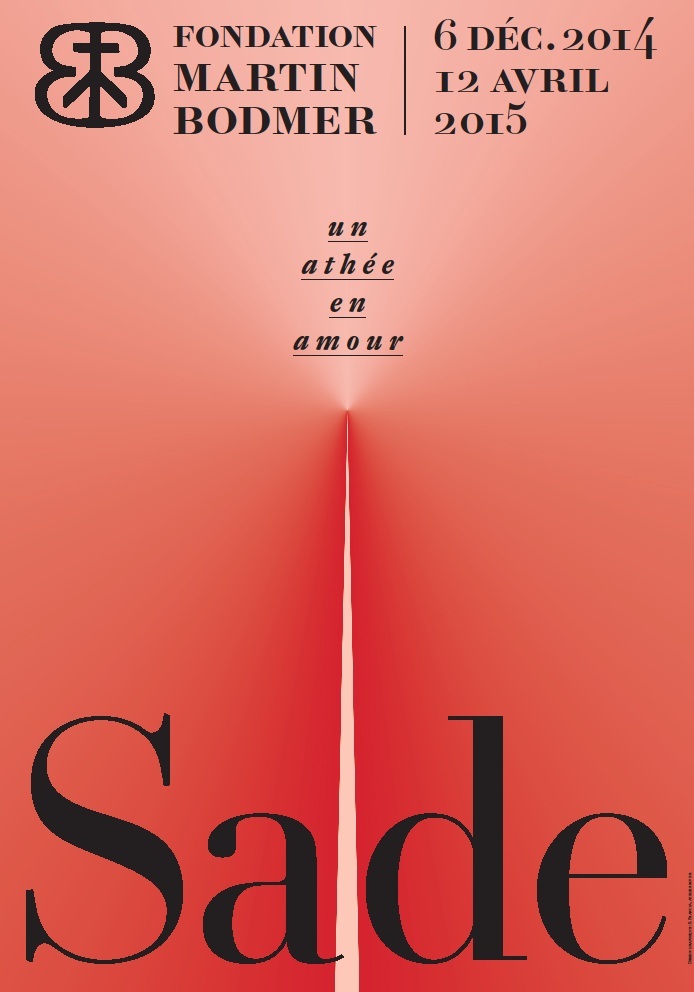 In queste settimane, trascorso da pochi giorni il bicentenario della morte (3 dicembre 1814), sono in corso in diversi punti d’Europa degli eventi in celebrazione di Sade. Una prima importante iniziativa è la mostra “Sade. Attaquer le soleil” al Musée d’Orsay di Parigi, curata dalla grande studiosa sadiana Annie Le Brun. Una seconda mostra, “Sade, un athée en amour”, è organizzata alla Fondation Martin Bodmer di Ginevra per la cura di Jacques Berchtold e Michel Delon, la massima autorità in materia. La prima esposizione va in cerca di Sade trovandolo dappertutto (nei dipinti di Goya, Géricault, Ingres, Rodin, Picasso…); la seconda, più filologica, esibisce manoscritti originali, illustrazioni d’epoca e altri reperti storici quali il calco in gesso del cranio di Sade. Alla dimensione espositiva si sommano poi le iniziative accademiche: un convegno a Parigi (“Sade en jeu”, 25-27 settembre) e uno a Aix-en-Provence (“Les lieux de la fiction sadienne”, 23 ottobre). I risultati scientifici della recente ondata di studi sadiani sono talvolta sorprendenti, come quando, nel corso di una sessione dal titolo “Sade auteur comique?” del convegno parigino, la sala si è trovata a ridere alla lettura di alcuni passaggi particolarmente barocchi delle 120 giornate di Sodoma. Un terzo convegno ad Amsterdam (“Sade Today”, 2 dicembre) ha individuato in Sade un “teorico queer” ante litteram. Gli approcci francesi e quello olandese mostrano delle sostanziali differenze di impostazione: i primi, pur lasciando spazio a ipotesi non convenzionali, partono dall’analisi dei testi; l’altro apre le porte all’attualizzazione e alla libertà interpretativa.
In queste settimane, trascorso da pochi giorni il bicentenario della morte (3 dicembre 1814), sono in corso in diversi punti d’Europa degli eventi in celebrazione di Sade. Una prima importante iniziativa è la mostra “Sade. Attaquer le soleil” al Musée d’Orsay di Parigi, curata dalla grande studiosa sadiana Annie Le Brun. Una seconda mostra, “Sade, un athée en amour”, è organizzata alla Fondation Martin Bodmer di Ginevra per la cura di Jacques Berchtold e Michel Delon, la massima autorità in materia. La prima esposizione va in cerca di Sade trovandolo dappertutto (nei dipinti di Goya, Géricault, Ingres, Rodin, Picasso…); la seconda, più filologica, esibisce manoscritti originali, illustrazioni d’epoca e altri reperti storici quali il calco in gesso del cranio di Sade. Alla dimensione espositiva si sommano poi le iniziative accademiche: un convegno a Parigi (“Sade en jeu”, 25-27 settembre) e uno a Aix-en-Provence (“Les lieux de la fiction sadienne”, 23 ottobre). I risultati scientifici della recente ondata di studi sadiani sono talvolta sorprendenti, come quando, nel corso di una sessione dal titolo “Sade auteur comique?” del convegno parigino, la sala si è trovata a ridere alla lettura di alcuni passaggi particolarmente barocchi delle 120 giornate di Sodoma. Un terzo convegno ad Amsterdam (“Sade Today”, 2 dicembre) ha individuato in Sade un “teorico queer” ante litteram. Gli approcci francesi e quello olandese mostrano delle sostanziali differenze di impostazione: i primi, pur lasciando spazio a ipotesi non convenzionali, partono dall’analisi dei testi; l’altro apre le porte all’attualizzazione e alla libertà interpretativa.