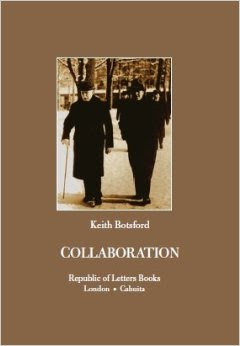Il progetto Ms
di
Stefano Felici
«Ma il meccanismo è un’illusione, e consiste proprio in questo: ti compare una schermata di parametri e linee, grafici senza senso, percentuali di completamento, e poi, sempre con tutto bene in vista, come se un’infinità di ingranaggi avesse trovato l’allineamento perfetto, finalmente uno, due, tre, quattro messaggi che in sequenza ti dicono che ora funziona, che è tutto a posto, che si può cominciare: davanti a te hai il superamento dell’intelligenza umana e non hai che da chiedergli qualcosa; ma dietro, in tempo reale, ci siamo noi e quelli di sopra, più quelli di sopra a quelli di sopra, e così all’infnito. È ovvio, sì, non me lo devi nemmeno dire; ma tu hai capito qual è il magma, il vibrante di tutta l’illusione?»
Sono quattro ore diagonali e il sole picchia duro alla finestra. A me non va più di lavorare. E ho una sete preoccupante.
Sopra i muri bianchi hanno appeso le stampe stilizzate dei quadri dirigenziali. «Sono dei Mondrian orrorifici, e se li guardi bene riesci a leggerci persino com’è che finirà il mondo.»
Io, a queste cose, dette dalla gente ironica per bella mostra, ci credo. Ne spiego la ragione: non penso che parlino per bocca propria. Sono terminali di un flusso, una parobola di ritorno messa in circolo da lontano, che arriva quando deve. E chi pensa di scherzare è solamente attraversato.
Chi mette in circolo queste cose, alla fonte, è il maligno. Io ci credo. E dal momento che in queste cose ci credo, penso corrispondano alla verità. E perché il maligno dovrebbe dire la verità, se è maligno?, mi si chiederebbe; e io risponderei: gioca. Ha così tanto vantaggio che ormai la partita è vinta. Anche se non c’è alcuna partita. Eppure, la vittoria esiste.
Così, da uno scompartimento all’altro, ci passiamo bigliettini di auguri, oppure ci congratuliamo per un giorno in più trascorso nell’edificio e non a casa. Un altro collega ironico, di quelli attraversati, mi racconta spesso – e quando racconta, forse non se ne accorge, ma ha una scarica di spasmi ai muscoli facciali da far vomitare per il terrore – tutta una storia che finisce con un uomo che passa a casa cinque giorni di fila, senza mai uscire, e siccome capisce che uscire di casa non ha più alcun senso, e non avendo alcun senso nemmeno la sua casa, alla fine si suicida. E io gli dico che una volta ho trascorso a casa tre giorni filati, e lui mi dice che cinque non è tre, e poi arriva un altro che sul piatto dei giorni ne mette quattro, ma quattro non è cinque, e per gradi prende corpo il terrore, in tutti, ma lo nascondiamo, o forse alcuni non hanno capito che questa storia dei cinque giorni non è ironia, è presagio, squarci di futuro offerti dal maligno. E chi parla è parlato.
I pavimenti dell’edificio sono viola cangiante. È stata la scelta di un lungo consiglio amministrativo, durato due giorni. In quei due giorni, nessun dirigente o rappresentante è mai uscito dalla sala riunioni. A noi impiegati è arrivata una mail. Oggetto: pavimenti viola cangiante. Io non l’ho nemmeno aperta.
Quando sento i racconti sul reparto programmazione, capisco che le star sono loro. In pratica, sono al centro del progetto. I pavimenti? Opera loro.
Ho una vaga idea che il maligno sia una manipolazione dei programmatori. Di sicuro, hanno peso decisionale su tutto. Mi è stato detto: «I pavimenti viola cangiante li hanno voluti i programmatori. Si sapeva dall’inizio. È stata una guerra titanica fra il loro rappresentante e l’amministratore delegato. Tutti gli altri sono rimasti a guardare. Esclusi. A fare i testimoni, al massimo. L’amministratore delegato voleva un bianco giallastro, i programmatori il viola cangiante. I programmatori l’hanno spuntata per il loro peso politico, non c’è nemmeno da dirlo. Ma senti qua: il viola cangiante, su certe persone che hanno una non so quale area del cervello particolarmente sviluppata, ha lo stesso effetto della cocaina. È una droga, in pratica. Questa cosa è uscita fuori nel mezzo del consiglio. E il bello è che forse si è rivelata la carta vincente.»
Ora: io sono agnostico, e nonostante il bruciore sulla nuca di quando penso a una vita consegnata alla volontà altrui, non ho proprio voglia di crearmi un olimpo di oggetti filosofici. Quindi la mia condotta per contrastare il maligno, semplicemente, è scandagliare il mio vissuto con un gioco di sponde, e in differita.
Spero comunque di scovare il bene. È ovvio. Ma lascio filare. Vorrei godere del contrasto dei due opposti che si sfidano per sancire chi ha la meglio, nel minor tempo possibile, come nello sport e nei racconti.
In camera resistono ancora due testoline di gambero in decomposizione. Emanano un fetore tagliente. Stanno dentro una vaschetta di plastica, per terra, sotto la finestra. Con una folata di vento, sono costretto ad andarmene in bagno.
Mi servono, credo sia superfluo dirlo, come indicatori di attinenza al reale. Se scompaiono, è la fine. Io non esisto, il maligno si è insediato, e tutto ciò che ne consegue.
«Il progetto Ms, in pratica, ti offre l’opportunità di tornare a credere in qualcosa di, capisci, di spesso, duro, compatto; Ms è il marmo sui cui camminerà chi ha paura delle sabbie mobili, se rendo l’idea. È stato creato da chi non ha bisogno che delle propria catarsi intellettuale, e questa, anche se non può essere rivelata a un utente Ms, è allo stesso tempo la sua garanzia a vita per il reale, per il reale come vero, come utile, per il reale come unica cosa che serve a chiunque. Parlare di illusione vale solo per noi, che facciamo un discorso su Ms. Ma Ms è progettato per esser fruito come un discorso. Per starci dentro. E ha dei firewall di concetto, lasciami dire, praticamnte inattaccabili.»
Ho passato l’ultimo mese a farmi domande, e ho rischiato sul serio di dimenticare la parte più difficile dei percorsi amministrativi. Mi servono quindi dei feticci di riferimento in cui poter salvare il groviglio delle mie intuizioni, dei miei ragionamenti. Faccio piccole sculture.
Sono ancora dell’idea di rimanere agnostico, ma il pensiero è il pensiero, e fa sì che io non sia un qualsiasi altro animale. È un’attività costante e necessaria, mio malgrado.
Pensare porta a domande, farmi domande mi è deleterio, quindi, come accade a tutti prima o poi, ho costruito un ponte di alleggerimento tra pressione psichica e realtà.
La prima scultura l’ho creata incollando una banconota da cento, vera, su un paralume merlettato. È una scultura elementare. Mi è venuta fuori, banalmente, perché ho pensato di dover eliminare i soldi dalla mia concezione di presente. E il paralume era lì.
La seconda scultura mi serve tutt’ora per allontanare l’ossessione del maligno: è una forchetta di plastica piantata in un vasetto di terriccio, che annaffio ogni mattina facendo pipì. Nel terriccio c’è il seme di una mela. Il dispositivo è semplice: finché la scultura rimane com’è, non ho alcun tipo di preoccupazione esistenziale.
Sono cinque ore diagonali e ancora non è tornata la voglia di mettermi a lavoro. Il lancio delle nuove serie di architetture per software aziendali è in preparazione. Ogni mattina, trenta fra dirigenti, informatici, psicologi e filosofi d’industria si riuniscono per degli interminabili brainstorming nella sala riunioni B, quella più piccola e calda. Gira voce che le idee migliori arrivino a un passo dalla crisi isterica.
Noi, del sedicesimo piano, facciamo il nostro. È il classico lavoro di routine. Siamo visti come i miracolati dell’azienda, e in un certo senso passiamo per quelli che sanno viversela: posto sicuro, guadagno modesto e poche rogne in generale.
Sappiamo così tante cose sull’edificio. E soprattutto di chi ci sta dentro. Perché sono gli altri a venire da noi a raccontarcele. Siamo la latrina per le loro congestioni psicologiche. Forse, ma non a ragione, pensano tutti che neanche sappiamo cosa farcene di queste storielle senza senso, che invece, decriptate, sono informazioni letali sui movimenti di questo o quel flusso di contingenze, questa o quella testa che si vuol tagliare: l’arazzo composto dalle storielle è, in poche parole, la diagnosi segreta della stessa azienda, che a sua volta è il totem del paese. E io l’ho capito.
Ho fatto altre sculture, ma devo essere sincero: non bastano.
Comincerò a scrivere un diario. No: una silloge. Ma romanzata.
Lo so, che cazzo, che è tutta un suggestione momentanea. E che mi tradisco. Ma non posso ignorare lo scarto tossico che continua ad ammucchiarsi sulle nostre teste, qui, in questi scomparti. I miei colleghi cominciano ad avere più di qualche sospetto sul fatto che gli altri ci vengono a dire, nascosti dal piglio aneddotico, com’è che falliremo. Questi narratori incontinenti sono come i colleghi ironici che parlano parlati, i mediatori del maligno, ma loro, gli altri, i narratori, lo fanno con coscienza – e con intenzioni diverse: metterci in salvo. (Sono loro il benigno?)
«Sì. Qualcuno che proprio non sopporta il progetto Ms, e intendo proprio nella sua essenza, mettendone in discussione le fondamenta, c’è. Si potrebbe dire che è una fazione nella fazione. Nel senso che quella dei programmatori è, a tutti gli effetti, una fazione; e al loro interno c’è un gruppetto, diciamo, di dissidenti. E questi non sono mica gli ultimi arrivati: sono esperti, hanno voce in capitolo. Sono pochi, questo sì, ma il loro pensiero è ascoltato, soppesato, e spesso non lo si può ignorare. Se qualcosa va a rilento – e finora è stato così – è a causa loro. Ma la questione importante è un’altra.
La questione è l’impatto che Ms avrà su questa realtà. Se hai studiato la storia, sai quali sono i meccanismi delle forme a scala globale calate dall’alto: qualcosa non si incastra, eccede, e viene amputato. Però, stavolta, la responsabilità percepita è oltre l’umano: e intendo, per responsabilità, l’impatto sul reale con causa ed effetto constatabili, consultabili, tangibili. Prendi la prossima asserzione come il proseguimento di quanto detto, e non come qualcosa da poter estrapolare: sarà la materializzazione di Dio. Le colpe verranno sganciate su Ms come bombe, e a loro volta fatte brillare.»
Ci sono, quindi, questi programmatori dissidenti che ci vengono a raccontare dei loro reflussi gastrici, delle partite a tennis interrotte da una pioggia improvvisa, e dei malori improvvisi appena svegli.
Ho messo insieme un po’ di queste storie, negli ultimi giorni. Ho un quadro e un abbozzo di teoria. Ve la dico in breve.
Il progetto Ms non è mai esistito. Non nei termini in cui se ne parla di nascosto in azienda. Esiste un progetto Ms, ma non è una soluzione: è una tappa. E avrà parecchio bisogno, ma davvero tanto, sul serio, dell’apporto più consistente che sia mai stato dato da parte del marketing. I brainstorming non vengono fatti per la nuova serie di software di architettura aziendale: vengono fatti per Ms.
Se Ms fallirà, a fallire sarà l’azienda. Il paese intero, non credo.
Questo, secondo la mia tesi, decentra il maligno dai confini del progetto Ms. I programmatori dissidenti, allora, non operano per il bene. Non direttamente. È proprio un’altra battaglia. Ma dei nessi, questo non lo escludo, possono anche esserci.
«Senti, questo proprio non dovrei dirtelo. Eppure non riesco a trattenermi. Non con te, almeno. Va bene. Dunque. Il progetto Ms non è interamente dell’azienda. Ne stiamo sviluppando solo una parte, ed è di quella parte, e solo di quella parte, che ci occuperemo nella fase operativa.»
È sparita una testa di gambero. Una sola.
Credo si sia intrufolato un topo. O magari è stata smembrata dalle blatte. La scultura del vasetto è sempre lì, uguale agli altri giorni. Però quella testa di gambero è scomparsa.
Metto una telecamera, fissa, sulla testa di gambero rimasta.
Sono preoccupato. Non riesco ad andare avanti se non per poche parole alla volta. E sconnesse. Le teste di gambero avevano una funzione precisa: eccola.
«Entrerà in funzione a ottobre del prossimo anno. È tutto pronto. A marzo cominceranno i test, quelli veri. Tra una ventina di mesi, tutti calati dentro Ms.»
Per i corridoi c’è il fermento delle guerre. Suonano anche piccoli allarmi a onde quadre. Tra gli scompartimenti si è smesso di parlare, e una strana paranoia sibilante ha cominciato a strisciarci intorno al collo.
Non riesco più a vedermi col mio informatore. Avrei voluto fargli leggere la mia silloge romanzata. L’ho intitolata: “Intrigo a palazzo”. C’è del sarcasmo, ma è del tipo auto-disinnescante: opera su se stesso, e leggendo la silloge si capisce perché, ci si impossessa della chiave, insomma.
La silloge è una premonizione di quanto accadrà: sono pensieri miei, aneddoti dei programmatori dissidenti e relative interpretazioni. Anche se sarebbe meglio chiamarle decriptazioni.
La chiave di volta della silloge è la combinazione di due aneddoti, di cui uno assente: quello assente riguarda me. E si capisce quale. Riporto dal testo:
È andato in vacanza per due giorni in questo paesino sul mare, dove non tornava da vent’anni. Ha trovato un paio di amici dei vecchi tempi e li ha convinti ad andare a pesca con lui, una domenica. Non sono riusciti a pescare nulla; ma hanno chiacchierato molto. Uno di loro ha un ristorante vicino al porticciolo, e all’ora di pranzo ci si sono diretti con grande appetito. I suoi amici hanno preso entrambi un branzino, mentre lui si è fatto portare dei gamberi belli grossi, ha detto. Erano una decina, e li ha spolpati di gusto, succhiandone le teste, nelle quali risiede quella poltiglia al tempo stesso amarognola e dolciastra. Il suo amico, il proprietario del ristorante, gli ha detto che i gamberi erano surgelati. Lui ha risposto che se l’aspettava, e che non era un problema; ha anche aggiunto che di gamberi ne mangerebbe, per quanto gli piacciono, di vivi, di crudi, e di morti in decomposizione.
Non dovrei aggiungere altro, ma la situazione, ora, è questa: c’è una voce su alcuni test clandestini condotti dai programmatori di Ms. E non solo quelli della nostra azienda. Anche di altre che, per quanto ne sapevo io, sono nostre concorrenti. Usano una rete privata per contattarsi. Inespugnabile, si dice.
Uno dei risultati di questi primi test clandestini, pare, ha provocato la svalutazione istantanea del mercato di una piccola area del centro america, che comprende alcuni stati come Belize, Honduras e Nicaragua. Nessuno sa spiegarsi quali possano essere i passaggi, la sequenza logica. Si è toccato un nervo a caso e si mosso un arto.
La testa di gambero decomposta, quella rimasta, è ancora lì. Ho visto il video degli ultimi tre giorni a velocità quadruplicata, e in effetti qualche blatta si avvicina a rosicchiare. Ma non tanto e non così avidamente da riuscire a farne fuori una intera in mezza giornata.
Se il maligno si manifesterà tra poco, non so se ritenermi fortunato: mi ritroverei morto, ma comunque su un picco del tempo.