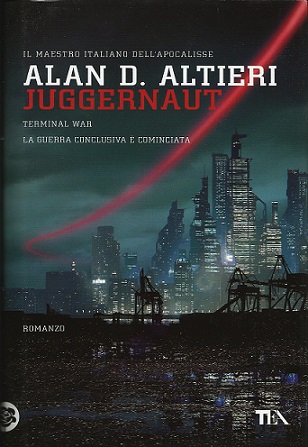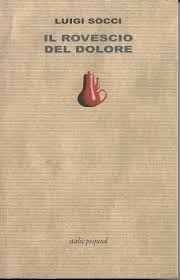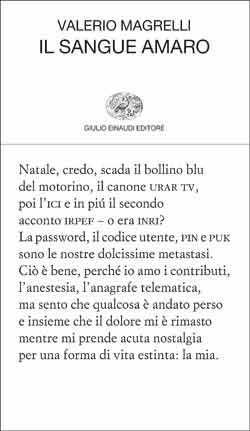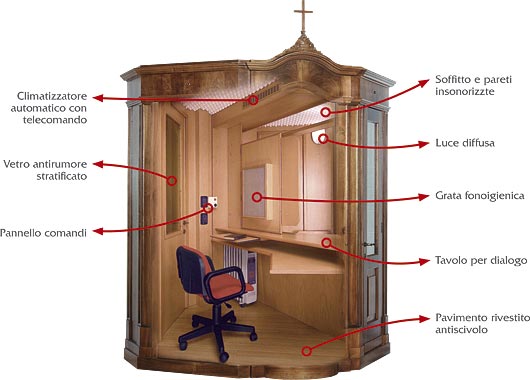Un incontro inatteso
di
Filippo Deodato
Aveva terminato la sua lezione su I Fratelli Karamazov quel pomeriggio. Aveva chiarito a se stesso e forse anche ai ragazzi presenti ad ascoltarlo, che le figure del Cristo e del Grande Inquisitore, convivono nel fondo dell’anima di ciascun uomo. Il giorno che si stava consumando volgeva rapido verso quella fase, che prende, nel tepore delle case, la forma dell’agognato riposo; niente aveva più da chiedere a quella mente stanca, che lenta, stemperava la sua estenuante tensione. Eppure, scritto segretamente nell’immediato futuro, c’era ancora qualcosa che lo attendeva e che avrebbe risvegliato nuovamente, di lì a poco, la sua attenzione; qualcosa che del resto aveva spesso vagheggiato nelle sue innumerevoli e malinconiche fantasticherie.
– Ciao Nathan, ci sentiamo presto. Oggi devo correre a fare la spesa e poi passare a ordinare il Dvd che ci servirà per il prossimo incontro – aveva detto prima di congedarsi da lui la sua amica e collega con la quale aveva ideato il progetto che una volta alla settimana li teneva impegnati di fronte trenta studenti di un liceo di periferia. – Ma no Carla, potrei prenderlo io il film. Di recente l’ho visto esposto nella libreria del centro commerciale che sta proprio lungo la strada che faccio per tornare a casa – rispose con naturale cortesia. – Oh caro, te ne sarei grato davvero se lo prendessi tu. Allora buona serata e … A martedì! –. Nathan si diresse verso il negozio ad effettuare l’acquisto come aveva promesso.
La libreria era semivuota, pervasa dagli umori eterogenei dei clienti che nell’arco dell’intera giornata l’avevano popolata. Una volta rimanere davanti a tutti quei libri senza sceglierne uno da portare via con sé, sarebbe stato impensabile; che la lettura compulsiva degli anni passati avesse molto spesso frenato i suoi slanci creativi più che alimentare un autentico desiderio di conoscenza, oggi rientrava tra le sue consapevolezze. La scrittura che aveva per anni mormorato dentro di lui come una vocazione silenziosa e immanifesta era ormai diventata una sorta di guardiano, e al contempo, un prezioso strumento che poteva dar voce all’impellente necessità presente nei recessi più profondi del suo essere; lo aiutava a perforare quel muro che blindava la sua frustrata sensibilità.
Passò con una rapida occhiata le novità impilate e ben in vista, sdraiate come seducenti sirene sugli scogli; lambì con lo spirito il suo reparto prediletto costellato di antiche e nuove costruzioni narrative. Sogguardò sprezzante la saggistica solida e velleitaria, tutta tesa a spiegare le tortuosità dell’attualità politica, prima che un rifiuto animalesco lo spingesse oltre, verso i quadri e i disegni che raccontavano la storia dell’arte. Una spossatezza sempre più grande respinse persino la bellezza dell’arte figurativa. Come dimentico del motivo che lo aveva portato fin lì, cercò allora i ripiani che ospitavano la fotografia, per documentarsi su uno degli autori contemplati nel suo progetto scolastico. Provò ad immergersi nel mondo colorato di McCurry; lesse, rimanendo impermeabile al loro significato, i commenti che raccontavano la complessità di quei luoghi tanto distanti, che il fotografo aveva percorso con coraggio, quando la sua distrazione, fu scossa dal calore di un’altra presenza. Un uomo sulla sessantina, ben vestito, sfogliava con garbo uno dei volumi sulla storia fotografica di Roma. Nathan gettò un rapido sguardo sulle pagine aperte del catalogo. Una foto che ritraeva Roma ai primi del ‘900 con al centro un calesse sopra una strada interamente allagata, fu il luogo cui conversero i rispettivi bisogni di manifestare un recondito, quanto umano, desiderio di comunicare.
– Non sembra cambiata molto da allora; gli stessi problemi avviliscono gli splendori della capitale – proruppe l’uomo iniziando la conversazione. – Forse sono cambiati solamente i mezzi di trasporto – rispose scherzosamente Nathan. I due avevano deposto dal suo trono la regina che spesso decide le nostre solitudini; il regno della diffidenza si era arreso alla loro volontà di aprirsi l’uno all’altro. All’uomo sembrò opportuno continuare il discorso che aveva audacemente cominciato. Sfruttò a pieno l’argomento per distillare con disillusione i torti subiti negli ultimi anni; dalla sua amarezza zampillavano ininterrotte condanne all’economia del suo paese e all’intera classe dirigente. Nathan reagì stizzito ma dissimulò il suo stato sforzandosi di non interrompere il flusso di parole e di non chiudersi come molte altre volte aveva fatto. Gli fu più chiaro adesso, il motivo per cui la politica finisce per imporsi su qualsiasi altro tema. – Lo sa lei che la Telecom era una delle aziende più ricche del mondo con i suoi 240.000 impiegati, oggi ridotti ai soli 50.000? Siamo stati gli inventori della carta prepagata e del Gsm; ma stiamo diventando un popolo di individualisti. Stiamo perdendo irreversibilmente l’idea di comunità. Le dico ancora una cosa: molti anni fa una delle case automobilistiche tedesche era sull’orlo del fallimento; molti operai rischiarono di essere licenziati.
Decisero allora per il bene di tutti con un encomiabile atto di civiltà di abbassarsi lo stipendio. Oggi la Volkswagen è uno tra i tanti vanti dell’industria della Germania. – Nathan annuiva passivamente, temendo di ascoltare l’ennesimo sollecito che lo invitava a trasferirsi in uno stato più sano, più prospero. Invece, quell’uomo che era vissuto in molte parti del mondo, smentì la sua tacita previsione, chiedendogli improvvisamente se aveva mai veduto il monumento dell’olocausto eretto a Berlino; esaltò il genio dell’architetto che lo aveva progettato e poi recitò alcuni versi in tedesco che il fascino di quell’opera gli avevano ispirato. Lo fece con voce fioca biascicando le parole. I suoi occhi presero ad inumidirsi; divennero una sorta di acquario dove smarrita nuotava la sua commovente fragilità. Proseguì esponendo le ragioni che avevano destato in lui tanta ammirazione: – Il memoriale della Shoah mi ha dato la possibilità di vedere il confine dove convivono l’amore e la morte. – disse sommessamente l’uomo – Lei la conosce la sua struttura? – Nathan fece si con il capo. – Poter vedere tra le fessure che dividono le stele commemorative, bambini saltellanti o lo sfilare ansimante dei turisti è uno spettacolo incredibilmente suggestivo! –. Nathan ascoltò con trasporto, senza afferrare fino in fondo il senso di quella singolare descrizione. Ripresero a parlare di politica, o meglio di tutti quegli attori politici che con ineguagliabile impudicizia e inverecondia, negli ultimi anni, avevano contribuito a gettare nel disincanto milioni di cittadini.
Nonostante i due si conoscessero da così poco tempo l’uomo confessò a Nathan un segreto che forse da qualche anno portava con sé: – Sa, lei è giovane ed ha ancora dentro di sé quella che si chiama speranza. Io non solo temo di averla perduta ma mi sento di dirle che mi spaventa l’idea di affrontare la mia vecchiaia in un paese che sembra non solo disconoscerne il valore ma che lascia i vecchi in balia delle loro debolezze. Nathan trasalì, sentendo che l’uomo che aveva di fronte non era l’ennesima noiosa incarnazione del malcontento generale; possedeva una sensibilità straordinaria ed era come avvolto da quella misteriosa tristezza di chi sopravvive ai suoi cari. Gli aveva inoltre narrato dello strano rapporto che possedeva con le proprie radici; si sentiva un specie di apolide pronto a radicarsi in tutti quei luoghi che il destino gli assegnava. I due condensarono nel favore di quella atmosfera le riflessioni che avevano maturato negli anni, fino a quando, qualcun altro non fu investito dall’emanazione contagiosa del loro desiderio di raccontarsi. Una terza persona insinuò con leggerezza il suo dissenso sulle ultime considerazioni critiche dell’uomo, che del resto, avevano lasciato perplesso anche lo stesso Nathan; lo fece non per affermare la propria ragione ma con la sola intenzione di partecipare ad una discussione dai toni pacati, aperta. I tre sconosciuti continuarono a dialogare e a scambiarsi in una totale armonia le loro idee; si ascoltavano con pazienza senza interrompersi l’un l’altro come se stesse loro più a cuore il legame magico che li teneva uniti rispetto a ciò che avevano realmente da dire.
Sembravano scoprire istante dopo istante il piacere di un umanità ritrovata. L’ultimo arrivato fu il primo ad abbandonare la discussione mentre gli altri due ne approfittarono per ritornare al loro prezioso confronto che prima di essere interrotto, aveva raggiunto una speciale intimità. Nathan si preoccupò che fosse tardi e invitò con dolcezza il suo interlocutore ad uscire dal negozio per lasciare che i commessi si preparassero per la chiusura. I due fecero qualche metro insieme fiancheggiati dai ristoranti brulicanti, interrompendo la loro marcia vicino una scala mobile. Nonostante il brusio la loro conversazione si fece ancora più confidenziale; Nathan si sentì compreso quando spiegò all’uomo i motivi che lo trattenevano nel suo paese e soprattutto gli parve di trovare un nuovo compagno lungo il suo faticoso percorso. Prima che i due si accomiatassero di nuovo qualcuno si permise di trovare un varco nella loro spontanea complicità: – Sono a quel tavolo laggiù insieme ad altri amici; se volete potete aggiungervi anche voi! Possiamo cenare insieme se vi va! –. Era lo stesso uomo che poc’anzi si era intrattenuto con loro. Declinarono entrambi con misurata gentilezza. Attraversati da un misto di stupore e gratitudine si salutarono con un inconsueto senso di pienezza generato -e di questo ne erano pienamente consapevoli – da un cibo che l’alienante modernità ha reso sempre più introvabile.