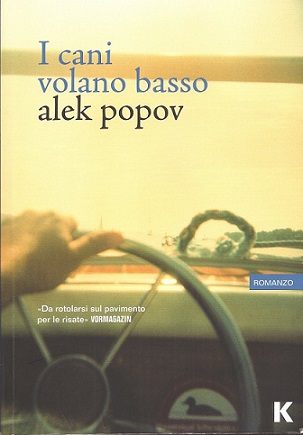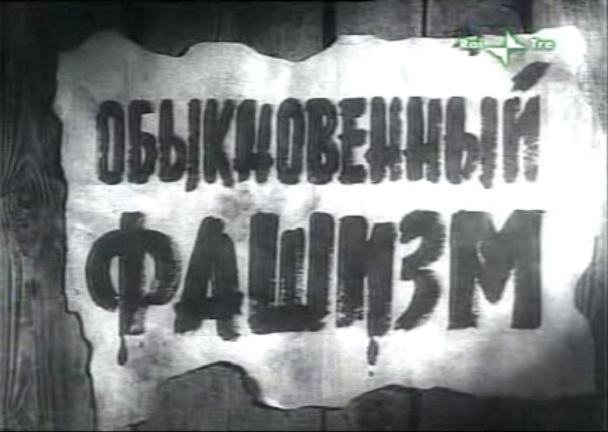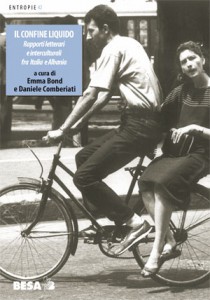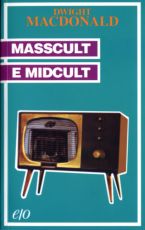Di Gian Pietro Fiorillo
io sono pazzo, pazzo / io sono pazzo tutto anzi strapazzo / se mi strapazzo troppo mi sollazzo /
ma poi mi giro e dormo o parto a razzo / io sono pazzo, pazzo / e parlo per parlare e mi sbarazzo / del mondo, e con che furia / gli faccio le boccacce / rendo pane raffermo per focacce / e gli spacco la faccia, sono feccia / e freccia sono e arco / non vado in nessun posto ma dove vado sbarco / occupo e sbanco e gioco / e prendo il banco / io sono a un tempo spendaccione e parco / spendo il mio tempo inutilmente e calco / come scena la vita come un palco / e per cortili inutili scorrazzo
fra i debosciati vivo del palazzo / ma dopo torno a casa e lì sferruzzo / con i libri proibiti e se mi faccio il mazzo / non te lo vengo a dire non capisci / che studio tutto il giorno e che m’ammazzo / che ci vuoi fare / che ci vuoi fare / che ci vuoi fare / sono pazzo, pazzo / sono solo un ragazzo / e sono sano / e sano / e sano / e sano / e sano / come un pazzo
(coro) sapete noi pazzi non siamo / la brutta impressione che diamo / eppure non siamo neppure / le sterili miti creature / che fanno la questua d’amore / non siamo neppure un cartello / per fare il dottore più bello / credeteci abbiamo un cervello / ed un cuore / proviamo la gioia / proviamo il dolore / sappiamo perfino pensare / diverso dall’operatore / di cui non sappiamo che fare / ma non glielo diamo a vedere / avrà pure lui da campare / di questo suo porco mestiere
e sono pazzo sono perché urlo / mi burlo dei cazzoni ma non ciurlo / nel manico e denuncio chi lo fa / e sono pazzo pazzo se sul prato / mi distendo e m’addormo anzi beato / dopo avere affogato in piscina l’avvocato / e il giudice pirlato / che venne ad interdirmi / l’ho frullato col girmi / e sono pazzo pazzo sulla spiaggia / non me ne frega un cazzo della pioggia / a dire il vero detesto la bambagia / perché mi fa venir la pappagorgia / e sono pazzo e sono pazzo e grido / e rido se il destino mi minaccia / con il suo ghigno spastico mi abbaia / come un mastino mastico la ghiaia / ma poi basta un festino ed è bonaccia / del grugno del destino me ne frego / dico a me gli occhi plìs così lo strego / e la morte per me è soltanto un segno / è finita la gara e incomincia il convegno / contegno / contegno / contegno / ragazzi / marionette / giovani donne e vecchi ve ne prego
/ mantenete il contegno / nel giorno del trapasso ad altro Regno
(coro) sapete noi pazzi non siamo / la brutta impressione che diamo / eppure non siamo neppure / le sterili miti creature / che fanno la questua d’amore / non siamo neppure un cartello / per fare il dottore più bello / credeteci abbiamo un cervello / ed un cuore / proviamo la gioia / proviamo il dolore / sappiamo perfino pensare / diverso dall’operatore / di cui non sappiamo che fare / ma non glielo diamo a vedere / avrà pure lui da campare / di questo suo porco mestiere
io sono pazzo e passo giù in cantina / perché quel topo nero si avvicina / l’avevo chiuso in frigo stamattina / mi porge qualche cosa una mentina / ma no non è una menta è medicina / io sono un pazzo passero lo vedi / sono solo una pezza per i piedi / sono il divanoletto su cui siedi / prendo le medicine e il corpo puzza / in pochi mesi moltiplica la stazza / e sono pazzo e pazzo anche di più
se prendo lo zyprexa e il risperdal / se mescolo la merda che mi date / con la droga da strada e le fottute / che d’ogni tipo e prezzo voi spacciate / dietro la protezione della scienza / che serve solamente / per lavarvi la coscienza / son malato di mente / e di cervello / perché il cervello voi me lo ammalate / con l’aloperidolo e l’aripiprazolo / con altre terapie poi mi ammaliate / mi bidonate
ma con un po’ di coca mi riprendo / e vado al lungofiume quando è notte / preferisco le botte
a quei cancelli chimici che mi somministrate / cimici sottopelle che iniettate / che ci rendono bestie maltrattate / e che ci fanno urlare / urlare / urlare / urlare / e piangere e pisciare dentro al letto / scappare e rifugiarsi nella pancia dell’orsetto / pisciare con i cani sul muretto / se mi venite a prendere mi getto / da questi cinque piani ora mi butto / e non è ancora tutto nossignori / nostra dama è la donna di dolori
(coro) sapete noi pazzi non siamo / la brutta impressione che diamo / eppure non siamo neppure / le sterili miti creature / che fanno la questua d’amore / non siamo neppure un cartello / per fare il dottore più bello / credeteci abbiamo un cervello / ed un cuore / proviamo la gioia / proviamo il dolore / sappiamo perfino pensare / diverso dall’operatore / di cui non sappiamo che fare / ma non glielo diamo a vedere / avrà pure lui da campare / di questo suo porco mestiere
io sono pazzo cazzo / cazzo cazzo cazzo cazzo – e stracazzo / io sono pazzo tutto anzi strapazzo / se mi strapazzo troppo mi sollazzo / ma poi mi giro e dormo e vaffanculo al cazzo / io sono pazzo pazzo / dico le parolacce sul terrazzo / le grido al tutto il mondo e non m’ammazzo
/ di vino ho sempre piene le borracce / rendo pane raffermo per focacce / e se mi stai sul cazzo io ti spacco la faccia / e sono feccia / sono letame e scarico di cuccia / se posso mi nascondo nel soppalco / quando vengono a prendermi / li scalcio e li scappuccio / e divento invisibile / come carta velina / e divento risibile / come carta di riso / e divento irascibile / come il vento che infuria / e che sfotte la gente troppo seria / e i poveri impiegati disgraziati / che credono d’averci ammortizzati / e i pavidi infermieri / che non lo sanno e sono / solo carabinieri / io sono pazzo cazzo / io per cortili inutili scorrazzo / fra i debosciati vivo del palazzo / frequento case chiuse per far piacere al cazzo / ma dopo torno a casa e lì sferruzzo / con i libri proibiti e se mi faccio il mazzo / non te lo vengo a dire non capisci / che studio tutto il giorno e che m’ammazzo / che ci vuoi fare / che ci vuoi fare
/ che ci vuoi fare / sono pazzo e cazzo / sono solo un ragazzo / e sono sano / e sano / e sano / e sano / e sano / come un pazzo
(coro) sapete noi pazzi non siamo / la brutta impressione che diamo / eppure non siamo neppure / le sterili miti creature / che fanno la questua d’amore / non siamo neppure un cartello / per fare il dottore più bello / credeteci abbiamo un cervello / ed un cuore / proviamo la gioia / proviamo il dolore / sappiamo perfino pensare / diverso dall’operatore / di cui non sappiamo che fare / ma non glielo diamo a vedere / avrà pure lui da campare / di questo suo porco mestiere
e sono pazzo sono perché urlo / mi burlo dei cazzari ma non ciurlo / e sono pazzo pazzo se sul prato / mi distendo e m’addormo anzi beato / io sotterro in giardino l’avvocato / dopo averlo affogato in piscina / e il giudice cretina / che venne ad interdirmi / l’ho frullata credetemi col girmi
/ e l’ho mandata / a cercare il nirvana con i vermi / e sono pazzo pazzo sulla spiaggia / detesto la violenza e la distanza / fanno cagare i medici con la condiscendenza / stampata sulla faccia / io faccio breccia / per quei pochi tatuaggi sulle braccia / per i capelli lunghi con la treccia / perché mangio il briccino e me la rido / del chimico frustino che mi danno / in vena e alla capoccia fanno danno / danno / danno / fanno / Gesù perdona loro se non sanno / non me ne frega un cazzo detesto la bambagia / perché mi fa venir la pappagorgia / e sono pazzo e sono pazzo e grido / e rido se il destino mi minaccia / con il suo ghigno spastico mi abbaia / come un mastino mastico la ghiaia
/ ma poi basta un festino ed è bonaccia / del grugno del destino me ne frego / dico a me gli occhi plìs così lo strego / e la morte per me è soltanto un segno / è finita la gara e incomincia il convegno / contegno / contegno / ragazzi marionette / giovani donne e vecchi ve ne prego / mantenete il contegno / nel giorno del trapasso ad altro Regno / io sono pazzo e passo / giù in cantina / perché quel topo nero si avvicina / l’avevo chiuso in frigo stamattina / mi porge qualche cosa una mentina / io sono un pazzo passero lo vedi / sono solo una pezza per i piedi / prendo le medicine e il corpo puzza / in pochi mesi moltiplica la stazza / e sono pazzo e pazzo anche di più / se prendo lo zyprexa e il risperdal / se mescolo la merda che mi date / con la droga da strada – e puttanate / che d’ogni tipo e prezzo voi spacciate / dietro la protezione della scienza / che serve solo per lavarvi / la coscienza / son malato di mente / e di cervello / perché il cervello voi me lo ammalate / con altre terapie poi mi ammaliate / mi bidonate
(coro) sapete noi pazzi non siamo / la brutta impressione che diamo / eppure non siamo neppure / le sterili miti creature / che fanno la questua d’amore / non siamo neppure un cartello / per fare il dottore più bello / credeteci abbiamo un cervello / ed un cuore / proviamo la gioia / proviamo il dolore / sappiamo perfino pensare / diverso dall’operatore / di cui non sappiamo che fare / ma non glielo diamo a vedere / avrà pure lui da campare / di questo suo porco mestiere
io sono pazzo e kazzo con la kappa / quando m’inkazzo picchio con la zappa / io sono un verme amici e datemi la pappa / in fondo sono solo lo smandrappa / sono un bambino piccolo che scappa
/ benché quello che vuole lui ce l’abbia / ma sa giocare solo a far castelli / di rabbia / rabbia / rabbia / rabbia / rabbi / rab / ra / r / rap / rapì / rapito
(coro) e rapirono il pazzo tra la folla / ne fecero un pupazzo con la colla / lo appesero al reparto psichiatrico / e dissero alla madre non è niente / è malato di mente / ne faremo un perfetto demente / ve lo restituiremo / entro quindici giorni / improrogabilmente
/ sapete, spiegava il dottore / non contano i sogni o il dolore / è solo questione / di neurotrasmissione / il giovane l’ha squilibrata / non gliela faremo bilanciata / i pazzi sapete non sono / del tutto diversi da un sano / è solo che sono malati / ma noi ve li diamo guariti / diciamolo fanno impressione / se sbavano un poco e il tremore / non deve turbarvi in eccesso / abbiamo dei farmaci adesso / che fermano il battito stesso / del cuore / talvolta il malato poi muore / però posso dirvi in coscienza / che questo prescrive la scienza / signora noi siamo soltanto / dei medici ancora il trapianto / non c’è del cervello / di certo sarebbe più bello / col bisturi e con il coltello / e il trapano appeso a tracolla / però con la chimica odierna / facciamo miracoli, senta / se ce lo dà in pasto due giorni / facciamo che il pazzo / non torni mai più / ad essere il pazzo che fu
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / / /