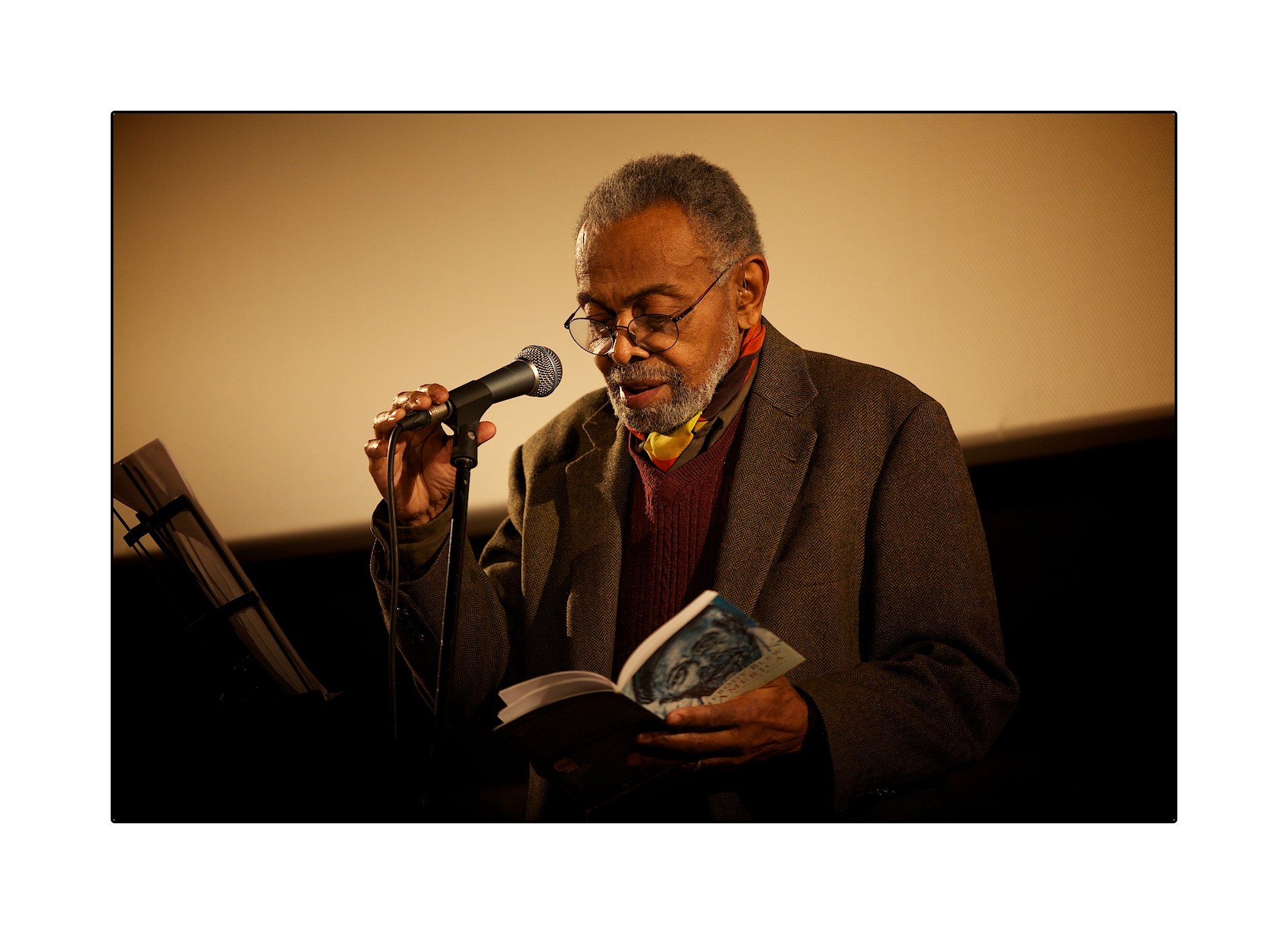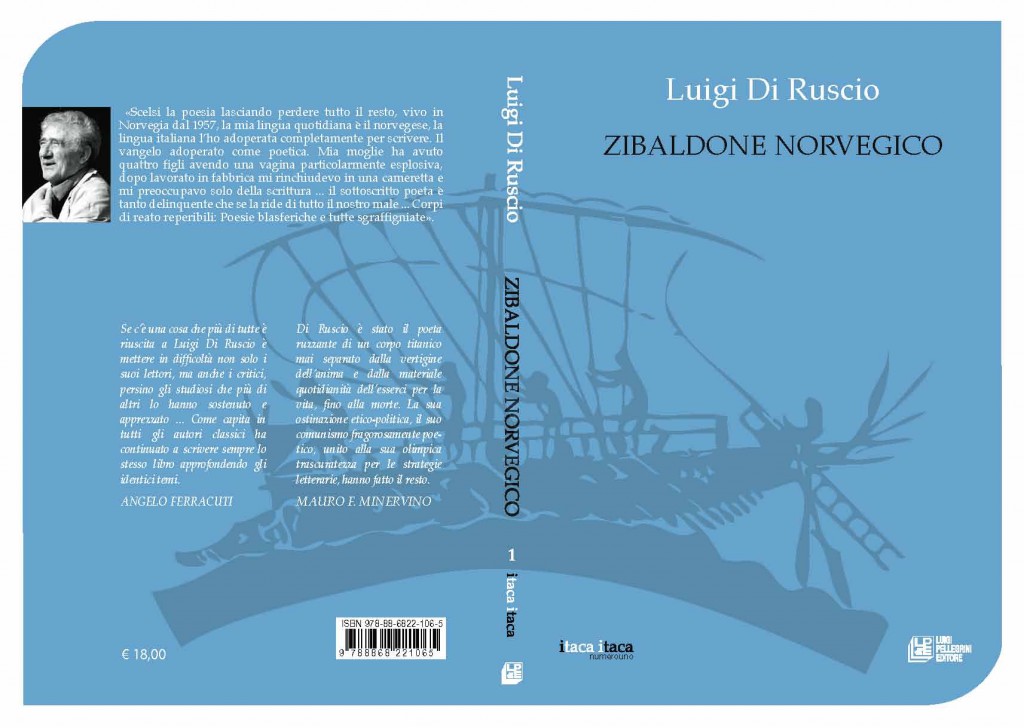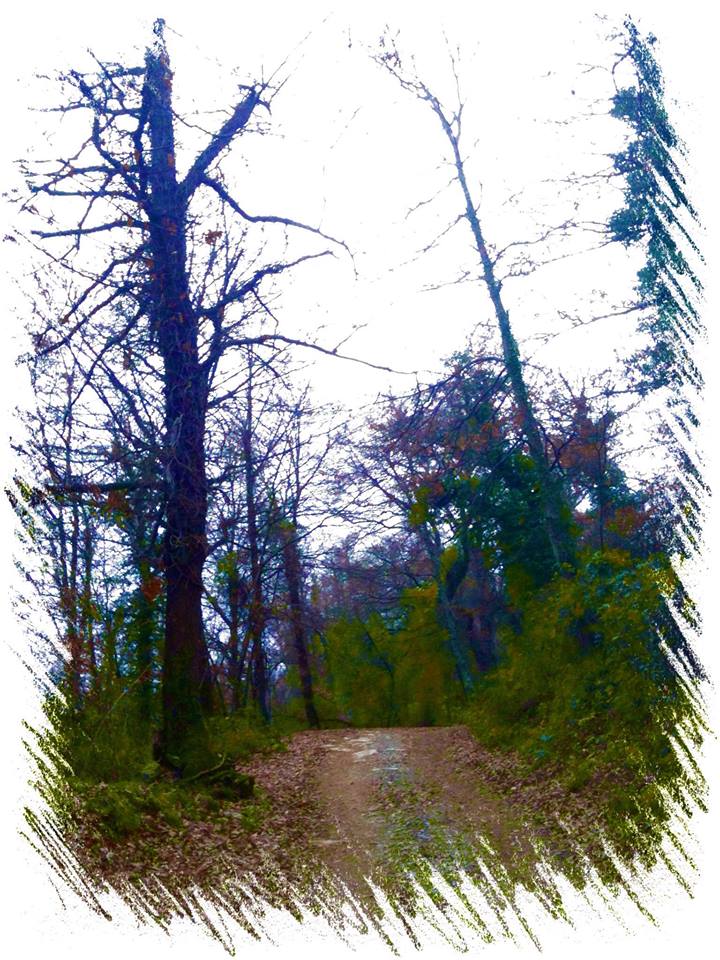Manuel Vázquez Montalbán e le maschere delle città
di Alberto Giorgio Cassani
«Buon pro le faccia». Così, in quello che è rimasto l’ultimo romanzo della serie Carvalho, Millennio 2. Pepe Carvalho, l’addio il detective privato più conosciuto di Spagna si era congedato dal mondo e dal suo pubblico, destinazione il carcere La Modelo di Barcellona. Con lui, ci aveva salutato anche il suo creatore, lo scrittore Manuel Vázquez Montalbán, per gli amici “Manolo”.
Perché il 18 ottobre 2003 un infarto l’aveva stroncato in un “nonluogo”, l’aeroporto di Bangkok; una morte sul lavoro, in uno dei tanti, forse troppo faticosi per lui che soffriva di cuore, tour de force internazionali fatti per reclamizzare il suo ultimo romanzo. Ironia della sorte, e davvero morte letteraria la sua, visto che la sua scomparsa è avvenuta nella città in cui lo scrittore aveva ambientato uno dei suoi primi romanzi della serie Carvalho, Gli uccelli di Bangkok.
Una di queste tappe pubblicitarie l’aveva portato, nel novembre del 2000, anche nella città in cui abito, Ravenna, in una serata in cui il ridotto del teatro Alighieri si era riempito all’inverosimile del pubblico dei suoi tanti ammiratori, per la presentazione de L’uomo della mia vita. Qualche ora prima, a las cinco de la tarde, al Museo dell’Arredo di Russi, nello spazio progettato da Ettore Sottsass, per la regia di Gianfranco Tondini e col supporto tecnico dell’architetto Alessandro Vicari, chi scrive, molto indegnamente, non essendo un attore, aveva reso un omaggio alla Barcellona di Pepe Carvalho, impersonando quest’ultimo in un breve monologo dal titolo Il centravanti è stato assassinato questa sera.
Con la scomparsa di Vázquez Montalbán, la Spagna e non solo essa, ha perso una delle voci critiche più profonde, intelligenti ed ironiche che abbia mai avuto. Perché “Manolo” non è stato solamente un grande scrittore “di genere”, ma un grande scrittore tout court, come dimostrano i tanti libri e saggi da lui pubblicati al di là della serie Carvalho. Basta leggersi Il pianista (El pianista, 1985, trad. it. di Hado Lyria, Palermo, Sellerio, 1990), o Io, Franco (Autobiografía del general Franco, 1992, trad. it. di H. Lyria, Milano, Frassinelli, 1993), per capire la sua qualità letteraria, la sua ricerca lessicale, il suo impegno intellettuale. Lunghissima la serie dei riconoscimenti, se i premi, come in questo caso, servono a confermare la grandezza di un autore: Premio Vizcaya de Poesía del Ateneo de Bilbao (1969), Premio Planeta (1979), Premio Boccaccio (1988), Premio Ciudad de Barcelona (1988), Premio Recalmare Leonardo Sciascia-Città di Grotte (1989), Premio Nacional de Narrativa (1991), Premio Europa (1992), Premio Flaiano (1994), Premio Nacional de la Crítica (1995), Premio Fregene, Premio Nacional de las Letras Españolas (1995), Premio Città di Scanno (1997), Premio Grinzane Cavour (2000). In suo onore, dal 2006, è stato creato il Premio Carvalho, dedicato alla produzione letteraria di genere poliziesco. A lui, la sua città natale, Barcellona, il 3 febbraio 2009, ha intitolato una piazza, tra la calle de Sant Rafael e la Rambla del Raval, vicino al luogo di nascita dello scrittore e all’amatissimo ristorante Casa Leopoldo.
Di uno scrittore, quando non c’è più, rimangono i ricordi di chi l’ha amato e conosciuto, ma, soprattutto, restano le opere. E queste vanno lette, rilette e studiate. Per ciò è nata l’Asociación de Estudios Manuel Vázquez Montalbán, di cui fanno parte sette studiosi, sei spagnoli e un francese, dedicata allo studio e alla diffusione della sua opera. L’Associazione ha creato un sito web , che, tra le altre cose, contiene notizie, video, libri e articoli apparsi dal 2010 e convegni. Tra questi, l’Associazione ha organizzato, dal 2 a 4 febbraio del 2012 un primo Congresso Internazionale dal titolo: “Manuel Vázquez Montalbán: Nuevas perspectivas críticas”, svoltosi all’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona; un secondo, Extraordinario, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa, si è appena tenuto dal 17 al 19 ottobre, sempre presso l’Università barcellonese. Parte delle relazioni saranno pubblicate sulla rivista elettronica dell’Associazione «MVM: Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Montalbán».
“Manolo”, per tutta la sua vita, ha ragionato sul tema della Memoria. La città è il luogo che può conservarla o cancellarla. A Barcellona, protagonista di tutta la serie Carvalho, come in ogni grande città, entrano in gioco quattro città: quella della «Memoria», del «Deseo», della «Geometría» e della «Compasión». Queste quattro città, in realtà, a ben guardare, sono soltanto “due”: la città della «Memoria/Compasión» e quella del «Deseo/Geometría». La prima è la città degli Storici e degli Scrittori che, come l’Angelo della Storia di Walter Benjamin, ha il volto rivolto all’indietro nel tentativo di ricomporre le macerie causate da quella bufera che si chiama Progresso e che soffia dal Paradiso; la seconda è la città degli Architetti, del Progetto e dell’Utopia, che guarda, invece, solo al Futuro. Quest’ultima tende a cancellare la prima. Occorre perciò fare opera di “resistenza”, tentando di salvare le tracce delle tante archeologie urbane. Vázquez Montalbán ce l’ha insegnato: la “ricchezza” di una città sono i suoi strati archeologici. Per questo Roma è una delle città più belle al mondo. Per la città non vale lo slogan del grande architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe: «Less is More». Per la città, il più è più.
Occorre però sgombrare il discorso da un possibile equivoco. È inevitabile che non si possa conservare tutto: senza oblio non ci sarebbe la possibilità di agire, di creare nulla. Si resterebbe paralizzati. Lo ha scritto, una volta per tutte, Nietzsche nella seconda delle Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Il problema, però, per Vázquez Montalbán, è che i vincitori non cancellino, per sempre e del tutto, le tracce dei vinti. Questo è il punto centrale. Perché questa sarebbe la seconda e definitiva morte. Si muore una volta, quando si cessa di respirare; e si muore definitivamente quando nessuno si ricorda più di noi. Ecco perché “Manolo” fa dire a Pepe Carvalho: «Quando muoio scomparirà la memoria di quei tempi e di quella gente che facendomi nascere mi hanno messo nella platea della loro rappresentazione»; e ad un altro personaggio mette in bocca questa riflessione: «Ogni morto si porta via una parte della nostra immagine».
Purtroppo, la stragrande maggioranza di ciò che vediamo di una città sono le “maschere” dei vincitori di turno. Gli antichi romani adoperavano due parole assai incisive: damnatio memoriæ, la cancellazione completa di tutte le testimonianze di una vita vissuta. Il malcapitato non era nemmeno esistito. Vázquez Montalbán, al contrario, ci ricorda continuamente il dovere di ricordare. E lo fa utilizzando un mezzo indiretto, apparentemente inadeguato: un detective privato, ex comunista, in seguito killer di Kennedy al servizio della CIA, rientrato in Spagna, a Barcellona, per sbarcare il lunario come “annusapatte”. Com’è possibile? In realtà, Pepe Carvalho è il flâneur dei nostri tempi, che si muove nella città come in un paesaggio della memoria, registrando i mutamenti subìti dai luoghi della sua infanzia. Come scrive, infatti, Walter Benjamin (citato da “Manolo” ne L’uomo della mia vita) «Se una persona scrive un libro sulla propria città, esso avrà sempre una certa affinità con le memorie; non per nulla l’autore ha trascorso la sua infanzia nel luogo descritto». E il romanzo giallo diviene, per Vázquez Montalbán, un «mezzo di conoscenza sociale o psicologica» , anche della storia architettonico-urbanistica della città.
Seguendo le tracce delle vittime e dei carnefici, Pepe Carvalho incontra le diverse archeologie di Barcellona e scopre, assieme al suo autore, che il rischio serio che corre la sua città è che gli archeologici del futuro si troveranno di fronte solo a tre grandi ere «geologico-architettoniche»: «Gotico, modernismo e kolossalismo post-moderno». Inoltre, sembra ormai che l’anno zero, ante e post, sia diventato il 1992, l’anno delle Olimpiadi, tanto da poter suddividere la storia di Barcellona in tre grandi epoche: Pre-Olimpica, Olimpica e Post-Olimpica. I “vincitori” hanno selezionato le diverse archeologie di Barcellona, rimuovendone quasi completamente alcune (le archeologie che “Manolo” chiama «maledette») e valorizzandone, a volte addirittura “inventandone”, altre.
Dal Montjuïc, come vuole la leggenda, Ercole aveva ammirato la bellezza del sito naturale, adatto perfettamente alla fondazione di una città; sul Montjuïc si mostrano, in tutto il loro conflitto, vita e morte, Memoria e Deseo, Geometría e Compasión. Sul Montjuïc, infatti, sono stati realizzati i nuovi templi dello sport per le Olimpiadi: il nuovo stadio, che ha sventrato quello vecchio lasciandogli soltanto la pelle, il Palazzetto dello sport di Arata Isozaki e la fiaccola olimpica di Santiago Calatrava. Al contempo, sul versante verso il mare, il Montjuïc mostra il luogo della Morte, il Cimitero nuovo e il luogo che dava morte, il Castello del Montjuïc, da dove, in occasione delle rivolte popolari, si sparava sulla città, presa tra due fuochi grazie al parallelo cannoneggiamento dal versante della Ciutadella.
Ancora una volta la città, le città, devono decidere se mettersi o togliersi la maschera, se nascondere o rimandare la verità elementare della vita e della morte, se cercare di mitigare l’angoscia nomade, inscritta nei cromosomi dell’uomo, con l’ordine della sua geometria, contaminando il passato con l’avvenire, ben sapendo che, prima o poi, «toda ciudad es o será arqueología».
L’altro insegnamento che ci ha lasciato Vázquez Montalbán è il pericolo che tutte le città diventino uguali, dopo un processo di “pastorizzazione” che le renda asettiche, ripulite di tutti i batteri nocivi al turismo culturale; cosa che è avvenuto a Barcellona dopo le Olimpiadi, riducendola ad una città «bella ma senz’anima».
L’Hotel W Barcelona, dai più chiamato Hotel “Vela”, di Ricardo Bofill, su cui “Manolo” avrebbe certamente puntato la sua penna tagliente se l’avesse potuto vedere, ha definitivamente fatto diventare Barcellona l’alter ego mediterranea di Dubai, la nuova città-icona del XXI secolo: una Nueva Dubai, una città senza “inguini”, senza radici, un «campionario architettonico di valore universale» , prendendo a prestito una frase di Vázquez Montalbán su Barcellona. Ciò che rischiano di diventare, sotto l’“effetto Bilbao”, tutte le grandi città contemporanee: un campionario di firme di archistar©, che ormai hanno preso il posto dei grandi stilisti della moda. Le città finiranno su «Vogue».
Dopo aver compiuto un viaggio intorno al mondo – che sembra l’ultimo desiderio di vedere cosa accade fuori della sua tana, dal suo guscio protettivo di Vallvidrera, dove Pepe Carvalho e anche “Manolo” abitavano – il detective, inseguito dalle polizie di tutto il mondo per l’omicidio dell’odioso sociologo Jordi Anfrúns, torna a Barcellona. Barcellona, malgrado lei, diventa per Pepe Carvalho la città «da cui non si voglia far ritorno». Nel carcere La Modelo di Barcellona Carvalho era stato rinchiuso da giovane. E al carcere La Modelo ritorna, questa volta per sempre. Carvalho non riconosce più la sua città: e dunque tanto vale restarsene chiuso dentro una cella, da cui addirittura rimpiange di «esserne uscito». Vázquez Montalbán, da parte sua, stava per tornare a Barcellona, ma la morte l’ha colto distante da essa. Chissà se per lui Barcellona era quel luogo “da cui non voler far ritorno”.
A noi non resta che rendergli omaggio, un omaggio alla sua memoria (persino un vignettista satirico come Vauro, in Italia, gli ha reso uno struggente ricordo). Forse il migliore atto di riverenza che gli si possa fare è quello di nominare i luoghi di Barcellona che nessuno ricorda più. Come ha fatto lo storico dell’arte Juan José Lahuerta che, in un libro di qualche anno fa, ha riportato alla memoria due semplici soglie di una vecchia casa della Rambla di Santa Monica, oggi rimosse. Due pietre consumate dall’uso con due strani buchi, provocati, nel corso degli anni, dal continuo battere dei tacchi a spillo delle scarpe delle prostitute. A “Manolo”, sono sicuro, sarebbe piaciuto molto questo ricordo.
«¿La arquitectura transformará las agonías?» , si era chiesto Vázquez Montalbán in Ciudad. No, se non imparerà anche a ricordare.
Nota dell’autore:
Subito dopo aver pensato questo titolo, ho ricevuto dall’amico Antonio Pizza, docente di Storia dell’arte e dell’architettura all’Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Barcellona, un articolo di Josep Ramoneda, pubblicato su «El País semanal», n. 1932, del 6 ottobre 2013, dal titolo: Diez años sin Manolo: Reatrato impresionista de un amigo. Evidentemente il vuoto lasciato dallo scrittore barcellonese, col passare del tempo, è l’elemento che più colpisce. Questo testo è apparso, in forma più ampia sulla rivista «Trova Casa Premium», n° 85, ottobre 2013, pp. 56-60. Ringrazio il Direttore Fausto Piazza per averne concesso la ripubblicazione.
La foto riproduce qualcosa che oggi non esiste più: la soglia di una casa di appuntamento all’inizio delle Ramblas coi segni dei tacchi delle prostitute che lì “battevano” appunto, coi tacchi, per il freddo.