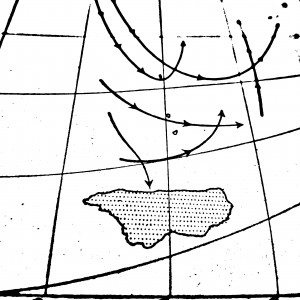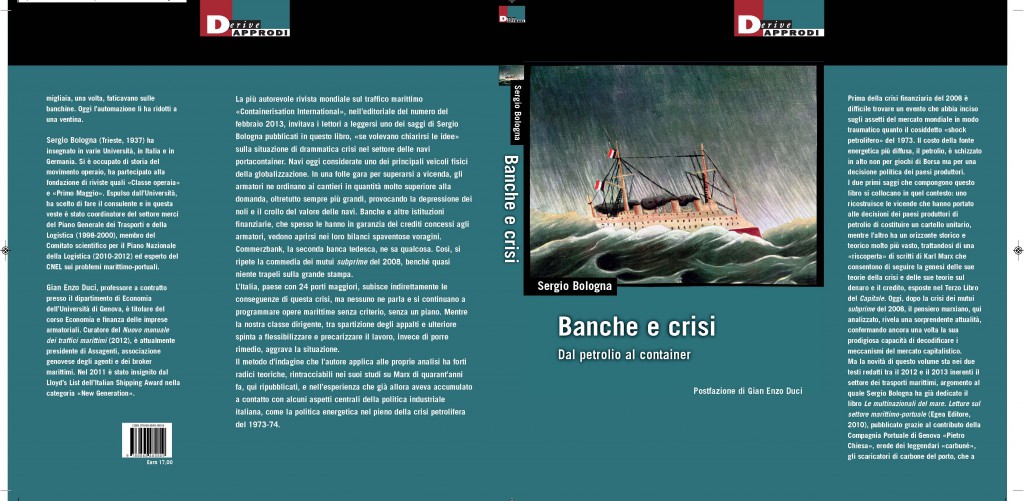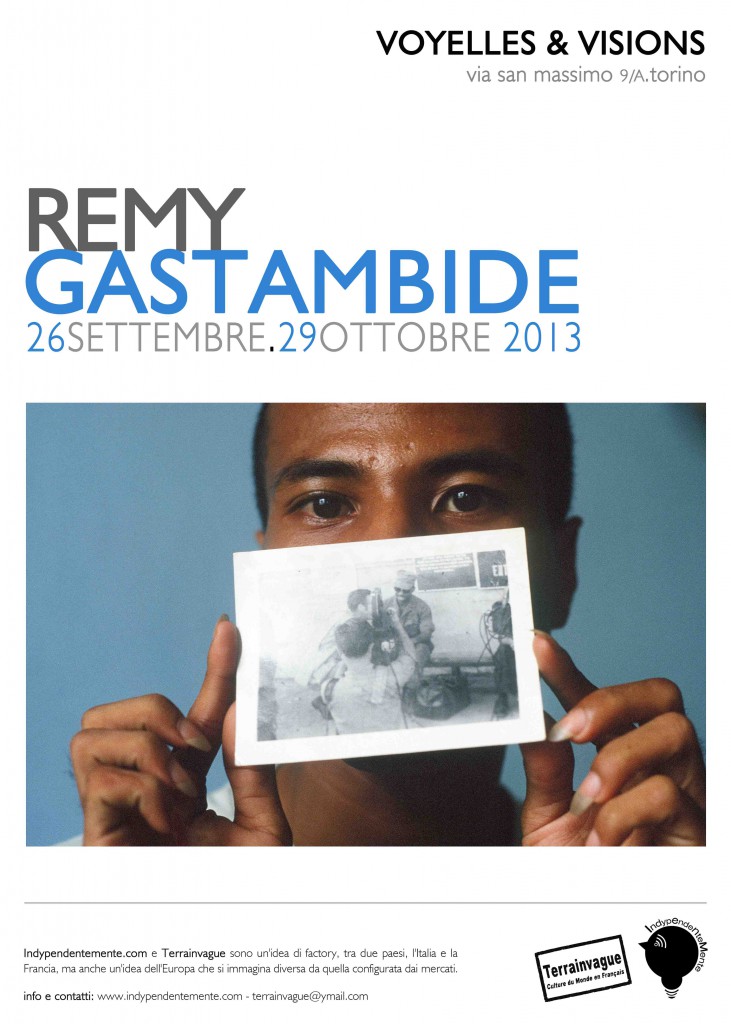di Francesca Fiorletta
Da More uxorio, inedito.
2.
L’amore sterile si fa di sabato.
Nadja, dovresti saperlo. Anche senza convivenza passano gli anni sterili. Mancano i soldi. Manca la volontà. Nadja, no certo, non a te.
Nessuno di questi è il tuo caso
-per me, il divertimento è sempre quello di montare gli spazi.
–
Ecco il mio amore fuori campo, che vuole farmi bere tutto il suo privato.
Una voce nel mio campo, gli spazi che monta sono i miei, e non c’è più alcuna traccia di blu, fra di noi. Non c’è freno, ormai, siamo un andante libero, già occupato. Già arredato da altri. Quanti spazi ci restano, ancora? Quanta sofferenza.
Ma devo trattenere il fiato, trattenere l’attenzione.
Ecco il caso di Nadja, allora, invece: lei è feconda, maturata giovane regina. L’andamento medio delle vite premiate e scialbe, diciamo del sabato, non la sfiora. Subisce solo a tratti una lieve battuta d’arresto. Noli me tangere. Questo è quasi un assioma inalienabile, insindacabile, osceno. Nadja è al posto di blocco.
Perché non vai a una manifestazione di bandiere no-tav, coi cobas del latte e l’aria fritta palpeggiata sui tram in sciopero? Sì, adesso, proprio tu.
Il rilassamento è un mestiere per i giorni feriali, e lei non si rilassa mai, mangia una foglia d’insalata a pranzo e una noce di cocco a cena.
Nadja, dai, prendi una granita, anche se piove.
-Guarda fuori!
–
Per una volta.
Dice che sta bene così, lei, che deve dimagrire, anche se porta la taglia trentotto, le calano di dosso le tette. Ha il cuore di giada, si veste come sua cugina delle medie. Porta addirittura i tacchi a spillo, talora, continua a ripetere che sta bene così, che deve essere alla moda.
Se ne va a spasso col tempo, taglia i riflettori, di sguincio. Non l’arresti nella sua follia, puoi solo accarezzarla, piano. Puoi solo rivolgerti a lei in falsetto, coi nomignoli più astrusi.
Che le vuoi bene, e tanto, pure se ormai hai paura a stringerla, che ti scricchiola con le nocche in mezzo ai gomiti: Nadja, sei una lucertolina.
Ma se glielo dici forte lei s’inorgoglisce, mette il musetto da cerbiatto.
Ti risponde:
-Lo so
–
Con un aspetto malaticcio e compiaciuto, chissà per cosa, poi.
Piagnucola. Si finge triste. Si finge grassa.
Ma dentro pensa:
-Sia mai, domani mangio un’unghia…
–
Si guarda addosso:
-Quanto pesa un’unghia?
–
Nadja è una contabile umorista.
-Allora non prendo l’ascenore
–
Questa storia sembra già in battuta d’arresto. Caduta, da libera. Pura fonte di libertà.
-Bisogna scremare le contingenze.
–
Mi dice l’altra voce, in arresto libero. Uno spazio che avevo provato a montare, tempo fa, per rifuggire alla noia. Uno spazio che m’è diventato faro, fondamento.
Ma forse è una battuta anche questa, una bagattella, che si fa lieve e impercettibile, talvolta. Che poi ritorna forte e chiara, nelle cene di birra, davanti alle edicole musicali. Una voce che continuo a sentire a sbalzi, dalle gallerie di un treno, lontano, vicino. Che prima era la voce personalissima di qualcuno, e adesso è già assaggio di qualcunaltro.
Tante voci continuano a deconcentrarmi. Devo riprendere l’attenzione.
Questo mi capita, anche in coppia di bicchieri.
-Ma tu no, tu mi lascerai, tu sei fedele.
–
Il termine fedele mi ha sempre turbato, non l’ho mai capito fino in fondo, che vuol dire, essere fedeli, credenti, democristiani, affiliati, mafiosi, seguaci, fedeli.
Mi piaceva ancora pensare che sarebbe stata sufficiente una novella intimità, una gioviale empatia lacustre e senza vomito, a preservarmi dalla noia.
Ma Nadja, che è sempre stata previdente, aveva detto già tutto in merito:
-Lascia perdere.
–
Le coppie novelle, però, quelle senza il sidro di mele, guarda caso, solo questo sanno fare, non sanno dare ascolto, mai. Sanno morirsi addosso, invece, in malo modo, e nemmeno troppo rapidamente. Quelle coppie, meglio ancora se di sabato, al calar della sera, sono sempre pronte a cinguettare, fornicare, eiaculare, brindare, gozzovigliare, sperimentare, ad appendersi, ad arruffarsi, a leccarsi, a succhiarsi, loro, noi, a strariparsi gli argini a vicenda, a lussureggiare.
Si dice: amarsi.
Amati, Nadja!
Bisogna amarsi. Amarsi, semplicemente.
Quante volte t’è capitato, Nadja? Una sola volta, dici davvero? Una sola volta nella vita poter stare così, disagiati, con semplicità? Sarà forse troppo poco.
Sarà stata solo una strana forma di reattività alla fortuna.
-Quante volte t’è capitato?
–
C’è chi ama tante persone diverse, a tutte le ore del giorno e della notte. Che bel coraggio, che ci vuole, eh? Che bella fatica dell’amore che è. Matrimoniale.
Più spesso ancora, però, capisci al volo quando quel primo vezzeggiativo, l’ardore erotico, il comico, il farlocco blues, inizierà a sembrare esaurito.
Ma riprendiamo l’attenzione.
Nadja al confronto sembra sempre impeccabile, è brava, anche se piove. Forse cerca solamente qualcosa da fare, di sabato. Vuole riaffermare la sua forte intimità di coppia, a dispetto delle assurde brume già marcate. Vuole riaffermare se stessa, forse prima davanti agli altri, davanti a me, dopo i pasti, in differita stereo fm.
Hai un concetto d’intimità davvero forte, Nadja, dovresti sposarti.
Nadja, così intima d’amore. Sei tanto intima di un amore così distratto, così diverso dal mio. Di quell’amore che non è mai stato incongruente, inaspettato, vitale. Questo lo penso io, d’accordo.
-Lo capisci, il perché?
–
Lo sai già, del tuo blu d’amore. Io che posso dire? Che ho sbagliato anche la centrifuga. E adesso non so proprio come farò, a ristrutturare tutto. Quanti modi esistono? Per me uno solo.
-Dobbiamo stare qui sempre, a farci la tara?
–
Mi dice la mia voce spaziale. Non dobbiamo, è il tuo spazio. Questo è lo spazio di Nadja, invece. Devo rimanere attenta, attenta.
Nadja riesce persino a superare i muri, riesce a superare tutta l’acqua che c’è, che viene giù. Mangia una piuma di cuscino e poi spacca cento, mille muri. Li attraversa, li comprime, li sfalda. O almeno vorrebbe.
È per questo che bisogna formalizzare. Le unioni.
-Tu vivi sull’uscio
–
mi ha detto la voce del treno, ieri sera, con la luna calante, in faccia.
-Cerca prima di decidere se vuoi entrare o no, almeno.
–
Nadja, tu sì che vuoi, invece. Vuoi eccome, e allora smettila, una buona volta, di fingere di essere povera, e smetti anche di lagnarti della tua indigenza d’indivia fuori orario.
Io, intanto, smetto di deconcentrarmi:
-Come l’hai ricevuta, la proposta?
–
Ma che cos’è che vorresti davvero, intimamente? Che cosa ti aspetti, allora, da tutto questo giro in chiave di sol?
Nadja non risponde, mai. Di getto.
9.
Nadja, eccolo qua il problema.
Ecco quello che serve. Serve un piano. Serve un piano d’azione incongruente, allora, serve un piano che funga bene da specchietto per le allodole, come fosse un ricordo fattivo degli avvenimenti mai avvenuti.
-Come fai tu.
–
Come una rarefazione di fatti poco concreti, troppo miopi per dire dell’indicibilità, sono troppe le talpe onanistiche per un futuro senza regole.
Nadja è sregolata, non è abbastanza ritagliata, pareva talmente bella questa storia, che è diventata una sorpresa! È sospesa, invece, è vilipesa in rappresaglia. È il mosto tumido della negazione occipitale, Nadja d’incanto. Lo schianto frontale, l’endemica autocoscienza, l’automa in proiezione. È la riappropriazione indebita di tutte le esistenze altrui che si svelano poi troppo vicine alle proprie.
Inizio a sospettare del niente, a seguire la logica dell’irreparabile, del dubbio. Bisogna utilizzarli i superlativi, o no?
Va ridotto l’uso dei superlativi.
-Scremare le contingenze.
–
Mi resta una Nadja col dubbio.
Il sospetto è una zona fissa, è infilzato dietro agli infissi opachi e ormai appannati, lerciati, sbertucciati di una Nadja senza vento. Dietro agli infissi divelti, con le squame farraginose, senti com’è chiara la fanghiglia puzzolente dopo lo scroscio del temporale.
-Allora, ha smesso?
–
Che poi è l’allagamento semantico, questo. È un vero e proprio tzunami cognitivo, come si fa a dire dell’io e del tu, e di Nadja tutta intera, stesa a terra tutta bagnata, nella pozza.
-Ma dove devi andare?
–
Resta con me.
Che si possa o non si possa parlare di tutto, che si debbano stilare liste e piani di studio, si sa, l’azione è sempre retroattiva, non è mai un vero organo di progresso, la scrittura.
Nadja è un gradiente d’intensità lasciato a macerare insieme alle rane bianche, coi girini, quegli occhi di fuoco chiusi nei barattoli del contrattempo. È una facezia, è la giocoleria, il mistero buffo del burlesque. Burla, si burla.
Nadja è burlona. Sine ira et studio. È senza peso. Taglia trentotto meno un chilo. Si spoglia piano nel sollucchero oltraggioso del Vetril, la soluzione al metadone plusvalente, l’ipercorrettismo mediatico. Scioglie da sola l’atarassia dei ghiacciai, scava il gelo onnipresente dentro le ossa e dentro la testa, fino all’ipofisi, nella noce del collo.
Nadja è la mandorla bovina, il dente aguzzo da regina della notte a far da reggicalze.
-Ormai siamo arrivati a un punto morto.
–
Serve un aiuto dalla regia, chiama il portatore di caffè, col mantello rosso a Cinecittà, tieni all’erta i bastoncini appesi del Mikado, mica solo schiamazzi e grida, mica solo bombole a gas, senti lo strepito notturno che si concepisce a tavolino, di giorno, sotto alle lampade al neon. Insieme. Alogena è l’attesa, febbrile la rinuncia.
Ma la ricomprensione, come si fa, la ricomprensione?
Rimane solo da concentrarsi. Ancora un poco.
La pressurizzazione dei cuscini, delle coperte e dei piumoni sottovuoto d’intensità. Lo scandaglio dell’abisso ci lascia uno scafandro come ricompensa. Ci vuole una ricompensa, ci vuole. Ci vuole un prima, un oltraggio. Ancora meglio, una coltre.
Stringiamoci nella forte ondata del dire e non dire, sapere e non sapere, l’afflato dell’amore, come si fa, come non si fa… Sei fritta Nadja, hai l’ affitto sistematico.
Allora:
-Come si fa l’amore?
–
Si mangia, s’inginocchia, si scopa, si sublima, si materializza, si spoglia, si suda, si spera, si spende, si spendono i giorni a pensare all’amore, si spendono le vite, i lavori, i trasporti, si spende la morte a pensare all’amore quanto dura, all’amore che per sempre si sposa.
Si sorseggia, si indugia, si colora, si testimonia, si lecca e si lascia piangere, si fa ridere, zitto e muto, il mutismo d’amore, un mutuo indotto, l’amore mutuale, mutuato dalla casata dell’incognito, del più vero che vero, le ignobili verità infilate al dito e lucidate, tutte arredate, calendarizzate, partorite e snaturate, poi, subito dopo.
-Serve sempre un piano.
–
Ancora per poco. Rimani attenta, concentrati. Sta finendo tutto.
L’amore che snatura si scrive e non si scrive, una predisposizione, dicono, la suggestione immateriale, che non è ancora un cromosoma in potenza, è un alterco in tromba di prisma, un’ altalena volontaria, ma… stiamo sbagliando qualcosa.
C’è un fatto che ti sciacqua, ti affanna e ti sospira, ti scoraggia sempre, ti opprime, ti ribalta, vedi le luci, ti disavanzi, e finisci a riempirti d’altro, di coito, il raccolto, il viaggio mancato, la mancanza di noi.
-Ma dove sei finita?
–
Tutto si scongiura e piano piano, senza tema, ci si sposa. L’amore in rosa. L’amore in forma di cosa. Cosa rara, e bella, e santa, e sana. Giusta cosa l’amore della famiglia, degli amici, dei cani e dei gatti, l’amore della battaglia, del segreto, un mistero misterioso. Poi viene l’amore del non dolore, l’inconveniente.
-Che cos’è Nadja?
–
Nadja si indovina, e basta.
Nadja mi racconta di credere negli oroscopi.
Cieca, subisce il potere misterico dell’astrologia. Per fallire e rimodularsi serve il fallico vuoto di senso della predizione. Perduta di senno, Nadja allora si concentra. Rinviene l’olfatto, si riappropria del tatto, sfodera il gusto, con l’orrore nell’ardore, nel carnaio udibile tutto l’edibile è sorgivo, per ogni plausibile inganno, Nadja è come un dirigibile narcolettico a vista, supino di una svista fuori orbita, di una subissale panacea decostruttiva.
La ricostruzione è metastorica, sempre. La ricostruzione è una redistribuzione ellittica.
Nadja, ti prego, concentriamoci!
Sempre empirica per difetto di empietà.
-Facciamo il gioco della mascolinità?
Ma è solo una beffa! Nadja mi guarda fisso, è tersa.
Si dispera fissamente, con la mente occupata, ha gli occhi sgombri, la lingua che è un pantano, lingua di platano, catino in fiore. Svende lo stomaco in allerta, con la gamba che ossessiona e punge da basso, punge sempre dove preme e fa più male.
Trema con la coscia ricurva, che imprime i suoi ticchettii volubili alle nervature di legno scuro di una sedia di cucina, blu cobalto, blu acquamarina, impernia piccole scosse moleste, scosse endemiche, epidermiche, laviche, sismografiche, cola giù giù, che scende fino al pavimento maculato, che brutto.
-A macchia di leopardo si disperdono le energie!
–
Si irrigano le energie tra i cunicoli osceni delle mattonelle di flanella, il grigio talpa dellemacchie, la scatola flambé, l’Hermitage, il Sunset Boulevard e l’oriente dissidente.
Nadja c’è stata.
Nadja non ha mai fame.
-Ma dove sei?
–
Adesso Nadja è assente.
-Stammi un po’ a sentire.
–
S’agita per gradi, ma di un tremore non suo, quasi fosse un’ansia astrale, una tecnica da perito industriale saraceno, la saliva oscena sul far della sera. Adesso vuole alzarsi, vuole alzarsi da questa sedia e vuole farlo subito. Nadja bisciattola. Fai la pipì a letto, copri bene il divano fumé. Adesso vuole aria, vuole bere, vuole fumare. Adesso vuole scopare, vuole piangere, vuole vomitare, vomitare e rigettare, vuole epurare e assatanare, assaggiare e rastrellare tutto, sempre tutto, anche il lutto, tutto fuori.
-Liberi tutti!
–
Immantinente, l’intimità, con la pistola giocattolo del tenente, le bolle di sapone a forma di sciroppo nuziale, la torta rosa con gli sposi dipinti sopra, in plastilina d’art decò.
-Tenetela ferma!
–
È un tratto distintivo, è un tratto di penna, questo, è un’impennata cospicua di pennuti rovesci, diretti da uno stormo che ammassa, che insidia e devasta la festa.
Lei che sbeffeggia, che lambisce il nubifragio. Che defeca sul bustrofedico viandante.
È un’agnizione cacofonica, l’antilirica è slabbrata.
È il pescatore errante, il barocco rococò nel vernissage della grazia pensante.
Il collirio persistente l’hai già dato alla Vergine Maria, Nadja, quello che resiste agli urti e che non macchia.
-E tanti cari saluti a vossìa!
–
Mandami una cartolina dal campanile.
Lei che fremita e fermenta, che gorgoglia d’insicurezza ma non smette di ondeggiare. S’agguanta alla mia coscia con la coscia, tutta sudata e spasmodica e appiccicata.
Nadja è l’aria, è il pomeriggio, e adesso è di nuovo tutto buio, è come l’alba.
Piove.
Faccio le prove di Nadja.
-Bisogna darsi forza.
–
Tocca singhiozzare il suo racconto mano a mano, tutta satura di segreti, con la mano nella mano, senza smettere. Per darsi forza basta bere un bicchiere, basta spogliare una finestra e masticare l’aria, una mandibola fina fina, imprecisata, una coltre imprescindibile di vuoto e di dentro, il senso e l’inverso. Come un inverno plausibile e doloroso, è ancorata all’immagine di un mare concettoso, alla primavera dei sensi, al risveglio dell’autunno in fiore, aspetta ancora, c’è il melone, il melograno lascivo d’agosto, ci sarà persino l’arrosto al buffet, tutt’in piedi, schiena dritta, gran battage. Non smette più di darsi la forza, da fuori.
-Ti puoi rilassare, adesso.
–
Come miete furori, lei che getta via i colori del dissenso. Una politica corretta. Ha invertito la rotta, ormai è cotta, è amara, è sinestetica e ridondante. Ma adesso basta, Nadja, dai.
Basta con questo fallo imperante, basta con questa dialettica del fare e avere, mai, sempre terza è l’insipienza del non dare.
-Non lo dire!
–
Non lo spiegare mai il perché, sei tu quella che legge gli oroscopi.
Sei quella che strizza gli occhi, che si mordicchia un labbro, che miagola su una sedia da cucina, che dipinge tende alle finestre, che vola oltre la terrazza, sulla città.
Nadja è ormai sotto coperta. Del segno della bilancia.
Ma quanto sei bella, oggi. Ti brillano le orecchie.
-Ho detto forse. È complicato.
–
Bevo io, beve lei. Come al solito.
Mi guarda come se fossi una creaturina spaventata, mi vede neonata, si ricorda di me all’asilo, più di quanto farebbe una madre, mi pensa pulcino, si sente chioccia.
-Quand’è che diventerai grande?
–
Si preoccupa per me, nel suo mondo tutto chioccia. Nel suo mondo di scale a croce, manca ancora la toppa. Io che non varco l’uscio, per rispetto.
-Ma perché?
–
Continuare a farsi male, come se fosse l’unica soluzione plausibile. Continuare a dirsi addio, sotto i portici assolati.
Cambio discorso, non mi sembra il momento.
Guardo i pacchi sparsi in corridoio, i vestiti per terra, i libri in valigia.
Poso il bicchiere, non sento quasi più, dalle tonsille.
Nadja mi si avvicina, tenera.
Si ricorda di non essere troppo dura, con me.
Si ricorda che a parlare troppo ci si fa anche male.
Stavolta mi dice solo:
-Fai la brava.