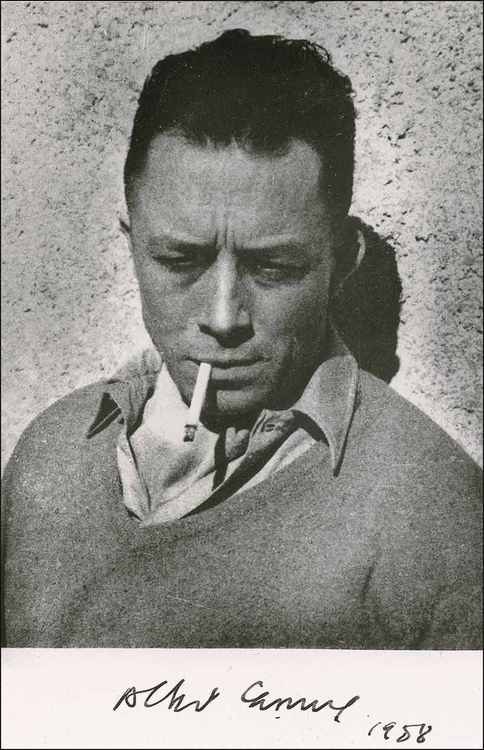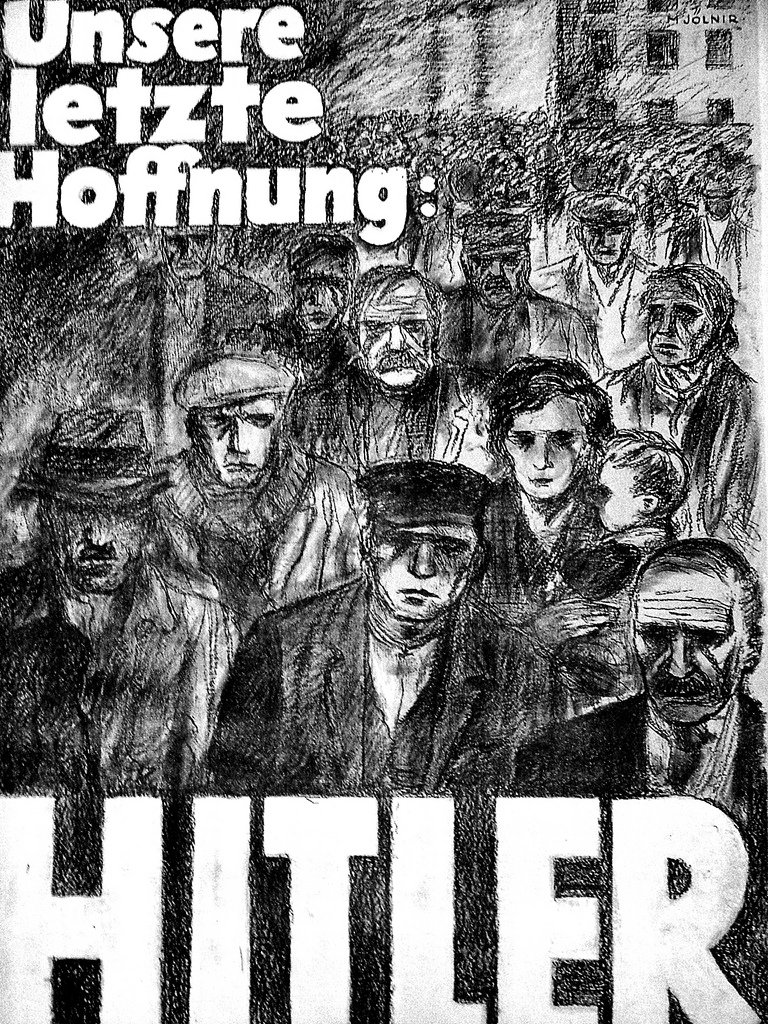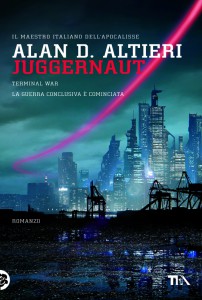di Riccardo Ielmini
di Riccardo Ielmini
Il sant’uomo, ci dissero, era ospite dei benedettini, all’Eremo, sul pendio meridionale del Monte Nudo. L’avevano ospitato anche se nessuno dei pezzi grossi della Chiesa si era pronunciato, nemmeno in via provvisoria, sulle sue visioni, o sulle guarigioni, o quello che era. Il sant’uomo, ci dissero, era lassù, bazzicava nei boschi di qui e di là dal versante svizzero; questo ci dissero, se volevamo vederlo, o toccarlo, o pregare con lui. Dissero questo a noi tre, che non tornavamo su, a Verbate, dal 1979, quando il buen retiro di famiglia era la villa liberty di nonno Karl, affacciata sul lago Maggiore. Allora, nel ’79, io e mio fratello non avevamo ancora vent’anni. Quando tornammo, sulle tracce del sant’uomo, era il settembre ’96. Eravamo tornati, noi tre irriconoscibili, dopo la telefonata di mio padre.
«Ciao Francesco», aveva detto la voce, riempiendo il mio attico spencolato su Milano. «Sono papà».
«Ciao. Cosa vuoi?». Mi misi a sedere, accesi l’abat-jour e guardai l’orologio alla parete, in fondo alla camera da letto. Le tre. Fuori c’era vento. Mi alzai, cordless in mano, e andai alla finestra: sotto di me, la metropoli sconfinata e silente.
«Ho bisogno di te. Domani mattina, verso le nove».
«Sai che ore sono?».
«Allora, domani mattina. Vieni a casa, non in ufficio». Non lo sentivo da un paio d’anni – l’ultima volta per il funerale di mamma. Quella voce non mi era mancata. Non stava iniziando una riappacificazione in stile hollywoodiano, dissi a me stesso. Niente alleluja da figliol prodigo. Le rogne fra noi erano corse troppo a fondo per tornare indietro con un colpo di cancellino sulla lavagna. Io avevo ferito le sue ambizioni su di me, quando, nel 1982, ero scappato in Germania inseguendo i miei sogni di gloria. Che colpo per lui, quando mi aveva visto in televisione ancheggiare come un cretino sui pezzi dance che avevo piazzato in classifica fra il 1983 e il 1985. E io, proprio come il cretino che ancheggiava in tv, avevo azzerato l’adorazione nei suoi confronti quando mio padre aveva fatto correre la voce che per lui ero un paio di foto sbiadite dal passato, e basta. Al telefono la voce pareva incupita. La mia era un calco della sua, e a questa fedeltà genetica dovevo il mio successo nello showbiz. Avevo cantato, con questa sua voce, refrain ambigui con eloquenti mugolii femminili di sottofondo, su basi elettroniche campionate dal mio produttore. E il gioco era fatto. Nel giro di tre anni ero riuscito a vendere tre milioni e mezzo di dischi: ero diventato il «dance master italian hammer» – i deejay giocavano a storpiare in inglese il mio cognome, Martelli, un’altra cosa che dovevo a mio padre. Avevo messo da parte una piccola fortuna, e poi investito quasi tutto in immobili – un albergo in società a Formentera, e una decina di appartamenti qua e là per quell’Europa. Ammirai ancora Milano per un pugno di secondi. Poi feci il numero e lo richiamai. Sì, adesso sembravo il figliol prodigo.
«Papà. Francesco».
«Cosa c’è».
«Perché mi hai chiamato?».
«Sono malato» replicò.
«Cos’hai».
«Vieni domani, alle nove. A casa».
Ero tornato a Milano nel ’93, per mettere in piedi un’agenzia di moda. Belle ragazze magrissime e furbe per la stagione delle sfilate. Io e lui non ci eravamo né incontrati, né cercati. Due Martelli dispersi in due milioni di persone, come in quella vecchia canzone che mia madre fischiettava piantando rose nel giardino della villa, su, al Nord.
Passai a prenderlo e lo trovai pronto, con una borsa bianca. Si alzò. Mi strinse la mano come fossimo due vecchi soci in un affare andato così così. Era invecchiato male. Chissà invece come dovevo apparirgli io, sotto la maschera da forever young che ci ostinavamo a coltivare, io e i vecchi colleghi-one-shot, con le nostre stupide battute sulle pollastrelle da camerino.
«Andiamo» disse.
Il vento aveva accampato una lunga sequenza di nuvole grigie che ci scortarono lungo l’autostrada A8. Mi disse che dovevamo andare a Verbate, e non mi azzardai a chiedere perché. Fu quando uscimmo dall’autostrada, per costeggiare la piana del lago di Varese, che mi raccontò delle sue intenzioni.
«C’è un uomo, dalle nostre parti». Aveva sempre detto nostre per indicare Verbate, a due passi dalla Svizzera, anche se noi eravamo di Milano. Ripeteva che erano le nostre parti da quando, nel 1943, i Martelli erano sfollati per scampare ai bombardamenti. «C’è un uomo. L’ho visto in televisione. Guarisce la gente, fa miracoli, vede cose. Voglio parlare con lui».
Ascoltai guardando dove le nuvole si scontravano con il sipario delle Alpi, e sembrava finire il mondo. Uno che guarisce e vede cose: un santone, pensai. Andiamo da un santone, accidenti.
Arrivammo a Verbate in tarda mattinata. Mio padre aspettò che parcheggiassi l’auto, poi mi disse che avremmo alloggiato al Sempione, l’unico albergo di Verbate – una costruzione fredda che aveva sempre fatto piccolo cabotaggio: sciatti rappresentanti senza fortuna, coppie di ambulanti, comitive di donne attempate in viaggio con una federazione sindacale. Non ci aveva mai dormito nessuno di famiglia: un tempo, prima che tornassero definitivamente a Colonia, c’era la villa del nonno, che ci accoglieva con la solita battuta sulle «zimmer a pagamento». Nella hall dell’hotel ci aspettava Giovanni, mio fratello. Fu una sorpresa, vederlo. Si era trasferito a Zurigo, dove faceva il cardiochirurgo. Invidiabile carriera, la sua, con i suoi viaggi newyorkesi alla fine degli anni Ottanta, i suoi master, le sue pubblicazioni e le sue due mogli – la seconda era una ragazzina dieci anni più giovane di lui, un’ossuta modella belga passata anche per la mia agenzia. Giovanni aveva la faccia tirata a lucido ed era stretto in un completo grigionero che lo rendeva glaciale più della stretta di mano che mi diede dopo aver abbracciato mio padre.
«Papà ha un carcinoma ai polmoni. Grave» disse quando restammo soli, al bar della hall.
«Non sapevo nulla» risposi imbarazzato, sorseggiando il mio Martini.
«Gliel’hanno diagnosticato un paio di mesi fa. Hanno escluso la lobectomia. Ha già fatto un ciclo completo di radioterapia. Se i risultati non sono buoni, dovrà fare la chemio». Parlava come se fossi il parente di uno dei suoi pazienti, o come fossimo due sconosciuti che si trovano a parlare per forza di causa maggiore, in un posto, e in un momento in cui non vorrebbero trovarsi. «Il cuore invece è sano. È forte. Il cuore di un toro. Perciò soffrirà molto a lungo». La frase galleggiò in mezzo alle note jazz che arrivavano dallo stereo acceso. Giovanni, prima che ciascuno prendesse la propria strada, era stato la mia stella cometa: il primo ad uscire in barca a vela, il primo a provare i deltaplani lanciandosi giù dal Monte Nudo, il primo ad attraversare a nuoto il lago nelle furenti estati di Verbate.
«Sai perché siamo qui?» gli chiesi.
«Per il santone» rispose sorridendo.
«E cosa credi che faremo?».
«Quello che vuole papà. Gli accordi sono che facciamo così, poi lui si fa visitare da un mio collega, a Zurigo. E decidiamo il da farsi».
«E cosa faremo, in concreto?».
«Cerchiamo il sant’uomo, lo troviamo, papà ci parla o non so cosa. Poi ce ne torniamo tutti dove siamo venuti. E papà si fa curare, se è possibile».
Mi diedero una camera con le finestre affacciate sul lago. Oltre la strada, l’imbarcadero. Rimasi tutto il pomeriggio a guardare i traghetti che si succedevano con il loro inimmaginabile carico di vita.
Dunque il sant’uomo era su, al Monte Nudo. Bella montagna, pensai, per andare a fare l’eremita, o quello che era: un panettone di boschi di robinie e castagni, e poi, all’improvviso, ai millecinquecento di quota, un cucuzzolo, una prateria battuta dai venti e dal sole. Impiegammo un quarto d’ora dall’albergo, a bordo del fuoristrada di Giovanni, per arrivare dove finivano le carrabili, e cominciava la vecchia mulattiera per l’Eremo. L’aria era umida, e l’erba gonfia di rugiada e vapore, e, camminando sulla mulattiera, si scivolava sui ciottoli che lastricavano il fondo. Ci fermammo un paio di volte a riprendere fiato. Giovanni controllava mio padre: nel silenzio del bosco potevamo sentire distintamente il respiro corto di un uomo vecchio, di un uomo malato. Pensai alla stagione eroica dei miei quattordici anni, quando mio padre stava per diventare un pezzo grosso della società del nonno – cave, sabbia, e tutto il resto della baracca – e ciò nonostante trovava tempo per arrampicarsi con noi su cime alpine con nomi altisonanti. Mi chiesi perché le cose non erano rimaste così immeritatamente brillanti. Conclusi in due secondi che se era andata così, noi eravamo colpevoli. Forse eravamo stati troppo distratti e irriconoscenti quando nostra madre ci portava sotto le sfilate di ex voto nella chiese e un qualche dio aveva permesso che sperperassimo le nostre fortune.
All’improvviso arrivò una ragazza, scalpicciando sul fondo della mulattiera, di corsa. Ci passò accanto, facendo un rapido cenno con la testa. Indossava grandi occhiali scuri, e mentre ascendeva, leggera, lasciò nell’aria un profumo di frutta. Restammo a guardarla, come da bambini si guarda una farfalla che entra in casa e poi esce, e sparisce nel blu. Quando la ragazza fu oltre la curva del sentiero, e si confuse con le piante e i cespugli, sorridemmo, noi tre, come non facevamo da secoli.
Ci volle poco meno di un’ora per arrivare all’Eremo – un rudere rimesso a nuovo dal lavoro muscolare e paziente dei benedettini. Il bosco diradò, e si aprì una piana con una roccia bianca: e sopra, l’Eremo. Come ci vide arrivare, un uomo ci venne incontro. «Il santo non c’è» disse guardandoci come uno scolaro disorientato.
«E dov’è?» chiese Giovanni. Mio padre si sedette su un masso.
«Dicono che è più su ancora, nei boschi».
«E quando torna?».
«Il padre superiore dice che non si sa mai a che ora».
«Cosa facciamo?» chiesi.
«Andiamo a cercarlo» rispose mio padre, inaspettatamente risoluto.
«Papà, resti qui. Vai dentro, chiedi ospitalità nell’Eremo» intervenne Giovanni. Mio padre cercò di prendere fiato, poi fece un cenno con la testa come per dire che sì, era ragionevole.
«Com’è?» chiesi a due donne sedute sulla pietra assieme all’uomo.
«Il sant’uomo? Alto. Un uomo alto, con i baffi, e gli occhi azzurri. Ha il cielo, ha il cielo benedetto in quegli occhi» disse una, infervorandosi come nostra madre, quando ci portava alle memorabili sfilate di ex voto.
«Lui vede, vede qualcosa. Qui, dove preghiamo» disse l’altra, accennando al boschetto sulla destra. Non sembravano facce da creduloni. Nella loro eleganza misurata sembravano usciti da un romanzo di Jane Austen.
«Cosa? Cosa vede?» chiese Giovanni.
«Lui vede. Vede una donna, una donna celeste» rispose la prima donna.
«La Madonna. È la Madonna» interruppe l’uomo con fervore.
«Il vescovo non ha ancora confermato» ribatté lei pragmaticamente.
«Comunque vede qualcosa, e qualcuno è guarito» si stizzì l’uomo.
«Sì, sì» disse lei. L’altra donna aveva seguito la conversazione guardando verso mio padre, seduto sul masso a riprendere fiato.
«Papà. Resti qui» disse di nuovo Giovanni. Mio padre si alzò, ed entrò nell’Eremo. Noi costeggiammo il muro, e riprendemmo a camminare. La mulattiera si arrestava: da lì ci sarebbe stato solo il sentiero.
L’estate del ’77 – pensai – l’ultima volta che siamo passato di qui, io e Giovanni, sotto una tempesta tracimata nera dalle Alpi. L’acqua ci era scivolata incontro, infangandoci le caviglie, erodendo il fondo del sentiero, con le radici degli alberi sospese a mezz’aria. Io e lui come cavalieri nella bufera, e il cielo sferzato da saracche furenti. E ricordai anche che, fradici ed estatici, ci eravamo messi a gridare versi di vecchie canzoni nel vuoto davanti a noi, verso il lussureggiante arcobaleno che aveva tagliato la valle, alla fine della burrasca. Te lo ricordi, Giovanni, il ’77? – avrei dovuto chiedergli. Invece dissi: «Dove sarà l’uomo?».
«Non lo so. Da qualche parte» rispose lui.
«Sì, ma se ha tagliato fuori sentiero, sarà difficile trovarlo».
«No, avrà seguito il sentiero. Tutti seguono il sentiero» continuò Giovanni. Procedeva senza girarsi: adoravo ancora seguirlo, la fantastica figura di spalle che mi apriva il mondo. Mi voltai per vedere in basso: ormai eravamo fuori tiro per tutti e per tutto. In alto il cielo era diventato grigio.
«Sta facendo brutto. Forse pioverà» dissi.
«Sssst» comandò Giovanni facendomi un cenno con la mano. Si piegò sulle ginocchia come un capitano di brigata partigiana, dove il sentiero, con un gomito, seguiva le gobbe del pendio. «Hai sentito?» aggiunse sottovoce.
«No» risposi. Aria fredda risalì dal canalone alla nostra destra.
«Sssst» intimò, di nuovo. Si sentiva un rumore confuso – di rotolamento, di foglie e sterpi. Un rumore in avvicinamento.
Poi, dall’ultima striscia di bosco che ci sovrastava, sul pendio alla nostra sinistra, qualcosa piombò su di noi.
Giovanni si accorse per primo. Balzammo via appena in tempo. Una massa scura si piantò sul sentiero. Era un grosso animale.
«Un cinghiale!» esclamai. Restammo fermi, ad osservarlo per qualche secondo.
«È vivo» disse mio fratello. «È ferito» aggiunse. C’era una freddezza nel modo in cui diceva quello che diceva: come gli auguri per Natale e Pasqua per mantenere le promesse a nostra madre.
«Gli hanno sparato. Guarda la zampa» aggiunse. Presi l’iniziativa e mi chinai sul corpo del cinghiale: il sangue sgorgava dalla ferita e colava sul sentiero. Quindi mi piegai sulle ginocchia, per ascoltare il respiro. Era una bestia che incrociava il mio cammino, come quella volta, attraversando la Foresta Nera, durante il tour promozionale del 1984, quando la mia faccia riempiva le fanzine: io e il mio produttore avevamo quasi travolto un cervo balzato fuori dalla macchia. L’auto si era fermata ad un palmo dal suo manto, e avevamo avuto il tempo di ammirare le maestose corna. La bestia ci aveva fissato per qualche secondo e avevo desiderato toccarla. Ora perlustravo il cinghiale che si dibatteva, e provai lo stesso desiderio. Fu a quel punto, quando stavo per chiedere a mio fratello cosa avremmo fatto, che lui comparve, sbucando di corsa, dal gomito del sentiero.
Un’apparizione. Non ridimensionerò l’impressione che mi fece, il sant’uomo. Un uomo alto, biondo: una specie di vichingo, con lunghi baffi che gli marcavano la faccia, un camicione a scacchi rossi e neri, i pantaloni di velluto al ginocchio, le calze di lana grossa, e gli scarponi vecchia scuola. Un’apparizione che correva scomposta sul sentiero.
«Ehi!» gridò, avanzando balzelloni. Io mi alzai, staccandomi dall’animale ferito, e capii subito che era lui: lui era il sant’uomo. C’erano le indicazioni dei vecchi, giù all’Eremo, ma io lo intuii lì, quando smise di correre, dondolando la lunga smagrita figura e arrotolando le maniche della camicia: mi sembrò un grande bambino, qualcuno che poteva assomigliare all’idea che avevo di un sant’uomo. Non un vegliardo gonfio della sua nomea. No: un grande bambino biondo, con gambe magre e piedi lunghi.
«Ehi» ripeté. I baffi folti sapevano di antico vezzo.
«È ferito» dissi, per giustificare d’essere accovacciato vicino alla bestia.
«Sono stati i bracconieri. L’ho visto scivolare giù per il pendio» disse l’uomo. Sembrò quasi non accorgersi di Giovanni. Gli passò di fianco, con il suo passo baldanzoso, si chinò sul cinghiale e sembrò sussurrargli qualcosa. «Piove, fra poco» aggiunse. «Portiamolo al riparo. Bisogna togliere il proiettile». Era piegato sotto il peso dello zaino. Ci fu un attimo di silenzio, con il vento che soffiava più forte e le prime gocce d’acqua battenti.
«Bisogna sollevarlo, piano. Non possiamo trascinarlo. Dove lo portiamo?» chiese Giovanni.
«Di qui» e fece segno dalla parte da cui eravamo venuti. Oltre i castagni c’era una parete rocciosa, e uno squarcio la attraversava. Si alzò sulle ginocchia. Al suo cenno eravamo pronti.
Nella caverna eravamo finalmente all’asciutto. L’uomo doveva esserci già stato.
«Accendiamo il fuoco» disse, e si avvicinò ad un mucchio di sassi disposti in cerchio. Prese della legna. Filò dritto in fondo alla caverna e tornò con un contenitore di plastica. Aprì e versò del liquido che fece incendiare rapidamente i ceppi. Caldo e luce riempirono la cavità.
«Siete venuti a cercarmi» disse, mentre si chinava sul cinghiale.
«Sì» rispose Giovanni. Fuori pioveva e tuonava forte.
«L’ultimo temporale prima dell’autunno» sentenziò l’uomo. «Adesso c’è da salvare lui» disse indicando la bestia. Lo guardai meglio, illuminato dalla luce del fuoco. Poteva avere cinquant’anni.
«Cosa vuoi fare?» chiesi.
«Gli togliamo il piombo che ha nel fianco, e poi si vedrà».
«Io sono un medico» intervenne Giovanni.
«Bene, dottore. Aiutami» disse, ed estrasse un lungo coltello dallo zaino. Fu rapido: scaldò la lama sul fuoco e incise la pelle dell’animale – noi l’avevamo afferrato per le zampe e le tenevamo ferme, ogni volta che fremevano agli affondi del ferro bollente. Sembrava di essere in un film con John Wayne. Poi toccò mio fratello, che prese del filo che l’uomo aveva pescato in una tasca della camicia, e ricucì la ferita – e fu la prima, fu l’unica volta che ebbi il privilegio di vedere all’opera le sue mani da milioni all’anno: veloci, precise, sicure.
«Cosa volete che faccia?» chiese l’uomo, quando tutto si era concluso – piombo estratto, ferita suturata, cinghiale avvolto in un plaid a scacchi gialloverdi: un lavoro da dio.
«È per nostro padre» dissi. «È malato e ha letto di te: che guarisci le persone, che vedi qualcosa. È così, no?»
«Vedo qualcosa» ripeté lui, sorridendo, e sedendosi vicino al fuoco. Estrasse una pipa dallo zaino, e accese il tabacco con un legnetto arroventato. Spirali di fumo carezzarono la volta della grotta. Ogni gesto che compiva ridicolizzava la futilità delle nostre vite.
«E tu non puoi curarlo, dottore?» chiese a Giovanni.
«Ci sono cose che non si possono curare» rispose mio fratello.
«Lo so» disse, esalando fumo denso dalla bocca. «Io sto morendo» aggiunse. L’animale, sdraiato su un fianco, emise un leggero fischio che si esaurì, come aria che esce dal foro di un copertone. «Sto morendo. Un anno fa, mi hanno detto che c’era solo da aspettare. Così ho preso armi e bagagli e sono salito quassù» raccontò. Il fuoco balbettava e l’uomo aggiunse un ceppo nodoso. «Una notte di agosto mi sono svegliato all’improvviso» continuò «e c’era una luce, più giù, nel cuore del bosco, a due passi dall’Eremo. C’era luce, e mi sono avvicinato. E ho visto qualcosa. L’ho vista, credo: era bellissima. La Bellissima. Non diceva niente, non ha mai detto niente, nemmeno le volte successive». Si lisciò i lunghi baffi. «È vero, dottore» riprese volgendosi a Giovanni. «Non si può curare, non tutto. Non si può curare, eppure si guarisce». Ancora oggi mi capita di pensare a quelle parole, e al fatto che pensai subito che non si potesse non credere, al grande bambino, anche fossero state balle colossali, tutte le dicerie su di lui. «Avrei voluto essere geloso di quella luce, della Bellissima» continuò. «Tenermela per me. Ma ho finito per parlarne con i padri dell’Eremo. Così è arrivato qualcuno, e poi altri ancora. È stato così per mesi. Poi qualcuno ha detto che avevo fatto qualcosa per lui. Che era guarito, o cose simili». Aspirò ancora, come stesse parlando di qualcosa che lo riguardava appena.
«Chi è la bellissima?» chiese mio fratello.
«Una donna. Bellissima. Ho smesso di sentirmi morto».
«La Madonna?» incalzò Giovanni. A me già non serviva sapere altro. Era la Bellissima, come la chiamava il grande bambino. Mio fratello, invece, faceva così anche quando nostra madre ci portava ad accendere candele sotto i cuori argentati degli ex-voto. Lui non credeva ad una virgola delle spiegazioni di nostra madre.
«Non lo so. Dico solo che è bellissima». Guardava le volute di fumo. «E vostro padre?» chiese.
«All’Eremo. Non ce la faceva» risposi.
«Io non posso vederlo, oggi, né domani. Devo portare questo cinghiale nel bosco, su, alle tane». Gettò lo zaino e si distese, appoggiandovi la testa.
«Sì, capisco» disse Giovanni, guardandomi. Ci fu silenzio per un paio di minuti. Io continuai a fissare il respiro corto del cinghiale.
«Sta per spiovere. Uscirà il sole» riprese lui.
«Ci prepariamo» disse mio fratello.
«Guarirà?» chiesi. Io agli ex-voto avevo sempre voluto credere.
«Se passerà la notte» rispose lui.
«Allora addio» tagliò corto Giovanni.
«Non dite di avermi incontrato» disse lui. Misi lo zaino sulle spalle, e mi avviai. Giovanni mi precedeva. Prima di uscire, accarezzai il cinghiale. Feci un cenno con la mano all’uomo, ma lui aveva chiuso gli occhi, e dondolava una gamba, canticchiando.
Il sentiero era diventato un pantano. L’aria era satura di vapore, e di gocce come spilli che piovevano dagli alberi. Giovanni ed io puntavamo energicamente i talloni nel fango.
«Non diciamo niente a papà» disse.
«No».
«È un uomo che muore» aggiunse.
«Sì» confermai, ma non sapevo se stesse parlando di nostro padre, o del sant’uomo.
«Chissà come si chiama» disse lui, alludendo forse all’uomo, forse alla Bellissima, cui entrambi stavamo segretamente pensando. Ma in quel momento comparve il sole, e tutto tornò semplice e chiaro.
Credo che mio padre avesse capito, quando ci vide sbucare dal sentiero. Mi guardò come lo avevo visto fare quando ero quasi affogato nel lago, l’estate del ’71, cadendo dal mio optimist. Io non avevo fatto piagnistei e lui mi aveva guardato come per sollevarmi da un peso. Fece lo stesso quando lo trovammo seduto dove l’avevamo lasciato. «Scendiamo» disse lui, mettendosi davanti al gruppo. Scivolavamo sui ciottoli della mulattiera, ancora bagnati. Non si parlò del sant’uomo. Mai più l’avremmo fatto. Ad un certo punto, eccola, la ragazza. La sentimmo arrivare alle nostre spalle: saltellava sui ciottoli, leggera, illuminata dal sole. Ci fermammo a bordo del sentiero.
«Buongiorno» disse con voce brillante.
«Buongiorno» rispose mio padre.
Forse era lei che il sant’uomo aveva visto, chissà; o qualcuno del genere, doveva essere – pensai. Rimasi fermo a guardarla scendere, leggera come aria pulita. «Francesco». Era la voce di mio padre. «Andiamo» aggiunse.
«Sì» risposi. Poi feci due balzi, battendo con la mano sulla spalla di Giovanni, e mi misi in testa al gruppo.
In certi pomeriggi, quando Milano sale al mio attico con i suoi rumori feroci, allora penso al sant’uomo. O a quello che è rimasto di lui, dell’aura sacra che lo aveva avvolto per qualche tempo. Ho provato a seguire la sua vicenda, da lontano, spulciando in riviste che non avrei mai pensato di sfogliare. Forse volevo sapere cosa ne era stato dell’animale, se era valsa qualcosa tutta quell’acqua presa, e la lama nella carne, e il piombo buttato fuori dalla ferita, e il fuoco preistorico. Ho messo via una decina di articoli – il sant’uomo? tutta infatuazione popolare: visioni e guarigioni e tutto il resto, con tanto di testimoni, e sopralluoghi. Così dicevano i giornali. Un imbroglione. Eppure io l’avevo visto, il grande bambino che correva balzelloni. Ad un certo punto, poi, ho smesso di cercare notizie su di lui. Ho cominciato a coltivare la speranza che il cinghiale fosse ricomparso nei boschi, e che il sant’uomo se ne fosse andato, da qualche parte, con la Bellissima. Andato, puff!, sparito. È questo che ho immaginato, senza parlarne con nessuno, fino a quando mio padre è morto, l’anno scorso. Allora, quando siamo rimasti soli nella camera mortuaria dell’ospedale, ho ricordato a Giovanni di quella volta sul Monte Nudo. Giovanni mi ha guardato. Sembrava volesse dirmi: non fare il sentimentalone, alla tua età. Così ci siamo messi a ridere, lì, nella camera mortuaria, con il corpo di mio padre davanti a noi, composto, elegante, severo, e abbiamo pensato a quanto tempo era passato, e mio fratello era convinto che fosse successo tutto nel ’98, e io a dirgli, a insistere – no, ti sbagli, era il ’96, papà è rimasto vivo altri dieci anni, dieci anni esatti sono trascorsi da quando abbiamo diviso la grotta con il sant’uomo. Giovanni non mi ha dato ragione, come faceva con nostra madre; ha guardato in alto, e poi ha fatto un cenno, come per dire che era stato quel che era stato, e basta, che l’importante era che fosse accaduto. Poi ha aggiunto che saremmo dovuti tornare, lassù – magari ci si mette d’accordo, una di queste volte. Una delle sue balle. Ho detto di sì, come ho sempre fatto con tutto ciò che mio fratello mi ha proposto negli anni, anche se sapevo che non saremmo mai saliti sul Nudo. Ho detto di sì, come se avessi bisogno di sperare di rivedere qualcosa, o qualcuno. Quando penso tutte queste cose, in certi pomeriggi, e guardo in basso Milano, e lontane, nella foschia chiarissima, eccole, le Alpi celesti e verdi di boschi, allora avvicino la poltrona alle vetrate accese dal sole, mi siedo, allungo le gambe, incrocio le braccia dietro alla testa e respiro, respiro, respiro.