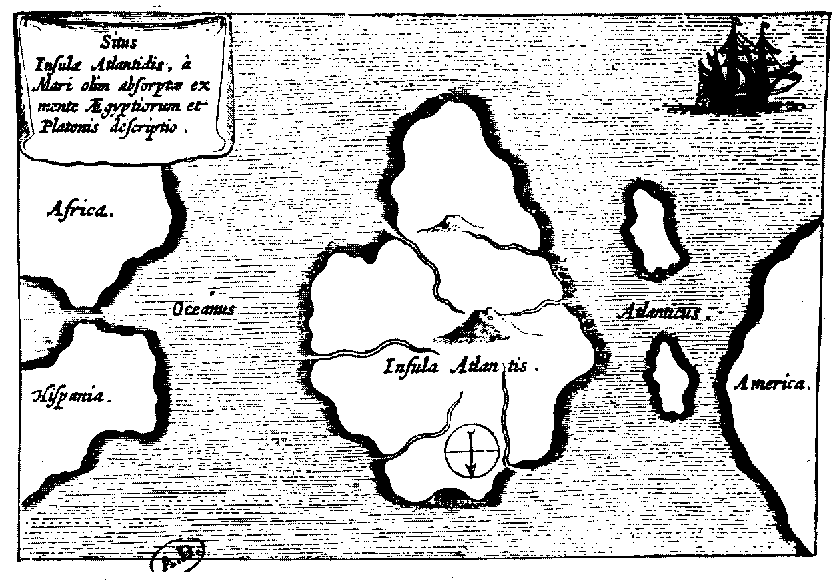L’homo poeticus dei romanzi
Sul rapporto tra romanzo e memoria
di
Simona Carretta
La memoria, forma ed effetto del romanzo
«Je me souviens», io mi ricordo, è la scritta che figura sulla targa delle automobili di Montréal, città in cui mi trovo a trascorrere qualche giorno per via di un convegno. Il significato originario di questa massima, considerata il motto ufficiale del Québec almeno dal 1883 – quando l’architetto Eugène-Étienne Taché la iscrisse sulla facciata del Parlamento -, è ancora oggi oggetto di varie interpretazioni. Che indichi l’antico legame del Québec con la cultura francofona o semplicemente l’attenzione dei quebecchesi verso il loro bagaglio storico, l’adozione di questa massima esprime, da parte del Québec, l’assunzione della memoria a valore.
Così, anche Montréal, la cui architettura combina stile liberty ed elementi futuristici, cattedrali neogotiche e grattacieli, ma che per alcuni aspetti mi appare come un concentrato della vecchia Europa, stranamente posto fuori dall’Europa (basta entrare in una delle fornitissime librerie del Boulevard Saint-Laurent per ritrovare il cuore della letteratura europea, nello stile delle migliori librerie parigine), si presenta ai miei occhi, che la visitano per la prima volta, come città della memoria.
Se mi soffermo su questo è perché vi scorgo il segno di una piccola coincidenza, dal momento che il convegno a cui sono invitata ha come oggetto proprio il tema della memoria, da esaminare in rapporto al romanzo.
Mentre ci penso, rifletto sul fatto che l’attitudine alla ricerca di corrispondenze, quel filo rosso che permette la connessione tra i ricordi, sembra rispondere ad un tipo di immaginazione che si potrebbe qualificare come romanzesca.
I meccanismi che decidono della reminescenza di un avvenimento, o del suo oblio, non sembrano infatti rispondere a parametri logici, ma ad un altro ordine di criteri, apparentemente particolari e soggettivi: rispondenti al desiderio dell’uomo, più o meno inconscio, di rappresentarsi il proprio vissuto secondo una trama. Sotto questo impulso, la memoria organizza una composizione che accoglie, più facilmente, i ricordi di quei determinati eventi che sembrano confermare quel particolare significato, individuato come chiave di interpretazione dell’esistenza, mentre tende ad escludere gli altri, destinati perciò a cadere nell’oblio.
Qualunque sia il disegno così tratteggiato, che ritragga lo svolgersi di un’esistenza più o meno felice, dalla sua contemplazione l’uomo trae una gratificazione. Questo disegno infatti, a prescindere dagli esatti contenuti della sua rappresentazione, appare, in ogni caso, bello: aggettivo da intendere nel senso di armonioso, compiuto.
Il piacere che se ne trae corrisponde principalmente ad una soddisfazione di natura estetica: la stessa che si prova davanti ad una composizione (figurativa, musicale o letteraria) nella quale ogni elemento trova chiaramente la sua collocazione e che può dirsi, per questo, riuscita.
In questa continua commutazione, ad opera della memoria, di eventi quotidiani o puramente accidentali in un racconto interiore che presenta una struttura coerente si manifesta una profonda tensione umana, in cui si può cogliere – credo – uno slancio etico.
Questo corrisponde alla speranza di poter sempre cogliere, attraverso il turbine degli eventi, la raison d’être di un’esistenza; speranza che sembra raccogliere l’unico residuo forse ancora superstite di ciò che un tempo era la fiducia nel destino. Così l’uomo, forse senza neanche saperlo fino in fondo, stabilisce in ogni momento la propria gerarchia dei ricordi secondo leggi di natura estetica.
Se, da un lato, l’arte del romanzo sembra riflettere i processi della memoria nella definizione delle sue strutture compositive, allo stesso modo, la maniera in cui l’uomo tende ad elaborare i propri ricordi risulta in qualche modo influenzata dalla lettura di opere romanzesche: la stessa capacità di ricordare sembra essere ispirata dai romanzi. Da alcuni in particolari.
«E’ proustiano !» – diciamo, in genere, di un ricordo che improvvisamente ci assale, restituendoci un frammento di vita lontana e, con esso, quel che un tempo eravamo e che credevamo per sempre perduto.
Attraverso i continui andirivieni nella memoria del suo personaggio protagonista (questi salti temporali nel passato o nel futuro, a cui i critici danno il nome di «flashbacks», o «flashforwards») Proust – molto più che la filosofia di Bergson – condiziona la maniera di ricordare propria dell’uomo moderno.
Lo abitua a organizzare la sua memoria per «serie di variazioni su tema» (per riprendere un’espressione cara a Deleuze, lettore della Ricerca): a confrontare, in ogni istante, quel che di nuovo accade con tutti gli episodi precedenti della stessa “serie”; questo, alla ricerca di «segni», cioè di antiche premonizioni che confermino il suo carattere di necessità.
In questa attitudine al confronto con i ricordi si riconosce la cifra artistica dell’universo proustiano, in cui ogni evento assume un senso solo se è possibile rapportarlo ad avvenimenti precedenti.
Per il narratore della Ricerca, la gioia di poter finalmente baciare Albertine non sarebbe la stessa, se non alla luce della disperazione, provata tante volte in passato, di potervi mai riuscire.
La stessa esperienza dell’amore – alla luce di quello che impariamo, leggendo Proust – sembra essere indissociabile dalla possibilità di ricollegare, con il filo d’Arianna della memoria, le relative immagini, e sensazioni, che con il tempo abbiamo accumulato della persona amata.
Per questo, si può dire che Proust abbia scoperto una nuova possibilità della memoria: quella di fungere da detonatore per il riconoscimento delle esperienze di senso (ossia, cariche del valore di necessità); questo, attraverso il rilievo delle coincidenze significative che possono riscontrarsi tra avvenimenti sparsi nel tempo.
La memoria, allora, sta al romanzo come un effetto. Tuttavia, essa vi corrisponde anche come forma, ossia come componente formale necessaria alla realizzazione dell’obiettivo conoscitivo del romanzo: sviluppare una visione dell’esistenza che si mantenga problematica e relativa (una visione dunque alternativa a quella, più sistematica, della scienza, o all’immagine piatta e superficiale della vita veicolata dai media).
A tal fine, l’elemento della memoria svolge un ruolo importante: l’introduzione, nel tempo del romanzo, del tempo passato – ossia, di una dimensione temporale presentata come diversa da quella in cui si svolge la principale storia raccontata – fornisce un’ulteriore angolazione da cui considerare i fenomeni narrati e contribuisce, in tal modo, a problematizzarli.
La stessa scoperta della relatività del tempo – ricordava Bachtin – rappresenta la principale conquista del romanzo ed è connessa alla stessa nascita di quest’arte; in questo elemento consiste, soprattutto, la sua lontananza dall’epos: genere che, invece, descrivendo le gesta degli eroi, presenta la loro epoca come un passato ideale e «assoluto».
Ne Le grandi scomparse. Saggio sulla memoria del romanzo (Les Grandes disparitions. Essai sur la mémoire du roman, PUV, Saint-Denis, 2008), Isabelle Daunais scrive che la propensione ad esaminare il presente attraverso il ricordo del passato, ossia a scoprire il “nuovo” attraverso l’osservazione di quello che un tempo c’era e ora non esiste più, contraddistingue la storia del romanzo, a partire dai suoi più celebri capolavori.
In Don Chisciotte o Madame Bovary, il motore di avvio della storia è costituito proprio dallo smarrimento registrato dai protagonisti, una volta constatata l’impossibilità di vedere corrispondere il mondo in cui vivono al bagaglio delle aspettative personali, quest’ultimo elaborato su modelli ereditati dal passato; che si tratti dei codici in vigore nei romanzi cavallereschi, amati da Don Chisciotte, o del galateo tipico delle storie d’amore ottocentesche, preferite da Emma.
Custodire la memoria poetica
Il romanzo contemporaneo è ancora popolato da figli putativi di Don Chisciotte o Madame Bovary; personaggi, a loro a volta lettori di romanzi, che si ritrovano a sperimentare la distanza tra il mondo di cui parlano quei romanzi e la realtà che li circonda.
Ad esempio, questo è il quadro entro il quale si definisce la vicenda esistenziale di David Kepesh, il protagonista del romanzo di Philip Roth Il professore di desiderio (1977).
Il problema di Kepesh è essenzialmente questo: come riuscire a resistere, quale senso dare alla vita, nel momento in cui ci si rende conto di vivere in un mondo – precisamente, quello occidentale post sessantottino – in cui la logica consumistica, a cui anche i rapporti umani sembrano ormai sottoposti, sembra rendere sempre più difficile non solo la possibilità di costruire delle relazioni d’amore durature, ma anche quella di abbandonarsi spensieratamente alla passione? Questo tormento accompagna il personaggio di Roth per tutto il corso della sua vita erotica: dal periodo della sua prima formazione universitaria trascorsa in Europa – dove si dedica ad una vera e propria tournée di amori libertini, di cui però si stanca presto – al fallimento del matrimonio con Helen, bella e ricca ereditiera che si scopre innamorata molto più dell’idea dell’amore che del marito. Per finire, con l’amara constatazione della natura dispotica che – al pari dei sentimenti – sembra contraddistinguere anche il desiderio, l’attrazione fisica, la cui volubilità può rischiare anch’essa di mettere in pericolo relazioni apparentemente stabili e durature; come quella che, al termini delle sua vicissitudini sentimentali, Kepesh intreccia con la dolce Claire.
A fare da contrappunto al contesto di disordine amoroso in cui si muove Kepesh, l’esempio dei suoi genitori: una classica coppia “vecchio stampo”, che incarna gli ideali di amore eterno e fedeltà reciproca. Non è un caso che – soprattutto nella seconda metà della romanzo – essi vengano descritti come deboli, fragili (verso la fine, la madre di Kepesh muore); in questo modo, essi simboleggiano la condizione di precarietà in cui, ormai, versano gli ideali da loro testimoniati.
Questo scenario conflittuale fa emergere un nuovo dilemma: nel momento in cui quei codici che prima avevano regolato i rapporti tra uomo e donna, tanto le dinamiche dell’amore quanto quelle del desiderio, si sgretolano e questi ultimi allora si manifestano nella loro nudità mostruosa, come forze astratte e ingovernabili, su quale base allora, se non sull’amore, né sulla passione, ciascuno può credere di vedere fondata la sua identità?
Il personaggio di Roth sperimenta questo disorientamento in maniera tanto più intensa non solo perché nato proprio a cavallo di questo cambiamento epocale, ma anche in quanto uomo di lettere.
Kepesh è un docente di letteratura comparata che, proprio nel momento in cui la sua vita amorosa sembra assumere una piega drammatica, si prepara ad organizzare un seminario sul tema del romanzo amoroso; l’intensa lettura dei romanzi a cui si dedica lo porta a confrontare la miseria delle sue esperienze con la storia delle grandi passioni descritte in Anna Karenina o Madame Bovary, o con le avventure licenziose di Henry Miller o Colette, e a trovarla, di conseguenza, ancora più difficile da accettare.
Proprio il ricorso di Kepesh alla letteratura può rappresentare, però, l’ancora di salvataggio contro il disorientamento di cui è vittima.
Anna Karenina (1877) il capolavoro di Tolstoj menzionato dal Professore di desiderio, è anche il libro preferito da Tereza, protagonista del romanzo L’Insostenibile leggerezza dell’essere (1984) di Milan Kundera.
Cameriera di provincia costretta dalla famiglia ad abbandonare gli studi, Tereza è però una lettrice appassionata: nei romanzi, ritrova quella bellezza di cui appare sprovvisto, invece, il mondo della sua prima giovinezza.
Il romanzo di Tolstoj viene menzionato più volte nell’Insostenibile leggerezza dell’essere, fornendo l’occasione per alcune riflessioni sul problema della memoria poetica: questione che contribuisce allo sviluppo del tema principale del romanzo kunderiano, articolato intorno all’opposizione leggerezza-pesantezza.
In particolare, la questione della memoria poetica sta a dimostrare il valore positivo che può assumere anche il polo della «pesantezza», intesa come necessità.
In un inserto del romanzo che si potrebbe definire meditativo, o saggistico, il narratore riflette sulla struttura del capolavoro di Tolstoj, che sembra basata sulla logica delle coincidenze: gli incontri tra Anna e Vronskij sono infatti spesso determinati da circostanze fortuite; la stessa Anna, verso la fine del romanzo, si toglierà la vita gettandosi sotto un treno, così imitando l’uomo ritrovato sui binari il giorno del primo incontro di Anna e Vronskij alla stazione.
Al contrario di quanto si potrebbe pensare – spiega Kundera -, queste coincidenze non dovrebbero indurre a considerare il romanzo di Tolstoj come troppo «romanzesco»; nel senso di falso, artificiale, troppo costruito.
Per Kundera, l’opera tolstoiana si dimostra invece realista nel cogliere l’impulso degli esseri umani a ricercare la presenza di nessi significativi negli eventi apparentemente accidentali, a cercare di costruire la loro esistenza come se fosse un romanzo; ossia, a sviluppare una memoria poetica: «L’uomo senza saperlo compone la propria vita secondo le leggi della bellezza – continua il narratore dell’ L’Insostenibile leggerezza dell’essere – persino nei momenti di più profondo smarrimento».
Nei suoi saggi, Danilo Kiš chiama «Homo poeticus» l’attitudine a cogliere negli eventi contingenti che scandiscono l’esistenza la trama di coincidenze sotterranee; sarebbe stata l’esistenza di questa funzione – la funzione poetica -, presente nell’uomo sin dalle origini, a permettere agli antichi di elaborare i primi racconti mitici, corrispondenti alle prime forme di ipotesi ontologiche.
Questa propensione a sviluppare un’immagine del mondo che non ne riduca il mistero e la complessità, questa mentalità poetica, oggi sempre più oscurata dalla mentalità tecnologica, può essere custodita solo dai romanzi.
Essi ci mettono in guardia dalla scomparsa di Homo poeticus; dal pericolo che può risultare, al fine del raggiungimento di una felicità e della realizzazione personale, dalla perdita della capacità di coltivare una memoria poetica.
Nei romanzi di Kundera e Roth, i personaggi di Tereza e di David Kepesh traggono proprio dalla lettura uno spunto di salvezza.
Nel caso della protagonista dell’Insostenibile leggerezza dell’essere, proprio l’abitudine a leggere le coincidenze come segnali, appresa sulla scorta delle sue letture, la induce ad abbandonarsi alla storia d’amore con Tomáš.
Anche in Professore di desiderio, l’evocazione dei romanzi letti da Kepesh – che fanno da contrappunto ad un mondo, quello del personaggio, che sembra aver smarrito la memoria – non va intesa come una parentesi o come la prova della chiusura autoreferenziale del romanzo.
Al contrario, il senso della vicenda esistenziale di Kepesh si chiarisce solo nel momento in cui i due piani su cui è articolato Il professore di desiderio, quello relativo alla vicenda principale e quello più saggistico, che costituisce “il romanzo del lettore”, si incontrano.
Ciò avviene verso la fine del romanzo, quando, prendendo spunto da Una relazione per un’accademia di Kafka, Kepesh decide finalmente l’impostazione da dare al suo seminario. Presenterà, ai suoi allievi, una sorta di confessione della sua vita sentimentale ed erotica. Da un lato, questo tentativo risponde all’obiettivo di presentare agli studenti l’universo amoroso di cui parlano i romanzi oggetto del corso come qualcosa di non astratto, ma accessibile a tutti. Questa impresa, però, dà anche a Kepesh una nuova possibilità: quella di ritornare Homo poeticus, di interpretare la sua vita come un romanzo e di trovare così una forma di consolazione.