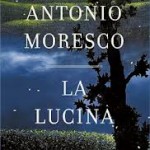(è da pochi giorni in libreria La Caduta il primo romanzo di Giovanni Cocco. Ringraziamo la casa editrice Nutrimenti per averci permesso di pubblicarne un estratto. G.B.)
(è da pochi giorni in libreria La Caduta il primo romanzo di Giovanni Cocco. Ringraziamo la casa editrice Nutrimenti per averci permesso di pubblicarne un estratto. G.B.)
di Giovanni Cocco
Helladios –
Atene, 20 giugno 2014
Serrava la lingua, mordendola fino a sentirne il sangue, nello spazio di gengiva ricavato tra gli incisivi caduti anni prima, fissando la rete calata in acqua con la perizia di un biologo, e me lo sono immaginato per anni in quel modo, un eroe bislacco dei tempi della guerra, il remo al posto della spada, il collo rubizzo sul retro nel solco scarnificato dei due muscoli sternocleidomastoidei, ed era fiero, Helladios, di quella fierezza tutta speculativa e razionale, un angelo decadente destinato a non piegarsi, uno Psaronikos al contrario che sfidava il mare brandendo una fiocina, gli avambracci bruciati al sole del Mediterraneo, una ferrea volontà di potenza incistita nell’animo che gli avrebbe garantito le forze, lungo i primi sessant’anni, di viaggiare per tutto l’Egeo, solo con le proprie mani, armato di lenza e bastone, tutto muscoli e nervi, braccia magrissime e determinazione feroce, come se quella fame, una fame atavica alimentata a taramosalata e molluschi, fosse stata in grado, da sola, di partorire quel prodigio, quell’ossimoro vivente, un mastino anomalo fatto di pelle e ossa, un uomo che la vita, e la guerra, e le costrizioni, e la miseria, e la malnutrizione, non sarebbero mai state in grado di piegare, un miracolo aspro forgiato a fuoco dalla vita, una santabarbara lavoratrice capace, ogni giorno, verso il calar del sole, quando la campana di P. aveva già chiamato a raccolta gli isolani, di rimettersi al lavoro dopo le dodici ore passate a bordo del peschereccio, negli angoli più remoti attorno al Pireo, giusto il tempo di prendersi un ouzo, di salutare Zoe, di avere accordato una carezza rugosa a uno dei suoi nove figli e via di nuovo, a inventarsi un secondo mestiere, dopo aver infilato goffamente la canottiera tutta bucata nei pantaloni tagliati sopra il ginocchio, e tu lo avresti detto impassibile, a tratti, e forse anche eroico, Helladios, al tempo dei suoi anni migliori, a bordo del suo destriero, l’Eleutheria, un ventuno metri di medio tonnellaggio, con un ampio pozzetto e la carena azzurra, la cabina rovente all’interno della quale aveva condotto, come in un rito d’iniziazione, solo i figli maschi, la fronte imperlata di gocce di sudore, gocce salate a scorrergli dalle sopracciglia alle gote raspose ancora profumate di schiuma da barba e poi giù, di nuovo, fino alle labbra, ad alimentare quello sforzo sovrumano che non conosceva pause, né fatica, né sconfitte. Labbra, le sue, secche di vino e tabacco, capaci di schiumare rabbia e angoscia, determinazione incrollabile e un’indomabile fame di vita.
Adesso il vecchio Helladios è là, seduto in un angolo seminascosto della Papaiannou, la trattoria di famiglia. Una delle tante attività di Atene con il cartello vendesi appeso davanti all’ingresso.
I figli e molti dei suoi nipoti hanno perso il lavoro. Stephane si è messo a impilare cassette e vendere verdura in uno dei tanti mercati rionali che sorgono intorno al porto; Cristophe si mantiene lavorando in un magazzino di conserve; Cosmas è uno di quei cinquemila greci che, tramite una cooperativa sociale, hanno fatto domanda per un posto da raccoglitore di pesche su a Veria, nel nord del paese. Prima, questi lavori erano affidati agli immigrati. Adesso i greci fanno la fila fin dalle prime ore del mattino per una paga giornaliera di ventinove euro lordi.
Suo fratello Manolis ci aveva visto giusto. Era emigrato in Germania all’inizio degli anni Settanta.
Adesso vive a Francoforte. È uno dei numerosi greci che, col passare degli anni, sono diventati cittadini tedeschi. Per anni ha gestito una rivendita di Volkswagen. Si è fatto una posizione. Suo figlio ha potuto studiare. Di tanto in tanto telefona alla cognata. Il tono di voce è sempre più preoccupato.
“Come va, da voi?”, ha chiesto l’ultima volta Manolis alla moglie di Helladios all’indomani degli ennesimi disordini.
“Noi stiamo bene”, ha risposto Zoe. “E tu? Come sta Klaus?”.
“Io tiro avanti. Non mi posso lamentare. Klaus vive ancora a Berlino. Il lavoro va bene. Siamo preoccupati per quello che abbiamo visto in tv”.
“Qui le cose vanno sempre peggio. Il problema, Manolis caro, sono le banche”.
Zoe passa la cornetta alla nipote, che racconta le loro ultime disavventure.
Le cose hanno cominciato a mettersi male quando l’Unione europea ha fatto entrare in vigore la nuova normativa relativa alla pesca nei bacini del Mediterraneo. Il pescato, nel giro di pochi mesi, è diminuito del quaranta per cento. I prezzi sono saliti alle stelle. La concorrenza dei prodotti provenienti dal Baltico e dall’Oceano Indiano si è fatta serrata. In poco tempo intere generazioni di pescatori sono state costrette a chiudere bottega. Noi abbiamo resistito. Dopotutto rimaneva sempre la trattoria. Abbiamo stretto la cinghia. Nonostante le difficoltà la trattoria ha mantenuto per un anno un discreto giro d’affari. Riuscivamo a tirar fuori di che vivere. Non era granché, ma per noi era sufficiente. Poi è subentrata la crisi. Quella vera. Abbiamo iniziato a dilazionare i pagamenti ai pochi fornitori rimasti. L’improvviso crollo di una parte del soffitto nella sala più grande ci ha costretti a chiedere un prestito alla banca. La banca ha impiegato mesi per accordarcelo. Noi intanto perdevamo clienti giorno dopo giorno, un po’ per la crisi e un po’ per le condizioni del locale. Quando alla fine la banca ha erogato il prestito, il tasso era da strozzini. Gli incassi hanno cominciato a diminuire. Allora abbiamo chiesto alla banca una dilazione del pagamento.
La banca non ha voluto sentire ragioni. Non ha concesso proroghe. Le bollette non pagate hanno iniziato ad accumularsi. Avevamo ancora i fornitori da saldare. In pochi mesi siamo passati dal ritardo nel pagamento delle rate del prestito agli insoluti.
A poco più di un anno di distanza dalla concessione del prestito la banca ha fatto partire la procedura per il rimborso totale del finanziamento. L’ufficio legale ha fatto valere le sue credenziali con una ferocia inaudita. Non hanno preso nemmeno in considerazione l’ipotesi della concessione di un fido. Non hanno tenuto conto del fatto che fossimo clienti da oltre quarant’anni.
“Ordini che arrivano dall’alto”, ha detto uno degli impiegati allo sportello. “Dobbiamo assolutamente rientrare”, ha concluso il vicedirettore.
Helladios torna ai suoi pensieri, si concentra sui particolari.
Da tempo non riesce più a muoversi e l’unica compagnia rimastagli è il fascio luminoso e ininterrotto proveniente dalla televisione, che in questi giorni proietta in diretta le immagini di un paese in fiamme.
Uomini, a migliaia.
Intere famiglie.
Una carovana ininterrotta di persone percorre l’Egnatia Odos verso est. La gente è allo stremo. Ripensa al dopoguerra, il vecchio Helladios. Ripensa al tempo in cui ogni cosa sembrava a portata di mano. Adesso è diverso. Le immagini della tv mostrano scene agghiaccianti.
Manca tutto. Non solo i generi di prima necessità. Manca l’elettricità, l’acqua corrente, il gas. Il carburante è terminato da settimane.
La telecamera inquadra le auto rimaste incolonnate lungo il margine della strada, immobili, preda dei disperati. Le carcasse degli automezzi sul ciglio della carreggiata si sono trasformate in alloggi di fortuna destinati alle migliaia di persone che si sono riversate lungo il confine tra Macedonia e Tracia da ogni angolo del paese.
Lo speaker parla dei due nemici da combattere per chi si è messo in marcia: la polvere di giorno e il freddo di notte. L’escursione termica non dà tregua alle popolazioni in cammino. Molti erano pieni di speranza, il giorno della partenza; arrivano da lontano, alcuni da Igoumenitsa. Dopo aver attraversato buona parte del territorio greco, si sono resi conto che non è rimasto più niente.
Solo miseria.
Fame.
Polvere a sferzare gli occhi ad ogni folata di vento. A incollarsi alle scarpe ormai logore, consunte. Helladios rimane immobile, le condizioni di salute non gli permettono una corretta deambulazione. Però sembra intendere ogni parola. La telecamera inquadra il paesaggio circostante.
I pochi campi destinati alla coltivazione sono rimasti abbandonati. Dalla strada asfaltata fino a dove un tempo cominciava il frumento è un susseguirsi ininterrotto di radici, barbe, erbacce. La campagna è una distesa monotona, grigia, brulla, resa ancora più spoglia dal sole che durante le ore diurne sembra voler rimanere incollato allo zenit.
Non è rimasto più nulla da depredare.
I più fortunati riescono a rimediare un passaggio, magari solo per poche miglia, a bordo dei soli automezzi ancora dotati di benzina.
Lo speaker racconta un episodio:
Oggi abbiamo visto transitare un furgone rosso. Il cassone era pieno di persone. Una specie di apparizione: sembrava nuovo, l’autocarro. Appena uscito dalla carrozzeria. Il treno di gomme ancora immacolato. Le modanature cromate scintillanti lungo la fiancata. Alcuni ragazzi hanno provato ad aggrapparvisi. Altri si sono buttati nel mezzo della corsia, nel tentativo di rallentarne la corsa. Il furgone ha accelerato e gli occupanti, dal cassone, hanno respinto a calci il tentativo dei ragazzi di salire.
Lo abbiamo accompagnato con lo sguardo mentre si allontanava sollevando una nuvola di polvere densa, greve, capace di impregnare le narici.
Sullo sfondo, in ogni direzione, decine di cani, smunti e magrissimi, vagano senza meta.
Latrano fino a notte fonda. Una specie di litania che accompagna le notti dei disperati, insieme al crepitare del fuoco acceso grazie agli pneumatici.
La telecamera indugia su un’immagine: una ragazza incinta, mentre tiene per mano un bambino, allatta un vecchio senza denti appoggiato con la schiena ai resti di una roulotte.
Vorrebbe raccontarti, il vecchio Helladios, lui che ne ha viste tante, come tutto è cominciato.
Come si è arrivati fino a qui.