
VI
Quaderno americano
di
Federico Zuliani
1.
Tu, che non mi scrivi più,
so però che vivi ancora oltre certe finestre
senza più libri, importanti, senza
permetterti le debolezze che
ti concedevi, soltanto, per farmi sentire
un po’ meno impotente, un po’
meno vinto. Tu sai nutrirti infatti
di questo buio che io invece temo
e che s’è annesso, ad uno ad uno, i miei
porti. La notte, poco s’adatta ai borghesi
– che credono ai giorni fasti, alle luci, alle case
dalle tovaglie stirate, coi monogramma.
Ma tu, che già allora sapevi
di questa era ventura di passaporti
negati, di cavalli di Frisia e di
desiderio d’Armenia, hai preso
per tempo la via dell’esilio
dalla convinzione che saremmo potuti
divenire ciò per cui le madri
c’hanno educato, in quel tempo, ad essere,
nei giorni dei calzini stirati, delle
certezze, repubblicane. Oggi
so che hai preso un posto, anche per me,
tra i tavoli dei reduci, dei colpiti, da proscrizione.
2.
Ci hanno insegnato la diaspora nei gesti
delle madri, delle possibili nuore,
da che parte andasse il coltello
sulle tavole spoglie delle feste avite
e dal sacro timore per le parole avvolte
nel vuoto greve del non pronunciato.
Ma oggi, di contra, ci ritroviamo
perché, come ultimo sfregio, chi possiede le chiavi
delle nostre vite, ci ha vietato
di andare incontro alla morte, indossando
le maschere funebri degli antenati.
Le maschere, che conserviamo negli atri
delle case, e che sono state prese
sui volti dei morti, sui corpi già vuoti
d’aria, ma ancora vestiti, ancora in possesso
degli oggetti che si lasciano ai vivi, che rimangono
a ricordarci dell’illusione che sta, tra noi,
e il credere che ci sarà dato di
avere, pure noi, quegli anni
che sono stati, prima, dei padri e dei nonni.
Ma oggi, in questo paese che ci chiama altri,
quelli, ci spiegano che è meglio
– per ragioni di salute pubblica –
che la morte esca dalla vita degli uomini
perché ricorda troppa se stessa, perché
priva del sonno i bambini. E così, nella diaspora,
i padroni ci impongono infine d’avanzare soli;
ci vogliono nudi, uguali, nel nostro essere nati
senza padre né madre, nel non essere
di nessuna gens, nel sapere nostro, solo il presente.
Come ad ogni legge ingiusta prima, anche a questa
obbediremo, per poi indossare le maschere
mentre siamo soli, in casa. La libertà
nelle case ci impone però, senza accorgercene,
nuovi confini, ma soprattutto, ce ne rende
i guardiani (gli schiavi) più attenti, i più fedeli.
Oggi che sono transenne tutto intorno a noi,
la morte ha smesso di uscire in strada,
è divenuta privata, come i parcheggi,
o il diritto proprio dei Greci di Ionia, su cui è costruita
l’illusione collettiva per cui, rinunciando
alla morte, si possa avere in cambio la vita.
3.
Avrei voluto portarti con me, Ossip Emili’ovic,
ma Marina ha ragione: l’America non si addice
ai tuoi piedi, e so che sei contento di aspettarmi laggiù
assieme a Proserpina, e agli dei della casa
a cui è stato interdetto il passaggio del mare.
Quaggiù, sappi, godo l’estate delle persone non grate
in questo deserto di grattacieli posti a difesa
del nulla che viene, e che vive nei fiumi,
nelle grandi pianure delle metropolitane.
L’Armenia, qui, è tavolini con tovaglie a quadretti
con i bordi macchiati, e non c’è spazio
per le nostre lentezze, per il tuo modo di
aspettare che la notte si alzi, che vengano a dirci
che è ora di andare. L’esilio si sconta nei tabacchi
ignoti, nel sali e scendi per i supermercati.
Mancano, poi, le pattuglie, e per questo
se ne sentono i passi avanzare, tra i tombini
sopra le tombe levigate dei mezzi piani. Il mondo,
oltre il mare, è fatto per chi crede ai profeti,
per i-senza-vergogna nel dire “io”. Mi
manchi. Aspettami, te ne prego. Tornerò
perché il buio di Mosca è diverso, con te
e pure la radio annuncia in un modo diverso
che è meglio dormire con le finestre sprangate.
4.
Viaggiando s’apprende a conoscere
l’attesa che anticipa lo squillo delle sirene,
mentre si fanno le scale, quando si è in coda
per la Comunione. Qui, di notte,
i miei amici sono tutti cinesi
mi confondo coi nomi, pretendo
che sappiano almeno come ci si ubriaca.
Diverso però è il ritornare, e trovare
che la propria città ha assunto i colori del buio
che s’è federata in nostra assenza coi barbari.
E così, spogliati lo zaino ed i gradi, non rimane
che augurarsi che presto venga il tempo
di un’anabasi ultima che ignori i sentieri
e che proceda tra i tetti, fra le ombre lunghe
dei sottoscala. Viaggiando, abbiamo tentato,
tante volte, ma invano, di spogliarci nudi,
di confonderci, nelle folle, di sparire
nelle strettoie anguste delle stazioni;
ma ogni tentativo, fatuo, ha lasciato
su di noi, più indelebile, la mera lingua
delle madri e dei padri, questa cosa
invincibile e atroce, che mi impone, anche ora,
di dire “noi”. Tornare, mi obbliga, così
ad accettare che questo vuoto che tocco
solo, ignoto, ma che ha saturato anche l’aria
di cui sono fatte le cattedrali, è il mio vuoto,
che questa indegna colpa, la mia colpa.
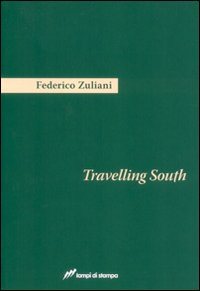 Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006. La dimora del tempo sospeso segnala tra l’altro Travelling South, di cui esiste una bella ricognizione su Absolute Ville
Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006. La dimora del tempo sospeso segnala tra l’altro Travelling South, di cui esiste una bella ricognizione su Absolute Ville





 Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012
Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012
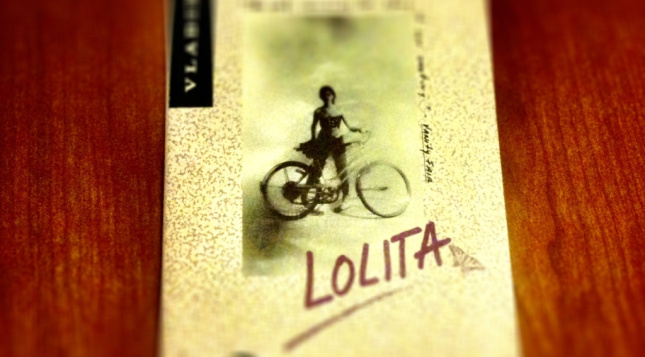
 Via via che la mia collaborazione con Tunué andrà solidificandosi, potrò parlare sempre meno dei suoi libri, il che è un peccato: se conoscevo già bene la casa editrice di Latina per il suo catalogo estero, nel quale spiccano capolavori come Rughe di Paco Roca o Perché ho ucciso Pierre di Alfred & Ka, sto scoprendo solo adesso la sua altrettanto interessante produzione italiana, nell’ambito della quale si va a inserire il nuovo progetto di adattamento di romanzi italiani recenti, la cui prima uscita è Il tempo materiale, fumetto di Luigi Ricca tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Vasta, uscito per minimum fax nel 2008. La scelta, va da sé, è azzeccata: quando, quattro anni fa, per effetto dell’aver cominciato a scrivere, per così dire, “seriamente”, cominciai ad avvicinarmi anche alla letteratura italiana contemporanea dopo anni spesi soltanto su opere dei secoli scorsi, Il tempo materiale fu uno dei romanzi usciti in quel periodo che mi persuasero che anche qui e oggi si potevano fare cose ottime: che, insomma, valeva la pena. (Gli altri due erano Ultimo parallelo di Filippo Tuena e Puerto plata market di Aldo Nove, che non è del 2008, ma che comprai nella riedizione Einaudi Stile Libero di quell’anno, credendolo appena uscito).
Via via che la mia collaborazione con Tunué andrà solidificandosi, potrò parlare sempre meno dei suoi libri, il che è un peccato: se conoscevo già bene la casa editrice di Latina per il suo catalogo estero, nel quale spiccano capolavori come Rughe di Paco Roca o Perché ho ucciso Pierre di Alfred & Ka, sto scoprendo solo adesso la sua altrettanto interessante produzione italiana, nell’ambito della quale si va a inserire il nuovo progetto di adattamento di romanzi italiani recenti, la cui prima uscita è Il tempo materiale, fumetto di Luigi Ricca tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Vasta, uscito per minimum fax nel 2008. La scelta, va da sé, è azzeccata: quando, quattro anni fa, per effetto dell’aver cominciato a scrivere, per così dire, “seriamente”, cominciai ad avvicinarmi anche alla letteratura italiana contemporanea dopo anni spesi soltanto su opere dei secoli scorsi, Il tempo materiale fu uno dei romanzi usciti in quel periodo che mi persuasero che anche qui e oggi si potevano fare cose ottime: che, insomma, valeva la pena. (Gli altri due erano Ultimo parallelo di Filippo Tuena e Puerto plata market di Aldo Nove, che non è del 2008, ma che comprai nella riedizione Einaudi Stile Libero di quell’anno, credendolo appena uscito).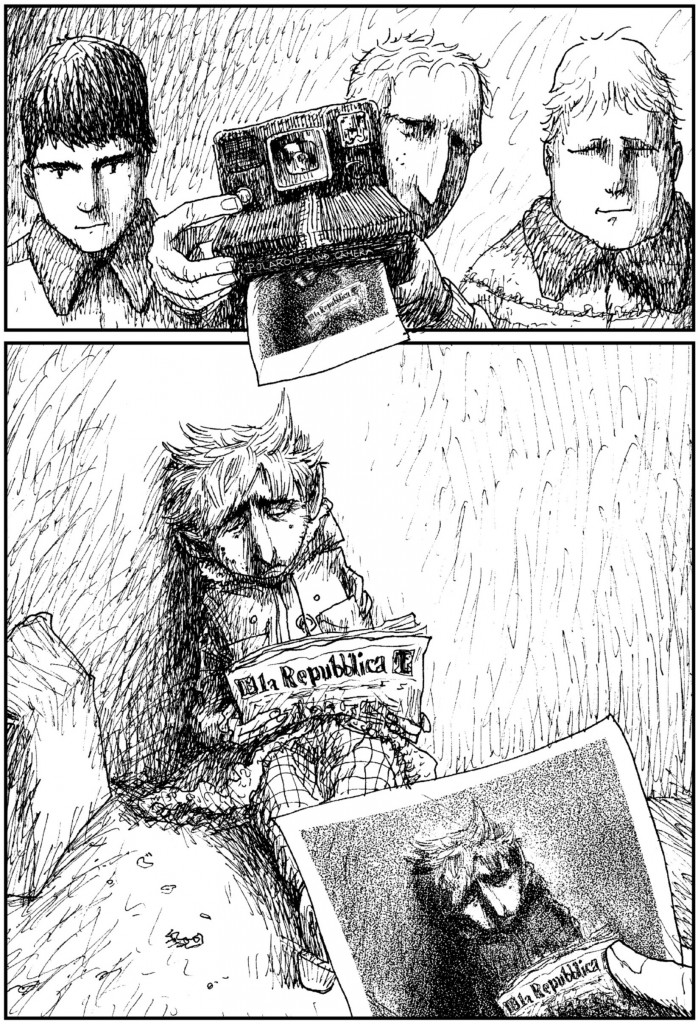
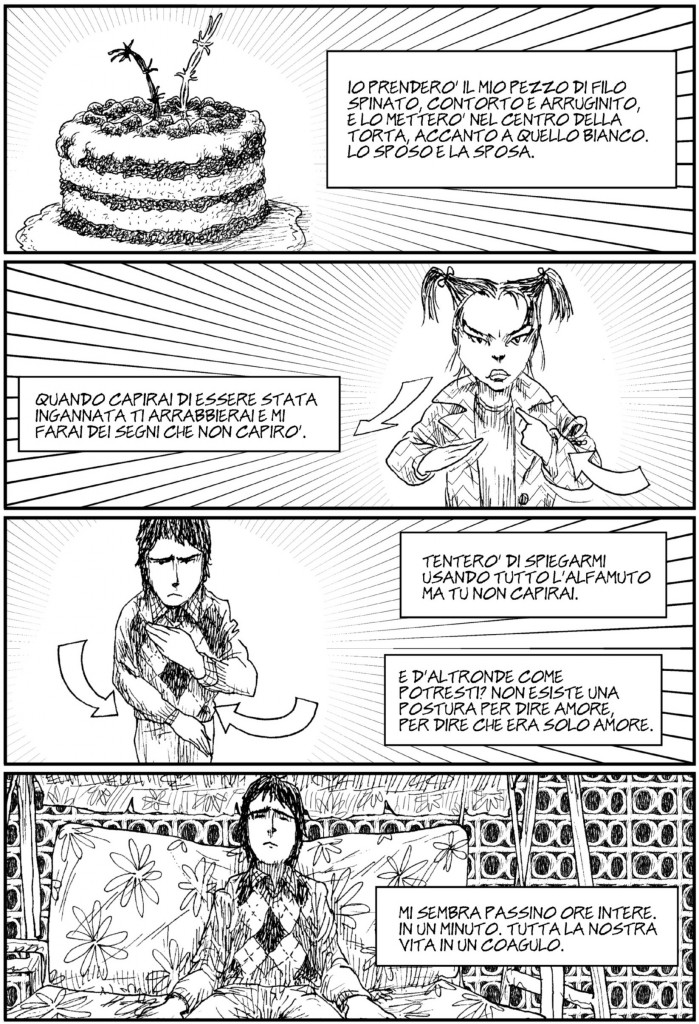 alità della lingua, nel fumetto il fatto di averli sempre tutti e tre sott’occhio, lì disegnati, se da un lato limita le suddette dimensioni, dall’altro potenzia la vicenda sotto il profilo del crudo realismo, e ci si scopre a pensare “ma guarda che razza di piccoli, perfidi bastardi,” mentre li si guarda catturare Morana, “interrogarlo”, fotografarlo, ucciderlo, o a scuotere la testa di fronte alla messa in scena dei loro deliri ideologici.
alità della lingua, nel fumetto il fatto di averli sempre tutti e tre sott’occhio, lì disegnati, se da un lato limita le suddette dimensioni, dall’altro potenzia la vicenda sotto il profilo del crudo realismo, e ci si scopre a pensare “ma guarda che razza di piccoli, perfidi bastardi,” mentre li si guarda catturare Morana, “interrogarlo”, fotografarlo, ucciderlo, o a scuotere la testa di fronte alla messa in scena dei loro deliri ideologici.
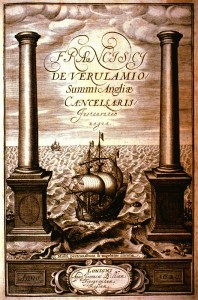
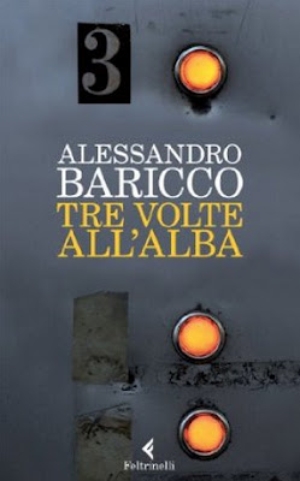

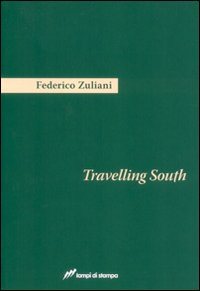 Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006.
Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006. 
 di Luca Ricci
di Luca Ricci
