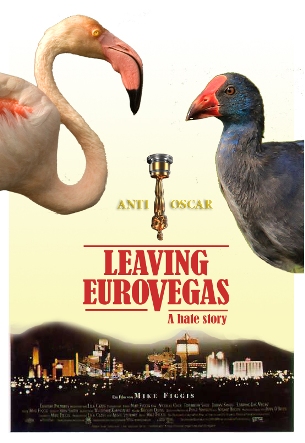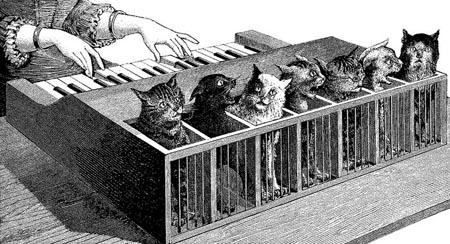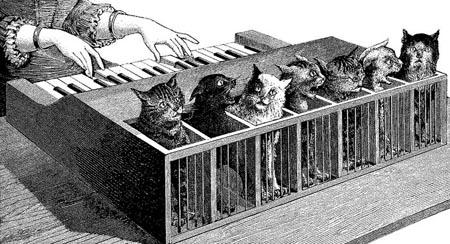di Giuseppe Zucco

Ricordo che i miei si leggevano l’Ulisse ad alta voce,
l’uno con l’altra, a letto: con un atteggiamento
fichissimo, tenendosi per mano, tutti e due animati
da questo amore davvero feroce per qualcosa.
David Foster Wallace
La storia degli attacchi all’Ulisse di James Joyce è antica quanto il libro stesso, scrive Valerio Magrelli in “Leggete le note da Dante a Joyce”, un articolo apparso su La Repubblica. Ma una sprezzatura leggendaria come quella di Virginia Woolf, per la quale leggere il capolavoro di Joyce era come trovarsi di fronte a un disgustoso studente universitario che si schiaccia i brufoli, non equivale alle ultimissime staffilate degli scrittori di grido come Jonathan Franzen e Paulo Coelho.
Se la prima, contemporanea dello scrittore dublinese, anteponeva il gusto personale e la morale vittoriana alla critica letteraria più illuminata, gli ultimi, invece, nostri contemporanei, (ma neanche un attimo contemporanei di Joyce, in quanto a consapevolezza letteraria), nei loro interventi a gamba tesa – interventi ritenuti tanto più autorevoli poiché amplificati dalla cima del successo commerciale – dimostrano neanche tanto sottilmente che leggere Joyce, comprenderlo, richiede fatica. Una fatica tanto più fisica se alla lettura dell’opera si accompagna tutto il compulsare delle note esplicative.
A questo punto dell’articolo, peraltro condivisibile, se non fosse che il piacere, la gioia e la sfida intellettuale che la lettura dell’Ulisse assicura è continuamente affossata sotto la lapide della parola fatica, Valerio Magrelli – il quale, sono sicuro, vuole bene a Joyce, e scrive per proteggere Joyce, e veglia sul sonno eterno di Joyce scacciando dalle sue prossimità i moscerini del successo commerciale – seguita le proprie argomentazioni compiendo un doppio passo falso e a tutto discapito di Joyce.
Intanto, paragona l’Ulisse alla Divina Commedia. Ma non tanto per illuminare e preservare la grandiosa architettura delle due opere – cosa che a suo tempo già fece Harold Bloom con altro dispendio di energia. Quanto per giustificare la presenza delle note appena sotto o di lato al testo, dimenticando a proposito tutta una serie di circostanze, non ultima il fatto che al contrario dell’Ulisse, la Divina Commedia è un poema composto tra il 1304 e il 1322 nelle cui terzine incatenate di versi endecasillabi si scioglie non l’italiano, ma un suo progenitore, il volgare fiorentino, lingua che per essere goduta a pieno ha bisogno di un apparato critico a fianco. Certo, l’Ulisse, al pari della Divina Commedia, è un’opera-mondo composita, pluriforme, stratificata, gremita di allusioni e di significanti doppiofondo in cui si annida il fantasma della storia, della mitologia, della letteratura, di Omero e Shakespeare soprattutto, ma la sua lingua è uno spettacolo molto più vicino ai bengala accessi sotto la cui volta ci si può avventurare senza nessuno che ti tenga per mano.
Anche se il vero e proprio punto della questione viene qualche riga dopo. Sempre e solo per ribadire l’importanza delle note – considerando le note non come un paratesto, ma come parte del testo, come se il commento a furia di spintoni si fosse introdotto nel testo originario, mimetizzandosi tanto da non potere più sciogliere l’uno dall’altro – Valerio Magrelli lascia rotolare questo sassolino lungo il pendio della nostra attenzione senza neanche presentire il rischio di una valanga: Come i Canti della Commedia, i capitoli dell’Ulisse vanno affrontati soltanto dopo aver letto le loro analisi. […] Occorre cominciare dal commento a ogni singolo capitolo, per poi passare al capitolo stesso. In tal modo la lettura procederà libera, ma sulla scorta di indicazioni indispensabili.
Dato che già nella collana degli Oscar Mondadori l’Ulisse è venduto inseparabilmente da una Guida alla lettura, significherebbe pure che prima ancora di sincronizzarsi agli oscillamenti fisici erotici spirituali di Leopold Bloom toccherebbe arrancare dentro duecentottantadue pagine di ragguagli critici. La Guida alla lettura, tra l’altro, debutta con questo tenore: Ulisse è un punto di arrivo non solo nell’attività creativa di Joyce, ma nell’evoluzione della letteratura occidentale. Al pari di Waste land di Eliot (pubblicato nello stesso anno 1922), e più ancora della Recherche proustiana, segna la consumazione definitiva dell’esperienza decadente e simbolista, e perciò anche di quella romantica e post-romantica, sfociata nel decadentismo.
Da un punto di vista puramente sentimentale, è come se tu ti fossi innamorato, e volessi baciare a tutti i costi la ragazza più bella del pianeta terra, ma al colmo di timidezza, al solo fine di avvicinarla, decidessi intanto di frequentare e sedurre e baciare la sua migliore amica, la quale ti parla tutto il tempo della più bella, dei suoi trascorsi e delle sue aspirazioni, nonostante l’aspetto della migliore amica, al contrario dell’immagine della ragazza che palpita tra le parentesi delle tue costole, abbia qualcosa di ferocemente antisociale, un certo strabismo, per esempio – e, a tratti, una irreparabile bruttezza.
Il commento, per dirla tutta, le note, sono molto utili, a volte necessarie, ma non hanno mai la stessa forza espressiva cognitiva emotiva del testo originale – almeno, è quasi impossibile trovare qualcosa che suoni uguale: per questo è sempre meglio che si palesino dopo e non prima, il rischio sarebbe quello di disperdere quel senso di avventura e il desiderio di smarrirsi che pervade chi pesa questo genere di titoli in mano. Per di più, l’opera, ancora meglio, in questo caso, l’Ulisse, non si esaurisce nel suo contenuto, nella tirannia del contenuto che le note impongono, ma dispiega parte del suo potere e del suo fascino nel continuo elettrico sbocciare della lingua.
È anche per questo che fa tanto più male, a fine lettura, l’articolo di Valerio Magrelli. Non solo per questo infinito procrastinare il piacere della lettura. O per la pretesa di curare la fatica della lettura – là dove si presenta – con la fatica di seguire prima migliaia di altre annotazioni appuntate, il più delle volte, in un noiosissimo stile accademico. Quanto per questa implicita sfiducia alla migliore letteratura. Come se questa, James Joyce in testa, non riuscisse più a bussare e a farsi accogliere senza che prima qualcuno non ne annunci la presenza. Come se il lettore – un lettore disposto, bisogna riconoscerlo, parzialmente già attrezzato, a scalare le grandi opere – prima ancora di capire, non sentisse, non avvertisse di per sé, la bellezza, il rilancio, l’invenzione, la scommessa.
[qui, l’articolo di Valerio Magrelli pubblicato su La Repubblica del 12/9/2012. La citazione di David Foster Wallace è tratta da Come diventare se stessi. Foster Wallace si racconta, di David Lipsky, Minimum fax 2011]






 di Carlo Ruggiero
di Carlo Ruggiero
 Dopo un paio di giorni di stanza a Filtu torniamo a Negelle ripercorrendo l’unica strada della regione, quella voluta dal gerarca Rodolfo Graziani per invadere l’Etiopia sotto il Fascismo. Ormai il tappetino d’asfalto è completamente abraso e si saltella come sulle montagne russe. Ma ecco di nuovo un camion, velocissimo, che ci supera. Ma si può sapere chi sono quei pazzi?, chiedo al mio accompagnatore. “Il chat non può aspettare” mi viene risposto. Scopro così che sugli altopiani dell’Etiopia cresce una pianta autoctona che produce germogli che masticandoli danno una lieve ebbrezza. In pratica è uno stupefacente naturale, qui assolutamente legale, di cui l’intero corno d’Africa e buona parte della penisola arabica ne è consumatore accanito. Solo che il chat – qat nello Yemen – ha da essere consumato fresco, appena germogliato. E per questo ogni mattina un sistema logistico organizzato meglio di un esercito in assetto di guerra riesce a distribuire nel raggio di centinaia di chilometri le frasche allucinogene. Persino l’impenetrabile confine somalo si apre al passaggio dei camion di chat senza troppo discutere. Neppure a farlo apposta nel villaggio che abbiamo appena raggiunto notiamo il camion fermo che distribuisce fasci di verdura come fossimo al mercato. I due ragazzi col kalashnikov sul camion però mi fanno capire che la cosa è meno divertente e folkloristica di quanto immagini.
Dopo un paio di giorni di stanza a Filtu torniamo a Negelle ripercorrendo l’unica strada della regione, quella voluta dal gerarca Rodolfo Graziani per invadere l’Etiopia sotto il Fascismo. Ormai il tappetino d’asfalto è completamente abraso e si saltella come sulle montagne russe. Ma ecco di nuovo un camion, velocissimo, che ci supera. Ma si può sapere chi sono quei pazzi?, chiedo al mio accompagnatore. “Il chat non può aspettare” mi viene risposto. Scopro così che sugli altopiani dell’Etiopia cresce una pianta autoctona che produce germogli che masticandoli danno una lieve ebbrezza. In pratica è uno stupefacente naturale, qui assolutamente legale, di cui l’intero corno d’Africa e buona parte della penisola arabica ne è consumatore accanito. Solo che il chat – qat nello Yemen – ha da essere consumato fresco, appena germogliato. E per questo ogni mattina un sistema logistico organizzato meglio di un esercito in assetto di guerra riesce a distribuire nel raggio di centinaia di chilometri le frasche allucinogene. Persino l’impenetrabile confine somalo si apre al passaggio dei camion di chat senza troppo discutere. Neppure a farlo apposta nel villaggio che abbiamo appena raggiunto notiamo il camion fermo che distribuisce fasci di verdura come fossimo al mercato. I due ragazzi col kalashnikov sul camion però mi fanno capire che la cosa è meno divertente e folkloristica di quanto immagini.
![limousine1[1]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2012/09/limousine11.jpg)








 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo