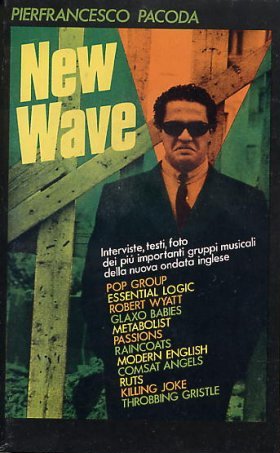In redazione a Frigidaire, a Roma, arrivavano molte visite. Una quantità di collaboratori veniva nella palazzina di Monteverde Vecchio, una villetta col cortile interno, un giardino abbastanza trascurato e un piccolo pergolato, per consegnare articoli, disegni, proposte. Talvolta per litigare, durante misteriose riunioni nell’ufficio del direttore. Con Tanino Liberatore, per esempio, che arrivava da Parigi, non mancavano mai urla, o rumori non meglio identificati. Quando era il turno dei bolognesi si accendeva una luce nella redazione, dove dominava il look cupo autonomia/via dei Volsci, la luce dell’eleganza: Marcello Jori, giovane pittore che utilizzava una interessante commistione tra immagini fotografiche in polaroid e tecnica pittorica, entrava con la sua bellezza aristocratica, i vestiti alla moda (il nero era sempre in voga), i modi affabili, da giovane vincente; Andrea Pazienza, seguito spesso da tipi equivoci, ambigui, spuntati da chissà dove, con giubbotti di pelle extralusso che riempivano di meraviglia il direttore; Massimo Iosa Ghini, che curava servizi/performance d’avanguardia, architetto anche nello stile che usava per aprire e chiudere le porte; Daniele Brolli, il letterato avant-garde anni ’80 multimediale, disegnatore, illustratore, sceneggiatore; Giorgio Carpinteri, che disegnava personaggi duri, cuneiformi, il primo, credo, a utilizzare guanti da lavoro come accessorio d’abbigliamento.
Note per un libretto delle assenze
all’amica Georgia
Erano verdi, rosse, e c’erano già alla tua venuta. Esistevano da molto tempo prima, nel mondo. Le cercavi con la coda dell’occhio non badando alla luce ma alzandoti facendo leva sui gomiti, oppure lasciandoti quasi cadere dal letto a castelletto, da sopra, perché da sotto ce l’avevi dritta davanti a te. Una luce tenue eppure immensa, piccola e diffusa per tutta la cameretta. Era un gesto di madre – non erano certo i padri a chinarsi sulla presa per il lume- e insieme al respiro di chi dormiva nel letto accanto, in quello di sopra, sotto, c’era una luce appena appena colorata, a farti compagnia. Così se ti veniva d’aprire gli occhi all’improvviso ne scorgevi la mano sicura, i suoi fasci di luce come dita. Spariva durante il giorno come una lucciola. E all’improvviso, al crepuscolo la vedevi apparire. Un respiro lungo senza intermittenza, tra te e tua madre, era.
la conta delle lentiggini
di Flavia Ganzenua
Io sono il mio labirinto e mi cibo di chi ci si perde.
Disobbedisci, ruba il sale e scappa, di corsa, sotto il letto. Accucciati e resta lì. Tua madre sbraita, si china a terra, e ti cerca a tentoni. Tu scalci, le mordi la mano se non sa come ti deve toccare, se ancora non ha imparato. Scalci, ma poi ti lasci prendere perché sai che in quel momento e in quello solo, tra urla e ceffoni, finalmente sei al sicuro.
Mo Yan: letteratura contadina
 (riproponiamo un articolo del 2010 su Mo Yan, oggi Nobel per la letteratura)
(riproponiamo un articolo del 2010 su Mo Yan, oggi Nobel per la letteratura)
di Andrea Pira
“Chi le ma?” “Hai mangiato?”. È una strana frase da dire a qualcuno quando lo si incontra per strada. L’equivalente cinese del nostro “come stai?”. Un saluto comune tra le vecchie generazioni per le quali rispondere con un sì vuol dire “sto bene”. “Quando ero piccolo, negli anni Sessanta, noi bambini andavamo a cercare le bacche per mettere qualcosa nello stomaco”, ha detto Mo Yan, in Sardegna per partecipare al festival letterario ‘L’isola delle Storie” di Gavoi. Per il più importante autore cinese contemporaneo il cibo fu la musa ispiratrice. “Decisi di prendere carta e penna in mano quando un mio amico mi disse di conoscere uno scrittore che mangiava tre volte al giorno”, ha raccontato. “Ci pensate? Tre pasti, mentre noi vedevamo la gente morire di fame”.
intorno alle locande
di Massimo Bonifazio
furono altre guardie di frontiera a farmi il verso,
a deporre i legni bianchi sopra ai fossi:
orpelli, o ponti necessari, sfuggiti al gracidare
del cemento. solo dopo arrivarono alle travi
rune a sciami, scolpite da mani meno esperte
di quelle che lisciavano i lenzuoli.
* * *
si andava componendo il gelo del mattino;
giù per la rancida domanda finita a costellare
le torbe, gli sterpeti; né mi riuscì mai l’inseguimento
lungo quei greti afflitti, quelle forre
ripiegate sulle case.
Battute per un cinema muto: Carlo D’Amicis
Nota di lettura
di
Francesco Forlani
su La battuta perfetta di Carlo D’Amicis
C’è uno strano film, del 1966, Due marines e un generale, diretto dal regista Luigi Scattini e che vede, come protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Strano perché ad un certo punto, con una parte tutt’altro che secondaria, scopriamo Buster Keaton. Il quale, nei panni di un generale della Wehrmacht, da gigante del cinema muto, non dirà una parola. Solo una battuta, insieme sorprendente per i nostri comici, e terribile, nel finale della scena proposta qui in ouverture: Thank you. Dice.
Due anni prima, nel 1964, Buster Keaton aveva interpretato, O, il personaggio protagonista di Film, unica prova cinematografica di Samuel Beckett che ne aveva firmata la sceneggiatura. Film, privo di sonoro, e con un’unica battuta: «Shhh!» che nella parte iniziale l’autore fa dire a una signora appena travolta da Keaton, per zittire il compagno che vorrebbe reagire. La fortunata formula di Berkeley, “Esse est percipi” era stata la parola chiave dell’esperimento, certo poco capito all’epoca, del grande drammaturgo irlandese: “essere è essere percepito, sentito, visto. E allora perché rinunciare al silenzio se il silenzio può farci sentire quello che sta accadendo? Se può darci l’illusione di essere percepiti?
La battuta perfetta, di Carlo D’Amicis (1964) si apre sulla troupe di Pasolini che sta girando a Matera, terra d’origine del protagonista, Canio Spinato, in quello stesso anno, il 1964, il Vangelo secondo Matteo.
Il padre di Canio, Filippo, che sarà assunto alla RAI pochi anni dopo,” faccia da stronzo, da democristiano”, quando da Roma riesce a tornare in famiglia, se ne sta rinchiuso nel suo studio. Al figlio che vive quel mutismo come un lutto, si limita a spiegare:
il silenzio è ascolto. Dicevi. ma io non sentivo niente. Il silenzio è verità. ma a me sembrava chiaramente una bugia.
Spaesamento
di Alessandra Sarchi
Giorgio Vasta, Spaesamento , Editori Laterza, Bari 2010
“L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima: qui è la chiave di tutto”. La tappa finale del viaggio in Italia di Goethe (1786-7) fu ricca di rivelazioni; a Palermo, in seguito a una visita all’Orto Botanico Goethe cominciò a formulare la teoria di quell’Urpflanze , la pianta matrice di tutte le altre, la pianta archetipale, che avrebbe sviluppato nella pubblicazione “Metamorfosi delle piante” (1790) ed esteso al mondo delle attività umane, come idea che esiste un inizio, potenzialmente in grado di tenere in sé ogni possibile conseguenza e derivazione.
Imprescindibile
One Man Show dello scrittore Franz Krauspenhaar. Tra poesia, racconti, improvvisazioni e altro ancora.
Venerdì 9 Luglio a Milano
presso la Fondazione Durini, Sala delle danze –
all’interno della mostra “Il Mito del vero/il ritratto/il volto” in via Santa Maria Valle 2 (vicino a via Torino, MM Duomo.)
Dalle ore 21 fino ad orario imprecisato.
FK sarà presente in sala anche fra le 18 e le 20 per due chiacchiere preventive.
L’Aquila vola su Roma
ma la cura dei terremotati non era il fiore all’occhiello del nostro governo?
Gesti senza domani
di Carlo Tirinanzi De Medici
(a F., con autonomia)
Diversi romanzi usciti in Italia negli ultimi anni hanno per protagonisti bambini e adolescenti. Al di là delle evidenti differenze di qualità, stile e scopo, in opere come Io non ho paura di Niccolò Ammanniti (2001), Il tempo materiale di Giorgio Vasta (2008), Stabat mater di Tiziano Scarpa (2008), Riportando tutto a casa di Nicola Lagioia (2009) o Acciaio di Silvia Avallone (2010) si racconta di ragazze e ragazzi non ancora maggiorenni che devono destreggiarsi in un mondo distante, misterioso, a tratti incomprensibile: quello degli adulti. In questi romanzi si racconta l’epoca dell’immaturità e il percorso che disegnano è quello di una conquista progressiva della consapevolezza da parte dei giovani.
Leggendo Robert Walser
di Franco Fortini
Quanti mai mi attribuiscono sordità a scritture che hanno a proprio oggetto la condizione “limbale”, l’al di là dei nostri giorni intravveduto dall’Idiota dostoevskiano. E invece la proposta di chi riesce in qualche modo ad annunciare quella condizione, come paradossale contatto di presente/avvenire e di possibile/desiderabile, l’ho sempre udita. Vorrei non sentirmi scorato per non essere riuscito, almeno in prosa, a far capire o a capire io per primo che tutto un ordine, una schiera di verità, quali lo stato del secolo ha affidato in gestione a corpi intellettuali più o meno remoti da me, o anche remotissimi, sono sempre stati e continuano ad essere il fondo ma anche il sostegno e in definitiva la ragione di tutto quel che mi pare debba essere perseguito. O fede, se così si vuol chiamarla.
Flebo
di Alice Keller
Flebile tubicino che mi entra nel braccio, che buca la mia sottilissima vena per cercare di ristorare con un po’ d’acqua questa terra secca e arida, per cercare di dare quel nutrimento, quel liquido vitale, che ormai chi doveva farlo non le dà più. Mamma che dà l’acqua a un bambino che non è in grado di gestirsi da solo. Bimba irresponsabile, non sei capace di occuparti di te, non vuoi bere, capricciosa, ora ti imbocco io, te la do io, l’acqua, bimba in coma anche se cammina ancora.
Brotherhood
di Aldo Busi
Bisogna assolutamente promuovere il film più bello in circolazione, “Brotherhood” (2009) di Nicolo Donato, origini italiane e cultura danese, gli impressionanti interpreti principali si chiamano Thure Lindhardt e David Dencik, distribuito in Italia dal coraggiosissimo Occhipinti (un nome con una garanzia di segno opposto: molto impegno e pochissimo mascara). Dobbiamo fare in modo che almeno i nostri occasionali lettori vadano a vederlo prima che la grande distribuzione se lo inghiotta togliendolo dal cartellone. E’ un’opera magnificamente brutale e brutalmente magnifica sul machismo del branco (con relative sguince tam-burine) e la subcultura ispirata da Dio Patria Famiglia nelle giovani menti, non sempre già tossicodipendenti, gestite da fanatici vecchi nostalgici del mito della Natura Naturale.
A casa Brescia non risponde nessuno
di Sarah Zuhra Lukanic
In quel pomeriggio piovoso e bigio, mi ero riparato sotto il portico che conduceva a casa di Alessandro Brescia. I miei abiti, neri e logori, preannunciavano la brutta notizia che stavo portando. In quel periodo mi faceva da scorta Luek, un ragazzo singalese. Nel nostro cantiere era una specie di gatto randagio, benvoluto da tutti. Il suo nome era composto di 52 lettere, ma lui si faceva semplicemente chiamare Luek, che in singalese vuol dire amico. Con noi lavoravano parecchi lavoratori stranieri. Alcuni venivano con Albert, il rumeno che possedeva una ditta edile e se la passava piuttosto bene. C’era un macedone, c’erano due ragazzi moldavi e poi Danilo l’ucraino. Albert spifferava in giro la storiella che Danilo avesse fatto la guerra. Io so che la guerra in Ucraina non c’era stata, ma era inutile contrariare Albert.
l’Eugenio
[È nato un nuovo blog, l’Eugenio, tenuto da Francesco Guglieri. Questo è uno dei primi pezzi apparsi.]


 “Cos’è questo libro?” verrebbe da chiedersi, parafrasando un’altra opera di Tiziano Scarpa, appena ci si ritrova tra le mani questo suo ultimo La vita, non il mondo. Nel volumetto della collana “Contromano” – che, lo dico subito, è indirizzato unicamente ai più ferventi devoti dello scrittore veneziano – sono raccolte un centinaio di esperienze personali, descritte in modo sintetico (al massimo mezza cartella), vissute da Scarpa nel corso di un paio d’anni. Non è una collezione di prose d’arte – e non vuole esserlo: uno degli intenti di tutta l’operazione è proprio la messa tra virgolette del concetto di estetico. E a dire il vero è un intento perfettamente raggiunto dal momento che raramente questi pezzi si possono definire “belli”… – ma neanche propriamente un diario. Assomiglia piuttosto a un esperimento. Di nuovo si è costretti a specificare. L’esperimento non è nella ricerca di una qualche forma, appunto, sperimentale: precedenti illustri nella tradizione novecentesca non sono difficili da trovare (tra i tanti possibili, uno a caso: il Perec de L’infra-ordinario con la sua indagine “sull’abituale”), e non rappresenta un’eccezione neanche in un’opera, come quella di Scarpa, che ha fatto dello scarto dalla norma una regola. No, si tratta piuttosto di un esperimento filosofico (un’indagine fenomenologica): cosa resta dell’Io quando lo spogliamo di tutto ciò che non è Io? Ovvero, cosa resta della vita quando le sottraiamo il mondo.
“Cos’è questo libro?” verrebbe da chiedersi, parafrasando un’altra opera di Tiziano Scarpa, appena ci si ritrova tra le mani questo suo ultimo La vita, non il mondo. Nel volumetto della collana “Contromano” – che, lo dico subito, è indirizzato unicamente ai più ferventi devoti dello scrittore veneziano – sono raccolte un centinaio di esperienze personali, descritte in modo sintetico (al massimo mezza cartella), vissute da Scarpa nel corso di un paio d’anni. Non è una collezione di prose d’arte – e non vuole esserlo: uno degli intenti di tutta l’operazione è proprio la messa tra virgolette del concetto di estetico. E a dire il vero è un intento perfettamente raggiunto dal momento che raramente questi pezzi si possono definire “belli”… – ma neanche propriamente un diario. Assomiglia piuttosto a un esperimento. Di nuovo si è costretti a specificare. L’esperimento non è nella ricerca di una qualche forma, appunto, sperimentale: precedenti illustri nella tradizione novecentesca non sono difficili da trovare (tra i tanti possibili, uno a caso: il Perec de L’infra-ordinario con la sua indagine “sull’abituale”), e non rappresenta un’eccezione neanche in un’opera, come quella di Scarpa, che ha fatto dello scarto dalla norma una regola. No, si tratta piuttosto di un esperimento filosofico (un’indagine fenomenologica): cosa resta dell’Io quando lo spogliamo di tutto ciò che non è Io? Ovvero, cosa resta della vita quando le sottraiamo il mondo.
Chat noir Chat
Schwarze Katz (il gatto nero)
di Francesco Forlani
a Raul di Isabella
Un nome così a Berlino, a Parigi, non suscita mica ilarità, mica si presta ai doppi sensi, con quella sua pronuncia che sulla seconda parola accentua le zeta con indomita soddisfazione, come succede da noi, mica da voi. Da noi se chiami un Pub Schwarze Katz, minimo minimo ti arrestano per oltraggio al comune senso del pudore, oppure, non se ne fa nulla perché da noi tutto è oltraggio. La città moderna è oltraggio alla Reggia che si gira sull’altro fianco della pianura, e a quella antica che si limita a darle un’occhiata dalla Torre impizzata nella collina. E la guarda fare, la sua vita che è oltraggio alla vita. Alessandra Schwarze Katz era la vita. Avevamo pochi anni, ma nell’epica di quei pochi anni diciamo che lei era l’eroina mentre io non contavo un cazzo per nessuno. Per nessuno tranne che per lei, che mi dedicava sempre grandi sorrisi ogni volta che ci vedevamo in comitiva, giganteschi mostri di motorini e braccia che si muovevano lungo un perimetro assai ristretto e che si sviluppava intorno al centro della città lungo un asse che andava dalla sala giochi del Jolly Joker, con il muretto poco distante di una piccola piazza, fino alla fine della centralissima Via Mazzini. In una delle stradine sulla destra c’era appunto lo Schwarze Katz, il gatto nero. Il mio gatto invece era grigio, pelo lungo, persiano, una gatta in verità dal nome imprestato dagli Aristogatti, Minou come qualche anno prima avevamo depredato per il nostro dalmata, il nome Pongo alla carica dei centouno. Avevamo in famiglia di vero borghese soltanto gli animali domestici e dio.
PRIDE
Di Franco Buffoni
Perché è necessario coniugare la riflessione sull’omosessualità a quelle sulla laicità e sulla diffusione della cultura scientifica? L’obiettivo è l’affrancamento dal retaggio abramitico. Quel retaggio in virtù del quale si ritiene che un “creatore” abbia voluto generi e specie così come sono, immutabilmente: l’ordine del “creato”. Con conseguente fioritura del pregiudizio anti-omosessuale (praticamente assente nel mondo greco-latino) e descrizione degli omosessuali come coloro che ostacolano la “volontà divina”.
Questo assunto – che ho cercato di sciogliere in alcuni post apparsi su Nazione Indiana negli ultimi due anni – e che in tempi brevi spero di riuscire a tradurre in volume, mi è parso ancor più necessario lo scorso 3 luglio. Mentre nella ormai completamente laicizzata Londra un milione di persone sfilava in festa commemorando il primo Gay Pride di quarant’anni fa, a Roma alcune migliaia di persone erano costrette a sfilare accanto a uno striscione affisso da una associazione cattolica – fortemente protetta dalle gerarchie vaticane e sovvenzionata coi proventi dell’8 per mille – che definiva i diritti civili reclamati dagli omosessuali come “diritti alla perversione”.
Nulla di nuovo, mi si può replicare. Gli autori dello striscione sono in linea col Parlamento italiano che boccia la proposta di legge Concia contro l’omofobia e disattende sistematicamente l’art. 13 del Trattato di Amsterdam che condanna “i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali”. Ovvio che – se l’Italia si comportasse da paese civile e la legge contro l’omofobia fosse approvata – gli appartenenti a tali organizzazioni e i loro ispiratori e mandanti diretti e indiretti sarebbero immediatamente passibili di sanzioni.
Manuale di infiltrazione nei lavori per Expo e di connivenza alla milanese
“Alfabeta2”: la rivista e il sito
In edicola dall’8 luglio
il primo numero del mensile Alfabeta2
rivista d’intervento culturale
È attivo il sito alfabeta2.it