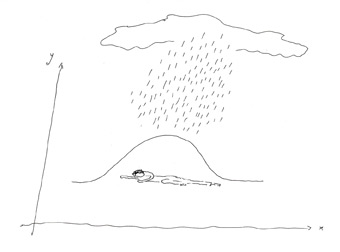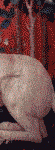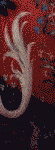di Marco Belpoliti
di Marco Belpoliti
Santa Sabina di Ramuscello (Pordenone). Una grande casa di color rosso mattone, dalla forma irregolare e gli infissi in legno chiaro, occupa il posto dove un tempo c’era il prato. L’hanno terminata da poco, e con la sua mole impegna tutto lo spazio visivo lungo la piccola via asfaltata che dalla chiesetta di Santa Sabina arriva qui incrociando la strada verso San Vito in Tagliamento. Una ragazza uscita dall’edificio dispone la biancheria su uno stenditoio pieghevole e traguarda più in là, oltre gli alberi. Dietro l’edificio, composto di due corpi asimmetrici, incastrati l’uno nell’altro, un Lego banale, c’è il resto di quel campo: erbacce che crescono dappertutto e i segni di un vivaio di piante abbandonate. Tra l’erba alta c’è anche un trattore dimesso, rovina della civiltà contadina nell’età della sua motorizzazione, anch’essa tramontata da un pezzo.



 Lungo il canale c’è il divieto di stazionamento, quindi non penso più alle macchine parcheggiate. Penso che ho fatto proprio bene a strapparmi via dalla cittadina dove sono cresciuto. Penso che passeggiare per quell’asfittico coacervo di costruzioni stritolato tra inospitali montagne è uno strazio, perché tutte le persone ti conoscono o comunque ti guardano insistentemente come ti conoscessero, e soprattutto in qualsiasi direzione tu ti diriga la cosiddetta città finisce subito: non rimane che girare in tondo a testa bassa, come nel cortile di una prigione. E quindi anche le idee finiscono per girare in tondo, per sprofondare nel gorgo della xenofobia.
Lungo il canale c’è il divieto di stazionamento, quindi non penso più alle macchine parcheggiate. Penso che ho fatto proprio bene a strapparmi via dalla cittadina dove sono cresciuto. Penso che passeggiare per quell’asfittico coacervo di costruzioni stritolato tra inospitali montagne è uno strazio, perché tutte le persone ti conoscono o comunque ti guardano insistentemente come ti conoscessero, e soprattutto in qualsiasi direzione tu ti diriga la cosiddetta città finisce subito: non rimane che girare in tondo a testa bassa, come nel cortile di una prigione. E quindi anche le idee finiscono per girare in tondo, per sprofondare nel gorgo della xenofobia.





 Come ho già segnalato
Come ho già segnalato