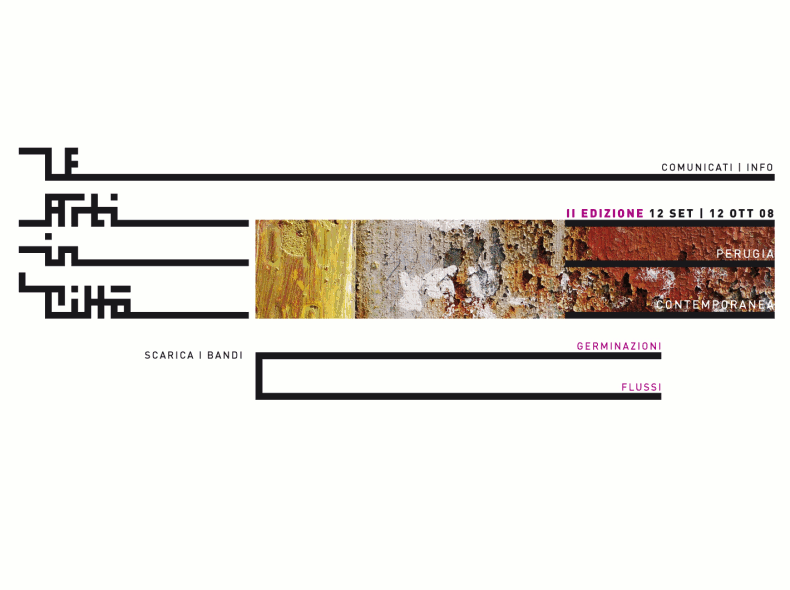di Chiara Valerio
Mario Desiati, Il paese delle spose infelici, romanzo, Mondadori (2008), pp. 227.
Ciascuno di noi poteva contare nel proprio albero genealogico una sposa infelice. Una zia, una bisnonna, un’ava con le stimmate dell’insoddisfazione. La depressione per reazione o ribellione ai destini di nozze e dunque di morte. La ragnatela di relazioni che ci univa tutti era in quell’insondabile maledizione: ho conosciuto, ho saputo, ho visto, ho stretto il cuore di una sposa infelice. Ogni figurina del mio album era unita all’altra da tutto questo. Il paese delle spose infelici di Mario Desiati è un romanzo di voci e circostanze, un incrocio. È plurale nonostante ogni personaggio abbia un nomignolo e ogni nomignolo una titubanza e ogni titubanza una variazione. E ogni variazione suppuri ancora in una nostalgia o in un fallimento. La voce che racconta, e che tradisce, perché come sottolinea Desiati, riordina, è quella di Veleno. Se Veleno racconta è sopravvissuto e se è sopravvissuto allora qualcuno si è perduto. In qualche modo. Quando il romanzo si spagina e la sposa incede nel Taras, nei piccoli rivoli tumefatti dagli scarichi del mostro di industrializzazione, chi legge sa già che qualcuno si è perduto. In qualche modo. Perché Desiati racconta i presagi come certi uomini incantano serpenti e i topi. In un paese in cui le spose erano infelici la volontà di illudersi era più forte di qualunque cosa, dare per un breve periodo un senso ai propri sogni, alla propria vanagloria.










 di Silvio Mignano
di Silvio Mignano